Da Don Bosco Ai Nostri Giorni
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
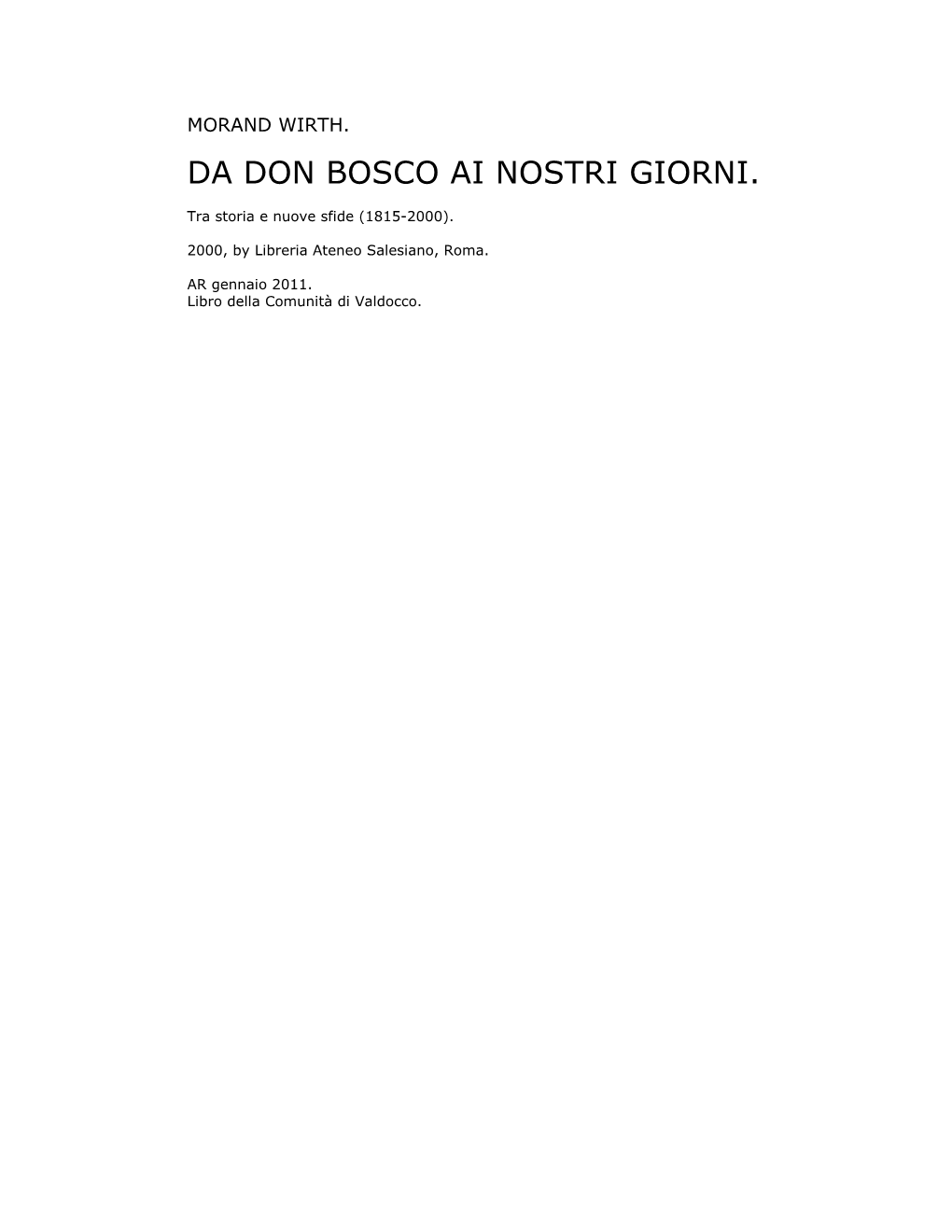
Load more
Recommended publications
-

Dai Consiglieri Professionali Generali Alla Federazione Nazionale CNOS-FAP
Dai Consiglieri Professionali Generali alla Federazione Nazionale CNOS-FAP Felice Rizzini Il processo innovativo della Formazione Professionale s'intensificò dopo la morte dì Don Bosco per il contributo determinante dei Consiglieri Professionali Generali, per gli interventi dei Capitoli Generali e per la dedizione alla causa da par te dei Salesiani Coadiutori, in parallelo agli interventi legislativi e normativi dello Stato ed allo spazio maggiore dato ad essa dalle iniziative pubbliche e private. Dopo Don Giuseppe Lazzero, che per primo esercitò il compito di Consigliere Generale Professionale della Congregazione dal 1886 al 1898, distinguendosi nella cura particolare alla formazione dei Coadiutori Salesiani, si succedettero: Don Giu seppe Bertello (1898-1910); Don Giuseppe Vespignani (una prima volta dal 1910 al 1911 ed una seconda volta dal 1922 al 32); Don Pietro Ricaldone (1911-1922); Don Antonio Candela (1932-1958); Don Ernesto Giovannini (1959-1965). Con il Capi tolo Generale XIX venne abolita la figura del Consigliere Professionale Generale. Fra di essi si distinsero per l'impulso dato alle Scuole Salesiane Professionali e Agra rie Don Giuseppe Bertello, Don Pietro Ricaldone, Don Antonio Candela e Don Ernesto Giovannini. 1 — Don Giuseppe Bertello Don Bertello arrivò a tale incarico con una profonda preparazione umanistica (laureato in teologia, in lettere e filosofia, membro dell'Arcadia e dell'Accademia Romana di S. Tommaso) e con una ricca esperienza di governo come direttore ed 127 ispettore, ma senza una preparazione specifica. Cercò di superare questo limite con lo studio personale e con il contatto diretto con l'esperienze salesiane e con quelle più importanti maturate in quel tempo in Italia e all'estero. -

Bollettino Salesiano
2015 - Digital Collections - Biblioteca Don Bosco - Roma - http://digital.biblioteca.unisal.it IN QUESTO NUMERO : Il nuovo Rettor Maggiore Don Luigi Ricceri pag. 161 "Pietro è qui " Identificate le ossa di San Pietro pag. 165 Che fanno i ragazzi in Colonia? pag. 172 Da 50 anni i Missionari salesiani IN COPERTINA • Una delle numerose fan- lavorano nel Rio Negro fare dei collegi e oratori salesiani del Congo pag. 185 Servizio sul Congo a pag . 183 Milletrecento ragazzi francesi, belgi, svizzeri « in marcia verso Domenico » 2015 - Digital Collections - Biblioteca Don Bosco - Roma - http://digital.biblioteca.unisal.it Don Bosco ha successoreil suo sesto Alle ore 12,10 del 27 aprile scorso, una nuova mano ha impugnato il timone della Congre- gazione Salesiana. DoN LUIGI RICCERI, salutato dagli applausi cordiali dei 150 capitolari che lo avevano voluto sesto Successore di San Giovanni Bosco . In quel momento cercò inu- tilmente di dominare la sua commozione, mentre i capitolari scavalcando il protocollo si assiepavano intorno a lui per avvolgerlo in un abbraccio affettuoso e per dirgli la loro gioia «Vogliamo formare una grande famiglia » L'intensa mattinata era cominciata ai piedi del- Con questa certezza i capitolari passarono nel- l'altare . Nella nuova chiesa dell'Ateneo romano il l'aula magna per la votazione . A uno a uno giura- Rettor Maggiore uscente don Ziggiotti celebrò la rono, con la mano posata sul Vangelo, di dare il Messa per invocare l'assistenza dello Spirito Santo . voto libero e segreto a quel superiore che giudicas- Nel Vangelo lesse le parole di Gesù : « Lo Spirito sero di eleggere al cospetto di Dio . -

RSS Vol29 1996 A015 N2
ISSN 0393-3830 RICERCHE STORICHE SALESIANE RIVISTA SEMESTRALE DI STORIA RELIGIOSA E CIVILE 29 ANNO XV - N. 2 LUGLIO-DICEMBRE 1996 LAS - ROMA (29)209_216.QXD 13-03-2006 5:13 Pagina 209 RICERCHE STORICHE SALESIANE RIVISTA SEMESTRALE DI STORIA RELIGIOSA E CIVILE ANNO XV - N. 2 (29) LUGLIO-DICEMBRE 1996 SOMMARIO SOMMARI -SUMMARIES ..................................................................... 211-214 Auguri al nuovo Rettor Maggiore don Juan Edmundo Vecchi ......... 215-216 STUDI STAELENS Freddy, I salesiani di don Bosco e le lotte sociopolitiche in un’epoca di transizione (1891-1918) ..................................... 217-271 DOFF-SOTTA Giovanni, Un contributo di don Carlo Maria Baratta all’azione di riforma della musica sacra in Italia (1877-1905) 273-316 FONTI MALFAIT Daniel - SCHEPENS Jacques, «Il Cristiano guidato alla virtù ed alla civiltà secondo lo spirito di San Vincenzo de’ Paoli» ..... 317-381 NOTE BELLONE Ernesto, L’avv. Felice Masera (1885-1938), primo presi- dente nazionale degli ex-allievi salesiani d’Italia dal 1921 al 1938 383-404 RECENSIONI (v. pag. seg.) NOTIZIARIO .................................................................................... 413-414 INDICE GENERALE DELLE ANNATE 1994, 1995, 1996 ........... 415-419 (29)209_216.QXD 13-03-2006 5:13 Pagina 210 RECENSIONI José Díaz COTÁN, La Familia Salesiana en Córdoba (Noventa años de vida apo- stólica) (A. da Silva Ferreira), pp. 405-408; Hugo Pedro CARRADORE, Monte Alegre ilha do sol (A. da Silva Ferreira), pp. 408-409; Francis DESRAMAUT, Don Bosco en son temps (1815-1888) (F. Motto), pp. 409-412; Alberto GARCÍA-VERDUGO e Cipriano SAN MILLAN, Desde el Arenal al Castro 100 años de Don Bosco en Vigo 1894-1994 (A. da Silva Ferreira), pp. -

Don Bosco's Definitive Vocational Commitment (1844-1846)
Don Bosco's Definitive Vocational Commitment (1844-1846) The Year 1846, Terrible and GloriOus Arthur J. Lenti, SDB 1. Don Bosco's Vocation Decision and Dream of 1844 on Bosco, after ordination in 1841, enrolled in the Pastoral Institute of St. Francis of Assisi for Priests (Convitto ecclesiastico). Here, while Dengaged in the study of moral-pastoral theology and preaching under the direction of Father Joseph Cafasso, he first became involved in a special ministry to young people at risk. 1 He met them doing time in the city prisons, idling on the streets and squares, and working at odd jobs in various workshops. He began gathering them for religious instruction and recreation on Sundays and holy days under the auspices of the Pastoral Institute of St. Francis of Assisi. Over the three years he spent there the initial small group of youngsters grew in numbers. It became ''his Oratory." Due to leave the Pastoral Institute in the summer of 1844 Don Bosco had to face a new personal vocational crisis. Ten years earlier, toward the end of his secondary course of study in Chieri, John Bosco had entered a period of vocational crisis and discernment that lasted from the spring of 1834 to the summer of 1835. He had seriously considered joining the Franciscans, but after a period of inner struggle and uncertainty, he had followed advice and entered the diocesan seminary instead. In 1844 the vocational crisis and discernment 'Father (Saint) Joseph Cafasso (1811-1860),like Don Bosco from Castelnuovo, was ordained in 1833, attended the Pastoral Institute (Convitto), and was chosen by its founder (Father Luigi Guala) to serve as lecturer in moral theology. -

Teachings on Spiritual Life
SAINT JOHN BOSCO TEACHINGS ON SPIRITUAL LIFE An anthology Introduction and notes by Aldo Giraudo LAS – ROME Introduction Aldo GIRAUDO, sdb Which of his writings best portray Saint John Bosco as a teacher of inner life and give us, if not all of his “spiritual doctrine",1 at least the most characteristic features of his spirituality, that fertile flow of good fruits we think of as a “school of holiness valid for every state of life”?2 The question is pertinent since not only did Don Bosco, like St Alphonsus, not leave behind pages revealing the intimacy of his being; he also did not consider bringing together a systematic picture of a spirituality, as we would call it today, or an ascetica, as he would have called it in his era: a harmonious set of spiritual reflections. Certainly he gave us splendid testimonies, few and modest as they were, of the spiritual life of others. He saw them in action and was himself a concomitant factor for them: Louis Comollo, Dominic Savio, Michael Magone, Francis Besucco.3 Though in narrative form and written to edify, these documents do highlight inner experiences and essential features of Christian spirituality as proposed for young people. A study of these biographical sketches, the inner pursuits of their youthful characters, and the general atmosphere of growth and development in the educational setting, in the community which was the context in which their spiritual adventure unfolded, allows us to garner the essential features of a model of youthful holiness, and the salient principles of a vade-mecum of ascetics comparable with the Introduction to the Devout Life by St Francis de Sales. -

Newsflash - Pascua 2020 NF Pasqua 2020 SPA:Layout 1 16/04/2020 18:56 Pagina 3
NF Pasqua 2020 SPA:Layout 1 16/04/2020 18:56 Pagina 1 EEXX AALLLLIIEEVVII NNeewwssffllaasshh AÑO 9 - NÚMERO 37 - P ASCUA 2020 Sucesos actuales religiosas y periódica social de la Confederación Mundial de los Exalumnos de Don Bosco Edición española - (traducciones: Nisaury Ventura) NF Pasqua 2020 SPA:Layout 1 16/04/2020 18:56 Pagina 2 EL P. Á NGEL FERNÁNDEZ ARTIME FUE RATIFICADO COMO RECTOR MAYOR (ANS – Roma) sejo Inspectorial y Vicario Inspectorial, y del 2000 al 2006 Inspector de León. El 28º Capítulo General de la Congregación Es licenciado en Teología Pastoral, Filoso - Salesiana ratificó al P. Ángel Fernández Ar - fía y Pedagogía. time el mandato como Rector Mayor para el sexenio 2020-2026. La elección tuvo Fue miembro de la comisión técnica que lugar en la primera votación. preparó el Capítulo General 26. En 2009 fue nombrado Inspector de Argentina Sur. El P. Ángel Fernández Artime, de 59 años, En el ejercicio de su cargo como Inspector nació el 21 de agosto de 1960 en Gozón- de Argentina pudo conocer y colaborar Luanco, Oviedo; emitió la Primera Profe - personalmente con el entonces arzobispo sión Religiosa el 3 de septiembre de 1978, de Buenos Aires, Cardenal Jorge Mario realizó la Profesión Perpetua el 17 de junio Bergoglio, hoy Papa Francisco de 1984 y fue ordenado sacerdote el 4 de El 23 de Diciembre 2013 fue nombrado Su - julio de 1987. perior de la Inspectoría de España-María Auxiliadora, un encargo que nunca asumió, Originario de la Inspectoría de León, fue pues el Capítulo General 27 lo eligió como delegado de la Pastoral Juvenil, Director nuevo Rector Mayor y X Sucesor de Don del colegio de Orense, miembro del Con - Bosco. -

Don Bosco Quiz
DON BOSCO QUIZ On the 150th Anniversary of the Congregation KNOW THE SALESIAN HISTORY BETTER 1) When was the Salesian Congregation formed? 18th Dec, 1859. 2) What was, according to Don Bosco, the hallmark of the congregation? Chastity 3) When was the Salesian society approved? 19th Feb, 1869. 4) What are the things that undermine the congregation? Idleness, fastidiousness about food and a spirit of reform, undermine religious congregation. 5) When was the Constitutions of the Salesians approved? 3rd April, 1874. 6) What did Don Bosco say about the congregation during his last sickness? Our congregation is led and protected by Mary Help of Christians. 7) When did Don Bosco meet Bartholomew Garelli? 8th Dec, 1841. 8) Who is the patroness of our congregation? Mary Help of Christians. 9) What did Don Bosco say about the role of Mary in the congregation? Mary Most holy is the Foundress and will be the sustainer of our works, it is on her account that our congregation exists and prospers. We cannot make a mistake, Mary guides us. 10) Who is the patron of our congregation? St. Francis of sales. 11) In how many countries are the Salesians present? 129. 12) What is the motto of our congregation? Da mihi animas cetera tolle. 13) When was the Decretum Laudis (the decree of praise) issued for the congregation? 23rdJuly, 1864. 14) What is the website of our congregation? www. sdb. org. 15) When was the first religious profession? 14th May 1862. 16) When was Fr. Pascual Chavez elected as he Rector Major for the first time? 3rd April 2002. -

THE LIFE of YOUNG DOMINIC SAVIO, PUPIL at the ORATORY of ST FRANCIS DE SALES by Father JOHN BOSCO TURIN G
THE LIFE OF YOUNG DOMINIC SAVIO, PUPIL AT THE ORATORY OF ST FRANCIS DE SALES by Father JOHN BOSCO TURIN G. B. PARAVIA & Co. Press 1859 Table of Contents Extract from a Pastoral Letter by Archbishop Gianotti, Gioanni Antonio My Dear Boys, Chapter 1. Home - The boy’s character - His early goodness Chapter 2. Good behaviour at Murialdo - Signs of virtue - Attendance at the village school Chapter 3. His first communion - Preparation, recollection and memories of the day Chapter 4. School at Castelnuovo d’Asti - An edifying occasion - Wise answer to bad advice Chapter 5. His behaviour at school at Castelnuovo d’Asti - What his teacher had to say Chapter 6. School at Mondonio - He puts up with a great injustice Chapter 7. The first time I got to know him - Some curious moments when we met Chapter 8. He comes to the Oratory of St Francis de Sales - His approach at the beginning Chapter 9. Grammar year - Curious incidents - School - He prevents a fight - He avoids danger Chapter 10. His decision to become a saint Chapter 11. His zeal for the good of souls Chapter 12. Various episodes and his way of dealing with his friends Chapter 13. His spirit of prayer - Devotion to the Mother of God - Mary’s month Chapter 14. He goes frequently to Confession and Communion Chapter 15. Penances Chapter 16. The Immaculate Conception Sodality Chapter 17. His special friends - Relationship with young Camillo Gavio 1 Chapter 18. His relationship with young John Massaglia Chapter 19. Special graces and particular deeds Chapter 20. His thoughts about death - His preparation for a holy death Chapter 21. -

Biographical Memoirs of Saint John Bosco
The Biographical Memoirs of Saint John Bosco by GIOVANNI BATTISTA LEMOYNE, S.D.B. AN AMERICAN EDITION TRANSLATED FROM THE ORIGINAL ITALIAN DIEGO BORGATELLO, S.D.B. Editor-in-chief Volume I 1815-1840 SALESIANA PUBLISHERS, INC. NEW ROCHELLE, NEW YORK 1965 IMPRIMI POTEST: Very Rev. Augustus Bosio, S.D.B. Provincial NIHIL OBSTAT: Daniel V. Flynn, J.C.D. Censor Librorum IMPRIMATUR: * Francis Cardinal Spellman Archbishop of New York May 6, 1965 The nihil obstat and imprimatur are official declarations that a book or pamphlet is free of doctrinal or moral error. No implication is contained therein that those who have granted the nihil obstat and imprimatur agree with the contents, opinions or statements expressed. Copyright © 1965 by the Salesian Society, Inc. Library of. Congress Catalog Card No. 65-3104rev All Rights Reserved Manufactured in the United States of America FIRST EDITION Bcbttateb WITH PROFOUND GRATITUDE TO THE LATE, LAMENTED, AND HIGHLY ESTEEMED VERY REVEREND FELIX J. PENNA, S.D.B. (1904-1962) TO WHOSE WISDOM, FORESIGHT, AND NOBLE SALESIAN HEART THE ENGLISH TRANSLATION OF THE BIOGRAPHICAL MEMOIRS OF SAINT JOHN BOSCO IS A LASTING MONUMENT To The Very Reverend RENATO ZIGGIOTTI Rector Major Emeritus of the Salesian Society Editor s Preface 'AINT JOHN BOSCO, the central figure of this vastly extensiveJ &biography , was a towering person in the affairs of both Church and State during the critical 19th century in Italy. He was the founder of two very active religious congregations during a time when other orders were being suppressed; he was a trusted and key liaison between the Papacy and the emerging Italian nation of the Risorgimento; above all, in troubled times, he was the saintly Christian educator who successfully wedded modern pedagogy to Christ's law and Christ's love for the poor young, and thereby de served the proud title of Apostle of youth. -

Apostolic Consciousness of Don Bosco: a Hermeneutical-Phenomenological Approach to His Spirituality
SEMINARE t. 36 * 2015, nr 1, s. 29-45 Ks. Francis-Vincent Anthony SDB Salesian Pontifical University, Rome APOSTOLIC CONSCIOUSNESS OF DON BOSCO: A HERMENEUTICAL-PHENOMENOLOGICAL APPROACH TO HIS SPIRITUALITY 1. Introduction The term ‘spirituality’ is gaining popularity with a wide range of meanings that refer to both religious and secular aspects of life1. If Christian spirituality was once seen as intrinsically bound to monastic life, the growth and proliferation of religious congregations and secular institutes engaged in active apostolate today, have highlighted the need of integrating apostolic action and spiritual life. From the perspective of monastic spirituality, apostolic action was at times regarded as a danger to spiritual life leading to activism and dispersion. Even when apostolic action was held in positive regard, it was considered as something parallel to spiri- tual life or a means to perfection2. The dualism of contemplation and action points to other underlying dua- lisms such as sacred and profane, consecration and mission, interior experience of the divine (love for God) and exterior action in favour of the human (love for man). A closer look at the life of Christ, the apostles, and the saints of active apos- tolic life, suggests that there is an inseparable bond between the spiritual and the apostolic dimensions of Christian living. With expressions such as “ecstasy of life and action” (St. Francis de Sales), “acting passively” (St. Vincent de Paul), “give me souls, take away the rest” (St. John Bosco), some saints tried to express the mystical transformation experienced by them in their apostolic life and action3. In the contemporary context, the emergence and the progressive configura- tion of ‘spiritual theology’ as a distinct branch has brought into focus ‘God-expe- rience’, ‘religious experience’ or ‘spiritual experience’ as the core of spirituality4. -

September 2, 2018 Deacon William Vaccaro 260 Westchester Avenue Mr
Pastoral Staff/Personal Pastoral/Conselho Pastoral Rev. Patrick Angelucci, SDB, Administrator Mrs. Irma Austin, Coordinator of Religious Education Sr. Ana Maria Causa, SA, Pastoral Associate Rev. Tarcisio dos Santos, SDB, Parochial Vicar Rev. Manny Gallo, SDB, Coordinator of Youth Ministry Rev. John Grinsell, SDB, DBCC Coordinator of Salesian Mission Rev. Tomasz Grzegorzewski, SDB, Parochial Vicar Rev. Jorge Rodriguez, SDB Parochial Vicar Rev. Joseph Vien Hoang, SDB, Parochial Vicar Deacon Ivan Gemio Deacon Michael Gizzo September 2, 2018 Deacon William Vaccaro 260 Westchester Avenue Mr. Jorge Camacho, Head of Maintenance Parish Offices: 16 Washington St. Ms. Silvia Inocente, Parish Secretary Port Chester, NY 10573 Ms. Maria Massa, Parish Secretary 914-881-1400 / Fax: 914-939-2807 Mr. Michael McCarthy, Finance Office Web: Portchestercatholicchurch.org Mr. John Sullivan, Facilities Manager Trustees: Arlete C. Sasseron Pedro Villanueva Parish Office Hours Weekly Novena Horas de Oficina Escritório Aberto Every Tuesday, After all Masses Honor of Mary Help of Christians & Don Bosco Mon.-Fri./Lun.-Vie/Seg a Sexta-feira: Every Monday after 8AM Mass Miraculous Medal Novena 9:00 AM - 4:00PM Every Wednesday after the 8AM Mass Divine Mercy Chaplet Sat. / Sáb: 9:00AM - 12:00PM Baptisms / Bautismos / Batismo Register in the parish office. / Visite la rectoría. / Passe pelo escritório da igreja. Eucharistic Celebration Weddings / Bodas / Casamento Celebración / Celebraçã Contact the parish office at least six months in advance. Please come to the church before reserving your venue. Contacte la oficina de la parroquia seis meses antes. Por favor vengan a la oficina Sunday / Domingo: antes de reservar el local. English / Inglés: 7:30AM & Procure o escritório da igreja, pelo menos com 6 meses de antecedência. -

Ricerche Storiche Salesiane Rivista Semestrale Di Storia Religiosa E Civile
2015 - Digital Collections - Biblioteca Don Bosco - Roma - http://digital.biblioteca.unisal.it RICERCHE STORICHE SALESIANE RIVISTA SEMESTRALE DI STORIA RELIGIOSA E CIVILE 5 ANNO III - N. 2 LUGLIO-DICEMBRE 1984 LAS - ROMA 2015 - Digital Collections - Biblioteca Don Bosco - Roma - http://digital.biblioteca.unisal.it RICEBCHE STORICHE SALESIANE Rivista sémestrale di stòtià a cur a iosa e dell’Istituto Storico Salesiano - Roma Arino III- N.. 2 ~ Luglio - Dicembre 1984 Dirmonè: istituto Storico Salesiano Via delia Pisana, ì l l l 0 0 16 3 ROM A Abbonamento per il 1985: Italia: L. 20.000 Estero: L. 25.000 Fascicolo singolo: Italia: L. 12.000 Estero: L. 14.000 Amministrazione: . Editrice LAS (Libreria Ateneo Sa lesiano) Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 . 0 0 1 3 9 ROM A Manoscritti, corrispondenze, libri per recensione e riviste c.c.p. 57492001 intestato a: in cambio devono essere inviati Pontificio Àténeò Salesiano alla liirezione della Rivista. Libreria L.AS. 2015 - Digital Collections - Biblioteca Don Bosco - Roma - http://digital.biblioteca.unisal.it RICERCHE STORICHE SALESIANE RIVISTA SEMESTRALE DI STORIA RELIGIOSA E CIVILE ANNO III - N. 2 (5) LUGLIO-DICEMBRE 1984 SOMMARIO STUDI D ruart Albert, Le recrutement salésien en Belgique (1891-1914) . 243-273 V alsecch i Tarcisio, Le ispettorie salesiane. Serie cronologica dal l’anno 1927 al 1981 275-294 FONTI Braido Pietro, La lettera di Don Bosco da Roma del 10 maggio 1884 295-374 Ferreira Antonio da Silva, Il dialogo tra Don Bosco e il maestro Francesco Bodrato ..........................................................................................?)15-J>8>1 G uerriero Antonio, Quattro lettere di mons. Giacomo Costama gna ai missionari del Vicariato Apostolico di Méndez e Gua- laquiza (E cuador).................................................................................