Alula Rivista Di Ornitologia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
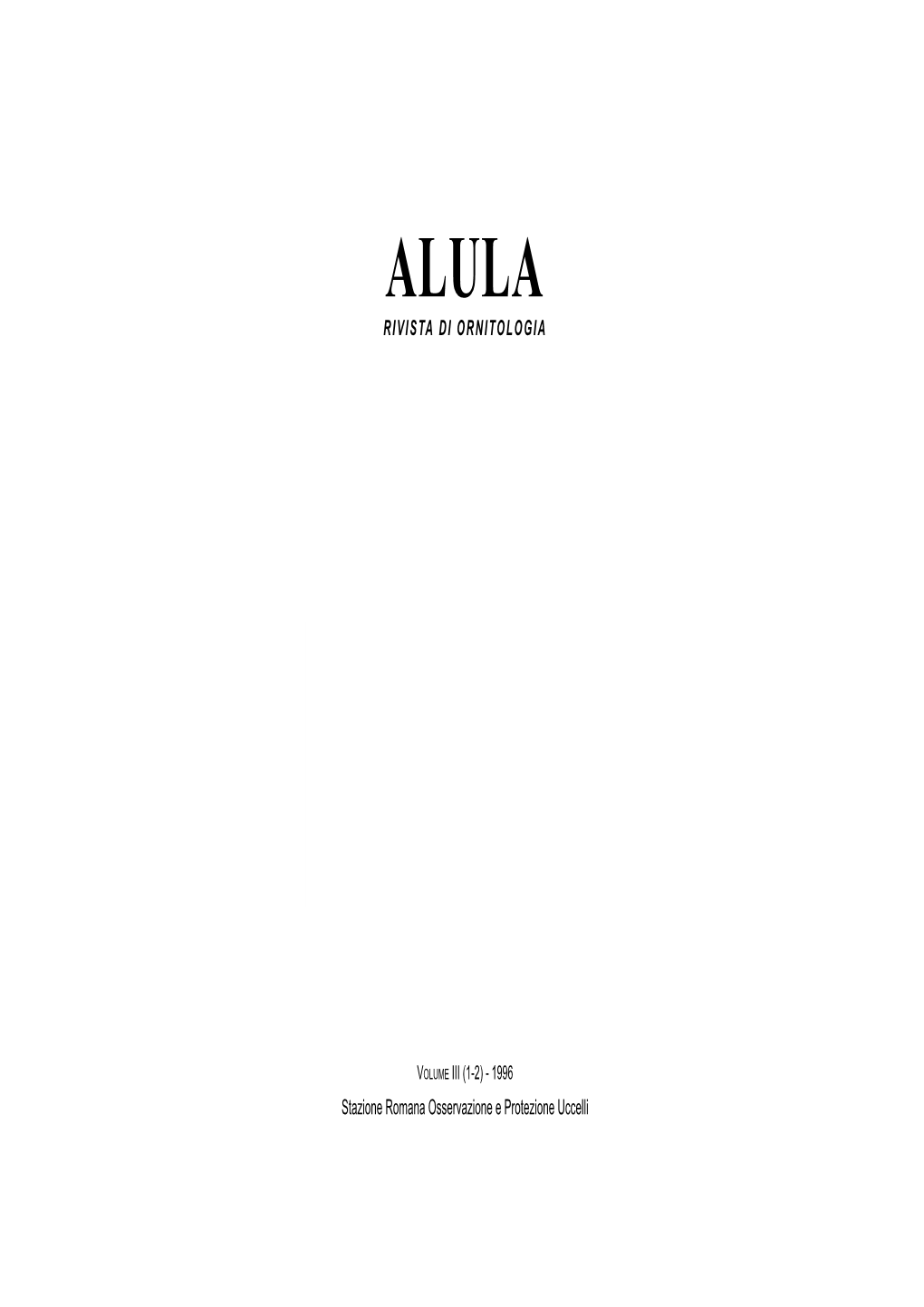
Load more
Recommended publications
-

Prog Salvaguardia E Tutela Del Parco Aurunci
PROGETTO SALVAGUARDIA E TUTELA DEL PARCO DEI MONTI AURUNCI e PARCO DEI MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia ENTE 1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il progetto (*) PARCO DEI MONTI AURUNCI SU00204 2) Denominazione e codice SU di eventuali enti di accoglienza dell’ente proponente il progetto ……………………………………… 3) Eventuali enti coprogettanti 3.a) denominazione e codice SU degli enti di accoglienza dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il progetto ……………………………………………… 3.b) denominazione e codice SU degli enti titolari di iscrizione all’albo SCU ed eventuali propri enti di accoglienza PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI - SU00347 Numero N. Sede di attuazione Comune Codice sede Nominativo Olp volontari PARCO AURUNCI Sede centrale Domenico Sepe Uff. serv. CAMPODIMELE 1 171032 2 Marzella Antonio Vigilanza e comunicazione PARCO AURUNCI CAMPODIMELE 2 Sede centrale Domenico Sepe Uff.promozione 171030 1 Tedeschi Antonio PARCO AURUNCI 3 ITRI 171043 2 Ialongo Giampaolo Vivaio del Parco Uff. patrimonio ambientale PARCO AURUNCI Soscia Fulvio 4 ITRI 171041 2 Vivaio del Parco Centro visitatori parco Antonio PARCO AURUNCI Monumento Naturale Settecannelle Mola della 5 FONDI 171019 2 Izzi Fabrizio Corte Uff. educaz. Ambientale PARCO AURUNCI Centro studi De Santis Ufficio promozione- FORMIA 6 171015 2 Buttaro Raffaele archivio dei Monti Aurunci PARCO AURUNCI SPIGNO 7 171020 4 Tarantino Marco Museo Naturalistico SATURNIA PARCO AURUNCI Palazzo Spinelli-Museo del Carsismo(percorso ESPERIA 8 171022 6 Perrella Paolo grotta carsica) 2 PARCO AURUNCI Monticelli Esperia-Uff. -
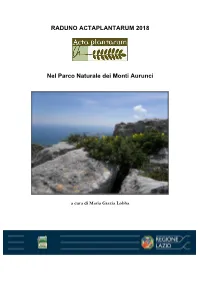
La Flora Dei Monti Aurunci Pteridophyta Aspleniaceae Asplenium Ceterach L.– MC in Quasi Tutta La Regione; Rupi, Muri, 0-1500 M Asplenium Obovatum Viv
RADUNO ACTAPLANTARUM 2018 Nel Parco Naturale dei Monti Aurunci a cura di Maria Grazia Lobba Il Parco Naturale dei Monti Aurunci Il Parco naturale dei Monti Aurunci, istituito con Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 della Regione Lazio (Art. 44, c. 1 lett. b), situato al Sud del Lazio, vanta un territorio eterogeneo, compreso in una fascia altimetrica che va dalla pianura a circa 30 metri s.l.m. fino alla quota di 1533 metri s.l.m. del Monte Petrella che si erge a poca distanza dalla costa. La catena dei Monti Aurunci possiede un misterioso fascino, segnando la conclusione del più importante sistema montuoso del Preappennino Laziale, di cui fanno parte anche i Monti Lepini e i Monti Ausoni. Gli Aurunci hanno la particolarità di essere l’unica catena montuosa laziale ad affacciarsi direttamente sul Mare Tirreno con vette che superano i 1500 metri. Il paesaggio dei Monti Aurunci regala scorci di grande suggestione; dalle cime più elevate della catena montuosa si possono scorgere le isole ponziane, il promontorio del Circeo, la Valle del Liri, i Monti del Matese e i Monti dell’Appennino abruzzese. Il paesaggio dei Monti Aurunci ha subito una lenta e graduale trasformazione dovuta alle attività antropiche che hanno prodotto opere di modifica del territorio, come ad esempio i terrazzamenti e i muri a secco, detti macere, realizzati per la coltivazione di uliveti. La millenaria presenza umana sugli Aurunci è testimoniata ancora meglio dagli antichi monasteri e dai piccoli rifugi, dai resti di dimenticate città e dall’eco di passate leggende che segnano il territorio del Parco Naturale dei Monti Aurunci. -

ANNUARIO CAI 2018 Versione
INDICE PRESENTAZIONE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Programma 2018 Per partecipare alle attività è obbligatorio venire con adeguata attrezzatura (scarponi da escursionismo impermeabili a caviglia alta, zaino da montagna 20-30 lt con cintura in vita) e abbigliamento da montagna da portare in ogni stagione (giacca a vento leggera impermeabile, maglione di pile). MONTE DATA ATTIVITÀ NOTE O GRUPPO MONTUOSO Escursionismo 14 gennaio Monte Cefalone (Sirente-Velino) Racchette da neve invernale 11 febbraio Escursionismo Tuscia 23/24/25 Escursionismo Mini campociaspole Terminillo (Monti Reatini) marzo invernale e piccozza/ramponi Riserva Naturale Monte Catillo 15 aprile Escursionismo (Tivoli) 21 maggio Escursionismo Mentorella (Monti Prenestini) Raduno regionale 10 giugno Escursionismo Gole di Celano (Sirente-Velino) Alpinismo Giovanile Lazio 16 giugno Festa Sezione CAI Roma Anniversario Fondazione 17 giugno Escursionismo Festa del CAI Roma Sezionale 15/21 luglio Campo Estivo Dolomiti 16 settembre Escursionismo P.N. Gran Sasso d’Italia 14 ottobre Escursionismo Monte Viglio (Simbruini) 11 novembre Escursionismo Parchi Regionali del Lazio Mountain-Bike Collaborazione 16 dicembre Arrampicata Sperlonga istruttori di Alpinismo N.B. Il programma potrebbe subire modifiche per motivi organizzativi o meteorologici. 25 26 DIFFICOLTÀ, DATA E MEZZO GRUPPO MONTUOSO, DISLIVELLO ACCOMPAGNATORI DI TRASPORTO PERCORSO E DURATA GENNAIO domenica 14 PNALM BLU-ROSSO De Filippi Val Fondillo - Valle Jancino - Val ↑300 m Masiello pullman Fondillo ↓300 m Di Pietro 11 km 4.30 ore sabato 20 Velino BLU-ROSSO De Filippi da Campo Felice ↑500 m Masiello auto proprie al Monte Cefalone ↓500 m Di Pietro 16 km Anelli di fondo nella piana 5.30 ore di Campo Felice BLU ↑200 m Metelli ↓200 m 10 km 4 ore domenica 21 PNALM BLU-ROSSO De Filippi da Forca d’Acero - Macchiarvana ↑380 m Masiello pullman Bosco Gravare - Rif. -

Commission Implementing Decision of 16 November 2012 Adopting A
26.1.2013 EN Official Journal of the European Union L 24/647 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 16 November 2012 adopting a sixth updated list of sites of Community importance for the Mediterranean biogeographical region (notified under document C(2012) 8233) (2013/29/EU) THE EUROPEAN COMMISSION, (4) In the context of a dynamic adaptation of the Natura 2000 network, the lists of sites of Community importance are reviewed. An update of the list of sites Having regard to the Treaty on the Functioning of the European of Community importance for the Mediterranean biogeo Union, graphical region is therefore necessary. Having regard to Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and (5) On the one hand, the update of the list of sites of flora ( 1), and in particular the third subparagraph of Article 4(2) Community importance for the Mediterranean biogeo thereof, graphical region is necessary in order to include additional sites that have been proposed since 2010 by Whereas: Member States as sites of Community importance for the Mediterranean biogeographical region within the meaning of Article 1 of Directive 92/43/EEC. For these (1) The Mediterranean biogeographical region referred to in additional sites, the obligations resulting from Articles Article 1(c)(iii) of Directive 92/43/EEC comprises the 4(4) and 6(1) of Directive 92/43/EEC should apply as Union territories of Greece, Cyprus, in accordance with soon as possible and within six years at most from the Article 1 of Protocol No 10 of the 2003 Act of Acces adoption of this Decision. -

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/159 DE LA COMISIÓN De 21
15.2.2021 ES Diar io Ofi cial de la Unión Europea L 51/187 DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/159 DE LA COMISIÓN de 21 de enero de 2021 por la que se adopta la decimocuarta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea [notificada con el número C(2021) 19] LA COMISIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Vista la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (1), y en particular su artículo 4, apartado 2, párrafo tercero, Considerando lo siguiente: (1) La región biogeográfica mediterránea a que se refiere el artículo 1, letra c), inciso iii), de la Directiva 92/43/CEE incluye los territorios, en la Unión, de Grecia, Chipre, de conformidad con el artículo 1 del Protocolo n.o 10 del Acta de adhesión de 2003, y Malta, así como partes de los territorios, en la Unión, de España, Francia, Croacia, Italia y Portugal, y, de conformidad con el artículo 355, apartado 3, del Tratado, el territorio de Gibraltar, de cuyas relaciones exteriores es responsable el Reino Unido, según se especifica en el mapa biogeográfico aprobado el 20 de abril de 2005 por el Comité creado en virtud del artículo 20 de la citada Directiva («Comité de Hábitats»). (2) La lista inicial de lugares de importancia comunitaria para la región biogeográfica mediterránea, a tenor de la Directiva 92/43/CEE, se adoptó mediante la Decisión 2006/613/CE de la Comisión (2). -

Interno Opuscolo CAI 2012 Interno Opuscolo CAI 2011
GENNAIO 2012 Domenica 8 Gennaio ACQUA DELLA FOTA-ABBAZIA DI S. STEFANO Monti Lepini Itinerario: da Fosso Sanguinetti (544 m) per Acqua della Fota (699 m) con arrivo all’Abbazia di S. Stefano (antica Abbazia di Malvisciolo, 819 m). Dislivello: 700 m Durata: sal. 3,00 h - disc. 2,00 h Difficoltà: E Dir: M. Giusti Domenica 15 Gennaio GIORNATA DELLA SICUREZZA IN MONTAGNA Manifestazione a cura del Soccorso Alpino Domenica 22 Gennaio MONTE DELLE FATE Monti Ausoni Itinerario: da Sonnino (401 m), costeggiando Mt. Ceraso si giunge alla cisterna Mareccia (749 m). Si prosegue per il versante sud di Mt. Tavanese per Fontana del Crapio (680 m). Quindi si raggiunge Serra Palombi (723 m) per poi salire dal versante ovest alla cima del Mt. Delle Fate (1090 m). Dislivello: 850 m Durata: 7,00 h Difficoltà: E Dir: F. Di Dio - S. Giancola 8 FEBBRAIO 2012 Domenica 13 Febbraio GROTTE DI COLLEPARDO E POZZO D’ANTULLO Monti Ernici Itinerario: da Collepardo si raggiunge Pozzo d’Antullo. Visita alle Grotte di Collepardo e quindi, per il sentiero della transumanza si raggiunge Ponte dei Santi. Dislivello: 100 m Durata: 2,00 h Difficoltà: T ˃ o Dir: M. Fiocco Domenica 19 Febbraio CIASPOLATA A PRATI DI MEZZO Monti della Meta Itinerario: da Prati di Mezzo (1410 m) per Sella della Cicogna (1750 m) fino a Fonte Fredda (1681 m). Ritorno per la stessa via. Dislivello: 400 m Durata: 3,30 h Difficoltà: EAI ˃ Pranzo: Polentata al ristorante Dir: P. Leonoro - S. Giancola 9 MARZO 2012 Domenica 4 Marzo ARCHEO TREK: CASTELLO DI MONTE ACUTO (e altri) Monti Lepini Itinerario: percorso alla riscoperta dei castelli medievali, per ricostruire la storia e le tradizioni delle zone del Frusinate. -

Programma Attività 2021
Corsi e Incontri di Cultura e del Sapere Biblioteca In sede è possibile consultare la biblioteca, ricca di manuali Nell’arco dell’anno saranno organizzati eventi inerenti la tecnici, monografie, romanzi e riviste inerenti la montagna. cultura montana e del territorio, con presentazione di La biblioteca offre i seguenti servizi: C libri, videoproiezioni, incontri etc. I dettagli degli eventi * consultazione - tutti i libri sono consultabili in sede saranno di volta in volta resi disponibili sul sito web e contattando il referente della biblioteca (servizio disponibile A nella bacheca della sezione. Con lo scopo di fornire le anche per i non soci CAI); basi per una corretta e sicura fruizione escursionistica * e/o alpinistica dell’ambiente montano, si organizzano prestito - i soci CAI possono usufruire del prestito libri alle I serate nelle quali si approfondiscono le tematiche più condizioni riportate nello specifico regolamento; * acquisto - sia i soci che i non soci CAI possono acquistare i diverse: dalla natura al rispetto della montagna, dalla sicurezza in parete al comportamento da tenere in libri in corso di edizione o disponibili in più copie. E ambiente innevato. I titoli dei libri disponibili sono pubblicati sulla pagina “Biblioteca” del sito web sezionale. S Videoproiezioni in Programma Manutenzione Sentieri SPELEOLOGIA P Nella pagina “Sentieri e Mappe” del nostro sito web sono La Grotta Segreta di Ulisse disponibili le tracce dei sentieri dei Monti Aurunci, contrassegnati Club Alpino Italiano AMBIENTE con la numerazione CAI dal n.906 al n. 980. Sono i sentieri a E The Dark Side of Mountain cui la Sezione CAI di Esperia provvede alla manutenzione e alla Sezione di Esperia segnatura. -

Il Progetto Life Go Park È Tra Gli 11 Progetti Approvati Nel 2012
l progetto Life Go Park è tra gli 11 progetti approvati nel 2012 Idalla CE nell’ambito del programma LIFE+ Informazione e comu- nicazione, che sostiene e co-finanzia progetti di eccellenza relativi alle campagne di comunicazione e di sensibilizzazione sulle temati- che ambientali e sulla protezione della biodiversità. Lo scopo del progetto è di migliorare la conoscenza delle Aree Na- turali Protette del Lazio da parte dei cittadini, rendendoli consape- voli dell’importanza di una interazione responsabile tra uomo e na- tura e della necessità di conservare l’ambiente in cui viviamo e la sua biodiversità. Le Aree Protette della Regione Lazio, anche tramite il progetto “Life Go Park”, offrono una serie di iniziative per fruire consapevolmen- te del territorio. Questi eventi, oltre a mostrare le caratteristiche degli habitat e le azioni prodotte dalle Aree Protette per la conservazione e la tute- la della biodiversità, mirano essenzialmente a dar modo ai cittadini di esercitare una “fruizione consapevole” e insieme emozionale per godere appieno delle peculiarità naturalistiche e storiche presen- ti nella Regione Lazio. D’altronde non si può tutelare ciò che non si conosce e si tutela ancora meglio quando c’è un legame emoziona- le con il territorio stesso. Questo opuscolo, realizzato in collaborazione con il progetto “Gior- niverdi” dell’Agenzia Regionale per i Parchi del Lazio, dà la possibili- tà di scegliere tra numerose escursioni che le Aree Protette regiona- li hanno calendarizzato tra il 25 aprile e il 27 settembre. Sono state pubblicate anche molte escursioni realizzate al di là del progetto “Life Go Park” per offrire un’informazione comunque più ampia possibile ai cittadini del Lazio. -

“Consolidare Lo Sviluppo Delle Aree Rurali Del Lazio”
ASSESSORATO PER LE POLITICHE DELL’AGRICOLTURA DIPARTIMENTO SVILUPPO AGRICOLO E MONDO RURALE Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 per “CONSOLIDARE LO SVILUPPO DELLE AREE RURALI DEL LAZIO” in attuazione del Reg. CE n.1257/99 ALLEGATI AL PIANO GIUGNO 2000 Allegato n.1 Buona Pratica Agricola normale Piano di Sviluppo Rurale – Reg. (CE) 1257/99 BUONA PRATICA AGRICOLA NORMALE (BPAn) PREMESSA: Il Regolamento CE n.1257/99 stabilisce che gli impegni agroambientali e le indennità compensative debbano tenere conto delle ordinarie pratiche agricole che sono individuate come “…l’insieme dei metodi colturali che un agricoltore diligente impiegherebbe in una regione interessata”. Infatti tutte le misure agroambientali (misura III.1) devono prevedere impegni che oltrepassano la buona pratica agricola “normale” (art. 23, comma 2, del Reg. CE n. 1257/99) mentre gli agricoltori che ricevono l’indennità compensativa in quanto operanti in zone svantaggiate (misura III.2) sono tenuti ad osservare almeno le buone prat iche agricole consuete (art. 14 del Reg. CE n. 1257/99). Di conseguenza gli agricoltori che assumono impegni agroambientali ricevono un premio calcolato facendo riferimento alla buona pratica agricola normale (art. 17 del Reg. CE n. 1750/99) e sono tenu ti a rispettare sull’intera azienda le buone pratiche agricole normali anche se l’impegno è limitato a parte di essa. Il presente documento, in conseguenza, definisce in maniera analitico-descrittiva la “buona pratica agricola normale” (BPAn) ossia gli impegni di base che l’agricoltore sottoscrive ed è tenuto ad osservare, per l’insieme delle superfici aziendali, qualora richiede di usufruire del regime di aiuti previsto nell’ambito della misura F (III.1) “agroambiente” nonché per beneficiare delle in compensative di cui alla misura E (III.2) “ zone svantaggiate”, del presente Piano di Sviluppo Rurale. -

Commission Implementing Decision
15.2.2021 EN Offi cial Jour nal of the European Union L 51/187 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2021/159 of 21 January 2021 adopting the fourteenth update of the list of sites of Community importance for the Mediterranean biogeographical region (notified under document C(2021) 19) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (1), and in particular the third subparagraph of Article 4(2) thereof, Whereas: (1) The Mediterranean biogeographical region referred to in Article 1(c)(iii) of Directive 92/43/EEC comprises the Union territories of Greece, Cyprus, in accordance with Article 1 of Protocol No 10 of the 2003 Act of Accession, and Malta, parts of the Union territories of Spain, France, Italy, Portugal and Croatia, and, in accordance with Article 355(3) of the Treaty, the territory of Gibraltar, for which the United Kingdom is responsible for external relations, as specified in the biogeographical map approved on 20 April 2005 by the committee set up by Article 20 of that Directive (the ‘Habitats Committee’). (2) The initial list of sites of Community importance for the Mediterranean biogeographical region, within the meaning of Directive 92/43/EEC, was adopted by Commission Decision 2006/613/EC (2). That list was last updated by Commission Implementing Decision (EU) 2020/96 (3). (3) The sites included in the lists of Community importance for the Mediterranean biogeographical region form part of the Natura 2000 network which is an essential element of the protection of biodiversity in the Union. -

Impaginato Ok Layout 1
Club Alpino Italiano Sezione di Monterotondo “Il Ginepro” Programma 2017 Sede e Punto Informativo Via di Francesco Via dell’Unione 113 - Monterotondo www.caimonterotondo.it - [email protected] SALUTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Caro lettore, se sfogli le pagine di questo opuscolo avrai di sicuro attrazione per la montagna, per la frequentazione del suo meraviglioso ambiente e probabilmente…sarai già nostro Socio. In ogni caso, per conoscere quali sono le attività della giovane Sezione di Monterotondo e gli intenti che la regolano, è opportuno comprendere in breve cosa è il Club Alpino Italiano. Il Club Alpino Italiano è un’Associazione con una storia di oltre 150 anni, la prima co- stituita nell’Italia unita il 23 ottobre 1863 da Quintino Sella. Come recita l’articolo 1 dello Statuto, “ha per scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale”. Dal- l’enunciato, il C.A.I. organizza attività di tipo: alpinistico, escursionistico e speleologico; di gestione di relativi corsi d’addestramento e formazione; di realizzazione e di manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche; di promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano nonché di ogni iniziativa idonea alla sua protezione e valorizzazione. Un panorama d’attività alle quali si aggiunge la realizzazione, la manutenzione e la gestione dei rifugi alpini e di bivacchi d’alta quota. Ne sono autori i Soci, riuniti in Sezioni coordinate da raggruppamenti regionali. I numeri del C.A.I. a livello nazionale, aggiornati al dicembre 2015, indicano la capillare diffusione sul territorio: 307.070 Soci, 503 Sezioni, 21 gruppi regionali. -

PROGRAMMA ATTIVITÀATTIVITÀ Relativa Segnalazione Agli Enti Interessati
Corsi e Incontri di Cultura e del Sapere Alcuni Consigli Pratici Nell’arco dell’anno saranno organizzati eventi inerenti la Andare in montagna senza conoscerla e senza essere PROGRAMMA CULTURALE cultura montana e del territorio, con presentazione di preparati vuol dire esporsi a gravi pericoli, rinunciando alla 12/01/2019 libri, videoproiezioni, incontri etc. I dettagli degli eventi possibilità di scoprire gioie e segreti affascinanti. La sicurezza e le tecniche sulle vie ferrate saranno di volta in volta resi disponibili sul sito web e Scegliete itinerari alla vostra portata nella bacheca della sezione. Con lo scopo di fornire le Dite sempre dove andate Febbraio 2019 basi per una corretta e sicura fruizione escursionistica Sappiate rinunciare, la montagna è sempre là I Sentieri e la Storia. Il passaggio della linea e/o alpinistica dell’ambiente montano, si organizzano Informatevi sulle previsioni atmosferiche Gustav sugli Aurunci serate nelle quali si approfondiscono le tematiche più diverse: dalla natura al rispetto della montagna, dalla Per tutte le escursioni è opportuno disporre di attrezzatura 23/02/2019 sicurezza in parete al comportamento da tenere in adatta: scarponcini da trekking, pantaloni caldi e comodi, I Racani verso i 4000 ed oltre ambiente innevato. giacca a vento (ottime quelle in gore-tex), maglione, guanti e cappello (sia in estate che in inverno), lampada frontale, 09/03/2019 coltellino, accendino, piccolo kit-pronto soccorso, acqua e Premiazione Bando Cultura Tutela Ambiente Montano viveri di conforto, maglia e calze di ricambio, telo termico Il CAI è attento a Club Alpino Italiano preservare e conservare Grado Difficoltà In sede è possibile consultare la biblioteca, ricca di Sezione di Esperia l’immenso patrimonio T = Turistica E = Escursionistica (sentieri evidenti con manuali tecnici, monografie, romanzi e riviste inerenti presente nelle montagne, dislivelli fino a circa 800 m) EE = Escursionisti Esperti la montagna.