Dopo La Morte Dell'io
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Gli Occhiali D'oro and the Dynamics of the Encouter Between Fiction And
26. «SE QUESTO MATRIMONIO … S’HA DA FARE» Gli occhiali d’oro and the Dynamics of the Encounter Between Fiction and Film 1 Cristina Della Coletta Via, dunque, giù, giù, tristo fantoccio odioso! Annegato, là, come Mattia Pascal! Una volta per uno! Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal Giorgio Bassani’s much-cited piece entitled Il giardino tradito – a firm prise de position against Vittorio De Sica’s adaptation of Il giardino dei Finzi Contini – has often obfuscated Bassani’s other reflections on the practice of cinematic adaptation. Bassani was neither dismissive of cin- ema as an art form nor fundamentally opposed to the transposition of novels into films. In fact, he displayed a keen and sustained interest in film, and collaborated in various ways with directors such as Mario Sol- dati, Michelangelo Antonioni, Alessandro Blasetti, Luigi Zampa, and Luchino Visconti 2. Author and co-author of «a dozen» of screenplays (some with Pier Paolo Pasolini), Bassani also wrote essays on film and film reviews 3. References to movie houses, actors, and films pepper 1 The ‘edited’ quotation from Manzoni is Bassani’s own (1966c, 65). 2 Bassani wrote and co-wrote numerous screenplays, including: Le avventure di Mandrin (1952, directed by Mario Soldati), Villa Borghese (1953, directed by Gianni Francolini), La provinciale (1953, directed by Mario Soldati), Il ventaglio (1954, an epi- sode directed by Mario Soldati in the filmQuesta è la vita), Casa d’altri (1954, an episode directed by Alessandro Blasetti in the film Tempi nostri), La mano dello straniero (1954, directed by Mario Soldati), La romana (1954, directed by Luigi Zampa), La donna del fiume (1954, directed by Mario Soldati), Senso (1954, directed by Luchino Visconti), Il prigioniero della montagna (1955, directed by Luis Treniker), and Teresa Étienne (1958, directed by Denys de la Patellière). -

“Cartevive”: Indice Dei Nomi 2018
“Cartevive”: indice dei nomi 2018 Le cifre indicano, nell’ordine, numero (in corsivo) e pagina (in tondo), le parentesi quadre che il nome non è esplicitamente citato nel testo. A Prato Giovanni 57 . 102 Alberti Francesco 57 . 150, 151 Abano Terme (Padova) 57 . 86 Albertine ( personaggio di Marcel Abbagnano Nicola 57 . 83 Proust) 57 . 48 Aberdam Renée 57 . 130 Albertini Carlo 57 . 130 Abraham Karl 57 . 82 Albio ( personaggio di Orazio) 57 . Accademia di Santa Cecilia, Roma 142 57 . 30 Albione 57 . 107 Accademia Italo-Russa ‘Sapientia Albisani Sauro 57 . 122 et Scientia’, Roma 57 . 121 Albonico Simone 57 . 123 Accademia Roveretana degli Albrighi Piero 57 . 130 Agiati 57 . 102 Alce Nero 57 . 107 Acquaviva Giovanni 57 . 130 Alcione (editore), Trieste 57 . 75 Actes Sud (editore), Arles 57 . 11 Aleksievič Svetlana 57 . 122 Ad Flexum (associazione cultura- Aleramo Sibilla 57 . 82, 111 le) 57 . 151 Algeria 57 . 38, 41, 66 Adelphi (editore), Milano 57 . 3, Alice ( personaggio di Lewis Car- 108, 142 roll) 57 . 10 Afribo Andrea 57 . 123 Alighieri Dante 57 . 71 Afrodite 57 . 55 “Allegoria” 57 . 90 Agamben Giorgio 57 . 99 Allegri Mario 57 . 103 Agliati Mario 57 . 85 Allenbach Beat 57 . 124 Agliati Ruggia Mariangela 57 . Alonge Giaime 57 . 98 136, 147, 148 Alpi 57 . 82 Agnelli Umberto 57. 138 Ambrosi Alfredo Gauro 57 . 130 Agnini Stefano 57 . 109 Ambrosioni Dalmazio 57 . 84, 85 Agorà Factory (editore), Dueville Amendola Giovanni 57 . 18, 20, (VI) 57 . 87 31, 93 Albano Mario 57 . 130 America 57 . 88, 104 Albenga (Savona) 57 . 108 Amerio Romano 57 . 85 Albert-Birot Pierre 57 . -

Cuadernos Hispanoamericanos
„ Cuadernos Hispanoamericanas 1 L^r ^ n 532 Eduardo Rosenzvaig El Chaco: Una física de los espacios monstruosos Rafael Gutiérrez Girardot Los Ditirambos de Dyonisos de Nietzsche José Miguel Oviedo La poesía peruana actual Ana María Diez y Jesús Díaz Armas La Epístola satírica y censoria de Quevedo Textos sobre Borges, Onetti, Machado, Miguel Hernández, Julián Ríos, Luis Landero, Benedetti y Juan Gelman Cuadernos anoamencanos iir "-— HAN DIRIGIDO ESTA PUBLICACIÓN Pedro Laín Entralgo Luis Rosales José Antonio Maravall DIRECTOR Félix Grande SUBDIRECTOR Blas Matamoro REDACTOR JEFE Juan Malpartida SECRETARIA DE REDACCIÓN María Antonia Jiménez SUSCRIPCIONES Maximiliano Jurado Teléf.: 583 83 96 REDACCIÓN Instituto de Cooperación Iberoamericana Avda. de los Reyes Católicos, 4 - 28040 MADRID Teléfs.: 583 83 99 - 583 84 00 - 583 84 01 DISEÑO Manuel Ponce IMPRIME Gráficas 82, S.L. Lérida, 41 - 28020 MADRID Depósito Legal: M. 3875/1958 ISSN: 00-11250-X - ÑIPO: 028-94-003-9 fnigpanoamcricanog) 532 Invenciones y ensayos 7 El Chaco: una física de los espacios monstruosos EDUARDO ROSENZVAIG 31 La Epístola satírica y censoria de Quevedo ANA MARÍA DÍEZ BENÍTEZ JESÚS DÍAZ ARMAS 45 Las trampas JUAN GRACIA ARMENDÁRIZ 53 Padres pródigos e hijos fecundos JOSÉ MIGUEL OVIEDO 69 Los Ditirambos de Dyonisos de Nietzsche RAFAEL GUTIÉRREZ GIRARDOT 85 Los poemas del padre ALEJANDRO LÓPEZ ANDRADA 7 X La muerte silenciada JOSÉ MARTÍNEZ HERNÁNDEZ Lecturas 109 En defensa de un rescate FRANCISCO JOSÉ CRUZ PÉREZ 532 /Hispanoamericanos) 115 Historia y leyenda del cante flamenco JOSÉ MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 118 Cuentos de Juan Carlos Onetti EDUARDO TIJERAS 121 Julián Ríos y Eduardo Arroyo: transformaciones para Alicia NILO PALENZUELA 123 Reedición de Morínigo FRANCISCO MORENO FERNÁNDEZ 126 Antonio Machado hoy, siempre y todavía JOSÉ CARLOS MAINER 130 La estética de Luis Landero LUIS BELTRÁN ALMERÍA 133 La narrativa breve de Mario Benedetti NELSON MARRA 138 Nueva crítica sobre Miguel Hernández RAMÓN F. -

Saverio Strati Voce Di Un Sud Umile E Dignitoso
@Documento elettronico rilasciato per uso personale. DRM - 08b4908d2f8c6298573218d6ac83f01a77f7f2bc40ad9d8285f42f6029593b8b963f72125731019fea271b8b873f6b39112e8d57767e5ea5378b2cdf6b9852b9 SABATO 12 APRILE 2014 LA SICILIA ggi Cultura .23 IL PREMIO LETTERARIO MORTA LA SCRITTRICE INGLESE I 12 in gara per lo «Strega» Townsend, «madre» di Adrian Mole Il Comitato direttivo del Premio Strega presieduto da Tullio De Mauro (nella foto) ha È morta a 68 anni Sue Townsend, la scrittrice britannica creatrice del personaggio selezionato i dodici libri in gara nel 2014. «Abbiamo constatato una qualità alta e di Adrian Mole, al centro di numerosi romanzi e di serie televisive. Si è spenta a l’emergere di temi legati sia alla ricostruzione storica sia ai dilemmi della nostra coscienza seguito di una breve malattia. Townsend aveva perso la vista negli anni ‘80 a di fronte al mondo contemporaneo» spiega De Mauro. «Abbiamo anche alcune novità: un causa del diabete. Divenne celebre nel 1982 dopo la pubblicazione del romanzo graphic novel e forme letterarie sperimentali». Ecco i libri candidati: «Non dirmi che hai «Il diario segreto di Adrian Mole, Anni 13 e 3/4», sulla tribolazioni, i sogni e le paura» (Feltrinelli) di Giuseppe Catozzella, presentato da Giovanna Botteri e Roberto delusioni di un adolescente. Considerato l’enorme successo del primo volume, ha Saviano; «Lisario o il piacere infinto delle donne» (Mondadori) di Antonella Cilento (Nadia continuato a scrivere la vita di Adrian Mole, rappresentandola fino all’età adulta, Fusini e Giuseppe Montesano); «Bella mia» (Elliot) di Donatella Di Pietrantonio (Antonio in molti altri volumi. Oltre a parlare della vita di Adrian, Townsend descrisse la Debenedetti e Maria Ida Gaeta); «Una storia» (Coconino Press) di Gipi (Nicola Lagioia e situazione sociale e politica in Gran Bretagna, con particolare riferimento alla Sandro Veronesi); «Come fossi solo» (Giunti) di Marco Magini (Maria Rosa Cutrufelli e Piero sinistra politica negli anni ottanta, nell’epoca thatcheriana. -

Bibliografia 2018
BIBLIOGRAFIA 2018 L E G G E R E I L P A E S A G G I O A cura di Fondazione Benetton Studi Ricerche AIB Veneto Leggere per Leggere 1 TERRE ALTE In montagna con l’Orsa Lucia, Antonella Abbatiello, Emme Edizioni BPE Compagno orsetto, Mario Rigoni Stern, Einaudi ragazzi BGE V Milo e il segreto del Karakorum, Enrico Brizzi – Luca Caimmi, Laterza BGE Luì e l’arte di andare nel bosco, Luigi Mainolfi – Guido Quarzo, Hopefulmonster BPE Il bosco racconta, Sabina Colloredo, Einaudi Ragazzi BGE V L’uomo montagna, Séverine Gauthier e Amélie Fléchais, Tunué RGR Il segreto del bosco vecchio, Dino Buzzati, Mondadori RGE V Storie del bosco antico, Mauro Corona, Mondadori RGE V La via di Schenèr, Matteo Melchiorre, Marsilio NGE V Le otto montagne, Paolo Cognetti, Einaudi NGE V Paesi Alti, Antonio G. Bortoluzzi NPE V Neve, cane, piede, Claudio Morandini, Exorma NPE La via del sole, Mauro Corona, Mondadori NGE V Razzo rosso sul Nanga Parbat, Reinhold Messner, Corbaccio NPE Sulla traccia di Nives, Erri De Luca, Feltrinelli NGE Montagne. Avventura, passione, sfida, AA VV, Lit NPE La pelle dell’orso, Matteo Righetto, Guanda NGE V La montagna volante, Christoph Ransmayr, Feltrinelli NGE … E se la vita continua, Cesare Maestri, Dalai NGE Segreto Tibet, Fosco Maraini, Corbaccio CPE La grande parete, Giuseppe Mazzotti, Nuovi Sentieri Editore CPE V Le due chiese, Sebastiano Vassalli, Bur CGE Montagne di una vita, Walter Bonatti, Rizzoli CGE I miracoli di Val Morel, Dino Buzzati, Mondadori CGE V La montagna incantata, Thomas Mann, Corbaccio CPE 2 CHIARE, FRESCHE -

Omaggio a Italo Calvino
Italo Calvino 1 Omaggio a Italo Calvino Torino, 13 febbraio - 24 marzo 2016 OMAGGIO A ITALO CALVINO `eun progetto che nasce nel giugno del 2015 da un’Idea di Ocra Lab idee per comunicare, Impresa culturale torinese di Cristina Ballerini, e che viene presentato alla Citt`adi Torino Biblioteche Civiche e alla Regione Piemonte, Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali, insieme all’Associazione d’Arte e Cultura Leon Battista Alberti alla vigilia della ricorrenza del trentennale dalla scomparsa del grande scrittore, con l’obiettivo di realizzare un Programma di iniziative culturali a lui dedicate, aventi come cifra comune la PLURALITA’, di linguaggi e di territori, e il luogo BIBLIOTECA ad ospitare e promuovere tutti gli eventi per continuare, o tornare a essere, punto di riferimento per la ’comunit`adel libro’ per la sua funzione di presidio alla LETTURA, luogo di democrazia e libert`a,principi dai quali ITALO CALVINO fu sempre animato. L’ADESIONE di SANREMO E TORINO, che condividono il progetto, vuole essere un ulteriore OMAGGIO, in quanto citt`achiave per la sua formazione e maturit`a,di pensiero e scrittura. Da questo embrione `enato il PROGRAMMA di iniziative inaugurate il 19 settembre 2015 con EVENTI E LETTURE AD ALTA VOCE organizzate nelle due citt`apartner, che prosegue fra febbraio e marzo con MOSTRE, SPETTACOLI, LETTURE, grazie al sostegno della Regione Piemonte e con le Part- nership di Citt`adi Torino Biblioteche Civiche, Comune di Sanremo, Biblioteca Civica F. Corradi e Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori. Gli eventi verranno ospitati nella Rete delle Biblioteche torinesi e nel la casa del Quartiere di San Salvario. -
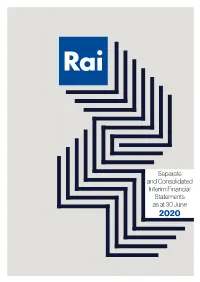
Separate and Consolidated Interim Financial Statements As at 30 June 2020
Separate and Consolidated Interim Financial Statements as at 30 June 2020 Separate and Consolidated Interim Financial Statements as at 30 June 2020 Contents 7 Introduction 17 Report on Operations 171 Interim Separate Financial Statements as at 30 June 2020 239 Interim Consolidated Financial Statements as at 30 June 2020 303 Corporate Directory 4 Contents Introduction 7 Corporate Officers 8 Organisational Structure 9 Introduction from the Chairman of the Board of Directors 11 Financial Highlights 12 Report on Operations 17 Mission 18 Market scenario 18 The Rai Group 24 Television 41 Radio 97 RaiPlay and Digital 107 Public broadcasting service function 116 TV production 119 Technological activities 120 Transmission and distribution activities 129 Sales activities 130 Other activities 135 Changes in the regulatory framework 143 Corporate governance 148 Corporate Governance Report - the Rai Control Governance Model and the Internal Control and Risk Management System (SCIGR) 150 Other information 155 Human Resources and Organisation 155 Safety & Security 159 Intercompany Relations 161 Significant events occurring after 30 June 2020 168 Outlook of operations 168 5 Interim Separate Financial Statements as at 30 June 2020 171 Analysis of the results and performance of operating results, financial position and cash flows for the first half of 2020 172 Financial Statements of Rai SpA 186 Notes to the Interim Separate Financial Statements as at 30 June 2020 191 Certification pursuant to article 154-bis of Italian Legislative Decree 58/98 235 Independent -

Luca Clerici APPARIZIONE E VISIONE. VITA E OPERE DI ANNA MARIA ORTESE A
Luca Clerici APPARIZIONE E VISIONE. VITA E OPERE DI ANNA MARIA ORTESE A. Mondadori, Milano 2002. Il 2002 è stato l’anno editoriale delle biografie di due donne solitarie, appartenute al Novecento e in fuga dal Novecento: Cristina Campo e Anna Maria Ortese. Della prima ci siamo occupati con un’intervista a Cristina De Stefano, autrice di Belinda e il mostro. Vita segreta di Cristina Campo pubblicata da Adelphi. Della seconda, Apparizione e visione. Vita e opere di Anna Maria Ortese, edita da Mondadori, è autore Luca Clerici, un’esegeta della scrittrice, a cui si deve anche una preziosa antologia degli scritti di viaggio, La lente scura (Milano, Marcos y Marcos, 1991). Clerici è uno studioso audace, e come gli audaci ha avuto dalla sua parte la fortuna, che gli ha permesso di recuperare e leggere oltre settecentocinquanta lettere autografe, che si riferiscono ai diversi e lontani periodi della sua vita. Dagli anni napoletani, quando giovinetta frequenta Palazzo Filomarino di casa Croce, agli anni romani e veneziani, ospite di Paola Masino e dello scrittore Massimo Bontempelli, che le apre le porte della letteratura, favorendo la pubblicazione di Angelici dolori. Dall’amicizia con Pasquale Prunas e con i giovani scrittori napoletani (Compagnone, La Capria) riuniti attorno alla rivista «Sud», alle prime apparizioni milanesi, dove incontra Quasimodo e la danzatrice Maria Cumani, Elio Vittorini e Alfonso Gatto. Queste lettere, che formano una mappa labirintica, permettono a Clerici di ricostruire minuziosamente il reticolo fittissimo dei suoi spostamenti, da una città a un’altra, dei rapporti burrascosi con i suoi editori, con gli altri scrittori; le moltissime incomprensioni, i disagi, i tormenti di un’anima inquieta e vagabonda, che la vita umilia, esacerba, mette in ginocchio. -

Il Castellet 'Italiano' La Porta Per La Nuova Letteratura Latinoamericana
Rassegna iberistica ISSN 2037-6588 Vol. 38 – Num. 104 – Dicembre 2015 Il Castellet ‘italiano’ La porta per la nuova letteratura latinoamericana Francesco Luti (Universitat Autònoma de Barcelona, España) Abstract This paper seeks to recall the ‘Italian route’ of the critic Josep Maria Castellet in the last century, a key figure in Spanish and Catalan literature. The Italian publishing and literary worlds served as a point of reference for Castellet, and also for his closest literary companions (José Agustín Goytisolo and Carlos Barral). All of these individuals formed part of the so-called Barcelona School. Over the course of at least two decades, these men managed to build and maintain a bridge to the main Italian publishing houses, thereby opening up new opportunities for Spanish literature during the Franco era. Thanks to these links, new Spanish names gained visibility even in the catalogues of Italian publishing houses. Looking at the period from the mid- 1950s to the end of the 1960s, the article focuses on the Italian contacts of Castellet as well as his publications in Italy. The study concludes with a comment on his Latin American connections, showing how this literary ‘bridge’ between Barcelona and Italy also contributed to exposing an Italian audience to the Latin American literary boom. Sommario 1. I primi contatti. – 2. Dario Puccini e i nuovi amici scrittori. – 3. La storia italiana dei libri di Castellet. – 4. La nuova letteratura proveniente dall’America latina. Keywords Literary relationships Italy-Spain. 1950’s 1960’s. Literary criticism. Spanish poetry. Alla memoria del Professor Gaetano Chiappini e del ‘Mestre’ Castellet. -

History and Emotions Is Elsa Morante, Goliarda Sapienza and Elena
NARRATING INTENSITY: HISTORY AND EMOTIONS IN ELSA MORANTE, GOLIARDA SAPIENZA AND ELENA FERRANTE by STEFANIA PORCELLI A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Comparative Literature in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York 2020 © 2020 STEFANIA PORCELLI All Rights Reserved ii Narrating Intensity: History and Emotions in Elsa Morante, Goliarda Sapienza and Elena Ferrante by Stefania Porcell i This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in Comparative Literature in satisfaction of the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy. ________ ______________________________ Date [Giancarlo Lombardi] Chair of Examining Committee ________ ______________________________ Date [Giancarlo Lombardi] Executive Officer Supervisory Committee: Monica Calabritto Hermann Haller Nancy Miller THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK iii ABSTRACT Narrating Intensity: History and Emotions in Elsa Morante, Goliarda Sapienza and Elena Ferrante By Stefania Porcelli Advisor: Giancarlo Lombardi L’amica geniale (My Brilliant Friend) by Elena Ferrante (published in Italy in four volumes between 2011 and 2014 and translated into English between 2012 and 2015) has galvanized critics and readers worldwide to the extent that it is has been adapted for television by RAI and HBO. It has been deemed “ferocious,” “a death-defying linguistic tightrope act,” and a combination of “dark and spiky emotions” in reviews appearing in popular newspapers. Taking the considerable critical investment in the affective dimension of Ferrante’s work as a point of departure, my dissertation examines the representation of emotions in My Brilliant Friend and in two Italian novels written between the 1960s and the 1970s – La Storia (1974, History: A Novel) by Elsa Morante (1912-1985) and L’arte della gioia (The Art of Joy, 1998/2008) by Goliarda Sapienza (1924-1996). -

{Dоwnlоаd/Rеаd PDF Bооk} the Place (Italian) Kindle
THE PLACE (ITALIAN) Author: Gary M Douglas Number of Pages: 164 pages Published Date: 15 Sep 2014 Publisher: Access Consciousness Publishing Company Publication Country: none Language: Italian ISBN: 9781939261939 DOWNLOAD: THE PLACE (ITALIAN) The Place (Italian) PDF Book In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. ), Saint Cyprian (Bishop of Carthage. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such historical works. Protagonista assoluto della storia è l'irresistibile burattino dal naso lungo, nel difficile tentativo di superare mille difficoltà e trasformarsi in un bambino vero. Das Standardwerk ein Muss für jeden, der Italien und seine Küche liebt. The Place (Italian) Writer Nuova edizione aggiornata. Da leggere ai propri figli nei momenti di più profonda intimità e amorevole vicinanza. Pietro Sino Ai Nostri Giorni. B 1. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. O conosci qualcuno che è stato nel peggior scenario. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. Immagina una vita in cui amate il modo in cui si guarda e si sente. -

Cas Li 306 Venetian Landscapes: a Contemporary Grand Tour
CAS LI 306 VENETIAN LANDSCAPES: A CONTEMPORARY GRAND TOUR Co-taught by Prof. Elisabetta Convento and Prof. Laura Lenci Office Hours: Two hours per week (TBD) or by appointment Office: BU Padua, Via Dimesse 5 – 35122 Padova (Italy) E-mail: Phone: Office (+39) 049 650303 Class Meets: 2 hours, four times a week (Summer), Bu Padua Academic Center Credits: 4 Hub Units: 1+1 (GCI and OSC) Course description There are places that inspire visitors and artists. The morphological aspects of the territory; the colors; the human trace on the physical territory; the history, culture and traditions are but some of the elements of a landscape fascination. The Veneto region, where Padua always played and still plays a lively cultural role, is particularly rich of suggestions and throughout the centuries inspired artists, musicians, writers. Johann W. Goethe, Lord Byron or Henry James wrote beautiful memories of their Italian journey and left us extraordinary depictions of cities like Padua, Venice and Verona surrounded by hills, mountains, lagoon, but also rural landscapes. Following the path of these famous travelers, the course aims to offer students the opportunity to discover the Veneto region through literary and cultural experiences. By means of on-site lessons, readings and field trips, students are able to recognize the local identity that deepens its roots into the landscape (natural and anthropic), culture (progress and tradition), language (Italian and dialect), history and society. During the course, students will read and discuss extracts from works by Luigi Meneghello, Mario Rigoni Stern, Dino Buzzati or Giovanni Comisso to only mention some, and visit places such as the Dolomites, the Veneto countryside, or cities like Padova, Treviso, Vicenza or Venezia.