Storia D'italia Nel Secolo Ventesimo. Strumenti E Fonti . I Elementi Strutturali
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rosanna Marani
Rosanna Marani Rosanna Marani nasce ad Imola il 12 ottobre 1946. Grazie a Gino Sansoni, editore di FORZA MILAN! approda a LA GAZZETTA DELLO SPORT, l'esordio avviene il 18 novembre 1973 con un'intervista a Gianni Rivera, da sei mesi in silenzio stampa, titolo a nove colonne: RIVERA E LE DONNE . In Rai collabora a GIORNI D'EUROPA e 7 GIORNI AL PARLAMENTO con Gianluca Di Schiena, collabora inoltre con AMICA, GRAZIA, IL GUERIN SPORTIVO, TEMPO, AGENZIA ASCA, MOMENTO SERA, MADAM CLASS, occupandosi di sport, cronaca nera, politica, costume, spettacoli. La sua collaborazione con le tv private inizia a Telenorditalia, Rosanna è la prima donna a condurre un talk-show sportivo, BAR SPORT. Quindi collabora con il tg di TeleSanterno, nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse emittenti locali: oltre alle già citate Telenorditalia e TeleSanterno ricordiamo: Canale 21 (NUMBER ONE, NUMBER TWO), Telelombardia (NOVANTESIMO DONNA condotto da Eliana Jotta), Antenna 3 Lombardia (MARINASUMAGOL, CABRIOFLIPPER, NON SOLO BICI, ANTENNA TREDICI, VISTI A SAN SIRO, SPECIALI CRONACA E POLITICA), Telenova (FAX 13). Si può quindi scrivere che Rosanna Marani, oltre ad essere stata la prima donna a condurre un talk-show sportivo, è stata fra le prime ad andare in onda su emittenti di diverse regioni. Nel 1979 il passaggio a Telemilano58 antenata di Canale5. Quindi una variegata collaborazione con la Fininvest: è inviata di BUONGIORNO ITALIA, delle news, di W LE DONNE, RECORD, SUPERFLASH e de GLI SPECIALE: "Mike Bongiorno e Ludovico Peregrini" sono stati i miei maestri severe ma importantissimi, mi hanno insegnato il ritmo e il taglio televisivo.". -

Un Film Lungo Un
CARTELLA STAMPA CARTELLA UN FILM LUNGO UN 19° GLOCAL FILM FESTIVAL 12 - 16 marzo 2020, Cinema Massimo MNC, Torino 50 TITOLI per 5 GIORNATE DI CINEMA PIEMONTESE APERTURA | Giovedì 12 marzo Proiezione di Pastrone! di Lorenzo De Nicola Ospiti in sala il regista e Fabrizio Bentivoglio. 2 SEZIONI COMPETITIVE PANORAMICA DOC | 6 documentari per 2 anteprime assolute e 3 anteprime regionali SPAZIO PIEMONTE | 20 cortometraggi OMAGGIO A GIANLUCA MARIA TAVARELLI | Venerdì 13 e lunedì 16 marzo Proiezione di Qui non è il paradiso, Portavi via e Un amore Conferimento del Premio ‘Riserva Carlo Alberto’ al regista 2 EVENTI CINEMA & TV | Incontro con PAOLO BELDÌ Incontro con uno dei registi più innovativi e prolifici della nostra televisione PREMIO PROSPETTIVA | Incontro con Marina Occhionero Conferimento del premio alla giovane attrice astigiana 1 PROIEZIONE SPECIALE La ragazza di via Millelire di Gianni Serra ABC GLOCAL MASTERCLASS | Disegnare il cinema - storyboard cinematografico con GIUSEPPE LIOTTI PROFESSIONE DOCUMENTARIO | 3 documentari, 1 premio, 330 studenti in giuria TORINO FACTORY | 3ª edizione del glocal video & lab contest per filmmaker under 30 8 FOCUS con festival e realtà gemellate Alessandria Film Festival Coorpi Corto e Fieno - Rural Film Festival Lovers Film Festival Muuh Film Festival Seeyousound International Music Film Festival Skepto International Film Festival TOHorror Fantastic Film Fest 1 MOSTRA “RITRATTI DI CINEMA. La sala, il lavoro, il pubblico” | Dal 5 al 29 marzo 2020, Polo del ‘900 Associazione Piemonte Movie | P.IVA 09277890019 | C.F. 94050840019 1 Sede legale e operativa: Via Vincenzo Maria Miglietti, 20 – 10144 Torino | Fisso: +39.011.4270104 | Mobile: +39.328.8458281 | www.piemontemovie.com 19° GLOCAL FILM FESTIVAL 12-16 marzo 2020, Cinema Massimo MNC, Torino Dopo l’anno della maggiore età, per il Glocal Film Festival è il momento della 19a edizione e con esso, dal 12 al 16 marzo 2020, la cinematografia piemontese sarà nuovamente protagonista al Cinema Massimo MNC di Torino. -

DVB-T2 La Seconda Generazione Del DVB Terrestre
TV Digitale www.sistemi-integrati.net Volume 4 - 2009 Volume Sistemi Integrati Tv Digitale Tv 4 Sistemi Integrati to fisso dovuto Switch-off Il passaggio alla TV digitale di Val d’Aosta e Piemonte occidentale DVB-T2 La seconda generazione del DVB terrestre DM 37/08 Dubbi interpretativi e problemi irrisolti In caso di mancato recapito si prega di inviare al CMP Roserio per la restituzione a pagare il dirit al mittente che si impegna Digitale terrestre Leggi e Decreti a tutela dell’utente finale Mediaset Premium Premium On Demand, Cinema Emotion e Cinema Energy Tivù Sat Le CAM e i ricevitori dedicati Vetrina prodotti Più di cento novità Sistemi Integrati, Anno 2°, Volume 4 – dicembre 2009 – PosteSistemi Italiane Integrati, Anno 2°, Volume SpA, spedizione in Abbonamento Postale 70% - DCB Milano. dalle Aziende leader di settore Switch-off la tappa più importante l 2010 verrà ricordato come l’anno dove oltre il 40% I della popolazione italiana passerà al digitale terrestre, vale a dire 23 milioni di cittadini. Le regioni coinvolte sono: Lombardia (inclusa la provincia di Piacenza), Piemonte Orientale, Emilia Romagna, Veneto (incluse le province di Mantova e Pordenone), Friuli Venezia Giulia e Liguria. Sono www.sistemi-integrati.net regioni importanti, situate nelle principali aree Nielsen, TV Digitale fondamentali motori economici del nostro Paese. Il calendario Volume 4 - 2009 - 4 Volume Sistemi Integrati prevede lo switch-over al 18 maggio per Lombardia, Piemonte 4 Tv Digitale Tv Orientale ed Emilia Romagna con il passaggio in digitale di Sistemi Integrati Sistemi Rai 2 e Rete 4. Per lo switch-off, invece, bisognerà aspettare dopo l’estate. -
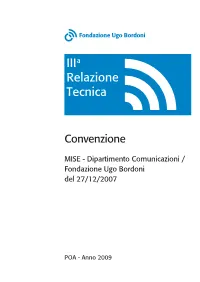
Attività FUB 2009
IIIa Relazione Tecnica Convenzione MISE - Dipartimento Comunicazioni / Fondazione Ugo Bordoni del 27/12/2007 POA - Anno 2009 Catasto e monitoraggio della qualità dei segnali televisivi PROG01CONV Responsabile Ing. Paolo Grazioso Catasto e monitoraggio della qualità dei segnali televisivi PROG01CONV – Responsabile Ing. Paolo Grazioso Introduzione La presente relazione descrive lo stato di avanzamento del progetto alla data del 31 dicembre 2009. Il progetto è nato con l’obiettivo di estendere e completare le attività svolte nell’ambito del progetto relativo al “catasto delle frequenze” (Conv. 7/3/2001). Il progetto mira a verificare la correttezza delle informazioni contenute nel catasto degli impianti televisivi mediante confronto con altre fonti informative tra i quali in primis il database del Censimento televisivo del 1990, il Registro degli Operatori delle Comunicazioni (ROC), i dati disponibili presso gli Ispettorati Territoriali. Ulteriori verifiche di congruenza sono effettuate sulla base dei dati delle ricezioni televisive, sia forniti dagli Ispettorati Territoriali stessi che reperibili pubblicamente su Internet (OTGTV, DGTVi), che infine del database delle ricezioni che verrà costituito all’interno del Catasto stesso e verrà popolato mediante campagne di rilevamento ad hoc. Al fine di effettuare una valutazione della copertura e della qualità dei segnali televisivi è infatti indispensabile poter disporre di un archivio o catasto che contenga i dati dei trasmettitori televisivi operanti sul territorio nazionale. La conoscenza di tali impianti è infatti indispensabile al fine di predisporre le opportune campagne di misura da un lato e di simulazione dall’altro. Inoltre, la conoscenza degli impianti televisivi effettivamente operanti in Italia, ed autorizzati a farlo, è necessaria al fine di predisporre la transizione alla tecnica digitale nelle varie aree tecniche in cui è stato suddiviso il territorio nazionale. -

FRANCESCA AMBROSINI: LA RICERCA DELLE NOTIZIE Numeri Arretrati LA MODA DENTRO E FUORI LE SFILATE Interviste
HOME SCHEDE+FOTO VIDEO FORUM PREMIO TGISTE NONSOLOMODA TUTTO TV PINK NEWS DONNE INTERVISTE ARCHIVIO Nel numero di questa settimana: Archivi magazine FRANCESCA AMBROSINI: LA RICERCA DELLE NOTIZIE Numeri arretrati LA MODA DENTRO E FUORI LE SFILATE Interviste VALENTINA CHIOCCHINI: PACATEZZA E CORDIALITÀ Interviste audio TWERK: IL TORMENTONE DEL BALLO SEXY Tgiste Style CRISTIANA CAPOTONDI: UNA VITA AL TOP Vademecum TELEGIORNALISTE - Donne che fanno notizia - Anno X N. 2 (390) 20 gennaio 2014 Registrazione Tribunale Modena: 1741 08/04/2005. Provider: Aruba Spa Cam girls: inchiesta Settimanale dedicato alle telegiornaliste, alle donne, alla tv e all'informazione 2 milioni di visite all'anno · Collabora con Telegiornaliste Speciali Direttore Responsabile: Giuseppe Bosso Redazione: Giuseppe Bosso, Francesca Succi, Premio Tgista dell'anno Michela Tortolano, Silvia Roberto, Maria Cristina Webmaster: Rocco Ventre Forum pubblico Consulenza editoriale: Francesca Succi Saullo, Malvina Podestà, Deborah Palmerini, Valentina Dellavalle Logo grafico: Isabella Succi La Redazione schede redattori E-mail: [email protected] 2mila F. Succi di TgisteStyle Saluti delle tgiste Telegiornalisti Francesca Ambrosini: alla ricerca delle notizie di cui non si parla di Giuseppe Bosso Strumenti Schede e foto «Mi piacerebbe dare spazio a quelle notizie, a quegli angoli della Terra che sono completamente ignorati. Per esempio il Congo, che improvvisamente pare essere balzato Video al centro dell’attenzione per la vicenda delle famiglie italiane bloccate laggiù: è una zona Cerca nel sito dell'Africa dove 20 anni fa ai confini con il Ruanda, nel silenzio del mondo, morirono quattro milioni di persone per un genocidio. Sarebbe il caso di aprire gli occhi su tante Nuove schede tgiste cose di cui non parliamo mai, e spero di poterlo fare». -

Elenco Inziative
CONSIGLIO OSSERVATORIO SULLA SPESA REGIONALE REGIONALE DEL VENETO ALLEGATOALLEGATO ALAL RAPPORTORAPPORTO DIDI MONITORAGGIOMONITORAGGIO Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO Articolo 2 FUNZIONI DELLA REGIONE Comma 1, lettera b) PROMOZIONE, IN ITALIA E ALL’ESTERO, DELL’IMMAGINE UNITARIA E COMPLESSIVA DEL TURISMO VENETO ELENCO COMPLETO DELLE INIZIATIVE* * L’elenco che segue è strutturato secondo la tassonomia sviluppata dall’Osservatorio. Le iniziative rappresentano aggregazioni o disaggregazioni di singoli provvedimenti d’impegno. 2 Indice Iniziative rivolte a operatori, aziende e giornalisti stranieri……... 5 Promozione in occasione di particolari eventi……………………... 6 Azioni coordinate di promozione……………………………………… 7 Fiere e altre manifestazioni…………………………………………….. 8 Spot, redazionali ed iniziative editoriali……………………………… 10 Studi, ricerche, consulenze, iniziative (in)formative………………. 15 Altro…………………………………………………………………………. 16 Sostegno ad iniziative locali……………………………………………. 17 3 4 Iniziative rivolte ad operatori, aziende e giornalisti stranieri Impegno Impegno da Iniziativa Anno Sub-categoria attuale rendiconto Aria di Venezia ad Istanbul 2008 Conferenze/Seminari/meeting 1.512,00 1.512,00 Tempolibero - Gitando - Vicenza 2008 Conferenze/Seminari/meeting 54.000,00 54.000,00 Iniziative turistico-promozionali rivolte al mercato francese 2008 Conferenze/Seminari/meeting 50.000,00 50.000,00 Italy Symposium Usa 2009 Conferenze/Seminari/meeting 646.145,40 650.000,00 Congresso annuale dell'ITT - -

Roberto Vecchioni, Il
EDIZIONE 119 - ANNO XIV N° 7 - SETTEMBRE 2020 Le sfide con la vita di Gherardo Dindelli, il partigiano di Sansepolcro alla soglia dei 97 anni, dei quali 71 di matrimonio L’Eco del TevereL’Eco è un periodico edito dall’agenzia Saturno Comunicazione sas – Iscrizione al Registro Stampa n.6/07 – Autorizzazione Tribunale di Arezzo 2 marzo 2007 Canzoni e melodie della nostra vita: il meccanismo alla base dell’abbinamento mentale di un brano con specifici ricordi Roberto Vecchioni, il cantautore-professore: il fascino dell’intellettuale in una fra le epoche d’oro della musica leggera italiana 1 2 SOMMARIO EDITORIALE n questo numero, che contiene anche gli spazi riservati alla campagna elettorale 4 delle regionali in Toscana, finiscono con il L’opinionista diventare protagonisti due partigiani: uno I ragazzi fortunati di essi, Gherardo Dindelli di Sansepolcro, degli anni ’60 conservaI una straordinaria lucidità a quasi 97 anni e parla delle sue avventure, comprese quelle nelle qua- li ha visto la morte da vicino. L’altro ci ha lasciato nel 6 2007 ed è Livio Dalla Ragione: dopo l’esperienza da capo brigata, Livio diverrà noto come uomo di cultu- Politica ra, che a Città di Castello ha impiantato il centro delle Speciale elezioni regionali 2020 tradizioni popolari di Garavelle e l’archeologia arborea a Lerchi. Una particolare inchiesta da noi condotta prende in esame un fenomeno tipicamente… umano: a tutti è successo - e succede tuttora - che l’ascolto 11 33 di un vecchio brano riporti subito alla mente una cir- Economia Satira costanza di quel periodo, festosa come triste e che ne La raccolta dei rifiuti “porta a La vignetta faccia rivivere le relative emozioni. -

In Musica Oesie
oesie Pin musica biettivi O Riconoscere nelle parole di molte canzoni 1 la qualità e le regole-guida del testo poetico Riconoscere nei temi proposti 2 dalle canzoni una grande aderenza ai problemi della società e in particolare ai problemi dei giovani Riconoscere il valore universale del linguaggio 3 musicale, come veicolo di messaggi di signifi cato sociale 1 ANTOLOGIA LETTERARIA © ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS Introduzione La consuetudine di accompagnare il testo poetico con la musica nasce in epoche molto lontane. Le più antiche opere letterarie della storia dell’umanità, le grandi nar- razioni epiche, venivano infatti cantate dagli aedi – i cantori erranti – che si accompa- gnavano con la lira, strumento che denominò poi la poesia lirica. Anche menestrelli e trovatori nel Medioevo continuarono a recitare versi e a cantare, accompagnandosi con uno strumento, il liuto. Molte tecniche stilistiche che costituiscono il testo poetico, la metrica, il ritmo, le fi gure retoriche del suono nascono su imitazione della musica, sfruttando le sonorità armoniose delle parole. Le rime, le parole allitteranti e assonanti, i costanti ritorni di termini e formule sono accorgimenti stilistici basati su armoniche risonanze. Un perfetto connubio tra testo e musica è rappresentato dal melodramma, detto anche opera lirica. Zeno (1668-1750) e Metastasio (1698-1782) sono i grandi inizia- tori di un genere molto popolare nel passato, che ha ancora oggi molti appassionati amatori. Tra i più insigni autori di testi per la musica spicca Lorenzo Da Ponte (1749- 1838), i cui libretti, autentici capolavori, furono musicati dal genio di Mozart. LE ROMANTICHE CANZONI DELL’OTTOCENTO Nell’Ottocento si affermò in Germania un tipo di composizione breve, incentrata per lo più su temi romantici come l’amore, la contemplazione della natura, l’anelito all’infi nito: è illied , un testo in versi destinato a essere musicato e cantato con accom- pagnamento del pianoforte. -
Presentazione Showman Trasformista Cantante
DIRETTAMENTE DA POMERIGGIO CINQUE con BARBARA D'URSO su CANALE 5 VITTORIA ALLA CORRIDA di CANALE 5 con GERRY SCOTTI OSPITATE A: MARKETTE LA7 con P. CHIAMBRETTI, SKY e CANALE ITALIA. CANTANTE/SHOWMAN/IMITATORE/ ANIMATORE/ DEE JAY / PIANISTA e ORGANISTA (per la chiesa) MA CON UN VALORE AGGIUNTO……… IL TRASFORMISMO UN MODO ORIGINALE DI FARE SPETTACOLO CON CAMBI D’ABITO COMPLETI A SCELTA , alcuni veloci a seconda della situazione, di personaggi (10/12) della musica italiana e straniera, come Elvis Presley, Renato Zero, Elton John, Vasco Rossi, Jovanotti e tanti altri, cantando e giocando con le loro voci interagendo con il pubblico presente (tra una portata e l’altra) . Per il resto dell’evento intrattiene gli ospiti all’aperitivo suonando il pianoforte (meglio se in loco) o come DEE JAY con musiche a scelta dagli sposi. A inizio pranzo o cena propone canzoni cantate di qualsiasi genere coinvolgendo il pubblico con giochi, balli di gruppo e animazione e balli di tutti i generi e a sorpresa cambi d’abito (Trasformismo), un modo originale per ricordare il vostro evento importante. Disponibile sia in Italia che all’estero. Munito di impianto audio: DA 800 A 1800 WATT. Impianto luci: 6 fari da 300 watt l’una SU RICHIESTA ANCHE CON ALTRI MUSICISTI! violinista VIRTUOSO e/o cantante donna, a seconda del budget. 1 Zucchero Renato Zero Elvis e la sua sposa Elton John 2 E per sorridere… Gioco – Animazione Animazione e coinvolgimento tra i tavoli 3 E per finire in bellezza…..si balla !!! 4 Altri travestimenti sono disponibili a seconda della tipologia -

Curriculum David Ambrosioni Si Avvicina Alla Musica Fin Da Piccolo
Curriculum David Ambrosioni Si avvicina alla musica fin da piccolo ascoltando musica classica e jazz e suonando ad orecchio chitarra e tastiera . A 8 anni inizia lo studio del clarinetto e della teoria musicale con il M° Erminio Santambrogio vice -maestro e successivamente Maestro del Corpo musicale S.Cecilia di Seveso , suonerà nel corpo musicale per 6 anni circa nelle fila dei primi clarinetti . Curioso di ogni forma d’Arte così come di culture musicali a 12 anni inizia a suonare il Sax tenore . In questo periodo decide di diventare un musicista professionista , si iscrive alla Civica scuola di musica Villa Simonetta a Milano dove studia clarinetto con il Prof. Maurizio Longoni . Si diploma in clarinetto al Conservatorio Luca Marenzio di Brescia . Studia Armonia e Composizione classica con diversi insegnanti . Sax e Improvvisazione jazz con il M° Paolo Tommelleri . Attivo nell’area milanese si esibisce con diversi gruppi dal jazz al blues , pop , ballo ecc. A 17 anni diventa musicista professionista , gira l’Europa al seguito di varie formazioni in concerti , festival , locali ecc. con l’incarico di Saxofonista/Clarinettista e Arrangiatore . Ha inoltre studiato con : Jerry Bergonzi , Joe diorio , Francesco Chimienti , Carlo Dell’Acqua , Maria Teresa Muttoni , Umberto fusco . Ha collaborato con : East Costa Big band , Alfredo Ray Orchestra , Big Band Viva il jazz , Gino Paoli , Alessandra , Leano Morelli , Walter Chiari , Marco Detto , Paolo Tommelleri , Fusion Madness , David Ambrosioni Quartet , Ambrosia Brass Band , Magenta Brass Band , Al Ventura , Frisco Blues band , Orchestra Nova Harmonia , Orchestra da camera san Zeno , Orchestra di fiati della Brianza , Marco Mandy Mandy Milano con il Pomofiore Antenna 3 lombardia , Ettore Andenna , Josè Mascolo , Lorella Cuccarini (Grease) , Piero Cotto , Allan Goldberg , Sante Palumbo , Attilio Zanchi , Renzo Zugnoni ecc. -

Scarica Il Programma Di Sala in Formato
Milano Svampa & Friends Piccolo Teatro Studio Lunedì 21.IX.09 Anteprima del film ore 21 documentario Nanni 70 dedicato a Nanni Svampa A seguire, spettacolo di Nanni Svampa con Lino Patruno Roberto Brivio Enzo Iacchetti Antonio Mastino Flavio Oreglio Alberto Patrucco 62° Alessandra Faiella Torino Milano Festival Internazionale della Musica 03_24.IX.2009 Terza edizione SettembreMusica Svampa & Friends Anteprima del film documentario Nanni 70 dedicato a Nanni Svampa regia di Simone Del Vecchio realizzato da LaBiografika A seguire, spettacolo di Nanni Svampa con Antonio Mastino alla chitarra Reunion de I Gufi con Lino Patruno, Roberto Brivio e la partecipazione straordinaria di Enzo Iacchetti, intervengono Flavio Oreglio, Alberto Patrucco, Alessandra Faiella Con un saluto di Massimo Zanello Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Regione Lombardia Massimiliano Finazzer Flory Assessore alla Cultura del Comune di Milano Con il contributo di In collaborazione con Comune di Milano - Assessorato alla Cultura Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa In viaggio con Nanni L’occasione della serata cinematografico-musicale è la presentazione alla città di Milano di una anteprima del film documentario Nanni 70, realizzato dalla etichetta milanese LaBiografika per la produzione Recording Arts, con il patrocinio e il contributo dell’Assessorato alle Culture, Identità e Autonomie della Regione Lombardia. Il film è un itinerario senza mappe nella biografia del cantante milanese Nanni Svampa che ha elevato la tradizione dialettale a nobili esiti facendola incontrare con il mondo poetico del cantautore francese George Brassens. Tallonato da un gruppo di film-makers milanesi lo chan- sonnier lombardo, che ha recentemente festeggiato i 70 anni (50 dei quali vissuti sul palco), si racconta alla telecamera in un viaggio della memoria, anarchico e divertente, tra Milano e il Lago Maggiore, i poli culturali del suo mondo poetico. -

Gli Anziani Ora Aspettano La Riforma Troppi
18COM01A1810 ZALLCALL 13 16:28:33 10/20/97 ICOMMENTI l’Unità 15 Sabato 18 ottobre 1997 STATO SOCIALE UN’IMMAGINE DA... L’INTERVENTO Gli anziani Troppi facili ottimismi ora aspettano I nuovi lavori spesso la riforma sono «ricattati» RAFFAELE MINELLI ANDREA FUMAGALLI SEGRETARIO GENERALE SPI-CGIL UNIVERSITÀ DI PAVIA A VELOCE soluzione della crisi politica, ON QUESTO intervento, intendo fornire alcune pre- con la riconferma del Governo Prodi, è cisazioni sul paginone dell’Unità del 7 ottobre, relati- motivo di soddisfazione per chi, come vo al dibattito sulle nuove figure emergenti del lavo- L noi, organizza una parte della società, C ro, in particolare su quello che viene chiamato il lavo- pensionati e anziani, tra le più deboli. La fine ro autonomo di seconda generazione. Il dibattito si è svilup- dell’esperienza del governo, uscito dalle elezio- pato essenzialmente all’interno di quella struttura under- ni del 21 aprile 1996, avrebbe aperto certa- ground che fa capo a riviste ed edizioni che ruotano nell’al- mente una fase di instabilità istituzionale, politi- veo della rete dei centri sociali autogestit. E‘ positivo che tale ca ed economica. A livello istituzionale infatti si dibattito “buchi” le pagine di quotidiani o di settimanali a ti- sarebbe complicato il percorso dei revisione ratura nazionale. Tuttavia, come sempre accade nell’analisi della prima parte della Costituzione, avviato di tematiche emergenti, è inevitabile il fatto di non riuscire a positivamente con i lavori della Bicamerale; a li- cogliere in modo compiuto tutti gli aspetti che le nuove pro- vello politico avrebbero ripreso vigore i settori blematiche sollevano.