Giulio Andreotti
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

«La De Non È Credibile Se Non Cambia»
SABATO 1 AGOSTO 1992 POLITICA INTERNA PAGINA 7'L'UNITÀ Lunedì Intervista alla vigilia del parlamentino scudocrociato «Il punto non è Forlani sì o no, ma l'assenza di fantasia Il segretario della Oc il summit il rinnovamento che vale per alcuni e non vale per altri Arnaldo Forlani Capisco il Pds che rifiuta di fare da ruota di scorta» «La De non è credibile se non cambia» Martinazzoli: «L'unità fittizia del partito è una prigione» «Il Consiglio nazionale sarà più dinamico di quanto anche la difficoltà di tutti i dibile un Consiglio nazionale ganniamo avicenda. Perfino i teologi sul caso Scotti si prevedeva». Alla vigilia dell'appuntamento de, grandi passaggi, le grandi tra più mosso e dinamico di quan Parliamo un momento del parla Mino Martinazzoli. «L'unità fittizia è una pri sformazioni. Nei partiti non ve to si immaginava. C'è da spe governo, senatore Martinaz do la consapevolezza dei peri rare che non riprenda la cri zoli. Questo di Amato è un gione». Aggiunge: «La De non è credibile se non coli che stiamo correndo. La stallizzazione dei gruppi. cambia». E su De Mita: «Constato la difficoltà di stare mia inquietudine aumenta, ma governo che serve al Paese o con amici che dicono sempre di no a me. Il rinnova non sono impaziente. Nell'89 Parliamo un po' di De Mita? è soltanto 11 governo possi «Dimettersi sono finiti 45 anni di democra I suol contrasta con lui sono bile? mento? Vale per alcuni e non per altri». «Capisco zia italiana, non disprezzabili frequenti. Cosa le rimprove Dire che è il governo possibile Occhetto che non vuol fare la ruota di scorta». -
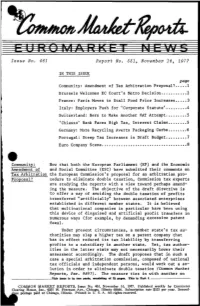
Issue No. 461 Report No. 331, November 16, 19,7
Issue No. 461 Report No. 331, November 16, 19,7 IN THIS ISSUE page CoIIlIIlunity: Amendment of Tax Arbitration Proposal? ••.•• ! Brussels Welcomes EC Court's Metro Decision .••••••.••• 2 France: Paris Moves to Stall Food Price Increases •••.• 3 Italy: Employers Push for 'Corporate Statute' ••••.•..• 4 Switzerland: Bern to Make Another VAT Attempt •.••.•••• 5 'Chiasso' Bank Faces High Tax, Interest Claims •••.•••• 5 Germany: More Recycling Averts Packaging Curbs •.•••••• 6 Portugal: Steep Tax Increases in Draft Budget ••••••••• 7 Euro Company Scene ... ,, ............ ,,,,,,, ... ,,,,.,,,, 8 Community: Now that both the European Parliament (EP) and the Economic •Amendment of and Social Committee (ESC) have submitted their comments on Tax Arbitration the European Commission's proposal for an arbitration pro- Proposal? cedure to eliminate double taxation, Commission tax experts are studying the reports with a view toward perhaps amend ing the measure. The objective of the draft directive is to offer a way of avoiding the double taxation of profits transferred "artificially" between associated enterprises established in different member states. It is believed that multinational companies in particular have been using this device of disguised and artificial profit transfers in numerous ways (for example, by demanding excessive patent fees). Under present circumstances, a member state's tax au thorities may slap a higher tax on a parent company that has in effect reduced its tax liability by transferring profits to a subsidiary in another state. Yet, tax author ities in the latter state may not necessarily lower their assessment accordingly. The draft proposes that in such a case a special arbitration commission, composed of national tax officials and independent persons, would work out a so lution in order to eliminate double taxation (Common Market Reports, Par. -

Download (515Kb)
European Community No. 26/1984 July 10, 1984 Contact: Ella Krucoff (202) 862-9540 THE EUROPEAN PARLIAMENT: 1984 ELECTION RESULTS :The newly elected European Parliament - the second to be chosen directly by European voters -- began its five-year term last month with an inaugural session in Strasbourg~ France. The Parliament elected Pierre Pflimlin, a French Christian Democrat, as its new president. Pflimlin, a parliamentarian since 1979, is a former Prime Minister of France and ex-mayor of Strasbourg. Be succeeds Pieter Dankert, a Dutch Socialist, who came in second in the presidential vote this time around. The new assembly quickly exercised one of its major powers -- final say over the European Community budget -- by blocking payment of a L983 budget rebate to the United Kingdom. The rebate had been approved by Community leaders as part of an overall plan to resolve the E.C.'s financial problems. The Parliament froze the rebate after the U.K. opposed a plan for covering a 1984 budget shortfall during a July Council of Ministers meeting. The issue will be discussed again in September by E.C. institutions. Garret FitzGerald, Prime Minister of Ireland, outlined for the Parliament the goals of Ireland's six-month presidency of the E.C. Council. Be urged the representatives to continue working for a more unified Europe in which "free movement of people and goods" is a reality, and he called for more "intensified common action" to fight unemployment. Be said European politicians must work to bolster the public's faith in the E.C., noting that budget problems and inter-governmental "wrangles" have overshadolted the Community's benefits. -

Documento Scaricato Dal Sito Mininterno.Net - Il Portale Per La Preparazione Ai Concorsi Pubblici - Esercitati GRATIS On-Line! N
N. Domanda A B C D 1 Dove si trova il Darfur, regione in cui Somalia Uganda Sudan Eritrea nel 2003 è iniziato un drammatico conflitto? 2 A quale partito è appartenuto Oscar Partito Repubblicano Partito Socialista Partito Democratico Democrazia Cristiana Luigi Scalfaro? 3 Quale dei seguenti politici italiani è Gianni Letta Raffaele Fitto Graziano Delrio Filippo Patroni Griffi stato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei governi Berlusconi? 4 Il 6/1/1980 venne ucciso dalla mafia Presidente della Presidente della Segretario della Sindaco di Palermo Piersanti Mattarella: quale carica Commissione Regione Siciliana Democrazia Cristiana ricopriva? antimafia 5 Alla storia recente di quale paese è Messico Bolivia Venezuela Colombia legata principalmente la figura di Hugo Chavez? 6 Alla storia recente di quale paese è Bielorussia Georgia Russia Ucraina legata principalmente la figura di Julija Tymosenko? 7 Quale incarico ha ricoperto Emma Ministro per gli affari Ministro degli esteri Vicepresidente del Ministro per i rapporti Bonino nel governo Letta europei Consiglio col Parlamento (2013-2014)? 8 Alla storia recente di quale paese è Costa Rica Messico Cuba Venezuela legata principalmente la figura del "subcomandante Marcos"? 9 Nel 2012 è sorta fra Italia e India una La MCS Melody La Exxon Valdez L'Enrica Lexie La Sirius Star controversia internazionale in merito all'arresto di due marò italiani imbarcati, come nuclei militari di protezione, a bordo di quale nave? 10 Quale carica ha ricoperto Yanis Ministro delle finanze -

The Schengen Agreements and Their Impact on Euro- Mediterranean Relations the Case of Italy and the Maghreb
125 The Schengen Agreements and their Impact on Euro- Mediterranean Relations The Case of Italy and the Maghreb Simone PAOLI What were the main reasons that, between the mid-1980s and the early 1990s, a group of member states of the European Community (EC) agreed to abolish internal border controls while, simultaneously, building up external border controls? Why did they act outside the framework of the EC and initially exclude the Southern members of the Community? What were the reactions of both Northern and Southern Mediter- ranean countries to these intergovernmental accords, known as the Schengen agree- ments? What was their impact on both European and Euro-Mediterranean relations? And what were the implications of the accession of Southern members of the EC to said agreements in terms of relations with third Mediterranean countries? The present article cannot, of course, give a comprehensive answer to all these complex questions. It has nonetheless the ambition of throwing a new light on the origins of the Schengen agreements. In particular, by reconstructing the five-year long process through which Italy entered the Schengen Agreement and the Conven- tion implementing the Schengen Agreement, it will contribute towards the reinter- pretation of: the motives behind the Schengen agreements; migration relations be- tween Northern and Southern members of the EC in the 1980s; and migration relations between the EC, especially its Southern members, and third Mediterranean countries in the same decade. The article is divided into three parts. The first examines the historical background of the Schengen agreements, by placing them within the context of Euro-Mediter- ranean migration relations; it, also, presents the main arguments. -

Gianni Fontana
biancheria biancheria giovannetti giovannetti verona verona NUOVI ARRIVI NUOVI ARRIVI P.zza Nogara, 6 - Tel. 045.8009234 P.zza Nogara, 6 - Tel. 045.8009234 ANNO 155. NUMERO 133 www.larena.it DOMENICA 16 MAGGIO 2021. € 1,40 (Verona e provincia a richiesta con Gente € 2,00) HAMAS E ISRAELE RIPARTENZA Ricoveri sotto quota 200. Giù i positivi nel 52% dei paesi ma solo tre Covid-free. Meno casi nel capoluogo DA CRISI IN EDICOLA IGNORATA VENEZIA A GUERRA Contagi, ecco i numeri IN NUMERI TOTALE Bonifacio Pignatti di tutti i Comuni veronesi a domanda è: perché Hamas ha •• Contagi in calo a Verona dì. Lo stesso anche nel capo- Domani vertice del governo trasformato in Il ministero della Salute apre e provincia. Per la prima vol- luogo. Solo tre i paesi scalige- sulle nuove misure mentre il L guerra quello che nei ta dopo mesi ieri i ricoverati ro con zero casi: Castagnaro, ministero della Salute apre primi giorni era apparso ai test salivari nelle scuole sono inoltre scesi sotto quo- Ferrara di Monte Baldo e ai test salivari per gli esami uno degli incidenti, seppur ta 200. Il 52% dei Comuni San Mauro di Saline. Sul di terza media e maturità a grave, che frastagliano la Ipotesi coprifuoco a mezzanotte veronesi sabato ha registrato fronte riaperture invece scat- corpo insegnante, studenti, 9,90 euro convivenza fra israeliani e un numero di positivi inferio- ta oggi lo stop alla quarante- personale ausiliario e di se- più il prezzo palestinesi? Perché dalla Turisti europei, stop quarantena re rispetto a quello di giove- na per i turisti dai Paesi Ue. -

Sergio Mattarella
__________ Marzo 2021 Indice cronologico dei comunicati stampa SEZIONE I – DIMISSIONI DI CORTESIA ......................................................................... 9 Presidenza Einaudi...........................................................................................................................9 Presidenza Gronchi ..........................................................................................................................9 Presidenza Segni ..............................................................................................................................9 Presidenza Saragat.........................................................................................................................10 Presidenza Leone ...........................................................................................................................10 Presidenza Pertini ..........................................................................................................................10 Presidenza Cossiga ........................................................................................................................11 Presidenza Ciampi .........................................................................................................................11 Presidenza Mattarella ....................................................................................................................11 SEZIONE II – DIMISSIONI EFFETTIVE ........................................................................ -

What Makes the Difference
Universität Konstanz Rechts-, Wirtschafts-, und Verwaltungswissenschaftliche Sektion Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft Magisterarbeit to reach the degree in Political Science SUCCESS AND FAILURE IN PUBLIC PENSION REFORM: THE ITALIAN EXPERIENCE Supervised by: Prof. Dr. Ellen Immergut, Humboldt-Universität PD Dr. Philip Manow, Max-Planck Institut für Gesellschaftsforschung Presented by: Anika Rasner Rheingasse 7 78462 Konstanz Telephon: 07531/691104 Matrikelnummer: 01/428253 8. Fachsemester Konstanz, 20. November 2002 Table of Contents 1. Introduction ..................................................................................................................................... 1 1.1. The Puzzle ............................................................................................................................... 1 2. Theoretical Framework ................................................................................................................... 3 2.1. Special Characteristics of the Italian Political System during the First Republic ................... 3 2.1.1. The Post-War Party System and its Effects..................................................................... 4 2.2. The Transition from the First to the Second Republic ............................................................ 7 2.2.1. Tangentopoli (Bribe City) ............................................................................................... 7 2.2.2. The Restructuring of the Old-Party System ................................................................... -

I Comizi Celebri Di Gerardo Pescatore
Comizi celebri ad Avellino di Gerardo Pescatore La fine della guerra col crollo del fascismo segnò la ripresa dell’attività politica e della vita democratica, che erano state soppresse durante il “ventennio”, culminante con le elezioni del 18 aprile 1948, subito dopo le votazioni per il referendum istituzionale e per la scelta dei deputati dell'Assemblea Costituente (2 giugno 1946). La campagna elettorale fu molto partecipata con contraddittori tra gli esponenti dei partiti, che avvenivano sulle piazze. Il popolo final- mente poteva riunirsi ed esprimere liberamente il suo sostegno a questo o a quel partito, senza il timore di essere arrestato per sovversione dell’ordine dello Stato. Memorabile fu il contraddittorio che vide di fronte Fiorentino Sullo, giovane segretario della Dc, e il grande avvocato nonché potente ministro fascista Alfredo De Marsico ad Atripalda. Il gio- vane, senza alcun timore reverenziale, tenne brillantemente testa al principe del foro dall’eloquio forbito e retorico, a cui seppe contrap- porre, con logica efficace, incentrata sui problemi e sulle analisi politi- che, la forza delle proprie ragioni. La presentazione dell’intellettuale nato a Paternopoli non poteva essere più felice e la sua popolarità crebbe di colpo. Però, passati i primi entusiasmi dopo la Liberazione, le forze politiche superarono quel clima di collaborazione appena instaurato e fecero pre- valere le divisioni e le contrapposizioni ideologiche, acuite dal contesto internazionale. Gli aiuti economici per la ricostruzione del Paese, assi- curati dal presidente degli Usa Truman, ebbero come conseguenza l'e- sclusione dei comunisti dal Governo che allora comprendeva ancora i partiti membri del Comitato di Liberazione Nazionale, con le dimissioni del presidente del consiglio Alcide De Gasperi (13 maggio 1947) e la nascita il 1° giugno ’47 del IV governo sempre presieduto da De Gasperi e costituito da DC - PLI - PSLI - PRI. -

Nuovi Lavori
NUOVI LAVORI NEWSLETTER APPROFONDIMENTI n.271 del 23 02 2021 Marini: il sociale e la politica: unica passione I temi trattati 1. Era per un di più di responsabilità (Raffaele Morese) 2. Un impegno politico onesto e autentico (Sergio Mattarella) 3. Un sindacalista, un maestro di vita (Anna Maria Furlan) 4. Siamo tutti figli e il pane è per tutti (Domenico Pompili) 5. Un uomo di poche parole, un politico appassionato (Maria Grazia Casellati) 6. Quando idealismo e pragmatismo convivono bene (Tiziano Treu) 7. Sulle spalle di un gigante (Andrea Orlando) 8. Chi era per me, Franco (Sandro Marini) 9. Il sindacato, casa comune e passione solidale (Giorgio Benvenuto) 10. Sindacalista e politico di grande valore (Sergio Cofferati) 11. Quando mi schierai con lui (Giuliano Cazzola) 12. Una bella esperienza di equilibrio e tenacia ( Franco Aloia) 13. Uomo consapevole della complessità della realità (Fausto Tortora) 14. Sapeva ascoltare, rispettava le diversità (Mario Colombo, Raffaele Morese) 15. Marini, un combattente. Il ricordo di Castagnetti (Federica Fantozzi) 16. Tra noi, neanche il minimo screzio (Concetto Vecchio) 17. Un forte legame, al di là delle diverse visioni(Gianfranco Morando) 18. Una bussola per i cattolici (Giorgio Merlo) 19. Una vita intensa ed esemplare (Michele Dau) 1. Era per ''un di più'' di responsabilità Raffaele Morese Per Franco Marini sono state espresse molte belle e sincere parole. Quasi nessuna di circostanza. Le avrebbe sicuramente gradite, anche se era poco portato ad accettarle e a fare complimenti. Non sarò io a venir meno a questo stile. Ma sicuramente mi riconosco in quelle che hanno riguardato il suo contributo, dato senza risparmio di energie, per il riscatto sociale e di dignità delle lavoratrici e dei lavoratori e per il consolidamento della democrazia nel nostro Paese, in tempi difficili. -

Settimana 09.04.06 - 18.09.06
Settimana 09.04.06 - 18.09.06 9-10 aprile - Si svolgono le elezioni politiche cui partecipano - per la prima volta, grazie alla neoistituita circoscrizione Estero - anche gli italiani residenti all'Estero. La coalizione di centro-sinitra. si afferma, sebbene con uno scarto molto ridotto, sulla coalizione di centro-destra. Alla Camera, l'Unione ottiene 19.001.684 voti (pari 49,8 per cento delle preferenze) e - grazie al premio di maggioranza - 340 seggi, mentre la Casa delle libertà con 18.976.460 voti (pari al 49,73) ottiene 277 seggi. All'Unione andranno anche sette dei dodici seggi assegnati nella Circoscrizione Estero. Al Senato, la Casa delle libertà ottiene - senza considerare la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige -17.153.256 (pari al 50,2 per cento) e 153 seggi, mentre l'Unione ottiene 16.725.077 voti (pari al 48,95 per cento) e 148 seggi. Per ottenere la maggioranza dei senatori elettivi al Senato (158 a 156, con un indipendente) risultano determinanti per l'Unione i senatori eletti all'Estero. L'affluenza alle urne registra un incremento, raggiungendo l'83,5 per cento. 28 aprile - Si tiene la prima seduta delle Camere della XV legislatura, con all'ordine del giorno l'elezione dei rispettivi presidenti. Il 29 aprile, Fausto Bertinotti, al quarto scrutinio, viene eletto Presidente della Camera con 337 voti. In tale scrutinio Massimo D'Alema, che aveva rinunciato a "correre" per la Presidenza, ottiene 100 voti, presumibilmente da deputati dell'opposizione. Al Senato - dopo l'annullamento di uno scrutinio, tra le proteste del centrodestra, non essendo stato trovato un accordo tra i segretari provvisori circa l'attribuzione di tre schede contestate, recanti il nome "Francesco Marini" - Franco Marini viene eletto, al terzo scrutinio, con 165 voti a favore (tre più della maggioranza assoluta dei componenti del Senato), contro i 156 voti andati al senatore Andreotti, candidato e sostenuto dal centrodestra. -

L'uomo Che Sussurrava Ai Barbari
ANNO XXIII NUMERO 218 - PAG V IL FOGLIO QUOTIDIANO SABATO 15 E DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018 L’UOMO CHE SUSSURRAVA AI BARBARI Da De Gasperi a Forlani, da Tangentopoli al Cav. Ora Vincenzo Scotti è il precettore della Terza Repubblica parlare dei Cinque stelle, in termini di Salvatore Merlo quasi disincarnati, è come se Di Maio e Toninelli, Paola Taverna e Alessan- o fatto in tempo a ve- dro Sibilia sparissero nelle parole di Hdere De Gasperi”, Scotti, con la loro mania di esprimere, dice. E adesso dà del tu a in una forma confusa e con termini Luigi Di Maio. E c’è forse maldestramente usati, pensieri lapa- tutta l’Italia, la sua storia lissiani e sentimenti incerti, tanto vio- e la sua politica, i suoi lenti e aggressivi quanto indetermina- spasmi involuti, in que- ti. Ci sono facce che non si combinano A TU PER TU - 34 bene con il pensiero complesso. Ma a Scotti la diffidenza appare inutile e sto lungo viaggio dall’uomo perfetta- misera, come gli ultimi resti di una mente grigio che non annunciava rivo- educazione ormai inservibile eppure luzioni, fino all’intossicazione di chiac- dura a morire. chiere e pernacchie del 2018, un grovi- Piccolo, magro, la polo blu sui panta- glio che porta il suggestivo nome di loni neri, i mocassini consumati, un’in - “cambiamento” e sembra incarnare an- telligenza estrema che gli traspare dal- cora una volta l’eterna rivoluzione ita- la pelle, come se le mani, il mento, la liana, dai moti di Reggio Calabria a Tan- schiena curva, tutte le parti del suo gentopoli, l’Italia dal metabolismo ac- corpo meditassero e capissero, Vin- celerato, gli umori e i furori, il plebei- cenzo Scotti si è mosso cavalcando due smo che si fa stato in un paese irrisolto.