Scarica Il Fascicolo N. 53-54
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
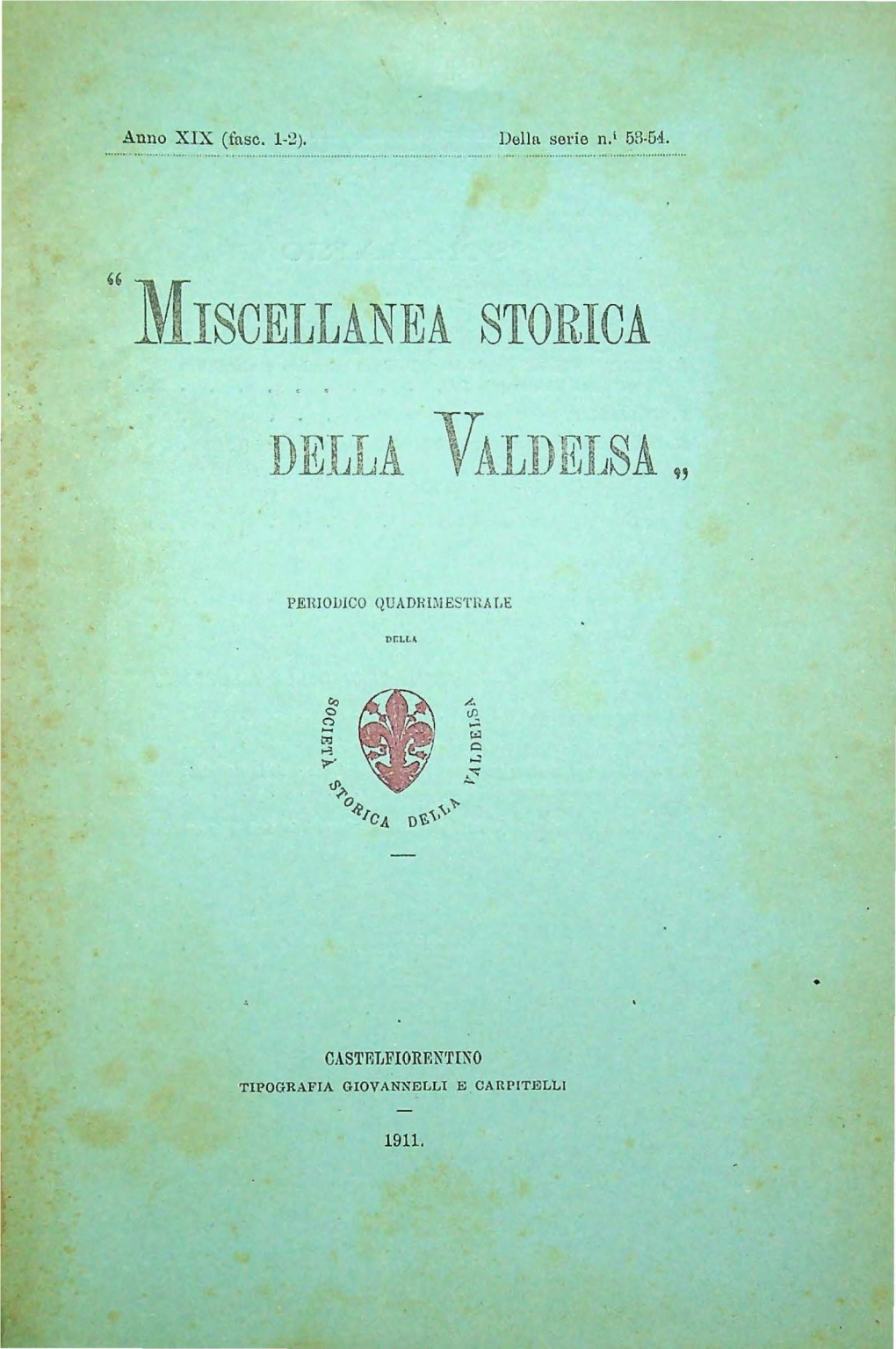
Load more
Recommended publications
-

Anagrafe Delle Societa' Della Delegazione Provinciale Di
ANAGRAFE DELLE SOCIETA’ DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 TEL.:050/26021-050/40938 FAX.:050/7912129 1 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- *** POL. A.BELLANI A.S.D. Matr.750137 2 Categoria - Girone:E Indirizzo - VIA S.JACOPO, 121 56123 PISA Tel.Sede-050/560093 Fax-050/560093 E-Mail:[email protected] Invio corrispond. c/o - SEDE Campo di giuoco - *V. BRONZINI* Tel.-050/560093 Indirizzo - VIA S.JACOPO, 121 PISA Colori sociali - ROSSOBLU Riserva - NERO Presidente - GUIDI FLAVIO Tel.abit-050/552814 Tel.Cell-335/7631576 Dirig.ch.urg. – POSSENTI MAURIZIO Tel.abit-050/28041 Tel.Cell-339/6672019 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- *** A.S.D. ACCIAIOLO CALCIO Matr.920748 3 cat. D.P. Livorno - Girone:A Indirizzo - VIA MARCONI, 4/A 56043 ACCIAIOLO FAUGLIA PI Tel.Sede-050/650831 Fax-050/650305 E-Mail:[email protected] Invio corrispond. c/o - SEDE Campo di giuoco - COMUNALE VAL DI TORA Tel.- Indirizzo campo - VIA PROVINCIALE VAL DI TORA ACCIAIOLO FAUGLIA PI Colori sociali - GIALLOBLU Riserva - VARI Presidente - DI GIAMBATTISTA TONINO Tel.abit-050/650831 Tel.Cell-348/2652259 Dirig.ch.urg.– MARTINUCCI DANIELE - BIASCI VALERIO - BETTI BRUNO Tel.Cell-349/4981938 – Tel.Cell-329/4151240 – Tel.Cell-347/5949884 ------------------------------------------------------------------------- -

Comunicato Ufficiale N. 13 Del 03/09/2019
Comunicato Ufficiale n. 13 del 03/09/2019 Stagione Sportiva 2019/2020 1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. ......................................................................................................................................... 364 2. COMUNICAZIONI L.N.D............................................................................................................................................. 367 3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE ............................................................................................................ 368 3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO .........................................................................................................................................................368 3.1.1. ASSEGNAZIONE SOCIETÀ ALLE DELEGAZIONI PROVINCIALI.....................................................................................369 3.1.2. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 ..................................................................402 3.1.3. CRITERI DI AMMISSIONE DEI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 2020/2021 .................................404 3.2. SEGRETERIA ..........................................................................................................................................................................410 3.2.1. CALENDARIO ED ELENCO CAMPI DEI CAMPIONATI DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA ......................................410 3.2.2. RICHIESTE VARIAZIONI DATA, ORARIO E CAMPO DI GIUOCO ...................................................................................410 -

Viva Xpress Logistics (Uk)
VIVA XPRESS LOGISTICS (UK) Tel : +44 1753 210 700 World Xpress Centre, Galleymead Road Fax : +44 1753 210 709 SL3 0EN Colnbrook, Berkshire E-mail : [email protected] UNITED KINGDOM Web : www.vxlnet.co.uk Selection ZONE FULL REPORT Filter : Sort : Group : Code Zone Description ZIP CODES From To Agent IT ITAOD04 IT- 3 Days (Ex LHR) Cities & Suburbs CIVITELLA CESI 01010 - 01010 CELLERE 01010 - 01010 AZIENDA ARCIONE 01010 - 01010 ARLENA DI CASTRO 01010 - 01010 FARNESE 01010 - 01010 LATERA 01010 - 01010 MONTEROMANO 01010 - 01010 ONANO 01010 - 01010 PESCIA ROMANA 01010 - 01010 PIANSANO 01010 - 01010 TESSENNANO 01010 - 01010 VEIANO 01010 - 01010 VILLA S GIOVANNI IN TUSC 01010 - 01010 MUSIGNANO 01011 - 01011 CELLENO 01020 - 01020 CHIA 01020 - 01020 CASTEL CELLESI 01020 - 01020 CASENUOVE 01020 - 01020 GRAFFIGNANO 01020 - 01020 LUBRIANO 01020 - 01020 MUGNANO 01020 - 01020 PROCENO 01020 - 01020 ROCCALVECCE 01020 - 01020 SAN MICHELE IN TEVERINA 01020 - 01020 SERMUGNANO 01020 - 01020 SIPICCIANO 01020 - 01020 TORRE ALFINA 01020 - 01020 TREVIGNANO 01020 - 01020 TREVINANO 01020 - 01020 VETRIOLO 01020 - 01020 ACQUAPENDENTE 01021 - 01021 CIVITA BAGNOREGIO 01022 - 01022 BAGNOREGIO 01022 - 01022 CASTIGLIONE IN TEVERINA 01024 - 01024 GROTTE SANTO STEFANO 01026 - 01026 MAGUGNANO 01026 - 01026 CASTEL S ELIA 01030 - 01030 CALCATA 01030 - 01030 BASSANO ROMANO 01030 - 01030 FALERIA 01030 - 01030 FABBRICA DI ROMA 01034 - 01034 COLLEMORESCO 02010 - 02010 COLLI SUL VELINO 02010 - 02010 CITTAREALE 02010 - 02010 CASTEL S ANGELO 02010 - 02010 CASTEL SANT'ANGELO 02010 -

Val Di Cecina.FH10
24 129 44 S. Lucia Agliati Nebbiano 5 Il Pero 5 PONSACCO M. RUGLIOLI Casastrada Lavoria 3 Dogana 108 5 4 Il Trivio Barbialla 3 2 La Turchia 186 S. Martino 4 a 4 1 Cenaia Quattro 4 Montacchita Gello Collelungo CASTELFIORENTINO 50 Vecchia Strade in 6. Forcoli Bagni Voltigiano 6 2 Perignano 3 Camugliano Partino Collegalli S. Stefano S. Chiara 3 4 sc 2 27. Alica Renacchi 2 a PALAIA 5 Cenaia 2 2. PROV. 5.5 C 439 2 -Le Casine 6 Villa 1 148 31. Lucagnano Medicea C. Profeti Volpaia Baccanella 6 193 4 F. Villa Saletta Orceto Solaia Srada 3 L' Olmo Toiano Le Cascine Petrazzi 5 5 3 4 Case 4. -Spinelli 6 62 La Capannina CAPANNOLI 1 Nuove Ceppaiano Convento Tinti dei Mori 5 3.5 4 Montefoscoli M. LA COLLINA Alberi Siberia Catelani SS. Annunziata 207 5. 7. Ripoli 2 Le Selve 5 Piazza 2 182 Sughera Tripalle 4 Mura 7 Colle Capavoli 3 193 C. Ferri 5 6 3. Cevoli S. Pietro Legoli 217 Varna 5 236 T. Egola DI Pillo 1. 147 Belvedere 3 4. 91 3 Sala Ripalta 5 Botteghino 2. S. Caterina Catignano 108 2 S. Ruffino 3. Sorgente 5 3. 5 Salsa CERTALDO FAUGLIA CRESPINA Tonda 5 LARI Chientina Selvatelle 5 Pratello 3 3. 194 MONTAIONE S. Pancrazio Soianella T. T Pieve . -Castelluccio Vicchio Libbiano 372 di S. Maria 5 272 Soiana 6 C 3. Gramugnana PECCIOLI R a 2. Usigliano 5 1. o r f 2. La Rosa g 4.5 alo 332 1 5 7 3 li 2.5 5 Badia a 5 1.5 o Ghizzano Castelfalfi Croce Badia di Casanova 3 Cerreto Tremoleto Casciana Morrone 144 6 GAMBASSI S. -

Elenco Degli Edifici Monumentali
MISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ELENCO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI X X X III Provincia di Pisa ROMA TIPOGRAFIA DELL'UNIONE EDITRICE Via Federico Cesi, 45 1921 AVVERTENZA L'idea di formare un catalogo di tutto il patri monio artistico dello Stato risale assai addietro nel tempo. Già l'imperatore Costantino aveva ordmata una statistica degli edifici e delle opere pubbliche che erano allora nelle quattordici re gioni delle città di Roma, donde risultarono, tra le altre opere, 22 statue equestri, 423 templi con 80 statue d’oro e 77 d’avorio e 1352 fontane. Quattordici secoli più tardi, il 20 aprile 1773, il Consiglio dei Dieci di Venezia comandava che fosse compilato il catalogo generale dei più insigni dipinti esistenti nei confini della Serenissima ; ma questo elenco aveva natura di semplice in ventario, di accertamento della consistenza patri moniale della Repubblica, senza effetti giuridici determinati. Questi invece cominciano ad appa rire connessi col catalogo delle opere d’arte nel l'editto Pacca del 7 aprile 1820, il quale, ordi nando la formazione di un elenco degli oggetti artistici più preziosi dello Stato Pontificio, im poneva alle commissioni preposte alla loro conser vazione di esaminarli « presso qualunque proprie tario e possessore ». Unificate le varie provincie in un solo regno, il concetto di porre il catalogo dei monumenti e delle opere d’arte a fondamento di ogni sanzione — fi legislativa appare in quasi tutti i disegni di legge presentati all’esame del Parlamento. Non com preso nel progetto Coppino del 31 maggio 1887, vi fu introdotto dalla Commissione parlamentare che volle la formazione di un unico catalogo degli immobili. -

Popolazione Delle Frazioni Geografiche E Delle Località Abitate Dei Comuni (20 Faseicoli 1'Egionali E Una Appenrliee Con Le Tavole Riassuntive) Voi
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 11° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 24 OTTOBRE 1971 VOLUME III POPOLAZIONE DELLE, FRAZIONI GEOGRAFICHE E DELLE LOCALITA ABITATE, DEI COMUNI FASCICOLO 9 TOSCANA ROMA - 1974 06 74 - Contratto del 20-12-1972 - (c. 1.400) - Soc. A.B E.T.E. - Roma INDICE AVVERTENZE . Pago V PROVINCIA DI MASSA-CARRARA TAVOLA 1 - Superficie territoriale e densità - Numero delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei - Popolazione residente per tipo di località abitata ......................... » 2 TAVOLA 2 - Altitudine e popolazione residente dei comuni, delle frazioni geografiche e delle località abitate . » 3 PROVINCIA DI LUCCA TAVOLA 1 - Superficie territoriale e densità - Numero delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei - Popolazione residente per tipo di località abitata ......................... » 12 TAVOLA 2 - Altitudine e popolazione residente dei comuni, delle frazioni geografiche e delle località abitate ..... » 13 PROVINCIA DI PISTOIA TAVOLA 1 - Superficie territoriale e densità - Numero delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei - Popolazione residente per tipo di località abitata ......................... » 30 TAVOLA 2 - Altitudine e popolazione residente dei comuni, delle frazioni geografiche e delle località abitate ... .. » 31 PROVINCIA DI FIRENZE TAVOLA 1 - Superficie territoriale e densità - Numero delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei - Popolazione residente per tipo di località abitata ...... ................. » 38 TAVOLA 2 - Altitudine e popolazione residente dei comuni, delle frazioni geografiche e delle località abitate .... » 39 ì 1 t IV i lNDICE I ! I I PROVINCIA DI LIVORNO TAVOLA 1 - Superficie territoliale e jdensità - Numero delle frazioni geografiche, dei centri e ~ei nuclei - Popolazione residente per tipo di località abitata .1... !. Pago 56 I TAVOLA 2 - Altitudine e pop~~~zio~e iresidente dei comuni, delle frazioni geografiche e delle locahta ablt,te . -

LDC2018 Classifica Definitiva Toscana.Xlsx
9° CENSIMENTO NAZIONALE I LUOGHI DEL CUORE CLASSIFICA REGIONALE TOSCANA POS. POS. REGIONE PROVINCIA COMUNE LUOGO TOTALE VOTI REGIONALE NAZIONALE 1 1 TOSCANA PISA CALCI MONTE PISANO 114.670 2 7 TOSCANA PISA PISA CHIESA DI SAN FRANCESCO A PISA 24.997 3 26 TOSCANA PRATO PRATO ORATORIO DI SAN BARTOLOMEO 14.162 4 35 TOSCANA PISTOIA PISTOIA IL PARTERRE DI PISTOIA 11.030 5 44 TOSCANA PISA SAN GIULIANO TERME ROCCA DI RIPAFRATTA 8.922 6 46 TOSCANA FIRENZE GREVE IN CHIANTI PIEVE DI SAN PIETRO A SILLANO 8.536 LA GUALCHIERA DI COIANO, O MULINO 7 55 TOSCANA PRATO PRATO NALDINI 7.180 GIARDINO ATELIER DI SCULTURA DEL 8 59 TOSCANA PISA SAN GIULIANO TERME MAESTRO SPOSITO 6.838 9 61 TOSCANA FIRENZE VINCI SAN DONATO IN GRETI-VINCI 6.651 10 71 TOSCANA GROSSETO MONTE ARGENTARIO TORRE DI CAPO D'OMO 5.617 11 130 TOSCANA LUCCA CASTELNUOVO DI GARFAGNANA FORTEZZA DI MONTALFONSO 3.573 12 136 TOSCANA PISA CAPANNOLI MARGINETTE, LE VIE DEL CUORE 3.372 13 137 TOSCANA FIRENZE BAGNO A RIPOLI GUALCHIERE DI REMOLE 3.360 14 143 TOSCANA FIRENZE VICCHIO EX STAZIONE DI FORNELLO 3.312 15 183 TOSCANA PISTOIA PESCIA CARTIERA LE CARTE 2.611 16 186 TOSCANA MASSA CARRARA TEATRO POLITEAMA 2.485 17 193 TOSCANA FIRENZE REGGELLO CASTELLO E PARCO DI SAMMEZZANO 2.382 18 208 TOSCANA PISA CALCI CERTOSA DI CALCI 2.001 19 209 TOSCANA GROSSETO ROCCASTRADA CRIPTA DELL'ABBAZIA GIUGNANO 1.982 20 228 TOSCANA FIRENZE FIRENZE GALLERIA RINALDO CARNIELO 1.512 21 230 TOSCANA GROSSETO ARCIDOSSO STRIBUGLIANO 1.486 22 242 TOSCANA LUCCA BAGNI DI LUCCA CHIESA DI SAN CASSIANO IN CONTRONE 1.253 23 245 TOSCANA -

Polimetriche
TABELLE POLIMETRICHE CPT LINEA 10 PISA - TIRRENIA - LIVORNO Pisa *2,0 Porta a Mare *4,0 *2,0 Luicchio *4,0 *2,0 / La Vettola *6,0 *4,0 / *2,0 S. Piero 7,0 5,0 3,0 4,0 2,0 Bivio S. Piero 12,0 10,0 8,0 9,0 7,0 5,0 Marina di Pisa 16,8 14,8 12,8 13,8 11,8 9,8 4,8 Tirrenia 21,7 19,7 17,7 18,7 16,7 14,7 9,7 4,9 Calambrone 30,0 28,0 26,0 27,0 23,0 25,0 18,0 13,2 8,3 Livorno Note: * Tratta urbana CPT LINEA 50 CRESPINA - COLLESALVETTI - PISA Crespina 2,8 Tripalle 6,2 3,4 Fauglia 11,2 8,4 5,0 Collesalvetti 13,9 10,7 7,7 2,7 Vicarello 17,8 15,0 11,6 6,6 3,9 Arnaccio 23,3 20,5 17,1 12,1 9,4 5,5 Ospedaletto 27,1 24,3 20,9 15,9 13,2 9,3 3,8 Pisa CPT LINEA 51 ORCIANO - LORENZANA - COLLESALVETTI Orciano 7,1 Lorenzana 9,1 2,0 Laura 11,3 4,2 2,2 Acciaiolo 14,8 7,7 5,7 3,5 Torretta 12,8 5,7 3,7 \ \ Botteghino di Tripalle 16,2 9,1 7,1 \ \ 3,4 Fauglia 18,6 11,5 9,5 7,3 3,8 8,4 5,0 Collesalvetti CPT LINEA 70 PISA - GELLO - PONTASSERCHIO - MARINA DI VECCHIANO Pisa 5,8 Cascine di Gello 6,5 / Cottolengo 8,2 / 1,7 S. -

Primo O Piazzato, Seguendo La Sua Il Cappello Rotondo, Con Larga Falda Piatta, in Paglia No, Monaci, Marchionneschi, Del Buono, Pitigliani Ecc
nn, ~~~~~ir 1"1418~. ANNO VIII. Pisa, Domenica '15 Luglio 1900. Num. 28. • isa• GIORNALE POLITICO AMMINISTRATIVO DELLA CITTÀ E PROVINCIA. AtttiON per te n anno lire::: per un semestre lire 3. Per abbonarsi .ttA : per avvisi rictome in prima pagina lire 8; in seeanda lire 1,50; basta mandare una cartolina vaglia all'amministrazione del Ponte; di Pisa. in terza lire 1,00; in quarta lire 0,50 per ogni linea o spazio dì linea. O Cedri di Redazione e Amministrazione: Piazza dei Cavalieri, num. 5. Pisa. Si pubblica la Domenica. Per avvisi finanziari. industriali, oommeroiali; per inserzioni; per necrologio, (Conto corrente con fa Posta). por rdriatud in cronaca, diffide, comunicati. ecc. eoc.: prezzi da contrattarsi. 111111111. Non parliamo della costituzione di Comitati elet- nostro, è bene che le classi dirigenti non si stac- al mare. È stato detto la questione dei ponti doversi torali permanenti senza che un partito si sia formato, chino dalle masse lavoratria; esse, sopra tutto collegare con un piano generale di riordinainento Il nuovo partito Gli è come pretendere di edificare senza fondamenta nelle campagne, dovrebbero tenere frequenti, af- delle comunicazioni, magari elettrico-trainviarie, inter- «MI e senza aver prestabilito ciò che si vuole edificare. fettuosi rapporti coi contadini, dimostrando non provinciali ecc. Ma, scetticismi elettorali a. parte, se Nell'ora presente essi avrebbero per risultato di fa- solo interesse ali' azienda, ina anche cordialità ha da venire dav vero, ben venga questo gran pro- Richiamare a novella vita le falangi liberali, muo- getto! Come per quasi tutte le cose grandi ci vorrà vere con esse alle future battaglie della vita sociale, vorire l' elezione di uomini che troppo facilmente si per quelli che la fanno prospera. -

THE BERNARD and MARY BERENSON COLLECTION of EUROPEAN PAINTINGS at I TATTI Carl Brandon Strehlke and Machtelt Brüggen Israëls
THE BERNARD AND MARY BERENSON COLLECTION OF EUROPEAN PAINTINGS AT I TATTI Carl Brandon Strehlke and Machtelt Brüggen Israëls GENERAL INDEX by Bonnie J. Blackburn Page numbers in italics indicate Albrighi, Luigi, 14, 34, 79, 143–44 Altichiero, 588 Amsterdam, Rijksmuseum catalogue entries. (Fig. 12.1) Alunno, Niccolò, 34, 59, 87–92, 618 Angelico (Fra), Virgin of Humility Alcanyiç, Miquel, and Starnina altarpiece for San Francesco, Cagli (no. SK-A-3011), 100 A Ascension (New York, (Milan, Brera, no. 504), 87, 91 Bellini, Giovanni, Virgin and Child Abbocatelli, Pentesilea di Guglielmo Metropolitan Museum altarpiece for San Nicolò, Foligno (nos. 3379 and A3287), 118 n. 4 degli, 574 of Art, no. 1876.10; New (Paris, Louvre, no. 53), 87 Bulgarini, Bartolomeo, Virgin of Abbott, Senda, 14, 43 nn. 17 and 41, 44 York, Hispanic Society of Annunciation for Confraternità Humility (no. A 4002), 193, 194 n. 60, 427, 674 n. 6 America, no. A2031), 527 dell’Annunziata, Perugia (Figs. 22.1, 22.2), 195–96 Abercorn, Duke of, 525 n. 3 Alessandro da Caravaggio, 203 (Perugia, Galleria Nazionale Cima da Conegliano (?), Virgin Aberdeen, Art Gallery Alesso di Benozzo and Gherardo dell’Umbria, no. 169), 92 and Child (no. SK–A 1219), Vecchietta, portable triptych del Fora Crucifixion (Claremont, Pomona 208 n. 14 (no. 4571), 607 Annunciation (App. 1), 536, 539 College Museum of Art, Giovanni di Paolo, Crucifixion Abraham, Bishop of Suzdal, 419 n. 2, 735 no. P 61.1.9), 92 n. 11 (no. SK-C-1596), 331 Accarigi family, 244 Alexander VI Borgia, Pope, 509, 576 Crucifixion (Foligno, Palazzo Gossaert, Jan, drawing of Hercules Acciaioli, Lorenzo, Bishop of Arezzo, Alexeivich, Alexei, Grand Duke of Arcivescovile), 90 Kills Eurythion (no. -

Piano Di Protezione Civile Dell'unione Valdera
UNIONE VALDERA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELL’UNIONE VALDERA Redazione Adozione Approvazione Aggiornamento Aggiornamento Aprile 2014 Del. Xxx 16/04/2014 Unione Valdera Piano di Protezione Civile – Aprile 2014 Piano redatto a cura del Servizio Protezione Civile e Ambiente dell'Unione Valdera Dirigente Area Servizi Tecnici Arch. Massimo Parrini Responsabile del Servizio Protezione Civile Dott. Geol. Andrea Sodi Collaboratori Dott. Geol. Silvia Lorenzoni Dott. Geol. Elena Baldi Dott. Geol. Fabrizio Meini Ing. Massimo Saleppichi Cartografie P3 snc Hanno inoltre collaborato: Bacci Massimiliano – Comune di Peccioli Becuzzi Egiziano – Comune di Calcinaia Ceccanti Daniele – Comune di Fauglia Cecchi Marco – Comune di Bientina Doveri Franco – Comune di Palaia Falchi Stefano - Comune di Ponsacco Giusti Luciano – Comune di Capannoli Granchi Marcello – Comune di Chianni Giannelli Massimo – Comune di Lajatico Montanelli Giancarlo – Comune di Lari Paoli Pieranna – Comune di Ponsacco Ponticelli Michele – Comune di Palaia Turchi Riccardo – Comune di Lari Zaccagnini Alessandro – Comune di Ponsacco Si ringraziano per l’amichevole collaborazioni: Dott. Carlo Meletti – INGV di Pisa per la parte sul rischio sismico Bechelli Stefano – Meteotoscana per la parte sui fenomeni meteorologici Dott. Antonio Campus per i confronti e le revisioni sul modello organizzativo Unione Valdera Piano di Protezione Civile – Aprile 2014 Sommario PREMESSA ................................................................................................................................... -

Manutenzioni Acquedotto - ACQUE Spa
Manutenzioni Acquedotto - ACQUE spa ALLEGATO 2 - Dettaglio manutenzione programmata delle reti PdI preventivo – 2020-2023 CT. 2 Basso Valdarno - GESTORE: Acque S.p.A. ACQUEDOTTO - manutenzione programmata rete acquedotto su manutenzione straordinaria totale rete acquedotto (% €prog/€ man.str.): 58 % costo produzione € quadriennali previsti km materiali km plastici o mc ingresso al n. riparazioni condotta n. riparazioni su Trend medio km km co gestione km controllo attivo km previsti in Area operativa Comune Codice rete DB infrastr. Distretto km Utenze totali servite D medio Criticità risorsa risorsa mc fatturati ILI distretto di manutenzioni Cod_AIT Intervento Note metallici altro distretto principale allacci rotture modellati pressione perdite sostituzione (€/mc) sostituzioni EMPOLESE Capraia e Limite AD00877 ADD. GREZZA CENTR CASTRA 1,22 1,22 63 - - EMPOLESE Capraia e Limite AD00878 ADD. GREZZA POZZI PIANALI 0,89 0,89 63 - - EMPOLESE Capraia e Limite AD00937 ADD. GREZZA SORGENTE LE CAVE 1,69 0,01 1,68 72 - EMPOLESE Capraia e Limite DI00111 RETE ACQ DI CASTRA 6,85 4,02 2,83 143 70 78.157 75.688 6 1 0,38 EMPOLESE Capraia e Limite DI00112 RETE ACQ DI CAPRAIA E LIMITE 31,91 14,77 17,14 3.149 90 363.920 308.725 20 27 31,77 ADD. BASSA PER DEPOSITO LA EMPOLESE Cerreto Guidi AD00159 FERRUZZA FUCECCHIO 8,14 2,45 5,69 254 12 8,16 ADD. CENTR. BASSA PER EMPOLESE Cerreto Guidi AD00822 DEPOSITO CORLIANO 4,95 4,95 - 0,00 223 8 4,95 EMPOLESE Cerreto Guidi AD00842 ADD. GREZZA POZZI CENTR. BASSA 2,06 0,50 1,56 206 1 2,05 EMPOLESE Cerreto Guidi AD00941 ADD.