SG.ED.04 - Relazione Paesaggistica.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
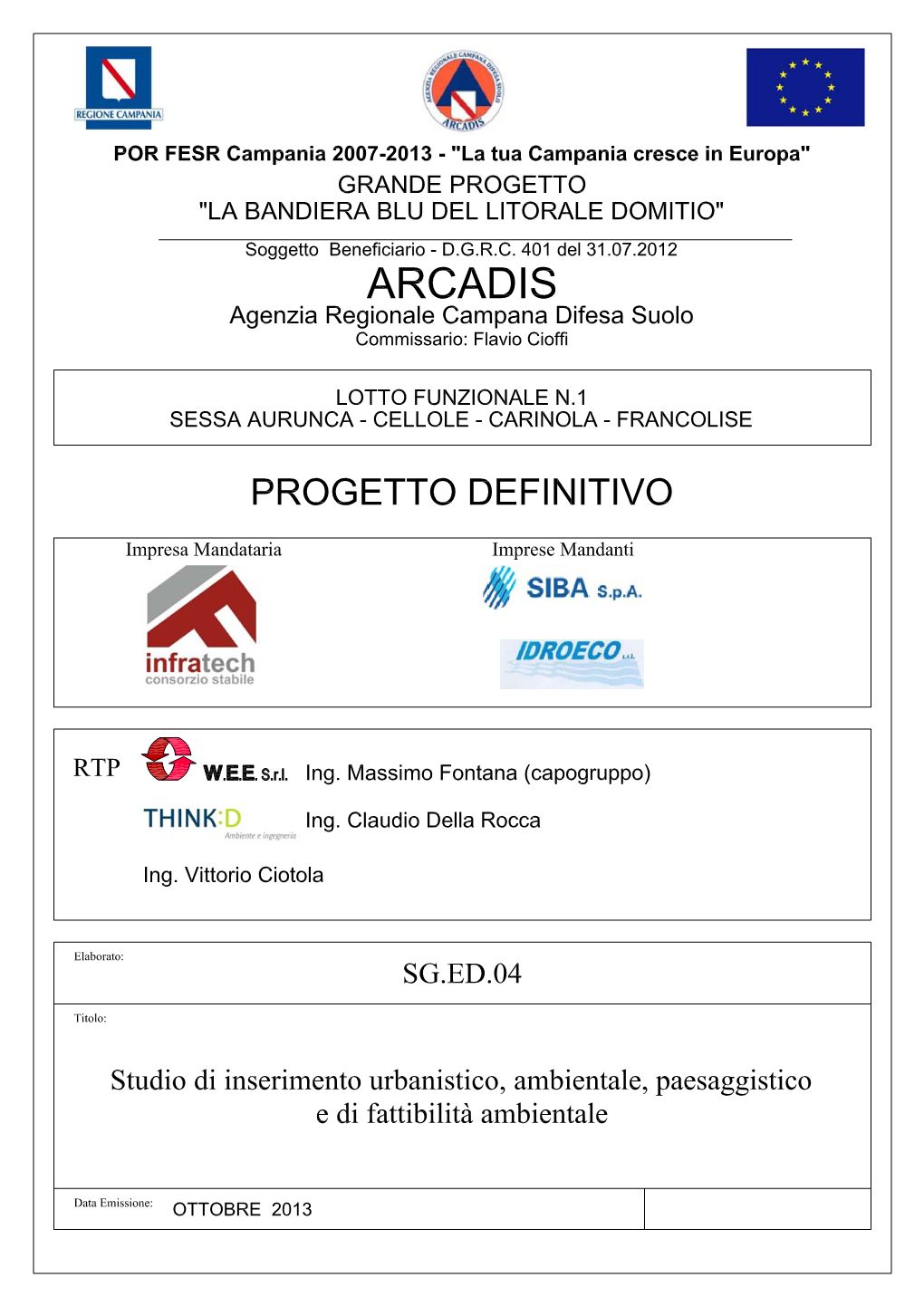
Load more
Recommended publications
-

Carta Dei Servizi
Carta dei Servizi Teano Ente Capofila, Caianello, Cellole, Conca della Campania, Francolise, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Pietravairano, Presenzano, Roccamonfina, Rocca D’Evandro, San Pietro Infine, Sessa Aurunca, Tora e Piccilli e Vairano Patenora. Presentazione La riforma del welfare locale, basata su una gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali, è stata perseguita da tutti i soggetti dell’Ambito territoriale C03 in modo forte e deciso. E ’ stato avviato, infatti, con un processo, innanzitutto culturale, di attenzione alle politiche sociali non più pensate come una somma di interventi generalizzati, ma come sistema capace di lavorare per la garanzia dei diritti, la qualità dei servizi, la tutela dei minori e la crescita responsabile delle comunità. I nostri interventi hanno mirato e continueranno a mirare ad accompagnare gli individui e le famiglie lungo tutto il corso della vita, riconoscendone i bisogni legati alle diverse fasi e a particolari circostanze biografiche, sostenendo e promuovendo le capacità individuali e delle reti familiari, nonché favorendo le iniziative di aiuto e di mutuo soccorso. La programmazione sociale messa in atto dai Comuni e dagli Ambiti territoriali rappresenta un periodo intenso per le opportunità che offre ai sistemi locali di ripensare la struttura del welfare. Ma è molto intenso anche per i forti cambiamenti che ha portato con sé e per i processi di innovazione organizzativa e procedurale che ha attivato nei sistemi amministrativi locali, consentendo una sostanziale rivisitazione delle funzioni di programmazione e monitoraggio delle politiche sociali ed un forte rinnovamento dei rapporti tra gli Enti locali e tutti i soggetti del Terzo Settore, gli altri soggetti privati e le altre istituzioni pubbliche. -

Linea L30 Baia Domitia – Mondragone – Napoli
Provincia di Caserta - Settore Trasporti, Mobilità e Infrastrutture Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Caserta Dipartimento di Ingegneria - Università del Sannio LINEA L30 BAIA DOMITIA – MONDRAGONE – NAPOLI Numero coppie corse Codice Nome Descrizione 7:00-9:00 13:00-15:00 17:00-19:00 Totale Giorno Percorrenza Media A+R Km Tipologia Giorni esercizio Percorrenze Annue Mondragone Napoli P.le Tecchio 4 4 4 16 108 Feriale 305 527.040,00 Mondragone Napoli P.le Tecchio 2 2 2 8 108 Festive 57 49.248,00 Mondragone Napoli P.le Mondragone Licola Staz. EAV 0 0 0 12 76 Feriale 305 278.160,00 L30 Tecchio Mondragone Licola Staz. EAV 0 0 0 6 76Festive 57 25.992,00 Baia Domitia Mondragone Napoli P.le 1 1 1 4 140Feriale 305 170.800,00 Km Totali Baia Domitia Mondragone Napoli P.le 1 1 1 3 140Festive 57 23.940,00 1.075.180,00 Tecchio 123 Provincia di Caserta - Settore Trasporti, Mobilità e Infrastrutture Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Caserta Dipartimento di Ingegneria - Università del Sannio LINEA L31 MONDRAGONE – GIUGLIANO - NAPOLI Numero coppie corse Codice Nome Descrizione 7:00-9:00 13:00-15:00 17:00-19:00 Totale Giorno Percorrenza Media A+R Km Tipologia Giorni esercizio Percorrenze Annue Km Totali Mondragone Napoli via Mondragone Castel Volturno Giugliano Circumvallazione Staz. L31 Villaricca Mugnano Napoli Metro Piscinola Piscinola 3 2 2 15 104Feriale 305 475.800,00 475.800,00 124 Provincia di Caserta - Settore Trasporti, Mobilità e Infrastrutture Programma -

Con Socio Unico
TERRA DI LAVORO SPA - CON SOCIO UNICO Società per i Servizi Globali di Manutenzione Urbana Provincia di Caserta ELENCO MANUTENTORI ADERENTI ALL'ACCORDO VOLONTARIO DEL 11/03/2009 TRA TERRA DI LAVORO SPA - ASSOCIAZIONI IMPRESE/ARTIGIANI - ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI AI QUALI E' POSSIBILE RIVOLGERSI PER AVERE L'APPICAZIONE DEL BOLLINO VERDE E ARANCIONE aggiornato al 08/02/2010 N ZONA DENOMINAZIONE INDIRIZZO CAP CITTA' TELEFONO FAX E_MAIL REF. 1 D'AMBROSIO NICOLA VIA S. SETTEFRATI N.19 81011 ALIFE 0823/918760 0823/918760 [email protected] D'AMBROSIO NICOLA 2 GUERRA STEFANO VIA STAZIONE N.41 81011 ALIFE 0823/783672 0823/783672 [email protected] GUERRA STEFANO 3 ALIFE DCP IMPIANTISTICA SPA VIA MATTEOTTI N. 30 81011 ALIFE 0823/28700 0823/918013 [email protected] PECE EMILIO 4 ALVIGNANO CENTRO BERETTA - DI LILLO VIA TRENTO N.07 81012 ALVIGNANO 0823/614157 0823/869819 [email protected] DI LILLO GIUSEPPE 5 ARIENZO ARRICALE VINCENZO VIA FONTANA VECCHIA N4 81021 ARIENZO 349/4605957 0823/1685747 [email protected] ARRICALE VINCENZO 6 ARCH. GOLIA NICOLA VIA I° TRV. SAN LORENZO(SC. P) N. 100 81031 AVERSA 081/8907656 081/8907636 GOLIA NICOLA 7 EDIL TECNOLOGY SAS DI MENDITTO RAFFAELE VIA SAN GIROLAMO N. 6 81031 AVERSA 081/8111084 081/2771813 [email protected] MENDITTO RAFFAELE 8 CLIMA SERVICE SAS VIA BOCCACCIO N. 27 81031 AVERSA 081/5045093 081/5045093 [email protected] IANNOTTA GIUSEPPE 9 CHECK SERVICE SAS DI STARNELLI CARMINE VIA PIRANDELLO N.27 81031 AVERSA 081/8902628 081/8154857 [email protected] STARNELLI CARMINE 10 AVERSA TECNOTHERM DI ANTONIO MALASOMMA VIA MICHELANGELO N.48 81031 AVERSA 081/5044455 081/5044455 [email protected] MALASOMMA ANTONIO 11 BELLONA OMNIMPIANTI SRL DELLA CIOPPA M. -

UBICAZIONI SEZIONI ELETTORALI PER SITO.Pdf
Numero TOTALE Descrizione Comune della Sede Indirizzo SEZIONI Sezione 1 AILANO 1 SedeMunicipale - 1° locale terraneo P.za C. A. Dalla Chiesa, n.7 2 AILANO 2 SedeMunicipale - 3° locale terraneo P.za C. A. Dalla Chiesa, n.7 3 ALIFE 1 EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA L.VESSELLA N.6 4 ALIFE 2 EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA L.VESSELLA N.6 5 ALIFE 3 EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA VIA VOLTURNO 6 ALIFE 4 EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA VIA VOLTURNO 7 ALIFE 5 EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA L.VESSELLA N.6 8 ALIFE 6 EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA L.VESSELLA N.6 9 ALIFE 7 EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE VIA TOTARI N.25 10 ALIFE 8 EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARARE S.MICHELEVIA PROV.LE PIEDIMONTE SANT'ANGELO 11 ALVIGNANO 1 Edificio Scuole Elementari C.so Umberto I 12 ALVIGNANO 2 Edificio Scuole Elementari C.so Umberto I 13 ALVIGNANO 3 Edificio Scuole Elementari C.so Umberto I 14 ALVIGNANO 4 Edificio Scuole Elementari C.so Umberto I 15 ALVIGNANO 5 Edificio Scuole Elementari C.so Umberto I 16 ARIENZO 1 SCUOLA MEDIA STATALE GALILEO GALILEI VIA CAPPELLA 17 ARIENZO 2 SCUOLA MEDIA STATALE GALILEO GALILEI VIA CAPPELLA 18 ARIENZO 3 SCUOLA MEDIA STATALE GALILEO GALILEI VIA CAPPELLA 19 ARIENZO 5 SCUOLA MEDIA STATALE GALILEO GALILEI VIA CAPPELLA 20 ARIENZO 4 SCUOLA ELEMENTARE CRISCI VIA CRISCI 21 ARIENZO 6 SCUOLA ELEMENTARE CRISCI VIA CRISCI 22 AVERSA 1 IST.MAGISTRALE "NICCOLO' IOMMELLI" VIA OVIDIO N°15 23 AVERSA 2 IST.MAGISTRALE "NICCOLO' IOMMELLI" VIA OVIDIO N°15 24 AVERSA 3 III°CIRCOLO -

Delibera Consiglio N. 10 Del 26.07.2017 (Modifica Statuto)
Unione dei Comuni Area Caserta Sud-Ovest (C.S.O.) Provincia di Caserta CANCELLO ED ARNONE – CELLOLE – FRANCOLISE - SANTA MARIA LA FOSSA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DELIBERA N. 10 del 26/07/2017 OGGETTO: Statuto dell’Unione dei Comuni Area Caserta Sud Ovest. Modifiche. L'anno duemiladiciassette il giorno luglio del mese di luglio alle ore 18:30, nella Sala delle adu- nanze consiliari del Comune di Francolise, in seguito a rituale convocazione disposta dal Presiden- te del Consiglio, sono presenti, come da appello nominale: PRESIDENTE PRESENTE ASSENTE TESSITORE Gaetano X CONSIGLIERI AMBROSCA Raffaele X BARRETTA Angelo X CALENZO Armando X CALIENDO Annamaria X EMERITO Pasqualino X GIUSTI Antonio X LAMBIASE Biagio X PAOLELLA Rosa Maria X PAPA Antonio X RUSSO Andrea X RUSSO Salvatore X Partecipa alla seduta il Segretario dell'Unione dott. Francesco Nazzaro. Il Presidente del Consiglio dell'Unione sig.ra Paolella Rosa Maria dichiara aperta la seduta per a- ver constatato la sussistenza del numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argo- mento di cui all'oggetto. Unione dei Comuni Area Caserta Sud-Ovest (C.S.O.) Provincia di Caserta CANCELLO ED ARNONE – CELLOLE – FRANCOLISE - SANTA MARIA LA FOSSA Il Consiglio dell'Unione Premesso che con delibera del Consiglio dell’Unione n. 19 del 24/10/2002 è stato approvato loStatuto dell’Unione dei Comuni Area Caserta Sud Ovest (C.S.O.); che lo Statuto è stato modificato con le successive deliberazioni del Consiglio dell’Unione n. 19 dell’11/02/2010, n. 06 del 04/5/2012 e n. 09 del 28/10/2015; Dato atto che il Comune di Sessa Aurunca, con la delibera di Consiglio comunale n. -
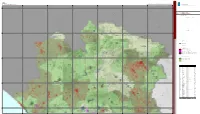
B5.2.1 Le Tipologie Insediative
0 1 2 4 6 8 10 Provincia di Caserta Km Provincia di Caserta Ptc 400000 410000 420000 430000 440000 450000 460000 Piano territoriale di coordinamento provinciale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 4 4 Territorio insediato IS B5.2.1 Le tipologie insediative data: settembre 2009 Inquadramento tavole__quadrante Nord CB CAPRIATI A VOLTURNO GALLO MATESE scala: 1:50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 FR 9 5 5 4 FONTEGRECA 4 SAN PIETRO INFINE LETINO CIORLANO Legenda PRATA SANNITA Confine provinciale VALLE AGRICOLA ! ! ! ! ! ! Confine comunale SAN GREGORIO MATESE MIGNANO MONTE LUNGO Tipologie insediative PRATELLA Tessuto urbano storico (3.354 ha) Tessuto urbano non residenziale (6.757 ha) PIEDIMONTE MATESE Tessuto urbano recente realizzato in presenza di Prg (3.094 ha) CASTELLO DEL MATESE Tessuto urbano recente realizzato in assenza di Prg (12.246 ha) AILANO ROCCA D'EVANDRO RAVISCANINA PRESENZANO Pianificazione urbanistica 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 5 5 4 4 Comuni provvisti di Prg entro il 1979 PIEDIMONTE MATESE Comuni provvisti di Prg entro il 1999 Comuni sprovvisti di Prg al 1999 SANT'ANGELO D'ALIFE CONCA DELLA CAMPANIA SAN POTITO SANNITICO GALLUCCIO TORA E PICCILLI Stato della pianificazione urbanistica comunale Decreto di Cod.Istat Comune Stato della pianificazione urbanistica Data di VAIRANO PATENORA approvazione approvazione 61001 Ailano Prg approvato D.P.G.R.C 227/2003 61002 Alife(*) Prg approvato D.P.G.R.C. 2490/1976 61003 Alvignano Pdf approvato D.P.G.R.C. 2026/1976 61006 Baia e Latina Prg approvato (variante) D.D.R.C. -

CURRICULUM PROFESSIONALE Dott. Ing. Achille SASSO
CURRICULUM VITAE ACHILLE SASSO ingegnere Dott. Ing. Achille SASSO CURRICULUM PROFESSIONALE Dott. Ing. Achille SASSO nato a PRESENZANO il 07 luglio 1960 residente a PRESENZANO in via Della Fossa, 1. Stato civile: Coniugato Nazionalità: Italiana TITOLO DI STUDIO 26 novembre 1987 LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA Conseguita presso l'Università degli Studi Federico II di NAPOLI ABILITAZIONE all'esercizio della professione di Ingegnere anno 1988 conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli ORDINE PROFESSIONALE 04 luglio 1989 ORDINE DEGLI INGEGNERI della provincia di CASERTA n. 1480 ABILITAZIONE all’insegnamento di Elettronica (Cl. Concorso marzo 2000 A034), conseguita presso l’ITIS “E. Majorana” di Cassino; ABILITAZIONE all’insegnamento di Informatica (Cl. Concorso gennaio 2001 A042), conseguita presso l’IPIA di Cassino; ISCRIZIONE MIN. INTERNI – LEGGE 818/84 06 marzo 2006 N. CE 01480/00590 ABILITAZIONE al Coordinamento della Sicurezza in fase di PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE 18 maggio 2016 – ART. 91 E ART. 92 DEL D. LGS. N. 81/2008 conseguita presso il centro di formazione NAVI S.r.l. di Cassino riconosciuto ed autorizzato da UN.A.PR.I. (Unione Autonoma Professionisti Italiani) STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA via Casilina, 37 81050 ‐ PRESENZANO (CE) Tel./Fax 0823 989521 Via casilina, 37 - Presenzano (CE) tel - fax 0823/989521 Dott. Ing. Achille SASSO a) RECUPERO E RIPARAZIONE EDIFICI COMUNE DI S. ANDREA DEL GARIGLIANO (FR) 21 ottobre 1989 Lavori di ristrutturazione fabbricato da adibire ad Uffici di G.M. n. 213 Conciliazione – L.R. n. 41/88 IMPORTO £. 100.000.000 – Progettazione 11 febbraio 1991 COMUNE DI S. ANDREA DEL GARIGLIANO (FR) G.M. -

“Monitoring of Mediterranean Coastal Areas. Problems and Measurement
DOMITIAN COAST. REHABILITATION’ OUTLOOKS OF THE NORTHERN COAST OF CAMPANIA Giuseppe Mazzeo CNR – Istituto di Studi sul Mediterraneo, Via Guglielmo Sanfelice, 8, 80134, Naples (Italy), phone +39 081 7682315, e-mail: [email protected] Abstract – Object of the paper is the Domitian Coast, an area belonging to the North-West of Campania Region, characterized by a series of contrasting factors. The fertility of the soil and the considerable length of an easily accessible and available coastline are threatened by an indiscriminate exploitation of the ground for anthropogenic uses. The uncontrolled expansion of urbanized areas and the reckless use of soil have transformed a potentially rich land into an example of a kind of management that is completely indifferent to the territorial risks. This state of affairs puts the brakes on any kind of developmental action. Policies tending to the redevelopment of urban centres and to the regeneration of natural and agricultural sites are focusing on this area. In fact, there is no lack of territorial planning and programming tools, despite the poor results. Therefore, it is not possible at the moment to forecast or, in any case, to hypothesise a future improvement of the situation. The first part of the paper analyses the Domitian territory and the issues characterizing this particular area on the basis of three categories of elements. Starting from the problems encountered, the second part indicates the possible intervention policies set up to redevelop this territory. Introduction The Domitian coastal strip in the Campania Region extends for about 52 kilometres from the estuary of the Garigliano, at the border of the Lazio Region, to the Municipality of Bacoli, in the Phlegrean Fields. -

VINCOLI PAESISTICI - D.Lgs
Assessorato ai Rapporti con il Consiglio Regionale - Sport - Lavori Pubblici - Opere Pubbliche - Parcheggi - Cave e Torbiere, Acque Minerali, Termali e Miniere Commissario ad Acta PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE Ordinanza T.A.R. Campania - Napoli - Prima sezione - n. 719 del 18/5/05 M O L E I O S Capriati a Volturno Gallo Matese PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE I Fontegreca 61079_01 San Pietro Infine Letino Ciorlano Tavola n. 3 - CE: VINCOLI PAESISTICI - D.Lgs. 42/2004 61030_02 Provincia di Caserta Z Prata Sannita Valle Agricola territorio di San Gregorio Matese Mignano Monte Lungo San Gregorio Matese 62044_00 Il Commissario ad Acta delegato Pratella 61001_09 61064_03 (Decreto Ass. Reg. LL.PP. n. 439 del 6/9/05) 62044_01 62044_03 Coordinatore A.G.C. LL.PP., OO.PP., Attuazione, Espropriazione Piedimonte Matese Castello Matese Santa Croce del Sannio Ing. Eduardo Morrone Ailano Gruppo montuoso del Matese Rocca d'Evandro A Ambito massiccio del Matese Raviscanina Napoli, Giugno 2006 Presenzano Sassinoro 61069_03 62044_04 Piedimonte Matese 61065_01 61039_10 Sant'Angelo d'Alife Conca della Campania Pietraroia San Potito Sannitico Morcone Galluccio Tora e Piccilli 62026_03 L Vairano Patenora Cusano Mutri 61095_10 Pietravairano Alife Marzano Appio massiccio del Matese Gruppo montuoso del Matese 62054_04 Baia e Latina zona di Roccamonfina Gioia Sannitica Caianello 62054_01 SS 87 e zona di Pontelandolfo complesso vulcanico Roccamonfina Cerreto Sannita Gruppo vulcanico di Roccamonfina Pontelandolfo Roccamonfina Campolattaro Roccaromana Fragneto -

Vivai Forestali Della Regione Campania
Assessorato Agricoltura e Attività Produttive A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura Settore Foreste, Caccia e Pesca Coordinamento e indirizzo: Gennaro Grassi – Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca Flora Della Valle – Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Caserta Salvatore Apuzzo – Funzionario del Settore Foreste, Caccia e Pesca Referenti Settori forestali decentrati e Settore per il Piano forestale generale: Elio Muscetta – Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Avellino Pasquale Pio Izzo – Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Benevento Massimo Pieri – Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Caserta Francesco Prisco – Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Napoli Alberto Mattia – Settore per il Piano Forestale Generale Pasquale Santalucia – Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Salerno Pasquale Graziosi – Settore Tecnico Amministrativo di Sant’Angelo dei Lombardi Si ringraziano per la fattiva collaborazione: Gerardo Di Grezia, Giuseppe Longobucco, Soc- corso Gambale, Aniello Andreotti, Giuseppe Gregorio, Gianmario Parente, Rocco di Cecco e Mario Carpino Si ringraziano, inoltre, tutti i partecipanti al progetto speciale intersettoriale dell’Area 11 2 “Linea di intervento B – articolazione tematica B5 – anno 2007 e gli operatori dei vivai fo- restali regionali. Indice Presentazione 5 Premessa 7 Situazione in Campania 7 Finalità 8 Produzioni 9 Cenni sulle tecniche di coltivazione 10 Distribuzione delle produzioni vivaistiche 10 Modalità di richiesta 10 Schede illustrative dei 16 vivai forestali regionali 13 Vivaio Capone – Altavilla Irpina (AV) 14 Vivaio Padula – Vallata (AV) 17 Vivaio G. Bianco – Guardia dei Lombardi(AV) 21 Vivaio G. Patrone – monte – Bagnoli Irpino (AV) 23 Vivaio G. Patrone – valle – Bagnoli Irpino (AV) 25 Vivaio Ex Azienda sperimentale – S. -

CALENDARIO TORNEO ESORDIENTI GIRONE " a " Andata
CALENDARIO TORNEO ESORDIENTI GIRONE " A " Andata 1°GIORNATA Ritorno A.12/12/2010 R. 27/02/2011 1 USD FIORENTE SPARANISE 9 SSC CARINOLA 2 SS INTERCALES 8 CSC MATESE 3 ASD REAL VAIRANO SCALO 7 U.S. CAIANELLO 4 ASD RIN. PIETRAMELARA 6 ASD SOCCER PIETRAVAIRANO 5 ASD REAL VOLTURNO 10 AS.CELLOLE 2°GIORNATA A. 19/12/2010 R. 06/03/2011 6 ASD SOCCER PIETRAVAIRANO 5 ASD REAL VOLTURNO 7 U.S. CAIANELLO 4 ASD RIN. PIETRAMELARA 8 U.S.REAL FALCIANO 3 ASD REAL VAIRANO SCALO 9 SSC CARINOLA 2 SS INTERCALES 10 AS.CELLOLE 1 USD FIORENTE SPARANISE 3°GIORNATA A. 09/01/2011 R. 13/03/2011 2 SS INTERCALES 1 USD FIORENTE SPARANISE 3 ASD REAL VAIRANO SCALO 9 SSC CARINOLA 4 ASD RIN. PIETRAMELARA 8 CSC MATESE 5 ASD REAL VOLTURNO 7 U.S. CAIANELLO 6 ASD SOCCER PIETRAVAIRANO 10 AS.CELLOLE 4°GIORNATA A. 16/01/2011 R. 20/03/2011 7 U.S. CAIANELLO 6 ASD SOCCER PIETRAVAIRANO 8 CSC MATESE 5 ASD REAL VOLTURNO 9 SSC CARINOLA 4 ASD RIN. PIETRAMELARA 1 USD FIORENTE SPARANISE 3 ASD REAL VAIRANO SCALO 10 AS.CELLOLE 2 SS INTERCALES 5°GIORNATA A. 23/01/2011 R. 27/03/2011 3 ASD REAL VAIRANO SCALO 2 SS INTERCALES 4 ASD RIN. PIETRAMELARA 1 USD FIORENTE SPARANISE 5 ASD REAL VOLTURNO 9 SSC CARINOLA 6 ASD SOCCER PIETRAVAIRANO 8 CSC MATESE 7 U.S. CAIANELLO 10 AS.CELLOLE 6°GIORNATA A. 30/01/2011 R. 03/04/2011 8 CSC MATESE 7 U.S. -

ALBO PRO LOCO Aggiornato Al 31.05.2020
All. A L.R. 18/2014 - ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO Aggiornato al 31 maggio 2020 PROVINCIA DI AVELLINO N. POS. PRO LOCO COMUNE AV 1 AIELLO DEL SABATO AIELLO DEL SABATO AV 2 ALTAVILLESE ALTAVILLA IRPINA AV 3 ANDRETTA ANDRETTA AV 4 AQUILONIA AQUILONIA AV 5/17 PRO LOCO NUOVA LAURO LAURO AV 6/12 ASSOCIAZIONE PRO LOCO NUOVAMENTE ARIANO IRPINO AV 7 ATRIPALDESE ATRIPALDA AV 8 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ABELLA AVELLA AV 9/12 ASSOCIAZIONE PRO LOCO MONTEFREDANE MONTEFREDANE AV 10 GERARDO CUCCINIELLO AVELLINO AV 11 AVELLINO AVELLINO AV 12 PRO LOCO BAGNOLI IRPINO E LACENO BAGNOLI IRPINO AV 13 BAIANO BAIANO AV 14 BONITO BONITO AV 15 CAIRANO CAIRANO AV 16 PRO LOCO AQUAE ELECTAE - QUAGLIETTA CALABRITTO AV 17 CALITRI CALITRI AV 18 CANDIDA CANDIDA AV 19 CAPOSELE CAPOSELE AV 20/10 PRO LOCO PATERNOPOLI PATERNOPOLI AV 21/12 ANTIQUA VILLA MAGNA DI VILLAMAINA VILLAMAINA AV 22 FORUM FELIX CASSANO IRPINO AV 23 CASTELFRANCI CASTELFRANCI AV 24 CASTELVETERE SUL CALORE CASTELVETERE SUL CALORE AV 25 CERVINARA - A. RENNA CERVINARA AV 26 CESINALI CESINALI AV 27 PRO LOCO PLANCA CHIANCHE AV 28 NUOVA PRO LOCO CHIUSANO S. D. CHIUSANO DI SAN DOMENICO AV 29 CONTRADA - ARMANDO VEGLIANTE CONTRADA AV 30 COMPSA CONZA DELLA CAMPANIA AV 31/11 ASSOCIAZIONE PRO LOCO I FALO' DI SAN NICOLA SAN NICOLA BARONIA AV 32 PRO LOCO LA SPIGA - FLUMERI FLUMERI AV 33 PRO LOCO LA FONTE FONTANAROSA AV 34 FORINO FORINO AV 35 FRIGENTINA FRIGENTO AV 36 CIVITATIS JESUALDINAE GESUALDO AV 37/19 PRO LOCO SUMMONTE SUMMONTE AV 38 /19 PRO LOCO MONTAGUTO MONTAGUTO AV 39 CRYPTA CASTAGNARIA