TESI Giuseppina Fava Fasani
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
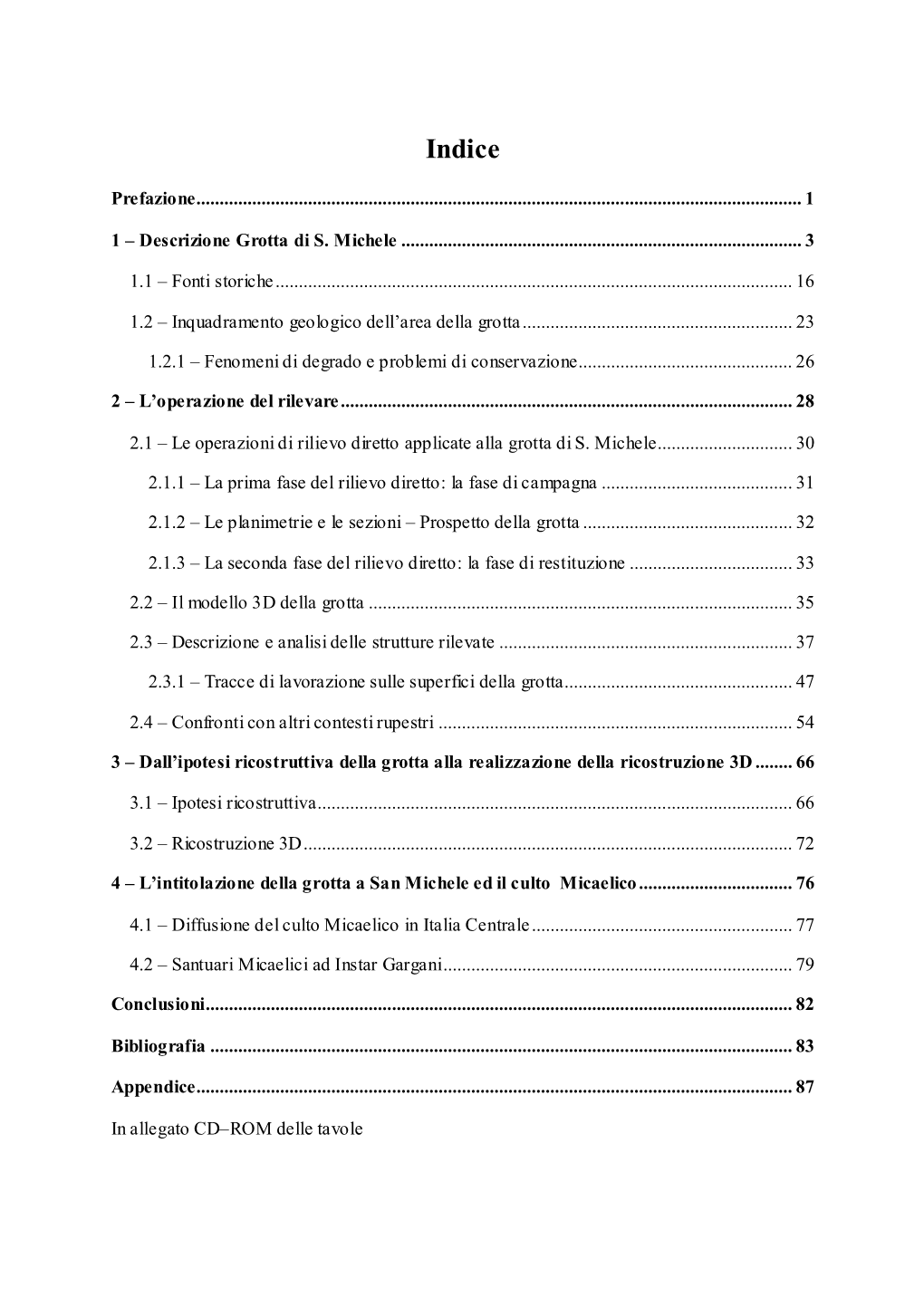
Load more
Recommended publications
-

The Client Community Nicolspdf III 2 Status Client
The Client Community NicolsPDF_III_2 Status Client Province Date No. Nomen Cognomen ? Aquae Sabaudiae Narbonensis 200 680 Smerius Masuetus ? Eburodunum Germ sup 150 292 Flavius Camillus ? Lepcis Afr proc 60 876 Rufus ? Lepcis Afr proc 60 877 Ignotus CA ? Reii Narbonensis 150 759 Ignotus AJ chec Auzia Mauretania 200 26 Aelius Longinus chec Sufetula Afr proc 732 check check city Verona Italia x 138 474 Nonius M. f. Mucianus citz ...enacates ? Pannonia 100 332 Glitius P. f. Atilius citz Abella Italia i 120 404 Marcius Plaetorius citz Abellinum Italia i 200 59 Antonius Rufinus citz Abellinum Italia i 225 183 Caesius T.f. Anthianus citz Abellinum Italia i 175 217 Claudius Frontinus citz Abellinum Italia i 175 218 Claudius Saethida citz Abellinum Italia i 175 219 Claudius Saethida citz Abellinum Italia i 200 278 Egnatius C. f. Certus citz Acinipo Baetica 225 378 Junius L. f. Terentianus citz Acinipo Baetica 200 422 Marius M. f. Fronto citz Acinipo Baetica 200 608 Servilius Q. f. Lupus citz Aeclanum Italia ii 126 277 Eggius L. f. Ambibulus citz Aeclanum Italia ii 150 468 Neratius C. f. Proculus citz Aeclanum Italia ii 161 509 Otacilius L. f. Rufus citz Aeclanum Italia ii 240 705 Calventius L f Corl...sinus? citz Aeclanum Italia ii 150 717 Maximus? citz Aeclanum Italia ii 150 795 Ignotus BF citz Aenona Dalmatia -1 615 Silius P. f. citz Aenona Dalmatia 23 678 Volusius L. f. Saturninus citz Aequicoli Italia iv 225 389 Livius Q. f. Velenius citz Aesernia Italia iv 150 1 Abullius Dexter citz Aesernia Italia iv -25 68 Appuleius Sex f citz Aesernia Italia iv 150 262 Decrius C. -

Map 44 Latium-Campania Compiled by N
Map 44 Latium-Campania Compiled by N. Purcell, 1997 Introduction The landscape of central Italy has not been intrinsically stable. The steep slopes of the mountains have been deforested–several times in many cases–with consequent erosion; frane or avalanches remove large tracts of regolith, and doubly obliterate the archaeological record. In the valley-bottoms active streams have deposited and eroded successive layers of fill, sealing and destroying the evidence of settlement in many relatively favored niches. The more extensive lowlands have also seen substantial depositions of alluvial and colluvial material; the coasts have been exposed to erosion, aggradation and occasional tectonic deformation, or–spectacularly in the Bay of Naples– alternating collapse and re-elevation (“bradyseism”) at a staggeringly rapid pace. Earthquakes everywhere have accelerated the rate of change; vulcanicity in Campania has several times transformed substantial tracts of landscape beyond recognition–and reconstruction (thus no attempt is made here to re-create the contours of any of the sometimes very different forerunners of today’s Mt. Vesuvius). To this instability must be added the effect of intensive and continuous intervention by humanity. Episodes of depopulation in the Italian peninsula have arguably been neither prolonged nor pronounced within the timespan of the map and beyond. Even so, over the centuries the settlement pattern has been more than usually mutable, which has tended to obscure or damage the archaeological record. More archaeological evidence has emerged as modern urbanization spreads; but even more has been destroyed. What is available to the historical cartographer varies in quality from area to area in surprising ways. -

Tituli Honorarii, Monumentale Eregedenktekens. Ere-Inscripties Ten Tijde Van Het Principaat Op Het Italisch Schiereiland
Annelies De Bondt 2e licentie Geschiedenis Optie Oude Geschiedenis Stnr. 20030375 Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte Vakgroep Oude Geschiedenis van Europa Blandijnberg 2 9000 Gent Tituli honorarii, monumentale eregedenktekens. Ere-inscripties ten tijde van het Principaat op het Italisch schiereiland. Een statistisch-epigrafisch onderzoek. Fascis 3: Inventaris. Promotor: Prof. Dr. Robert DUTHOY Licentiaatsverhandeling voorgedragen tot Leescommissarissen: Prof. Dr. Dorothy PIKHAUS het behalen van de graad van A Dr. Koenraad VERBOVEN Licentiaat/Master in de geschiedenis. Inventaris 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 5 1.1. Verantwoording nummering 5 1.2. Diakritische tekens 6 1.3. Bibliografie en gebruikte afkortingen. 6 2. Inventaris 9 Regio I, Latium et Campania 9 Latium Adjectum 9 Aletrium 9 Fundi 17 Anagnia 9 Interamna Lirenas 18 Antium 10 Minturnae 19 Aquinum 11 Privernum 20 Ardea 11 Rocca d’Arce 20 Atina 12 Setia 21 Casinum 12 Signia 21 Cereatae Marianae 13 Sinuessa 21 Circeii 13 Suessa Aurunca 21 Cora 13 Sura 23 Fabrateria Vetus 14 Tarracina 23 Ferentinum 15 Velitrae 23 Formiae 16 Verulae 23 Latium Vetus 24 Albanum 24 Lavinium 28 Bovillae 24 Ostia Antica 30 Castel di Decima 25 Portus 37 Castrimoenium 25 Praeneste 37 Gabiae 26 Tibur 39 Labico 27 Tusculum 42 Lanuvium 27 Zagarollo 43 Campania 44 Abella 44 Neapolis 56 Abellinum 44 Nola 56 Acerrae 45 Nuceria 57 Afilae 45 Pompei 57 Allifae 45 Puteoli 58 Caiatia 46 Salernum 62 Cales 47 Stabiae 63 Capua 48 Suessula 63 Cubulteria 50 Surrentum 64 Cumae 50 Teanum Sidicinum -

Discovering a Roman Resort-Coat: the Litus Laurentinum and The
DISCOVERING A ROMAN RESORT-COAST: THE LITUS LAURENTINUM AND THE ARCHAEOLOGY OF 1 OTIUM* Nicholas Purcell St John's College, Oxford I. Introductory Otium - the concept of leisure, the elaborate social and cultural definer of the Roman elite away from its business of political and military power - is famous. We can see in Roman literary texts how the practice of otium patterned everyday experience, and how it was expressed in physical terms in the arrangement, on a large and on a small scale, of all aspects of Roman space. The texts likewise show that much of what we would regard as social life, and nearly all of what we think of as economic, belonged in the domain of otium. The complexities and ambiguities of this material have been much studied.2 Roman archaeology equally needs to be an archaeology of otium, but there has been little attempt to think systematically about what that might entail. Investigating the relationship between a social concept such as otium and the material culture that is the primary focus of archaeology must in the first place involve describing Roman culture in very broad terms. The density of explicit or implicit symbolic meaning, the organisation of space and time, degrees of hierarchy of value or prestige: it is at that level of generalisation that the archaeologist and the cultural historian will find the common denominators that enable them to share in the construction of explanations of Roman social phenomena. In this account, which is based on research into a particular locality, we shall have to limit ourselves to one of these possibilities. -

Citizen Science Reveals the Presence of the Italian Red Squirrel in Campania
Quaderni del Museo di Storia Naturale di Ferrara - Vol. 2 - 2014 - pp. 91-94 ISSN 2283-6918 “Sometimes they come back”: citizen science reveals the presence of the Italian red squirrel in Campania EMILIANO MORI DISAFA Entomology & Zoology, University of Turin, Grugliasco (To) (Italy) - E-mail: [email protected] MATTIA MENCHETTI Department of Biology, University of Florence, Sesto Fiorentino (Fi) (Italy) - E-mail: [email protected] ABSTR A CT Citizen science currently represents a cost-effective strategy to collect points of occurrency through the involvement of common people. The current presence of the Europaen red squirrel in Campania has been since now doubtful, so that the regional Red List classified this arboreal rodent as Data Deficient. This species is threatened primarily by fragmentation of forest habitats as well as by competition with alien squirrels throughout its Italian range. Recently, red squirrel underwent a range expansion in the range of southern Latium, particularly evident since 2005. A citizen science project developed ad hoc for squirrels in Italy revealed three points of occurrence of red squirrel in northern Campania, on the border with Latium and Molise, where this arboreal rodent is well distributed. Morphological analysis ascribes these individuals to the Apennine endemic subspecies Sciurus vulgaris italicus. Further research will be needed to ascertain the presence of established reproductive nuclei in this region. Key words: citizen science, red squirrel, Campania (Italy). Introduction 2011; Mori et al., 2013b; Bertolino et al., 2014). Thus, a detailed knowledge on the distribution of Sciurus vulgaris in Citizen science currently represents a cost-effective strategy to Italy plays a key role for its conservation. -

Da Avezzano (112 M), Frazione Di Sessa Aurunca, Al Santuario Della
Da Avezzano (112 m), frazione di Sessa Aurunca, al Santuario della Madonna Grande ed Eccelsa di Casanova di Carinola, su un vecchio tracciato utilizzato dai pellegrini. Da una strada per la masseria Vignali si raggiunge il percorso un tempo utilizzato dalla base NATO. Lasciate le auto nella stradina della frazione adiacente al parco giochi d’Avezzano, si procede per la chiesa di San Tommaso Apostolo; dai gradini di questa chiesa, alle prime luci dell’alba della terza domenica di maggio, il popolo di Avezzano, spinto da una devozione che oramai si tramanda da generazioni, si raduna per avviarsi verso le pendici del Monte Massico, seguendo una delle vie più vecchie e suggestive del paese, detta volgarmente CAP’TUORT; i pellegrini, disposti in fila indiana e guidati dai più anziani, s’incamminano attraverso i sentieri della montagna per raggiungerne la sommità pregando e cantando in onore della Madonna, per poi scendere al lato opposto fino alla Cappella e attendere con devota fede l’arrivo dell’Immagine Sacra Brevi cenni di Morfologia e Clima Il modesto massiccio calcareo del Monte Massico, che culmina a 813 metri sul livello del mare, ha molto da offrire agli appassionati di natura. Il gruppo del Monte Massico è una catena di rilievi che partendo dalle pendici del Vulcano di Roccamonfina arriva alla costa Tirrenica. Il gruppo confina a nord col Vulcano di Roccamonfina ad est con la pianura del fiume Volturno, a sud con il Mar Tirreno ed ad ovest con la pianura del fiume Garigliano. Esso inoltre s’affaccia sulla costa di Mondragone e Baia Domizia. -

Il Territorio Di Sinuessa Tra Storia Ed Archeologia. Di Luigi Crimaco
Il Territorio di Sinuessa tra Storia ed Archeologia. Di Luigi Crimaco Il territorio tra il fiume Volturno e il Monte Massico, costituiva in antico buona parte, dell'antico retroterra agricolo assegnato alla colonia civium romanorum di Sinuessa, fondata nel 296 a. C. proprio al confine tra l'ager Vescinus (in saltu Vescino) e l'ager Falernus. Il territorio dell'antica città romana occupava una parte dell'agro Falerno che, secondo la tradizione, divenne ager publicus populi romani nel 340 a. C., immediatamente dopo la guerra combattuta da Roma contro i Latini e i Campani. Un anno dopo la sanguinosa strage del popolo aurunco, nel 313 a. C., venne fondata la colonia latina di Suessa Aurunca nei pressi del vulcano di Roccamonfina. La costruzione della via Appia nel 312 a. C. venne a sancire la definitiva annessione di quei territori a Roma. Più tardi, nel 296 a. C., in seguito ad una serie di scorrerie da parte dei Sanniti nell'agro Falerno, furono fondate le colonie romane di Minturnae e Sinuessa allo scopo di presidiare militarmente la zona. Questi, in breve, i fatti storici che portarono alla conquista e alla definitiva sistemazione di questa parte della Campania e alla fondazione della colonia civium romanorum di Sinuessa. Nel 217 a. C., durante la seconda guerra punica, a detta di Livio, l'agro Falerno fu devastato dalla cavalleria numidica e ingenti furono i danni apportati alle colture della zona. La devastazione del territorio sinuessano viene consumata sotto gli occhi del console romano Fabio Massimo, il quale assiste con il suo esercito dalla cima del Monte Massico, senza intervenire, alla distruzione delle case dei coloni sinuessani. -

The End of Local Magistrates in the Roman Empire
The end of local magistrates in the Roman Empire Leonard A. CURCHIN University of Waterloo, Canadá [email protected] Recibido: 15 de julio de 2013 Aceptado: 10 de diciembre de 2013 ABSTRACT Previous studies of the status of local magistrates in the Late Empire are unsatisfying and fail to explain when and why local magistracies ended. With the aid of legal, epigraphic, papyrological and literary sources, the author re-examines the functions and chronology of both regular and quasi-magistrates, among them the curator, defensor and pater civitatis. He finds that the expense of office-holding was only part of the reason for the extinction of regular magistracies. More critical was the failure of local magistrates to control finances and protect the plebeians. Key words: Cursus honorum. Late Roman Empire. Roman administration. Roman cities. Roman gov- ernment. Roman magistrates. El fin de los magistrados locales en el Imperio romano RESUMEN Los estudios previos relativos a la condición de los magistrados locales durante el Bajo Imperio son poco satisfactorios, porque dejan sin aclarar cuándo y cómo se extinguieron las magistraturas locales. Con ayuda de fuentes jurídicas, epigráficas, papirológicas y literarias, el autor examina de nuevo las funciones y la cronología de magistrados regulares y cuasi-magistrados, como el curator, el defensor y el pater civitatis. Se considera que los gastos aparejados a los cargos públicos explican sólo en parte la extinción de las magistraturas regulares; más crucial fue, en este sentido, el hecho de que los magistra- dos locales de este período fallasen a la hora de restringir los gastos o de proteger a los plebeyos. -

Mario Pagano Continuità Insediativa Delle Ville in Campania Fra Tarda Antichità E Alto Medioevo
Mario Pagano Continuità insediativa delle ville in Campania fra tarda antichità e alto medioevo [A stampa in La Campania fra tarda antichità e alto medioevo. Ricerche di archeologia del territorio . Atti della Giornata di studio, Cimitile, 10 giugno 2008, a cura di Carlo Ebanista e Marcello Rotili, Cimitile, Tavolario editore, 2009 (Giornate sulla tarda antichità e il medioevo, a cura di Carlo Ebanista e Marcello Rotili, 1), pp. 9-21 @ degli autori e dell’editore - Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”]. 9 MARIO PAGANO CONTINUITÀ INSEDIATIVA DELLE VILLE NELLA CAMPANIA FRA TARDA ANTICHITÀ E ALTO MEDIOEVO Potrebbe sembrare straordinario che, su un argomento così centrale per la storia di una regione importante come la Campania nel periodo che si esamina, in particolare per la sua rilevanza rispetto all’approvvigionamento di Roma (accresciuta dopo la fondazione di Costantinopoli), e come cerniera col Mediterraneo e in particolare con Costantinopoli, l’Africa, l’Egitto e la Terra Santa, i dati siano piuttosto scarsi. Eppure, pochissimi sono i siti delle ville romane in Campania scientificamente indagati e, anche questi, solo molto parzialmente; una gran quantità di scavi e scoperte occasionali sono inediti o solo insufficientemente pubblicati; assai carenti anche le ricognizioni di superficie; pochi gli studi specifici, e limitati a zone non molto estese. Certo, negli ultimi anni la situazione comincia in qualche misura a mutare, grazie anche ai maggiori investimenti economici degli ultimi anni, ai ritrovamenti avvenuti durante la realizzazione di grandi opere pubbliche e alla continua espansione edilizia che hanno investito la Campania, e alla importante e lodevole iniziativa, che assume già notevole rilievo per il Casertano e il Beneventano, della prof.ssa Stefania Quilici Gigli, che ha permesso la pubblicazione di alcuni fogli della Carta archeologica della Campania riguardanti in particolare la zona di Capua, la valle del Volturno e la Valle Caudina e, prossimamente, quella Telesina. -

V2017-Sinuessa.Pdf
SINUESSA, UN APPRODO SOMMERSO DI EPOCA ROMANA Archeologia, geomorfologia costiera, strategie sostenibili di valorizzazione Monografia a cura di Micla Pennetta e Alfredo Trocciola 2017 ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ISBN: 978-88-8286-340-1 Revisione editoriale: Giuliano Ghisu Copertina: Flavio Miglietta Foto in copertina: immagine del fondo marino, acquisita con indagini side-scan sonar, che mostra le “Pilae di Sinuessa” collocate in una vasta depressione di un banco tufaceo caratterizzato da una morfologia articolata SINUESSA, UN APPRODO SOMMERSO DI EPOCA ROMANA Archeologia, geomorfologia costiera, strategie sostenibili di valorizzazione A cura di Micla Pennetta e Alfredo Trocciola La monografia raccoglie i contribuiti di studi e ricerche condotti negli ultimi anni nell’area archeologica marina di Sinuessa nel golfo di Gaeta in Campania. Alla realizzazione del volume hanno contribuito diversi autori, specialisti in differenti discipline quali la geo- morfologia costiera, archeologia e beni culturali con la finalità di suggerire agli amministratori e stakeholder del litorale domitio strategie sostenibili per la valorizzazione dell’approdo sommerso di epoca romana. Presentazione di: Claudio Zucchelli Contributi di: Paolo Caputo, Sergio Cascella, Vera Corbelli, Veronica D’Ambrosio, Alberto De Bonis, Tiziana Di Luccio, Carlo Donadio, Carmine Minopoli, Angela Mormone, Vincenzo Morra, Raffaella Nappi, Micla Pennetta, Raffaele Pica, Monica Piochi, Maria Grazia Ruggi d’Aragona, Rosario -
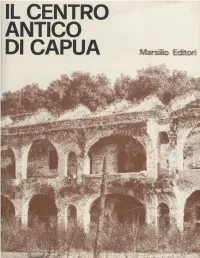
IL CENTRO ANTICO DI CAPUA Marsilio Editori ,R ' Y Øwa "
IL CENTRO ANTICO DI CAPUA Marsilio Editori ,r ' Y øwa " . t;4t;;9.:", 1.r.4 • ,_ ,''fi?• ,.#*': ',.:'14k 4,',:k.'fX'-": i.:!>5.-,t-,-. ,'`,r'',.'~..a-„,sk..? ..,s, - - '':',,,s-': , ,- „ -...,,,-,:,-;›,,,:,,,- .. „...,.. .., . -4... •,", -,.2....-ie, :.,. .-,,-...-;• .,.• ,....-4:":.(:'''' ' -. "•:' • :. ,'';''''''' . .'.k..'.',...-- " : :... -`-` '' • > . - - „, , ..:( , - - t'V,' ^;-''',- :1."' '.'-• -,-, dd '."k$7:1; • d ' ' CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDIO PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI - ROMA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA DELL'UNIVERSITÀ DI ROMA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LO STUDIO DEI MONUMENTI IL CENTRO ANTICO DI CAPUA METODI DI ANALISI PER LA PIANIFICAZIONE ARCHITETTONICO-URBANISTICA Ingrid Brock Paolo Giuliani Cristian Moisescu Marsilio Editori FONTI DELLE ILLUSTRAZIONI Comune di Capua: 1, 112; Hutzel, Roma: 3, 50, 54, 62, 67, 9 3 ; « Urbanistica »: 5, 6; Parapetti: 8, 109, 110; M.P. I Aerofototeca: 9, 98, 101; Curuni: 10, 20, 21, 52, 53, 55, 56, 66, 94, 95, 102, 103; Loew, Verhaeghe: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 60; Bi- blioteca dell' Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia del- l'Arte: 61, 88, 90, 91, 105, 106, 111; Biblioteca Hertziana, Roma: 76, 99; Kim: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87; Rigamon- ti: 100; Theocharidis: 104; Museo Campano: 107; Lysiak: 108; I.G.M.: 4; Autori: 7, 17, 18, 19, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 51, 57, 58, 63, 64, 68, 69, 71, 73, 74, 79, 80. Proprietà letteraria riservata Copyright 1972 by Marsilio Editori - Padova Stampa: Officina Tipografica -

Il Duovirato Nei Municipia Italici: Contributo Allo Studio Della Fase Finale Del Processo Di Municipalizzazione Nell’Italia Centrale E Meridionale
ARTÍCULOS Gerión. Revista de Historia Antigua ISSN: 0213-0181 https://dx.doi.org/10.5209/geri.74783 Il duovirato nei municipia italici: contributo allo studio della fase finale del processo di municipalizzazione nell’Italia centrale e meridionale Simone Sisani1 Recibido: 24 de junio de 2020 / Aceptado: 18 de noviembre Riassunto. Il contributo analizza in forma sistematica i casi noti di municipia retti da duoviri all’interno delle regiones augustee I-VII, con lo scopo di offrire una lettura in chiave strutturale della diffusione del duovirato municipale in area italica: l’analisi consente di formulare ipotesi sulle ragioni storiche del ritardo istituzionale manifestato da alcune aree della penisola, dove il processo di municipalizzazione giunge a pieno compimento soltanto a cavallo tra l’età cesariana e l’età augustea. Palabras clave: Cesare; duoviri; municipia; praefecturae; quattuorviri; Silla. [en] The Duovirate in Italian Municipia: Contribution to the Study of the Final Phase of the Municipalization Process in Central and Southern Italy Abstract. The contribution analyzes systematically all known cases of municipia governed by duoviri within the Augustan regiones I-VII, aiming at offering a structural reading of the diffusion of municipal duovirate in the Italic area: the analysis allows to formulate hypothesis on the historical reasons for the institutional delay manifested by some areas of the peninsula, where the process of municipalization is fully accomplished only between the Caesarian and the Augustan ages. Key words: Caesar; Duoviri; Municipia; Praefecturae; Quattuorviri; Sulla. Sommario: 1. Il duovirato come esito del riassetto istituzionale di municipia quattuorvirali. 2. Il duovirato come esito della promozione a municipia di realtà vicane.