Prefazione Dell'autore (Dal Tomo I)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
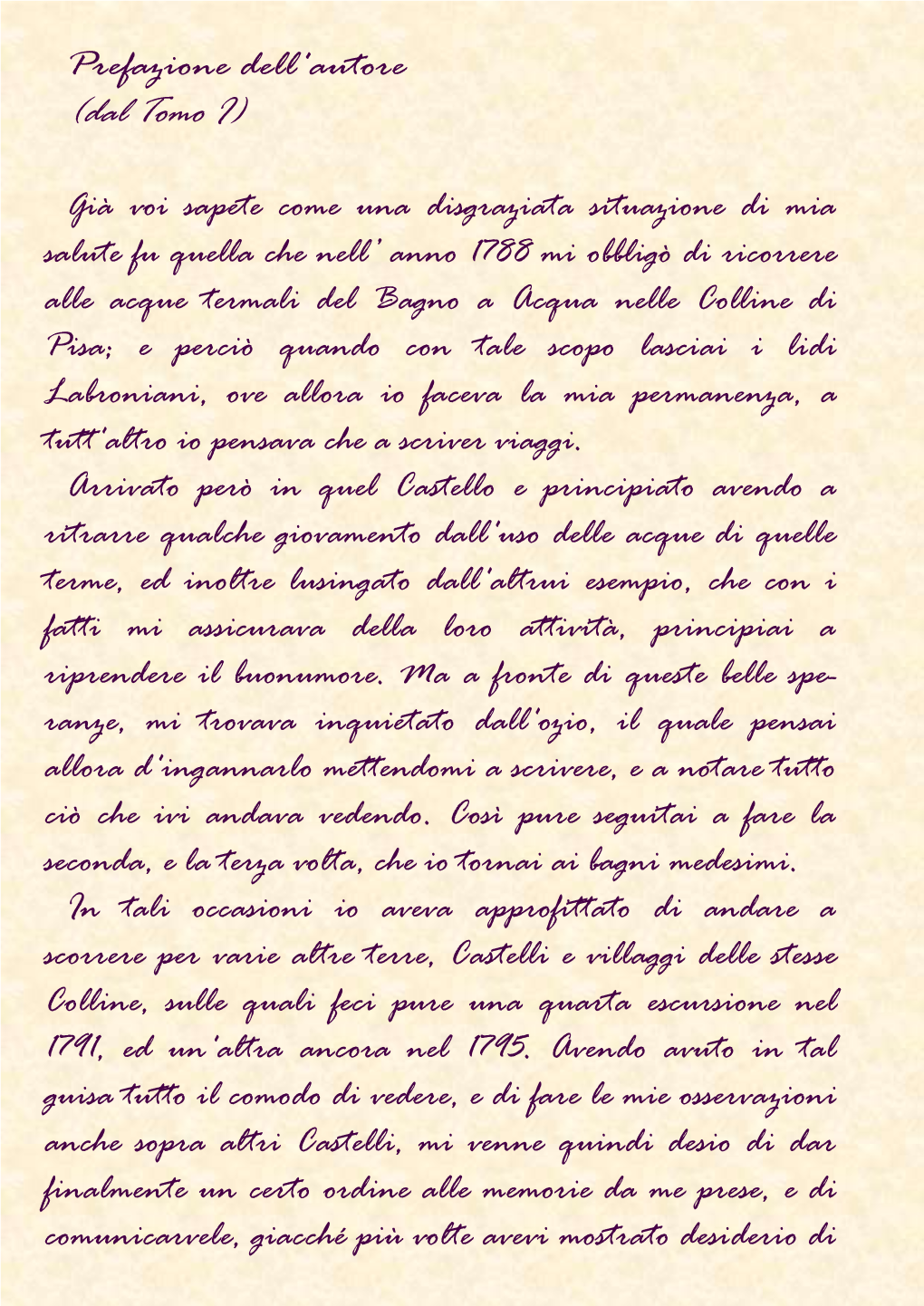
Load more
Recommended publications
-

Orari E Percorsi Della Linea Bus
Orari e mappe della linea bus 370 370 Pontedera-crespina-collesalvetti Visualizza In Una Pagina Web La linea bus 370 (Pontedera-crespina-collesalvetti) ha 2 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Collesalvetti: 13:21 (2) Pontedera Arrivo: 06:34 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus 370 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus 370 Direzione: Collesalvetti Orari della linea bus 370 54 fermate Orari di partenza verso Collesalvetti: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì Non in servizio martedì Non in servizio Pontedera Corsia 7 Via Sacco e Vanzetti, Pontedera mercoledì 13:21 V.Le Della Repubblica giovedì 13:21 Viale del Risorgimento, Pontedera venerdì Non in servizio V.Le Risorgimento Scuola sabato Non in servizio Viale del Risorgimento, Pontedera domenica Non in servizio Ospedale V.Roma 244 Pontedera V.Roma Informazioni sulla linea bus 370 Via Roma, Pontedera Direzione: Collesalvetti Fermate: 54 Pontedera V.Terracini Durata del tragitto: 62 min La linea in sintesi: Pontedera Corsia 7, V.Le Della S.Lucia V.Del Popolo Fr 11 Repubblica, V.Le Risorgimento Scuola, Ospedale, V.Roma 244, Pontedera V.Roma, Pontedera S.Lucia V.Terracini, S.Lucia V.Del Popolo Fr 11, S.Lucia, S.Lucia V.Del Popolo 88, V.S.Lucia Fr 7a, V.Prov.Di S.Lucia V.Del Popolo 88 Gello Bar, Gello Bv.V.D.Calende, Gello Podere Silano, Lavaiano, Lavaiano V.D.Repubblica 1, V.Maremmana V.S.Lucia Fr 7a Cimitero, V.Maremmana Demoliz. "Ruggero", V.Maremmana 18, V.Maremmana 52, V.Rossini 79, Quattro Strade Di Cenaia, V.Livornese -

STATUTO Approvato Con Delibera Del Consiglio Comunale N
COMUNE DI CRESPINA LORENZANA Provincia di Pisa P.zza C. Battisti n. 22 – 56042 Crespina Lorenzana (PI) Tel. 050 634711 – Fax 050 634740 e-mail: [email protected] STATUTO Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 26/11/2014 1 Titolo I Principi generali ed elementi costitutivi Art. 1 Principi fondamentali pag. 5 Art. 2 Finalità pag. 5 Art. 3 Principio di organizzazione pag. 6 Art. 4 Pari opportunità pag. 6 Art. 5 Programmazione, forme di cooperazione pag. 6 Art. 6 Territorio e sede comunale pag. 6 Art. 7 Albo pretorio pag. 7 Art. 8 Stemma e gonfalone pag. 7 Titolo II Ordinamento strutturale e funzionale Capo I Organi di governo Art. 9 Organi di governo pag. 8 Art. 10 Consiglio Comunale pag. 8 Art. 11 Competenze e attribuzioni pag. 8 Art. 12 Sessione e convocazione pag. 8 Art. 13 Linee programmatiche di mandato pag. 9 Art. 14 Commissioni pag. 10 Art. 15 Consiglieri pag. 10 Art. 16 Diritti e doveri dei consiglieri pag. 10 Art. 17 Gruppi consiliari pag. 11 Art. 18 Giunta Comunale pag. 11 Art. 19 Prerogative pag. 11 Art. 20 Composizione pag. 12 Art. 21 Organizzazione della Giunta pag. 12 Art. 22 Attribuzioni della Giunta pag. 13 Art. 23 Deliberazioni degli organi collegiali pag. 13 Art. 24 Sindaco pag. 13 Art. 25 Attribuzioni del Sindaco pag. 14 Art. 26 Attribuzioni di vigilanza pag. 14 Art. 27 Attribuzioni di organizzazione pag. 15 Art. 28 Vicesindaco pag. 15 Capo II Organi burocratici ed uffici Art. 29 Principi e criteri fondamentali di gestione pag. -

Disciplinare Di Produzione Dei Vini a Denominazione Di Origine Controllata “Terre Di Pisa”
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “TERRE DI PISA” Approvato con DM 18.10.2011 GU 256 - 03.11.2011 (S. O. n.229) Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011 Modificato con DM 12.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Modificato con DM 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Articolo 1 (Denominazione e vini) 1.1 La Denominazione di Origine Controllata “Terre di Pisa” è riservata ai vini “Terre di Pisa” rosso e “Terre di Pisa” Sangiovese che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2 (Base ampelografica) 2.1 La Denominazione di Origine Controllata “Terre di Pisa” Sangiovese è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: minimo 95%. Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%. 2.2 La Denominazione di Origine Controllata “Terre di Pisa” rosso è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah da soli o congiuntamente, minimo 70%. Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana. 2.3 Si riportano nell’allegato 1 i vitigni complementari che possono essere utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “ Terre di Pisa” iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. -

DOC Terre Di Pisa
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “TERRE DI PISA” Approvato con DM 18.10.2011 GU 256 - 03.11.2011 (S. O. n.229) Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 12.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf (concernente correzione dei disciplinari) Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Articolo 1 (Denominazione) 1. La Denominazione di Origine Controllata “Terre di Pisa” è riservata ai vini “Terre di Pisa” rosso e “Terre di Pisa” Sangiovese che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2 (Base ampelografica) 1. La Denominazione di Origine Controllata “Terre di Pisa” Sangiovese è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: minimo 95%. Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%. 2. La Denominazione di Origine Controllata “Terre di Pisa” rosso è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah da soli o congiuntamente, minimo 70%. Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana. Si riportano nell’allegato 1 i vitigni complementari che possono essere utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “ Terre di Pisa” iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. -

Ricerca Genealogica
CCAARRNNEESSEECCCCHHII SSTTOORRIIAA DDII UUNNAA FFAAMMIIGGLLIIAA Prato - 2007 Ricerca storica, testo e grafica a cura di Incipit www.incipitprato.com incipitss@ gmail.com SOMMARIO Una nuova genesi: i Carnesecchi a Tremoleto (1758-1810)..............................2 Il mestiere del bracciante a Lorenzana (1790-1900)........................................11 Documentazione visionata..................................................................................19 Dizionario dei termini notevoli..........................................................................21 Appendice fotografica .........................................................................................23 1 CAPITOLO I Una nuova genesi: i Carnesecchi a Tremoleto (1758-1810) La nostra indagine sulle vicende storiche della famiglia Carnesecchi si apre alla metà del secolo diciottesimo nel piccolo centro agricolo di Tremoleto, piccola borgata posta sulle colline che guardano Pisa da sud est1. È in questo piccolo angolo di Toscana infatti che vivono i tre fratelli Giuseppe, Lorenzo e Innocenzio di Francesco Carnesecchi, ed è qui che dalla fine degli anni cinquanta del Settecento vengono alla luce i loro figli, da cui prenderanno origine alcuni dei rami familiari oggetto della nostra ricerca. Cominciamo subito col dire che non sappiamo molto, almeno allo stato attuale delle indagini, sui primi anni di Giuseppe Lorenzo e Innocenzio, e ancor meno sappiamo riguardo alla vita condotta dal loro padre Francesco. La nebbia del tempo che sempre avvolge la vita dei più antichi esponenti di un dato gruppo familiare copre in questo caso i loro primi passi, tanto che non è stato possibile finora ricostruirne le vicende precedenti al loro soggiorno in Tremoleto. Alcuni dati relativi alle loro vite sono comunque ricostruibili con buona sicurezza: essi non erano originari di Tremoleto, visto che non compaiono all’interno della documentazione locale se non a partire dal 1758, anno in cui appunto nasce il primogenito di Lorenzo di Francesco, Eustachio. -

Polimetriche
TABELLE POLIMETRICHE CPT LINEA 10 PISA - TIRRENIA - LIVORNO Pisa *2,0 Porta a Mare *4,0 *2,0 Luicchio *4,0 *2,0 / La Vettola *6,0 *4,0 / *2,0 S. Piero 7,0 5,0 3,0 4,0 2,0 Bivio S. Piero 12,0 10,0 8,0 9,0 7,0 5,0 Marina di Pisa 16,8 14,8 12,8 13,8 11,8 9,8 4,8 Tirrenia 21,7 19,7 17,7 18,7 16,7 14,7 9,7 4,9 Calambrone 30,0 28,0 26,0 27,0 23,0 25,0 18,0 13,2 8,3 Livorno Note: * Tratta urbana CPT LINEA 50 CRESPINA - COLLESALVETTI - PISA Crespina 2,8 Tripalle 6,2 3,4 Fauglia 11,2 8,4 5,0 Collesalvetti 13,9 10,7 7,7 2,7 Vicarello 17,8 15,0 11,6 6,6 3,9 Arnaccio 23,3 20,5 17,1 12,1 9,4 5,5 Ospedaletto 27,1 24,3 20,9 15,9 13,2 9,3 3,8 Pisa CPT LINEA 51 ORCIANO - LORENZANA - COLLESALVETTI Orciano 7,1 Lorenzana 9,1 2,0 Laura 11,3 4,2 2,2 Acciaiolo 14,8 7,7 5,7 3,5 Torretta 12,8 5,7 3,7 \ \ Botteghino di Tripalle 16,2 9,1 7,1 \ \ 3,4 Fauglia 18,6 11,5 9,5 7,3 3,8 8,4 5,0 Collesalvetti CPT LINEA 70 PISA - GELLO - PONTASSERCHIO - MARINA DI VECCHIANO Pisa 5,8 Cascine di Gello 6,5 / Cottolengo 8,2 / 1,7 S. -

Burt N. 32 Parte Seconda Del 08/08/2018
Anno XLIX Repubblica Italiana BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana Parte Seconda n. 32 mercoledì, 8 agosto 2018 Firenze Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze E-mail: [email protected] Il Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblica- zione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate. L’accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gra- tuito e senza limiti di tempo. Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordi- nanze degli organi regionali. Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale. Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l’attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefi ci economici e fi nanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fi ni della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. -

Provincia Di Pisa
Comune di Crespina Lorenzana Provincia di Pisa VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL TERRITORIO DI LORENZANA Arch. Giovanni Parlanti Progettista Dott.ssa Elisabetta Norci Elaborazione VAS Studio di Geologia GeoApp Geol. Claudio Nencini Studi geologici H.S. Ingegneria srl Ing. Simone Pozzolini Studi idraulici Pian. Jr. Emanuele Bechelli Elaborazione grafica e Gis P.E. Luca Melani Responsabile Area 3 Pianificazione e assetto del Territorio Geom. Elisa Balestri Collaborazione Ufficio Tecnico Ing. Thomas D’Addona Sindaco Geom. Gianluca Catarzi Ass. Urbanistica All. A4 Schedatura del P.E.E. Tremoleto Adottato con Delibera CC. nr. del Giugno 2017 Regolamento Urbanistico Comune di Crespina Lorenzana Rilievo del Patrimonio Edilizio Esistente Provincia di PISA Scheda numero: TR - 001 SEZIONE GENERALE Data di rilevamento: MAGGIO 2017 Località: TREMOLETO Sezione: B Foglio: 4 Particella: 101 Toponimo CTR: COLLE ASTUTO Utoe: 2 TREMOLETO Edificio esistente al 1883 Estratto di CTR - scala 1:2.000 Estratto di Mappa Catastale Unità di Spazio - PS LEGENDA Subsistema 1 Unità di Spazio 1 – Nuclei urbani storici VINCOLI ☐ Beni Culturali (D.Lgs 42/2004, art. 10) ☐ Territori contermini ai laghi (D.Lgs 42/2004 art.142, comma 1, lett. b) ☐ Corsi d’acqua (D.Lgs 42/2004 art.142, ☐ Territori coperti da foreste e da boschi (D.Lgs comma 1, lett. c) 42/2004 art.142, comma 1, lett. g) ☐ Vincolo Idrogeologico (LR 39/2000, art. 38) ☐ Vincolo cimiteriale TIPOLOGIA INSEDIATIVA ☐ Casa colonica ☒ Villa ☐ Aggregato di ☐ Nucleo ☐ Edificio ☐ Chiesa, torre, case coloniche isolato -

Piano Di Protezione Civile Dell'unione Valdera
UNIONE VALDERA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELL’UNIONE VALDERA Redazione Adozione Approvazione Aggiornamento Aggiornamento Aprile 2014 Del. Xxx 16/04/2014 Unione Valdera Piano di Protezione Civile – Aprile 2014 Piano redatto a cura del Servizio Protezione Civile e Ambiente dell'Unione Valdera Dirigente Area Servizi Tecnici Arch. Massimo Parrini Responsabile del Servizio Protezione Civile Dott. Geol. Andrea Sodi Collaboratori Dott. Geol. Silvia Lorenzoni Dott. Geol. Elena Baldi Dott. Geol. Fabrizio Meini Ing. Massimo Saleppichi Cartografie P3 snc Hanno inoltre collaborato: Bacci Massimiliano – Comune di Peccioli Becuzzi Egiziano – Comune di Calcinaia Ceccanti Daniele – Comune di Fauglia Cecchi Marco – Comune di Bientina Doveri Franco – Comune di Palaia Falchi Stefano - Comune di Ponsacco Giusti Luciano – Comune di Capannoli Granchi Marcello – Comune di Chianni Giannelli Massimo – Comune di Lajatico Montanelli Giancarlo – Comune di Lari Paoli Pieranna – Comune di Ponsacco Ponticelli Michele – Comune di Palaia Turchi Riccardo – Comune di Lari Zaccagnini Alessandro – Comune di Ponsacco Si ringraziano per l’amichevole collaborazioni: Dott. Carlo Meletti – INGV di Pisa per la parte sul rischio sismico Bechelli Stefano – Meteotoscana per la parte sui fenomeni meteorologici Dott. Antonio Campus per i confronti e le revisioni sul modello organizzativo Unione Valdera Piano di Protezione Civile – Aprile 2014 Sommario PREMESSA ................................................................................................................................... -

Servizio Di Trasporto Scolastico 2017/2018
COMUNE DI CRESPINA LORENZANA Provincia di Pisa Area Servizi al cittadino PERCORSI ANNO SCOLASTICO 2017/18 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2018 PERCORSI E ORARI in vigore dal 2 ottobre 2017 1. Scuola Media “E. Cozzi” – Via Ragli, 10 – Crespina: orario delle lezioni 8:00-13:00. Lunedì e giovedì alcune classi escono alle ore 17:00. 2. Scuola Elementare “D. Dolci” – Piazza Di Vittorio, 8 - Cenaia: orario 08:30 –12:30. Due giorni a settimana l’orario è esteso a 08:30 –16:30. Alcune classi fanno tempo pieno 08:30 –16:30 – sabato chiusa 3. Scuola Materna “Il girotondo” - Via Piave, 56 - Ceppaiano: orario 9.00-16.00 4. Scuola Elementare – via Gramsci, 28- Lorenzana: orario 08:30 –16.30 sabato chiusa; Scuola Materna “Teste Fiorite” - Via Chiudendini, 3 – Lorenzana: orario 9.00-16.30; Scuola Media Fauglia: orario 8.00-13.00 Scuolabus utilizzati: n. 4 N.B.: Acronimi dei percorsi (esempi): CR ME PA A = Crespina Media Percorso A Andata CR EL PB R = Crespina Elementare Percorso B Ritorno CR MA PA C A = Crespina Materna Percorso C Andata LOMEPDA – LOELPDR = Lorenzana Media Percorso D Andata – Lorenzana Elementare Percorso D Ritorno 1 COMUNE DI CRESPINA LORENZANA Provincia di Pisa Area Servizi al cittadino PERCORSI ANNO SCOLASTICO 2017/18 SCUOLA MEDIA “E. COZZI” - LAVORIA PERCORSO A (CRMEPAA - CRMEPAR1) Fermate Andata Ritorno 7.20 13.05 Il Botteghino 7.22 13.07 Tripalle Case Ater 7.23 13.09 Tripalle Piazza 7.28 13.14 Via Siberia 7.30 13.16 Via Siberia incr. Via la Tana 7.35 13.21 Via la Tana 7.43 13.28 Il Colle 7.45 13.30 Piazza C. -

1. La Permanenza Degli Assetti Storici Del Territorio
1. LA PERMANENZA DEGLI ASSETTI STORICI DEL TERRITORIO Il territorio di San Minato è caratterizzata da una forte presenza di risorse storiche ed archeologiche, al momento non ancora valorizzate appieno, e dal mantenimento di una struttura territoriale che nella fascia collinare interna ha favorito un naturale “isolamento” determinato anche dalla presenza di un carico demografico prevalentemente concentrato nella fascia fluviale della piana dell’Arno. Questo “isolamento” ha favorito così una complessa sedimentazione delle molte tracce del suo passato (periodo romano, medioevale, rinascimentale, moderno, ecc.) e una integrazione dei modi d’uso che si sono succeduti nel tempo, ancora fortemente connessi e visibili nelle relazioni tra ambiente naturale e antropizzato. Si tratta oggi di determinare i modi per innescare processi di valorizzazione dei sistemi di risorse intesi quali momenti strategici di strutturazione e conservazione del territorio e contemporaneamente di sviluppo economico e qualitativo. Tali sistemi devono infatti assumere carattere di risorsa diffusa, e non di beni o monumenti isolati, e vanno considerati come elementi di una struttura territoriale – per punti, linee o aree – che deve suggerire i possibili obiettivi ed interventi cui far riferimento per conformare e valorizzare le possibili trasformazioni. Tale struttura territoriale, con qualità e forme da reinventare e valorizzare, segna il territorio e ne indirizza le trasformazioni diventando la base per un ambito di tutela e sviluppo dei caratteri ambientali propri del territorio samminiatese. Possiamo parlare di una storia del territorio di San Miniato solo dopo il XII secolo periodo in cui l'esplicitarsi del controllo politico unificatore imperiale, e in seguito comunale, lo trasformò in un sistema insediativo compiuto e articolato. -

Territorio E Popolamento Tra I Fiumi Arno, Cascina Ed Era
TERRITORIO E POPOLAMENTO TRA I Recentemente con l’ausilio del telerilevamento e delle FIUMI ARNO, CASCINA ED ERA: RICERCHE fonti archeologiche, documentarie e toponomastiche me- ARCHEOLOGICO-TOPOGRAFICHE ED dievali è stato possibile ricostruire il corso principale del- l’Arno in età storica, grazie anche all’identificazione del ARCHIVISTICHE tracciato relativo alla via Pisae-Florentia che correva in si- di nistra del fiume dalla metà del II sec. a.C. (CECCARELLI LEMUT-PASQUINUCCI 1991, pp. 129-132 e pp. 124-126; per i MARINELLA PASQUINUCCI, SERENA MECUCCI, maggiori interventi sul corso dell’Arno in età medievale e PAOLO MORELLI moderna DELLA ROCCA-MAZZANTI-PRANZINI 1987, p. 70; FEDERICI-MAZZANTI 1988, p. 602; CECCHELLA-PINNA 1991, pp. 57-59; CECCARELLI LEMUT-MAZZANTI-MORELLI 1994, p. Nell’ambito di recenti indagini interdisciplinari (geo- 414). logiche, geomorfologiche, idrografiche e paleoambientali) La natura irruente dei fiumi che solcano l’area, unita effettuate dal gruppo di ricerca facente capo alla Cattedra alla messa a coltura di sempre maggiori porzioni di territo- di Topografia Antica dell’Università degli Studi di Pisa, è rio ed al notevole disboscamento, soprattutto a partire dal- stato possibile arricchire notevolmente le conoscenze ar- l’età romana (STRABO 5, 2, 5, C. 223; PASQUINUCCI 1994a, p. cheologico-topografiche del territorio ad O e SO di Ponte- 195; EAD. 1988a, p. 52; EAD. 1986a, p. 44), hanno determi- dera, delineando un esauriente quadro diacronico di un’area nato disastrosi squilibri idrologici con frequenti inondazio- finora quasi del tutto sconosciuta per quanto riguarda le ni e, in certe epoche, formazioni paludose. Una traccia del- epoche più antiche.