091124 Quaderno Edoc SFR Chiara Nanetti 1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
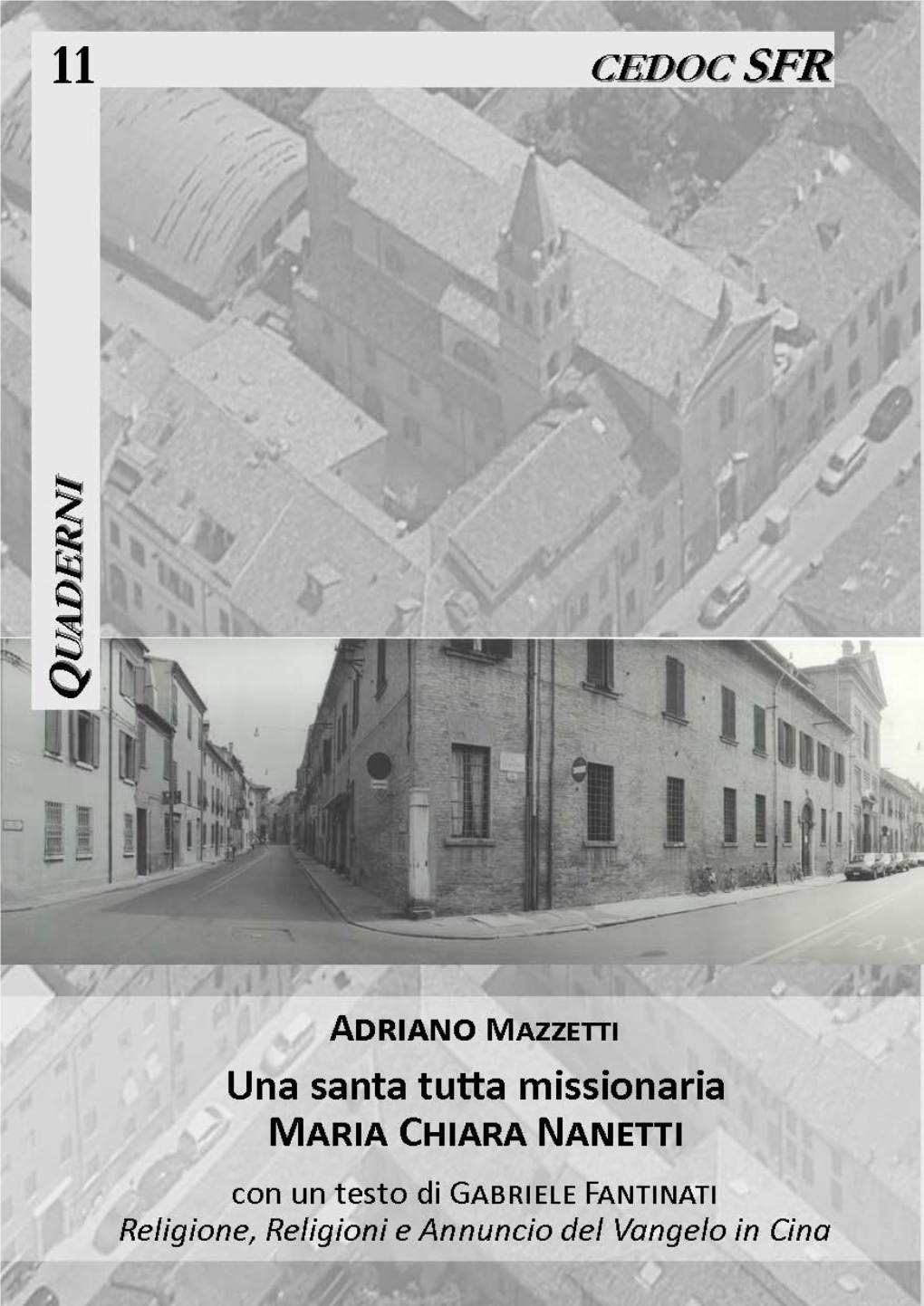
Load more
Recommended publications
-

Martirologio Romano
JULIO Día 1 de julio Kaléndis iúlii. Luna: abcde fghiklmnpqrs tu 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ABCDEF FGHMNP 25 26 27 28 29 30 29 1 2 3 4 5 1. Conmemoración de san Aarón, de la tribu de Leví, a quien su herma- no Moisés ungió sacerdote del Antiguo Testamento con óleo sagrado. A su muerte fue sepultado en el monte Hor. 2. En Vienne, ciudad de la Galia Lugdunense, san Martín, obispo (s. III ex.). 3. En el monasterio de Bebrón, en la región de la Galia Lugdunense, san Domiciano, abad, que vivió primero vida eremítica en este lugar, y habiendo reunido a muchos en torno suyo para que se dedicasen al servicio de Dios, fija su mirada en el cielo, dejó este mundo en buena ancianidad (s. V). 4. En territorio de Neustria Remense, san Teodorico, presbítero, discípu- lo del obispo san Remigio (533). 5. En Angulema, en Aquitania, san Eparquio, presbítero, que pasó treinta y nueve años en completa soledad entregado a la oración, y a sus discípulos les enseñaba: «La fe no teme el hambre» (581). 6* En la Bretaña Menor, san Golveno, obispo, de quien se dice que, des- pués de llevar vida solitaria, sucedió a san Pablo de León (s. VI). 7*. En el monasterio de Anille, en la Galia Cenomanense, san Carilefo, abad (s. VI). 8*. En Londres, en Inglaterra, beatos Jorge Beesley y Montford Scott, presbíteros y mártires, que, condenados a la pena capital por ser sacerdo- tes, pasando por crueles tormentos consiguieron la palma del martirio en tiem- po de la reina Isabel I (1591). -

The French Holy Childhood Association in China, 1843-1951
A Penny for the Little Chinese: The French Holy Childhood Association in China, 1843-1951 The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Harrison, Henrietta. 2008. A penny for the little Chinese: The French Holy Childhood Association in China, 1843-1951. American Historical Review 113, no. 1: 72-92. Published Version http://dx.doi.org/10.1086/ahr.113.1.72 Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:3228646 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA “A Penny for the Little Chinese”: The French Holy Childhood Association in China, 1843–1951 HENRIETTA HARRISON “You will sign up again this year for the work of the Holy Childhood, won’t you?” “I can’t—my parents don’t want to pay.” “But you must have some small sum. You can pay with your own money.” “I don’t have any money . I have a rabbit and I could sell it, but . ” Tears rose in the little boy’s eyes. “Come, come, I will put your name down.” “He is so pretty! And I like him so much!” Then, after a moment of reflection, “All the same, I could certainly sell him for the sake of the little Chinese.”1 Contract breaking off relations: Chen Zhiwan of Diantou village in the Western Mountains has a son, Yinwa, age 12, but his family is too poor to raise the child, so he requests to send him to the Geliaogou boys’ orphanage to be brought up, and to study and learn prayers. -

343 Anthony E. Clark Ji Li Recent Years Have Seen the Emergence Of
Men, Women and Gender in China book reviews Nan Nü 17 (2015) 343-348 343 Anthony E. Clark Heaven in Conflict: Franciscans and the Boxer Uprising in Shanxi. Seattle and London: University of Washington Press, 2014. xiii+219 pp. US$ 50.00. ISBN: 9780295994000. Ji Li God’s Little Daughters: Catholic Women in Nineteenth-century Manchuria. Seattle and London: University of Washington Press, 2015. xii+218 pp. US$ 50.00. ISBN: 9780295994727. Recent years have seen the emergence of a new approach to the study of rural Catholicism in China. By closely examining the specific circumstances of local society, and taking seriously the beliefs and biases of individual actors, schol- ars such as Eugenio Menegon and Henrietta Harrison have moved the study of Chinese Catholicism beyond its previous fixation on moments of crisis such as the Rites Controversy, and come to embrace Catholicism as a Chinese local religion.1 New works by Anthony Clark and Ji Li represent another step in this very welcome trend. The title of Anthony Clark’s book promises a discussion of the Boxer Upris- ing, a topic that is already overshadowed by the magisterial work of Joseph Esherick and Paul Cohen.2 Each of these two dwells largely on the circum- stances that immediately precipitated the event in its birthplace of Shandong province, and while neighboring Shanxi was where the Boxer movement argu- ably became the most violent, Clark’s short volume on the Franciscans and the Boxer Uprising in that province might at first glance be perceived as a slightly derivative account of these now well-known events. -

A Penny for the Little Chinese: the French Holy Childhood Association in China, 1843-1951
A Penny for the Little Chinese: The French Holy Childhood Association in China, 1843-1951 The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Harrison, Henrietta. 2008. A penny for the little Chinese: The French Holy Childhood Association in China, 1843-1951. American Historical Review 113, no. 1: 72-92. Published Version http://dx.doi.org/10.1086/ahr.113.1.72 Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:3228646 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA “A Penny for the Little Chinese”: The French Holy Childhood Association in China, 1843–1951 HENRIETTA HARRISON “You will sign up again this year for the work of the Holy Childhood, won’t you?” “I can’t—my parents don’t want to pay.” “But you must have some small sum. You can pay with your own money.” “I don’t have any money . I have a rabbit and I could sell it, but . ” Tears rose in the little boy’s eyes. “Come, come, I will put your name down.” “He is so pretty! And I like him so much!” Then, after a moment of reflection, “All the same, I could certainly sell him for the sake of the little Chinese.”1 Contract breaking off relations: Chen Zhiwan of Diantou village in the Western Mountains has a son, Yinwa, age 12, but his family is too poor to raise the child, so he requests to send him to the Geliaogou boys’ orphanage to be brought up, and to study and learn prayers. -
LES Lai'cs ET L'apostolat
MONSEIGNEUR CONFORTI Titre origina i: Monsignor Conforti, Vescovo di Par111a e Fo11datore dei Missionari Saveriani 2• edizione. EMI, Bologna 1991 Trad uit par Sr Marie Gabriel Multier. © 20 I O CSAM Soc. coop. a.r.I. Centro Saveriano Animazione Missionaria Via Pimnarta, 9 - 251 21 Brescia Tcl. 030/3772780 TUTII I DIRlTII R ISERVATI I diritti di tradui.ione. di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adallamcnto totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e le copie fo tostmiche) sono riservati per tutti i Pàes i. C 1992 JSME- PARMA Grafica STUDIO ZA Nl • PR Finito di stampare nel mese di aprile 2010 daUa Editrice Pubbliprin t Grafica -Travcrscto!o tPR) PRÉFACE ~en des titres, le Père Augusto Luca était l' auteur tout indiqué pour écrire la vie du Vénérable Mgr Guido Conforti. li nourrissait à son encontre les sentiments d'unfils envers un père, dont le charisme lui avait dévoilé sa propre vocation: en ejfet, le Père Luca est missionnaire de la Congrégation .fondée par Mgr Conforti lui-meme. De son regard de savant il scrute !es documents; les événements, !es faits, et !es voici qui parlent. En chrétien adm.iratif, il demande aux témoins !es signes de la présence mystérieuse de Dieu. Ce récit de la vie de Mgr Conforti compte tout }uste quatre-vingt-dix pages: une succession de cha pitres brefi; d'une lecture a/erte et agréable et cepen dant d'une exactitude scrupuleuse quant au contenu. Synthèse heureuse, possible pour celui-là seul qui en possède le sujet en profondew: Mgr Conforti, camme chacun de nous, appartient à une constellation: il est en lien avec un grand nombre de personnes dont il est le bénéficiaire, ceci vaut surtout dans sa jeunesse, et sur lesquelles il exerce une infiuence, surtout dans sa maturité. -

Consider Supporting Our Parish Through Online Giving. Safe Simple
r Cathedral Basilica of St. Joseph 14th Sunday of Ordinary Time July 8, 2018 “Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples. When the sabbath came he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, ‘Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands! Is he not the carpenter, the son of Mary, Sunday Mass Schedule 00000 Las Misas Dominicales and the brother of James and Joses and Judas and Simon? 4:30pm Saturday And are not his sisters here with us?’ 8:30am Sunday 10:00am Domingo And they took offense at him. Jesus said to them, 11:30am Sunday ‘A prophet is not without honor except in his native place 1:00pm Domingo and among his own kin and in his own house.’ Misa con Lengua de Señas 2o y 4o Domingo So he was not able to perform any mighty deed there, 5:30pm Domingo apart from curing a few sick people by laying his hands on them. Weekday Mass / Misas Diarias He was amazed at their lack of faith.” Mark 6:1-6a • Mon-Friday / Lunes a Viernes 7:30am & 12:05pm Confessions / Las Confesiones • Saturday / Sábado: 4:00 - 4:25pm • Mon-Friday / Lunes a Viernes 11:45am-12:00pm and by appt./ y con cita particular Parish Office / Oficina Parroquial • Mon-Friday / Lunes a Viernes 9:30am – 5:00pm • Sunday / Domingo 9:30am - 2:30pm • Closed Saturday / Cerrado en Sábado Cathedral Tours Visitas a la Catedral con Guía • Tuesday through Friday Martes a Viernes 1:00 - 3:00pm • Groups of 10 or more 10 personas o más Reflection Call / Llame para cita al When have you struggled to speak the truth among your friends? What 408-283-8100 ext. -

Spirtu U Óajja On-Line
Editorjal SPIRTU U ÓAJJA ON-LINE i s t n it OFM a u malta s k t fra n ©i l-4 ta’ Ottubru 1982 ©iet imwaqqfa l-Edizzjoni TAU fi ˙dan il- Provinçja Fran©iskana Maltija. G˙addew 25 sena ta’ ˙idma li Fmatulhom ©ew pubblikati 62 kotba, u˙ud minnhom ta’ divulgazzjoni popolari u o˙rajn ta’ kontenut xjentifiku g˙oli, kif ukoll Ωew© rivisti, speçjalizzati fil-qasam bibliku tal-˙idma tal-Fran©iskani fl- Art Imqaddsa u fil-qasam ta’ l-istudji Fran©iskani. F’din il-˙ar©a tar- rivista «Spirtu u Óajja» insemmu fil-qosor il-˙idma siewja biex ji©u 82 pubblikati kotba dwar Bibbja u Fran©iskane Ωimu f’Malta, ˙idma mibdija minn P. Raymond Camilleri OFM, fundatur ta’ l-Edizzjoni TAU. Kien g˙al din ir-ra©uni taç-çelebrazzjoni tal-25 anniversarju ta’ l- Edizzjoni TAU li, fil-website tal-Provinçja Fran©iskana Maltija, ©iet Rivista li to˙ro© kull tliet xhur inklu Ωa sezzjoni li hi intitolata «Franciscan Studies» bl-ewwel ˙ar©a (www.ofm.org.mt/noelmuscat), li fiha wie˙ed jista’ wkoll isib ir-Rivista f’April 1986 «Spirtu u Óajja» on line. Fil-fatt, min˙abba li jiena attwalment ninsab na˙dem fil-Kustodja Computer Setting: Fran©iskana ta’ l-Art Imqaddsa, u dan jo˙loq diffikultà g˙ax-xog˙ol ta’ Ìwann Abela ofm stampa tar-Rivista, ˙sibt li noffri opportunità ©dida lill-qarrejja. Mill- Joseph Magro ofm 1986, is-sena li fiha bdiet to˙ro© «Spirtu u Óajja», innutajt li n-numru ta’ Stampat: persuni li jistg˙u jaqrawha kif inhi llum qieg˙ed dejjem jonqos. -

Edito Dalla/Edited by the Orthodox Catholic Review
La Pena di Morte in Cina, considerazioni giuridiche e morali di Luca Scotto di Tella de’ Douglas (Prof. Dr. Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa) Edito dalla/Edited by The Orthodox Catholic Review 1 Pena Capitale e Tortura in Cina . Sino alle riforme delle Leggi Penali, era applicata in Cina in TRE modi: a- “Ling Chih”1, o morte lenta, il più grave, riservato ai parricidi e per altri delitti estremamente gravi. In essa il carnefice doveva infliggere mille e mille ferite e mutilazioni alla vittima in modo da non estinguerne la vita sino al colpo di grazia inferto al cuore; b- la decapitazione, rapidamente ed abilmente eseguita ovvero il Taglio della testa (detto anche “decapitazione” o “decollazione”). Il condannato, sovente con le braccia e le mani incatenate e con i ferri alle caviglie, viene legato ad un palo, o posto con il collo su di un ceppo di legno. Il boia colpisce quindi con una spadone ovvero con una sciabola pesante ed a lama larga sulla parte posteriore del collo. La morte avviene per via della rottura del midollo spinale con il primo colpo. Con un secondo colpo viene approfondito il taglio ma senza recidere necessariamente i vasi del collo: la testa può pertanto restare attaccata al busto. Il tempo è lo stesso che per la ghigliottina. Queste le differenze dalla decapitazione normale. Decapitazione mediante ghigliottina (anticamente denominata “guigliottina”, dal francese “guillotine”, che è dal nome di colui che la fece adottare in Francia il 1° marzo 1792, il Medico Dr. J. J. Guillotin, nato a Santes, il 28 maggio 1738. -

Missionari Saveriani Contenuti
COMUNICAZIONE M ISSIONE COMMUNICATION MISSION Missionari Saveriani Contenuti Carissimi fratelli, L l...crrERA Del 5uPeJuoRE GeNERAlE (ITAliANO EINGlese) Rl~~il®m r;~t~m:b~a·: ~5 _ar:n_i ~i pr:es_e~Zl! ~a~~ri~~a. 5 r ~~ ~pe~ie_nc:ia: de ~ue:t~:a -~~6~. d~ ~ol~m:b~a. 12 Baptism of1Rire: Chinds ChrdstJians and the Bc!mer Upnising ofl~ ~5 R. G. TteOEMANN RMX Capitolo Terzo: caratteristiche del nostro carisma 25 Seduçao neoliberal 33 FIIEIBETIO s~e~Hn Una pubbliGazione sui martiri saveriani 37 ERMANNO FERROJ SX l n occasione della canonizzazione àel Beato F. Fogolla 4@ NQBUO lwAMOT0, sx Qrowth and C@mmitmen't' 43 ENI'H0 CAsAI.U€CI, sx Un antico comandamento nuow 48 f.\t..Ae110 CeiiESOU, sx Notizie tial mondo sx 55 ! ~o~tt:i 4efu:r~i . 61 Puòblicazioni di Saveriani 63 Carissimi fratelli, La fede è una risposta al bisogno umano di felicità. O meglio: è proposta di un modo pienamente umano di vivere. Il credente non può pretendere che qualcuno accetti la sua proposta di fede, se da essa non sorgesse, e visibile, un modo di vivere più ampiamente e profondamente umano. Tanto più chiara e forte sarà la capacità di attrazione della proposta, quanto più questa sarà autentica, coeren te e chiara. Mi pare utile fermarsi un momento per cogliere la logica della fede in quanto si distingue dalla logica idolatrica (chiamo così qua lunque logica non credente, sia che affermi l'assenza di ogni assolu to sia che lo identifichi con qualche realtà diversa da Dio). Cerco di sintetizzare questa logica idolatrica secondo la visione più rigorosa, quella che nega cioè insieme a Dio ogni possibilità di giustificazione per la verità o il valore, ogni possibilità di salvezza etero o autofondata. -

Remembrance and Reconstruction in Catholic Shanxi, 1900-Present Anthony E
Whitworth Digital Commons Whitworth University History Faculty Scholarship History 2013 Out of the Ashes: Remembrance and Reconstruction in Catholic Shanxi, 1900-Present Anthony E. Clark Whitworth University, [email protected] Follow this and additional works at: http://digitalcommons.whitworth.edu/historyfaculty Part of the Asian History Commons, Cultural History Commons, and the History of Religion Commons Recommended Citation Clark, Anthony E. , "Out of the Ashes: Remembrance and Reconstruction in Catholic Shanxi, 1900-Present" Whitworth University (2013). History Faculty Scholarship. Paper 5. http://digitalcommons.whitworth.edu/historyfaculty/5 This Article is brought to you for free and open access by the History at Whitworth University. It has been accepted for inclusion in History Faculty Scholarship by an authorized administrator of Whitworth University. “Out of the Ashes: Remembrance and Reconstruction in Catholic Shanxi, 1900-Present” Anthony E. Clark, Ph.D., Whitworth University LEWI Conference Paper, Hong Kong 2013 (All citations and graphs in original chapter.) When the Sino-Western conflicts of the Boxer Uprising had reached their climax in 1900, the Shanxi Confucian, Liu Dapeng, penned a vivid account of the turbulence around his studio. In his Qianyuan suoji, Liu described the theatrical ceremonies of the Boxers who summoned the gods to possess their bodies: Suddenly they raised their gaze and then dropped to the ground as if they were in a sound sleep. Before long their hands and feet began to undulate. They stood erect and danced around with a fierce expression, their eyes shut so tightly they could not be opened. Then they made fists and claws with their hands, leaping and rushing around. -

941-448-8344
July 7 2019 Pastor Fr. Mark Heuberger Parochial Vicar Fr. Michal Szyszka Weekend Masses Saturday Vigil: 4:30 pm Sunday: 7:30 am, 9:30 am, 11:30 am Daily Masses Mon, Wed, Fri: 11am Tue, Thur, Sat: 8 am Holy Days Holy Day Vigil: 4:30 pm Complete schedules are listed in the bulletin prior to the Holy Day Confessions Saturday: 3:30 —4:20 pm Divine Mercy Chaplet Wednesdays 7pm in the chapel Unless noted in the bulletin Eucharistic Adoration First Friday of the Month 11:30 am— 4pm in the chapel “Do we not have in the Eucharist the living, true and real Jesus present before us?” —St. Teresa of Avila 2 Sunday, July 7, 2019 14th Sunday in Ordinary Time Go Deeper Into Today’s Gospel 14th This Sunday, Jesus reminds us that “the harvest is abundant but Sunday the laborers are few.” As Catholic disciples, we are the laborers that the Master is sending. All around us are opportunities to share the love and mercy of Jesus Christ - our homes, our workplaces, § Deceased n Living our neighborhoods, even our faith communities! Lest we feel unequipped for the task, Jesus gives us some advice. Monday, July 8 “Carry no money bag, no sack, no sandals.” We might not have a theology Gn 28:10-22a • Mt 9:18-26 degree or training in public speaking, but that doesn’t mean we can’t share 11am § Charles Bernoski the Gospel. The power of God is at work in simplicity. The disciples Tuesday, July 9 went forth with nothing as a St. -

July 12 Pastor Fr. Mark Heuberger Parochial Vicar Fr. Michal Szyszka Weekend Masses Saturday Vigil
July 12 2020 Pastor Fr. Mark Heuberger Parochial Vicar Fr. Michal Szyszka Weekend Masses Saturday Vigil: 4:30 pm Sunday: 7:30 am, 9:30 am, 11:30 am Daily Masses Mon, Wed, Fri: 11am Tue, Thur, Sat: 8 am Holy Days Holy Day Vigil: 4:30 pm Complete schedules are listed in the bulletin prior to the Holy Day Confessions Saturday: 3:30 —4:20 pm Divine Mercy Chaplet Wednesdays 7pm in the chapel Unless noted in the bulletin Eucharistic Adoration First Friday of the Month 11:30 am— 4pm in the chapel “Do we not have in the Eucharist the living, true and real Jesus present before us?” —St. Teresa of Avila 2 Sunday, July 12, 2020 15th Sunday in Ordinary Time Go Deeper Into Today’s Gospel § Deceased n Living Using the best seeds doesn’t always guarantee the best plants. An older Italian gentleman straight from Italy gave me these amazing tomato seeds that he Monday, July 13 claimed produced the best tomatoes ever grown. Without doubt, the fruit he St. Henry shared with me was a testament to that fact. These tomatoes were amazing! Is 1:10-17 • Mt 10:34-11:1 I couldn’t wait until the next growing season to plant these seeds and harvest 11am § John Moro my own tomatoes. The whole experiment ended up a failure. I did everything the gentleman said, but my fruit didn’t even come close. What happened? At Tuesday, July 14 first I was perplexed, then some years later the light dawned. The problem St.