L'italianizzazione E La Fascistizzazione Dei Nuovi
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
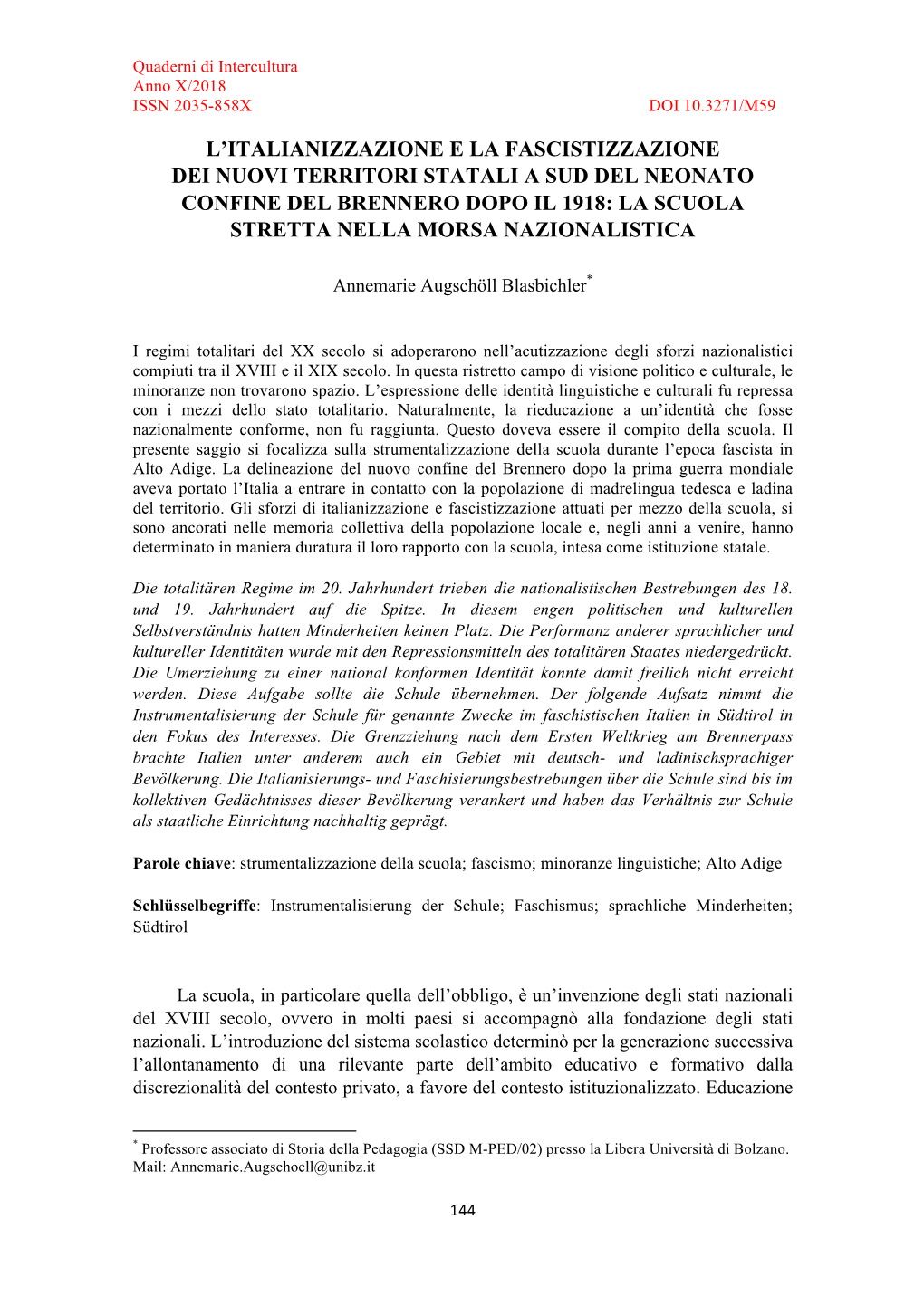
Load more
Recommended publications
-

Fascist Legacies: the Controversy Over Mussolini’S Monuments in South Tyrol
University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln Faculty Publications, Department of History History, Department of 2013 Fascist Legacies: The Controversy over Mussolini’s Monuments in South Tyrol Gerald Steinacher University of Nebraska-Lincoln, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub Steinacher, Gerald, "Fascist Legacies: The Controversy over Mussolini’s Monuments in South Tyrol" (2013). Faculty Publications, Department of History. 144. https://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/144 This Article is brought to you for free and open access by the History, Department of at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in Faculty Publications, Department of History by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. Gerald Steinacher* Fascist Legacies:1 Th e Controversy over Mussolini’s Monuments in South Tyrol2 Th e northern Italian town of Bolzano (Bozen in German) in the western Dolomites is known for breathtaking natural landscapes as well as for its medieval city centre, gothic cathedral, and world-famous mummy, Ötzi the Iceman, which is on dis- play at the local archaeological museum. At the same time, Bolzano’s more recent history casts a shadow over the town. Th e legacy of fascism looms large in the form of Ventennio fascista-era monuments such as the Victory Monument, a mas- sive triumphal arch commissioned by the Italian dictator Benito Mussolini and located in Bolzano’s Victory Square, and the Mussolini relief on the façade of the former Fascist Party headquarters (now a tax offi ce) at Courthouse Square, which depicts il duce riding a horse with his arm raised high in the Fascist salute. -

Architecture and Nation. the Schleswig Example, in Comparison to Other European Border Regions
In Situ Revue des patrimoines 38 | 2019 Architecture et patrimoine des frontières. Entre identités nationales et héritage partagé Architecture and Nation. The Schleswig Example, in comparison to other European Border Regions Peter Dragsbo Electronic version URL: http://journals.openedition.org/insitu/21149 DOI: 10.4000/insitu.21149 ISSN: 1630-7305 Publisher Ministère de la culture Electronic reference Peter Dragsbo, « Architecture and Nation. The Schleswig Example, in comparison to other European Border Regions », In Situ [En ligne], 38 | 2019, mis en ligne le 11 mars 2019, consulté le 01 mai 2019. URL : http://journals.openedition.org/insitu/21149 ; DOI : 10.4000/insitu.21149 This text was automatically generated on 1 May 2019. In Situ Revues des patrimoines est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International. Architecture and Nation. The Schleswig Example, in comparison to other Europe... 1 Architecture and Nation. The Schleswig Example, in comparison to other European Border Regions Peter Dragsbo 1 This contribution to the anthology is the result of a research work, carried out in 2013-14 as part of the research program at Museum Sønderjylland – Sønderborg Castle, the museum for Danish-German history in the Schleswig/ Slesvig border region. Inspired by long-term investigations into the cultural encounters and mixtures of the Danish-German border region, I wanted to widen the perspective and make a comparison between the application of architecture in a series of border regions, in which national affiliation, identity and power have shifted through history. The focus was mainly directed towards the old German border regions, whose nationality changed in the wave of World War I: Alsace (Elsaβ), Lorraine (Lothringen) and the western parts of Poland (former provinces of Posen and Westpreussen). -

Pergher Cover
MAX WEBER PROGRAMME EUI Working Papers MWP 2009/08 MAX WEBER PROGRAMME BORDERLINES IN THE BOR DERLANDS: DEFINING DIFFERENCE THROUGH HISTORY, RACE , AND " " CITIZENSHIP IN FASCIST ITALY Roberta Pergher EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE , FLORENCE MAX WEBER PROGRAMME Borderlines in the Borderlands: Defining difference through history, “race”, and citizenship in Fascist Italy ROBERTA PERGHER EUI W orking Paper MWP 2009/08 This text may be downloaded for personal research purposes only. Any additional reproduction for other purposes, whether in hard copy or electronically, requires the consent of the author(s), editor(s). If cited or quoted, reference should be made to the full name of the author(s), editor(s), the title, the working paper or other series, the year, and the publisher. The author(s)/editor(s) should inform the Max Weber Programme of the EUI if the paper is to be published elsewhere, and should also assume responsibility for any consequent obligation(s). ISSN 1830-7728 © 2009 Roberta Pergher Printed in Italy European University Institute Badia Fiesolana I – 50014 San Domenico di Fiesole (FI) Italy www.eui.eu cadmus.eui.eu Abstract The paper discusses the colony in Libya and the province of South Tyrol under Fascism. It focuses on their status as “borderlands” and what that meant in terms of defining the difference between the native populations on the one hand and the immigrant Italian population on the other. In particular, the paper analyzes the place afforded to the Libyan and the South Tyrolean populations in Italian ideology and legislation. It discusses the relevance of the myth of Rome for Italy’s expansion and analyzes various taxonomies of difference employed in the categorization of the “other,” in particular racial and religious markers of difference. -
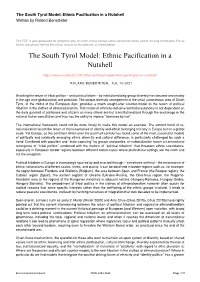
The South Tyrol Model: Ethnic Pacification in a Nutshell Written by Roland Benedikter
The South Tyrol Model: Ethnic Pacification in a Nutshell Written by Roland Benedikter This PDF is auto-generated for reference only. As such, it may contain some conversion errors and/or missing information. For all formal use please refer to the official version on the website, as linked below. The South Tyrol Model: Ethnic Pacification in a Nutshell https://www.e-ir.info/2021/07/19/the-south-tyrol-model-ethnic-pacification-in-a-nutshell/ ROLAND BENEDIKTER, JUL 19 2021 Avoiding the return of tribal politics – and political tribes – by institutionalizing group diversity has become one priority in the age of re-globalization and populism. The unique diversity arrangement of the small autonomous area of South Tyrol, in the midst of the European Alps, provides a much sought-after counter-model to the return of political tribalism in the clothes of ethnonationalism. This model of ethnicity-inclusive territorial autonomy is not dependent on the daily goodwill of politicians and citizens as many others are but is institutionalized through the anchorage in the national Italian constitution and thus has the ability to impose “tolerance by law”. The international framework could not be more timely to make this model an example. The current trend of re- nationalization favors the return of mono-narratives of identity and ethnic belonging not only in Europe but on a global scale. Yet Europe, as the continent which over the past half-century has found some of the most successful models of politically and juridically arranging ethnic diversity and cultural difference, is particularly challenged by such a trend. -

The South Tyrol Question, 1866–2010 10 CIS ISBN 978-3-03911-336-1 CIS S E I T U D S T Y I D E N T I Was Born in the Lower Rhine Valley in Northwest Germany
C ULTURAL IDENT I TY STUD I E S The South Tyrol Question, CIS 1866–2010 Georg Grote From National Rage to Regional State South Tyrol is a small, mountainous area located in the central Alps. Despite its modest geographical size, it has come to represent a success story in the Georg Grote protection of ethnic minorities in Europe. When Austrian South Tyrol was given to Italy in 1919, about 200,000 German and Ladin speakers became Italian citizens overnight. Despite Italy’s attempts to Italianize the South Tyroleans, especially during the Fascist era from 1922 to 1943, they sought to Question, 1866–2010 Tyrol South The maintain their traditions and language, culminating in violence in the 1960s. In 1972 South Tyrol finally gained geographical and cultural autonomy from Italy, leading to the ‘regional state’ of 2010. This book, drawing on the latest research in Italian and German, provides a fresh analysis of this dynamic and turbulent period of South Tyrolean and European history. The author provides new insights into the political and cultural evolution of the understanding of the region and the definition of its role within the European framework. In a broader sense, the study also analyses the shift in paradigms from historical nationalism to modern regionalism against the backdrop of European, global, national and local historical developments as well as the shaping of the distinct identities of its multilingual and multi-ethnic population. Georg Grote was born in the Lower Rhine Valley in northwest Germany. He has lived in Ireland since 1993 and lectures in Western European history at CIS University College Dublin. -

The Construction of Identity in South Tyrol Barbara L. Hilden
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 Canada License “A Sense of Place:” The Construction of Identity in South Tyrol Barbara L. Hilden B.L. Hilden 2 TABLE OF CONTENTS 1. History 1.1 Pre-Fascism 1.2 Fascism in South Tyrol 1.3 The Option 1.4 Post-War Times 1.5 Autonomy to das Paket 1.6 das Paket to the Present 1.7 Final Thoughts 2. Positioning 2.1 The Constructivist Approach 2.2 Identity 2.3 Positioning 2.3.1 First and Second Order Positioning 2.3.2 Intentional Positioning 2.3.3 Deliberate Self-positioning 2.3.4 Forced Self-positioning 2.3.5 Positioning of Others 2.4 Collective Positioning 2.5 Local Identity 2.6 Linguistic Identity in Minority Populations 2.7 Linguistic Construction of Regional Identity 3. Regionalism B.L. Hilden 3 3.1 Group Identity 3.1.1 Populations and Hollow Categories 3.1.2 The Individual, the Group, and the Nation 3.2 Localism 3.3 Diacritical Identity 3.3.1 Recursive, Segmentary, and Fractal Identities 3.3.2 Metonymic Misrepresentation 3.4 Community 3.4.1 Northern/Southern Distinction 3.4.2 Urban/Rural Distinction 4. Conclusions 5. References 6. Appendix A 7. Appendix B B.L. Hilden 4 NOTES On language: This thesis makes use of a number of German-language sources. Where necessary, the original quote is included followed by an English translation. Occasionally the original is paraphrased and the citation referenced. All translations, unless otherwise noted, are my own. On nomenclature: The names by which one references places can carry vast political and emotional significance. -

Securitizing Borders: the Case of South Tyrol
Nationalities Papers (2021), 1–19 doi:10.1017/nps.2021.14 ARTICLE Securitizing Borders: The Case of South Tyrol Andrea Carlà* Eurac Research – Institute for Minority Rights, Bolzano/Bozen, Italy *Corresponding author. Email: [email protected] Abstract Situated at the interplay between ethnic politics, migration, border, and security studies, this contribution analyzes processes of securitization of borders in South Tyrol, an Italian province bordering Austria and Switzerland with a German- and Ladin-speaking population and a past of ethnic tensions. South Tyrol is considered a model for fostering peaceful interethnic relations thanks to a complex power-sharing system. However, the arrival of migrants from foreign countries and the more recent influx of asylum seekers have revitalized debates around the borders between South Tyrol/Italy and Austria and among South Tyrolean linguistic groups. The current COVID-19 pandemic has brought further complexity to the issue. I use the concept of securitization—the process through which an issue is considered as an existential threat requiring exceptional measures—in order to understand why and how borders become exclusionary and restrictive, shaping dynamics of othering. With this framework, the article explores how South Tyrolean borders have been subjected to (de)securitizing and resecuritizing moves in discourses and practices. In this way, I shed new light on debates on the articulation of borders and interethnic relations that are occurring due to recent international migration, consolidation of nationalist agendas, and the current pandemic. Keywords: borders; securitization; South Tyrol; migration; interethnic relations Introduction Even as we celebrated the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall, one of the most notorious borders in recent human history, the subject of borders has never been so present and relevant. -

The South Tyrol and the Principle of Self-Determination
Eastern Illinois University The Keep Masters Theses Student Theses & Publications 1994 The outhS Tyrol and the Principle of Self- Determination: An Analysis of a Minority Problem Eva Pfanzelter This research is a product of the graduate program in History at Eastern Illinois University. Find out more about the program. Recommended Citation Pfanzelter, Eva, "The outhS Tyrol and the Principle of Self-Determination: An Analysis of a Minority Problem" (1994). Masters Theses. 2050. https://thekeep.eiu.edu/theses/2050 This is brought to you for free and open access by the Student Theses & Publications at The Keep. It has been accepted for inclusion in Masters Theses by an authorized administrator of The Keep. For more information, please contact [email protected]. THESIS REPRODUCTION CERTIFICATE TO: Graduate Degree Candidates (who have written formal theses) SUBJECT: Permission to Reproduce Theses The University Library is rece1v1ng a number of requests from other institutions asking permission to reproduce dissertations for inclusion in their library holdings. Although no copyright laws are involved, we feel that professional courtesy demands that permission be obtained from the author before we allow theses to be copied. PLEASE SIGN ONE OF THE FOLLOWING STATEMENTS: Booth Library of Eastern Illinois University has my permission to lend my thesis to a reputable college or university for the purpose of copying it for inclus~on in that institution's library or research holdings. 3--6\-9Y Date I respectfully request Booth Library of Eastern Illinois University not allow my thesis to be reproduced because: Author Date The South Tyrol and the Principle of Self-Determination. -

Storia E Identità Culturale in Una Regione Di Confine: Il Trentino-Alto Adige/Südtirol* Luigi Blanco
Storia e identità culturale in una regione di confine: il Trentino-Alto Adige/Südtirol* Luigi Blanco Premessa Il territorio attualmente occupato dalla regione «speciale» Tren- tino-Alto Adige/Südtirol1, la cui autonomia è costituzionalmente garantita dall’ordinamento della Repu lica italiana, è compreso tra il con!ine di Stato del "rennero a settentrione e la c#iusa di Borghetto, che lo separa a sud dalla provincia $eneta di %erona, e presenta una peculiarit& di !ondo, riconduci ile sostanzialmente alle $icende storiche che lo hanno interessato negli ultimi due se- coli. (sso è stato, infatti, caratterizzato da un peculiare processo, nondimeno comune ad altre regioni di frontiera), che ha visto una minoranza etnico-linguistica e culturale, quella italiana nell’Impe- + Il presente saggio riproduce quasi fedelmente, con poche integrazioni e gli in- dispensabili rimandi bibliografici, il testo in $ersione italiana dell’inter$ento tenu- to a (dimburgo il 7 ottobre 2004 in occasione del Convegno internazionale orga- nizzato dalla Saltire Society dal titolo «Cultural Policy – The %ie3 from Europe». 1 Tale denominazione è stata solo recentemente introdotta ufficialmente con la legge costituzionale del )-01 che ha riformato il titolo V della Costituzione della Repubblica italiana' ) Sulle regioni di !rontiera, oggetto di nuo$o interesse da parte della storiogra!ia, con ri!erimento in particolare alle dispute nazionali e culturali sui con!ini, segnalo *ui S' 45567 - A' A8A9TIA :edd;, Identità regionali nelle Alpi, numero monogra- !ico di «0rotagonisti» <<, 1===, n' ,>? 8' @' 8A66(R - R' 0(TRI :edd;, Die Na- tionalisierung von Grenzen. ur !onstru"tion nationaler Identit#t in sprac$lic$ ge- misc$ten Grenzregionen, 8ar urg )--)? 8' /ATTARBCCA :ed;, Nazionalismi di %rontiera. -
Introduction
Cambridge University Press 978-1-108-41974-1 — Mussolini's Nation-Empire Roberta Pergher Excerpt More Information Introduction On 20 September 1920, two years before gaining power, Benito Mussolini gave a speech in Trieste celebrating half a century of Italian unity.1 The city, conquered in the First World War and about to be formally incorpo- rated into the Italian nation, was a fitting location.2 After all, Italian nationalists hailed the Great War as the fourth war of unification, fought to “redeem” from Austrian rule territories they claimed as Italian. Among them, none was more precious than Trieste. Addressing his audience in a meandering, disjointed, and bombastic speech like so many he would give in his long career, Mussolini declared Italianità (Italianness) to be “the first fundamental pillar of Fascist action” and exhorted Italians everywhere to “shout loudly: We are Italians!”3 While the speech celebrated Italian unity, cohesion, and pride, it also acknowledged – as well it might, given the city’s mixed population – that Italy now included also non-Italians.4 Mussolini urged Italy to stand up to the newly conquered “tribes barking more or less incomprehensible lan- guages” at the borders of the nation. He also spoke dismissively of other populations challenging Italian rule, including recently subjected colonial peoples in North Africa, whom he mocked as “a handful of Arabs rebelling in Libya.”5 As he envisaged the Italy of the future, Mussolini left no doubt 1 The official fiftieth anniversary of Italian unification was celebrated in 1911. In his speech, Mussolini celebrated the anniversary of the conquest of the city of Rome on 20 September 1870. -
CAPITOLO PRIMO Dallo Stato Fascista Alla Liberazione
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE CATTEDRA DI TEORIA E STORIA DEI MOVIMENTI E DEI PARTITI POLITICI LA DIALETTICA PARTITICA PER LA RISOLUZIONE DELLA QUESTIONE ALTOATESINA. Dalla firma del Trattato di Saint-Germain-en-Laye alla formulazione del Primo Statuto di Autonomia Regionale RELATORE: CANDIDATO: Prof.ssa Vera Capperucci Claudia Cioffi Matr. 072112 Anno Accademico 2014-2015 1 Indice INTRODUZIONE Cenni storico-politici CAPITOLO PRIMO Dallo stato fascista alla liberazione 1.1 La politica centralistica dello Stato fascista e il processo di italianizzazione 1.2 I negoziati italo-tedeschi e le opzioni in Alto Adige 1.3 La zona di operazione delle Prealpi CAPITOLO SECONDO La politica interna italiana per l’Alto Adige 2.1 I movimenti clandestini di resistenza e la nascita della SVP 2.2 L’accordo CLN-SVP 2.3 La genesi degli Accordi di Parigi Degasperi-Gruber CAPITOLO TERZO La maturazione della prospettiva autonomistica 3.1 «Tra il dire e il fare». Le interpretazioni dell’Accordo di Parigi 3.2 A due passi dall’Autonomia: l’art. 116 e lo Statuto Innocenti 3.3 Lo Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige CONCLUSIONE BIBLIOGRAFIA 2 INTRODUZIONE CENNI STORICO-POLITICI La Grande Guerra combattuta tra le montagne della regione, dall’altopiano della Folgaria al valico di Luserna e di Vezzena, in una logorante guerra di trincea, sconvolse il panorama fisico e culturale della regione del Trentino comportando drammatiche conseguenze demografiche. Il Patto di Londra del 26 aprile 1915, stipulato dal Governo italiano con le potenze dell’Intesa, stabiliva l’annessione per il Regno d’Italia delle terre irredente della Venezia Tridentina – Trentino e Alto Adige o Tirolo meridionale ‒ della Venezia Giulia e dell’Istria. -

Le Vicende Della Scuola Altoatesina Nell'ultimo Secolo
Storia e scuola: le vicende della scuola altoatesina nell’ultimo secolo Bolzano 1900: storie di scuole, nazionalismi e plurilinguismo. Milena Cossetto Premessa Ricostruire la storia delle istituzioni scolastiche nel territorio tra le valli dell’Inn e dell’Adige è un po’ come entrare in un labirinto: quella che solitamente sembra una delle istituzioni più lente a metabolizzare le trasformazioni della società, della cultura, del mondo economico e del lavoro, in questa terra tra i monti spesso diventa, invece, la cartina al tornasole della qualità delle relazioni tra i tre gruppi linguistici e quindi, accanto alla storia e al fare storia, uno dei principali terreni di conflitto. Anche i tabelloni didattici, le carte parietali, i cartelloni – che dir si voglia – ad un primo sguardo sembrano essere consueti strumenti didattici, comuni a tutte le scuole in Europa tra la fine dell’Ottocento e i primi 50 anni del Novecento. Un’osservazione più attenta ci permette, però, di cogliere quelle differenze che da sempre hanno reso ricche le tradizioni culturali (pedagogiche e didattiche) tedesche, absburgiche ed italiane e nello stesso tempo le affinità che hanno poi permesso, nel crogiuolo del Tirolo-Sudtirolo-Alto Adige, di costruire delle scuole assolutamente originali, sia dal punto di vista dei contenuti, del calendario, dell’orario, della articolazione in discipline, sia della cultura pedagogica, sia dell’efficacia didattica. Certo, come scriveva Claus Gatterer1, “Chi sottrae una comunità, sia essa grande o piccola, all'analfabetismo, quegli compie un'impresa culturale e sociale al servizio dell'umanità. Chi porta l'abc in un villaggio dimenticato dal progresso, fa per questo villaggio più dei costruttori di strade e di ferrovie che lo collegano al mondo.