Archivio Storico Messinese - 70
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
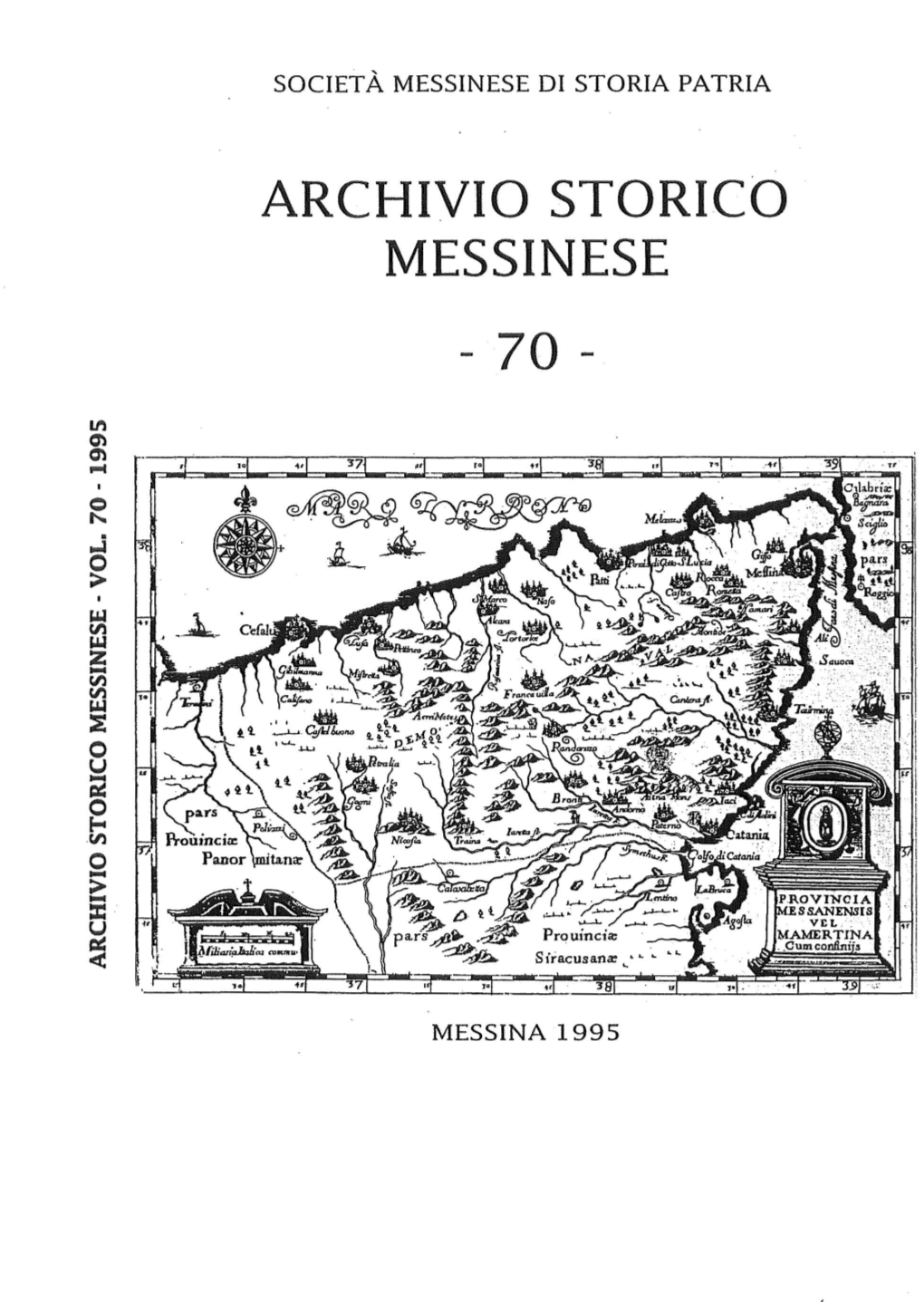
Load more
Recommended publications
-

Sicily's Ancient Landscapes & Timeless Traditions 2021
YOUR O.A.T. ADVENTURE TRAVEL PLANNING GUIDE® Sicily’s Ancient Landscapes & Timeless Traditions 2021 Small Groups: 8-16 travelers—guaranteed! (average of 13) Overseas Adventure Travel ® The Leader in Personalized Small Group Adventures on the Road Less Traveled 1 Dear Traveler, At last, the world is opening up again for curious travel lovers like you and me. And the O.A.T. Sicily’s Ancient Landscapes & Timeless Traditions itinerary you’ve expressed interest in will be a wonderful way to resume the discoveries that bring us so much joy. You might soon be enjoying standout moments like these: Who doesn’t love to eat in Italy? But Sicilian food, which is heavily influenced by the Arabs who thrived here, is in a league of its own. Sample the local flavors when you visit the Tunisian-inflected town of Mazara del Vallo and share a traditional Sicilian lunch with a local family. As you savor the home-cooked fare, you’ll learn how the city’s identity continues to evolve, and the vital role of the local fishing industry. You’ll also visit a home of a very different sort, one that traveler Carol Bowman described as “a house full of hope.” It’s Casa di Maria, an organization (and Grand Circle Foundation partner) established by a family in Catania to provide a loving home for children who are refugees or victims of neglect and domestic violence. The daughter-in-law of the founders (Sergio and Carmela) will enlighten you about Sicily’s foster care system. And you’ll meet more of the Casa’s extended family, including a young Nigerian woman who literally showed up on Sicily’s shores with nothing and grew up here, and hear her harrowing—but ultimately inspiring—story. -

Archivio Storico Messinese - 50
SOCIETÀ MESSINESE DI STORIA PATRIA ARCHIVIO STORICO MESSINESE - 50 - o l.Jj ,.....; o :> S iracusanre ", M E S S I N A 1987 ARCHIVIO STORICO MESSINESE PERIODICO DELLA SOCIETÀ MESSINESE DI STORIA PATRIA Autorizzazione n. 8225 Tribunale di Messina del 18·XI-1985 - ISSN 0392-0240 Direzione e Amministrazione presso l'Università degli Studi - 98100 MESSINA COMITATO DIRETTIVO Sebastiana Consolo Langher, Presidente Maria Alibrandi, v. Presidente Salvatore Bottari Vittorio Di Paola, v. Presidente Federico Martino Rosario Moscheo Giacomo Scibona Angelo Sindoni, Direttore Responsabile REDAZIONE Giacomo Scibona, coordinatore generale Giovanni Molonia Rosario Moscheo SOMMARIO: S. BOSCARINO SA ALBERTI Il Duomo di Messina dopo il terremo Note sul monastero basiliano di to del 1908 tra consolidamento e ri- San Michele Arcangelo il N uovo in costruzione ........................................................ Pago 5 Troina .. _............... ".......................... ".. """ .... "..... » 123 V. LA ROSA G. MOLONIA La chiesa di S. Elia a Noto antica.... Pago 45 La chiesa di Sant'Andrea Avellino e la "seconda casa" dei Teatini a Mes- A. FAZIO-G. GIORGIANNI sina ...... "........................ " ..................................... .. » 157 La Chiesa di S. Maria di Portella (Messina) ............... ".... """"""" ....... ".".............. Pago 77 In copertina: Provincia Messanen.sis vel Mamertina, da Atlante delle Provincie Cappuccine, Roma 1640 c. (Collezione Luciano Ordile). ARCHIVIO STORICO MESSINESE Periodico fondato nel Millenovecento SOCIETÀ MESSINESE DI STORIA PATRIA ARCHIVIO STORICO MESSINESE - 50 - III serie - XLI Vol. 50° dalla fondazione M E S S I N A 1987 SALVATORE BOSCARINO IL DUOMO DI MESSINA DOPO IL TERREMOTO DEL 1908 TRA CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE * Il Duomo della città di Messina era uno dei maggiori esempi dell'architettura medioevale della Sicilia e del Mez zogiorno d'Italia; esso ha avuto attraverso i tempi una vita tormentata, contrassegnata da crolli, incendi e molteplici in- terventi di ammodernamento e di trasformazione. -

I Terremoti E I Maremoti Dello Stretto Di Messina Dal Mondo Antico Alla Fine Del XX Secolo: Descrizioni E Parametri
estratto dal volume: Il terremoto e il maremoto del 28 dicembre 1908: analisi sismologica, impatto, prospettive, a cura di G.Bertolaso, E.Boschi, E.Guidoboni e G.Valensise, DPC–INGV, Roma–Bologna 2008, 813 pp. I terremoti e i maremoti dello Stretto di Messina dal mondo antico alla fine del XX secolo: descrizioni e parametri Alberto Comastri e Dante Mariotti Un excursus storico di oltre duemila anni sintetizza le conoscenze atte- state da fonti scritte. Antiche testimonianze, annotazioni in codici me- dievali, ma anche dettagliate relazioni di epoca moderna e rilevazioni contemporanee consentono di delineare un quadro il più possibile com- pleto della sismicità di quest’area, abitata fin dai tempi più remoti. Emergono diversi terremoti minori, alcuni dei quali quasi dimenticati, che tuttavia confermano un’immagine dell’attività sismica nell’area dello Stretto caratterizzata da eventi frequenti, ma dominata da rari ter- remoti catastrofici. Un’esplorazione nella storia sismica dello Stretto L’abate Giuseppe Mercalli, nel suo classico studio I terremoti della Calabria meri- dionale e del messinese (1897), definì 18 “centri sismici” – oggi diremmo aree sismo- genetiche – da cui si originavano i terremoti che periodicamente colpivano la parte meridionale della Calabria e il messinese. Tra questi, Mercalli non considerò il “cen- tro sismico” dello Stretto di Messina, perché riteneva che le notizie di cui era in pos- sesso, relative a terremoti localizzati a Messina e a Reggio Calabria, fossero effetti lo- cali di terremoti originati in aree adiacenti, soprattutto nella zona della Piana di Gioia Tauro, di cui fossero rimasti ignorati gli effetti nelle aree epicentrali. Dopo il catastrofico terremoto del 28 dicembre 1908, Mercalli (1909) fu costretto a rivedere la sua ipotesi precedente e, al termine dello studio dedicato a quell’evento straordinario, riconobbe l’esistenza del “centro sismico” Reggio–Messina, a cui colle- gò oltre al terremoto del 1908, gli altri eventi di cui aveva notizia. -

Rivista Di Temi Di Critica E Letteratura Artistica
Rivista di temi di Critica e Letteratura artistica numero 3 - 20 maggio 2011 Direttore responsabile: Giovanni La Barbera Direttore scientifico: Simonetta La Barbera Comitato Scientifico: Claire Barbillon, Franco Bernabei, Silvia Bordini, Claudia Cieri Via, Rosanna Cioffi, Maria Concetta Di Natale, Antonio Iacobini, César García Álvarez, Simonetta La Barbera, Donata Levi, François-René Martin, Emilio J. Morais Vallejo, Massimiliano Rossi, Gianni Carlo Sciolla, Philippe Sénéchal. Redazione: Carmelo Bajamonte, Francesco Paolo Campione, Roberta Cinà, Nicoletta Di Bella, Roberta Priori, Roberta Santoro. Progetto grafico, editing ed elaborazione delle immagini: Nicoletta Di Bella e Roberta Priori. Università degli Studi di Palermo ISSN: 2038-6133 - DOI: 10.4413/RIVISTA Facoltà di Lettere e Filosofia Copyright © 2010 teCLa – Tribunale di Palermo – Autorizzazione n. 23 del 06-10-2010 Dipartimento di Studi culturali http://www.unipa.it/tecla __________________________________________________________ Società Italiana di Storia della Critica d’Arte © 2010 Università degli Studi di Palermo Rivista di temi di Critica e Letteratura artistica numero 3 - 20 maggio 2011 48 Simonetta La Barbera Presentazione 12 Carmelo Bajamonte L’iter editoriale del “Mercurio siculo o sia collezione enciclopedica di materie, e argomenti relativi alle arti, scienze, e belle lettere” (1818) 26 Nicoletta Di Bella Musica nel “Poliorama pittoresco” 50 Jolanda Di Natale La modernità raggiunta: il rinnovamento della vita musicale a Palermo tra Otto e Novecento attraverso la nuova stampa periodica specializzata (“La Sicilia musicale” 1894-1910; “L’arte musicale” 1898; la “Rassegna d’arte e teatri” 1922-1936) 86 Marcella Marrocco Stefano Bottari direttore di “Arte antica e moderna” (1958-1966). Note sull’arte meridionale Proprietà artistica e letteraria riservata all’Editore a norma della Legge 22 aprile 1941, n. -

Di Tutti I Tempi
“I NEBRODI” DI TUTTI I TEMPI Addinga Pinuccio Ficarra chitarrista Adriano Luciano Ficarra danzerino Adriano Maria Rita Ficarra danzerina Adriano Patrizia Ficarra danzerina Agnello Ivana Gioiosa Marea danzerina Aiello Rita Patti danzerina Alcamo Vito Oliveri fisarmonicista Alemanni Massimo Capo d’Orlando danzerino Alemanni Salvatore Capo d’Orlando danzerino Alessandro Giovanni Messina fisarmonicista Arasi Carmelo Ficarra danzerino Artale Gaetano Ficarra chitarrista Bartolone Gabriella Gioiosa Marea danzerina Batia Antonino Ficarra danzerino Batia Letizia Ficarra danzerina Baudo Nino Ficarra friscalettaru Bello Eunice Capo d’Orlando danzerina Biscuso Antonio Ficarra tamburellista Biscuso Ciccino Ficarra mandolinista Biscuso Giuseppe Ficarra danzerino Biscuso Nunzio Ficarra tamburellista Biscuso Pasqualino Ficarra chitarrista Biscuso Sebastiano Ficarra danzerino Bonfiglio Enrico Ficarra marranzanista Bonfiglio Mimmo Ficarra danzerino Bonfiglio Sebastiano Ficarra danzerino Bontempo Calogero Naso danzerino Borà Paolo Gioiosa Marea friscalettaru Bruno Cinzia Brolo danzerina Bruno Lucia Brolo danzerina Bruno Nuccia Brolo danzerina Buono Pippo Patti danzerino Busacca Antonino Ficarra danzerino Busacca Ivano Ficarra trocculista Busacca Nunzio Ficarra trocculista Busacca Pietro Ficarra danzerino Buttà Adelina Ficarra danzerina Buttà Tindara Ficarra danzerina Buzzanca Salvatore Capo d’Orlando danzerino Calabrese Giuseppe Ficarra danzerino Calabrese Nuccio Ficarra percussionista Calamunci Cosè Tortorici fisarmonicista Calamunci Salvatore Ficarra -

J:\Monforte\Monforte
A cura di Filippo Imbesi, Giuseppe Pantano e Luigi Santagati Ricerche storiche e archeologiche nel Val Demone Atti del Convegno del 17-18 maggio 2014 Monforte San Giorgio (Messina) Società nissena di storia patria 1 Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/) 2 Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/) Ricerche storiche e archeologiche nel Val Demone Atti del Convegno di studi Monforte San Giorgio (Messina) Sabato 17 e domenica 18 maggio 2014 a cura di Filippo Imbesi, Giuseppe Pantano e Luigi Santagati 3 Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/) Società nissena di storia patria - Caltanissetta Collana Scarabelliana n. 17 Ricerche storiche e archeologiche nel Val Demone: atti del Convegno del 17-18 maggio 2014, Monforte San Giorgio (Messina) / a cura di Filippo Imbesi, Giuseppe Pantano e Luigi Santagati. - Caltanissetta: Società nissena di Storia Patria, 2014. (Scarabelliana ; 17) 1. Archeologia – Val Demone - Atti di congressi. I. Imbesi, Filippo <1970->. II. Pantano, Giuseppe <1957-> III. Santagati, Luigi <1949->. 937.81 CDD-22 SBN Pal0274229 CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” Poichè i curatori e gli autori considerano la cultura un bene collettivo, è possibile copiare questo volume con la sola preghiera di citarlo. Composizione grafico-tipografica a cura di Luigi Santagati In copertina: Particolare degli scranni lignei della chiesa Madre di Monforte San Giorgio. 4 Print to PDF without -

Opere Cantierabili Regione Siciliana Al 22 Dicembre 2016.Xlsx
ELENCO DELLE OPERE CANTIERABILI IN SICILIA AL 22 DICEMBRE 2016 Palermo, 22/12/2016 RICOGNIZIONE ANCE OPERE IMMEDIATAMENTE CANTIERABILI AL 29/04/2015 Palermo, 22/12/2016 RICOGNIZIONE ANCE OPERE IMMEDIATAMENTE CANTIERABILI AL 22/09/2015 PROGETTI IMPORTO 439 3.866 milioni € CATEGORIE DI OPERE NUMERO IMPORTO (€) A-Opere stradali (nuove o varianti) 27 1.725.088.173 B-Opere stradali (manutenzione, messa in sicurezza) 55 34.199.502 C-Opere ferroviarie 7 1.373.914.442 D-Infrastrutture portuali e marittime 1 4.850.000 E-Infrastrutture idriche 69 273.726.941 F-Opere di trasporto pubblico e per la mobilità urbana sostenibile 5 2.861.495 G-Opere urbane - Interventi su spazi pubblici urbani 80 121.212.120 H-Interventi su edifici scolastici 59 127.799.709 I-Interventi su edifici culturali 15 44.542.016 J-Impianti sportivi 23 20.284.504 K-Interventi su altri edifici pubblici 38 Palermo, 22/12/2016 L-Rischio idrogeologico e protezione dell'ambiente 46 87.410.077 M-Altri 14 11.626.087 TOTALE 439 3.827.515.066 RICOGNIZIONE ANCE OPERE IMMEDIATAMENTE CANTIERABILI AL 22/12/2016 PROGETTI IMPORTO 437 3.836 milioni € CATEGORIE DI OPERE NUMERO IMPORTO (€) A-Opere stradali (nuove o varianti) 26 1.699.088.173 B-Opere stradali (manutenzione, messa in sicurezza) 55 34.199.502 C-Opere ferroviarie 7 1.373.924.442 D-Infrastrutture portuali e marittime 1 4.850.000 E-Infrastrutture idriche 68 273.726.941 F-Opere di trasporto pubblico e per la mobilità urbana sostenibile 5 2.861.495 G-Opere urbane - Interventi su spazi pubblici urbani 80 121.212.120 H-Interventi su edifici -

Città Metropolitana Di Messina Sindaco Metropolitano Servizio Comunicazione E Ufficio Stampa
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA SINDACO METROPOLITANO SERVIZIO COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA Prot. n. 42/U.S. del 11/05/2021 Al Sig. Sindaco del Comune di (vedi elenco allegato) SEDE Oggetto: Piano Strategico della Città Metropolitana di Messina, richiesta pubblicizzazione del questionario conoscitivo sul sito istituzionale e sui canali social del Comune. Egregio Sig. Sindaco, nel mese di aprile 2021, la Città Metropolitana di Messina ha ufficialmente avviato il processo di predisposizione del Piano Strategico Metropolitano. In questa prima fase è stato realizzato un breve questionario online, anonimo, veloce e di semplice compilazione che racchiude le tematiche dei sei macro settori interessati dalla programmazione in corso: ambiente naturale, ricerca e tecnologia, coesione sociale, edifici e spazi pubblici, economia e turismo, mobilità. L'obiettivo è quello di raccogliere direttamente dai cittadini informazioni sul livello di conoscenza delle funzioni e delle attività svolte dalla Città Metropolitana, sulle priorità di investimento e di intervento da fissare negli anni futuri, sulle esigenze e sulle aspettative di sviluppo del territorio legate al Piano Strategico in fase di elaborazione. Il questionario può essere compilato online al link https://it.surveymonkey.com/r/CittametroMessina Per una più efficace campagna di diffusione si chiede di voler pubblicizzare la presente nota attraverso la sua pubblicazione nel sito istituzionale e nei canali social del Suo Comune. Grati per il contributo che potrà fornire si ringrazia per la collaborazione. Il Responsabile del Servizio Dott. Francesco Roccaforte Elenco Comuni: • Acquedolci • Alcara Li Fusi • Alì • Alì Terme • Antillo • Barcellona Pozzo di Gotto • Basicò • Brolo • Capizzi • Capo d’Orlando • Caprileone • Caronia • Casalvecchio Siculo • Castel di Lucio • Castell’Umberto • Castelmola • Castroreale • Cesarò • Condrò • Falcone. -

FARNETI-Ficarra-Anteprima.Pdf
Sommario VII Presentazione Nello Musumeci, presidente Regione Siciliana IX Presentazione Basilio Ridolfo XI Tutela consapevole e valorizzazione compatibile dei centri storici: appunti Giuseppina Carla Romby XV Ficarra. Studi e analisi per la riqualificazione e la valorizzazione del centro storico Silvio Van Riel SAGGI 1 1. Ficarra: città e architettura fra Ottocento e Novecento Fauzia Farneti 19 2. Arte e architettura religiosa a Ficarra Fauzia Farneti 25 2.1 Il convento dei Minori Osservanti o dei Zoccolanti a Ficarra Fauzia Farneti 45 2.2 Santa Maria della Grazia a Ficarra, da monastero a sede comunale Fauzia Farneti 67 2.3 La chiesa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo Fauzia Farneti 79 2.4 La chiesa di Maria SS. Annunziata Fauzia Farneti 95 3 Le foto raccontano: storia per immagini di un antico borgo nebroideo Franco Tumeo 109 4 Il contributo del rilievo urbano per la costruzione di un quadro conoscitivo del centro storico di Ficarra Stefano Bertocci 115 5 Il centro storico di Ficarra e la chiesa di Maria della SS. Annunziata: il rilievo integrato quale strumento di conoscenza Alessio Altadonna 127 6 Tipologie architettoniche e tecniche costruttive dell’edificato storico Monica Lusoli 159 7 Analisi e schedatura del patrimonio architettonico del centro storico Francesco Pisani 173 8 Ficarra: problemi di conservazione della città storica e valutazioni sulle principali forme di degrado Giovanni Minutoli 195 9 L’edificato storico e la sua vulnerabilità sismica e statica Silvio Van Riel 287 BIBLIOGRAFIA 295 ALLEGATI: Ficarra: Identità -

I Maremoti Nell'area Dello Stretto Di Messina
Mem. Descr. Carta Geol. d’It. XCvi (2014), pp. 87-128, figg. 32; tabb. 5 I maremoti nell’area dello Stretto di Messina The seaquakes in the Messina Strait area AveRSA m. (*), BUSSoletti g. (**), FeA m. (***), toRRe R. (***) RiASSUnto - Breve rassegna sullo stato delle conoscenze rela- 1. - intRodUZione tive agli eventi catastrofici costieri avvenuti in epoca storica nell’area dello Stretto di messina. Allo scopo di meglio definire gli elementi di Pericolosità areale esistente, vengono riportate i problemi che pone l’area geografica dello Stretto di Mes- una serie di informazioni riguardanti una loro minore intensità sina dal punto di vista della Pericolosità relativa al manifestarsi registrata in alcune località. È stata riscontrata la mancanza di di onde di maremoto a seguito di evento sismico o di frana dati certi sull’ultimo grande evento avvenuto nel 1908, sia per sottomarina è una questione ancora viva ed attuale. quanto riguarda i parametri del sisma (Magnitudo, epicentro, faglia infatti, è a tutti ben nota l’esistenza di un acceso ed sismogenetica) che per quelli relativi alle onde di maremoto. Per que- sto evento in particolare, si è rilevato che i tempi di impatto annoso dibattito sulla realizzazione di un Ponte sullo delle prime onde nelle aree a S dello Stretto sono piuttosto ri- Stretto che vede contrapposti da una parte i fautori della dotti. i valori elevati d’altezza d’onda e quelli relativi alla in- salvaguardia ambientale ed i cosiddetti catastrofisti con- gressione delle acque marine concordano arealmente ma vinti, dall’altra i fautori di un’opera ingegneristica na- discordano nelle localizzazioni stimate dell’epicentro del sisma. -

Curriculum Polino.Pdf
F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome DOTT. POLINO MARCO Indirizzo C.DA MARGI SUPERIORE NR. 113 - 98070 CASTELL’UMBERTO (ME) TeleFono 328.3882445 E-mail [email protected] - [email protected] Nazionalità Italiana Data di nascita 08.11.1982 ESPERIENZA LAVORATIVA • Date (da – a) dal 15 dicembre 2015 al 24 dicembre 2015 • Nome e indirizzo del datore di lavoro E.S.F.O. (Ente Superiore di Formazione e Orientamento) Sede Legale: Via Domenico Tempio 3/int. A - 98076 Sant’Agata di Militello (ME) • Tipo di azienda o settore Formazione ProFessionale • Tipo di impiego Docente Formatore Corso Modulo “Igiene e Sicurezza degli Alimenti” (30 ore) • Principali mansioni e responsabilità Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani. Priorità 3: Formazione giovani “Percorsi Formativi per il rafForzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana”. Corso Esperto in tradizioni culinarie etniche del Mediterraneo ID 4752. Progetto Integra id. 1459 Ambito Forgio CIP: 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/III-685 CUP: G49J15000230001. • Date (da – a) 14 e 15 novembre 2015 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castell’Umberto (ME) Sede Legale: via Garibaldi snc 98070 • Tipo di azienda o settore Banchi temporanei • Tipo di impiego Consulente esterno H.A.C.C.P. • Principali mansioni e responsabilità AfFidamento del servizio di consulenza igienico-sanitaria per la Registrazione Sanitaria (852/2004) dei Banchi temporanei. Pagina 1 - Curriculum vitae di Marco POLINO • Date (da – a) 06 ottobre 2015 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Provinciale Messina - Dipartimento Veterinario di Prevenzione - Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale (S.I.A.O.A.) Distretto Sant’Agata di Militello (ME) Sede Legale: via Medici nr. -

MICROZONAZIONE SISMICA !! Carta Delle Indagini
Attuazione dell'articolo 11 dalla legge 24 giugno 2009, n.77 MICROZONAZIONE SISMICA !! Carta delle indagini !! scala 1:5.000 J « Regione Sicilia 1 ª ! Comune di Montagnareale Ó L 1ÛÚÜ !! ! !! S 1?& J « ! 1 ª !! !! ! J « 1 ª J ! Ó !! « 1 ª L ! 1ÛÚÜ !! !! ! Regione Soggetto realizzatore Data J « 1 ª ! !! Novembre 2012 !! !! J Ó !! « 1 ª L !! ! 1ÛÚÜ ! Ó Regione Siciliana Università degli Studi di Palermo L J 1ÛÚÜ « 1 ª !! ! Ó ! L 1ÛÚÜ J Ó « 1 ª ! !! L J « ! 1 ª 1ÛÚÜ ! J ! « 1 ª ! Ó Legenda Ó L L 1ÛÚÜ 1ÛÚÜ SR & Sondaggio a carotaggio continuo & Verticale virtuale lungo profilo sismico a rifrazione ! ? ? ! ! J « 1 ª SL & Sondaggio a distruzione di nucleo & Verticale virtuale lungo profilo sismico a riflessione ! ? ? S ERT J « & Sondaggio a carotaggio continuo che intercetta il substrato & Verticale virtuale lungo tomografia elettrica 1 ª ? !! ? ! S DH ?& Sondaggio a distruzione di nucleo che intercetta il substrato ?& Prova sismica in foro tipo Downhole !! Ó !! L CH ?rx Sondaggio da cui sono stati prelevati campioni ?& Prova sismica in foro tipo Crosshole 1ÛÚÜ ! UH ?&& Sondaggio con piezometro ?& Prova sismica in foro tipo Uphole Ó S L Ó ?&& µ Sondaggio con inclinometro ÛÚÜ Prova penetrometrica con cono sismico 1ÛÚÜ ! SPT Prova penetrometrica in foro (SPT) J Stazione accelerometrica / sismometrica « ?& ª Ó Prova penetrometrica statica con punta meccanica (CPT) J Stazione microtremore a stazione singola « ÛÚÜ ª Ó Ó Ü E 6 Ù ÛÚÜ Prova penetrometrica statica con punta elettrica 66 Array sismico, ESAC/SPAC Ó U Ó ÛÚÜ Prova penetrometrica statica