Acqua È L'aumento E Umore Di Tutti I Vitali Corpi. Nessuna Cosa Sanza
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
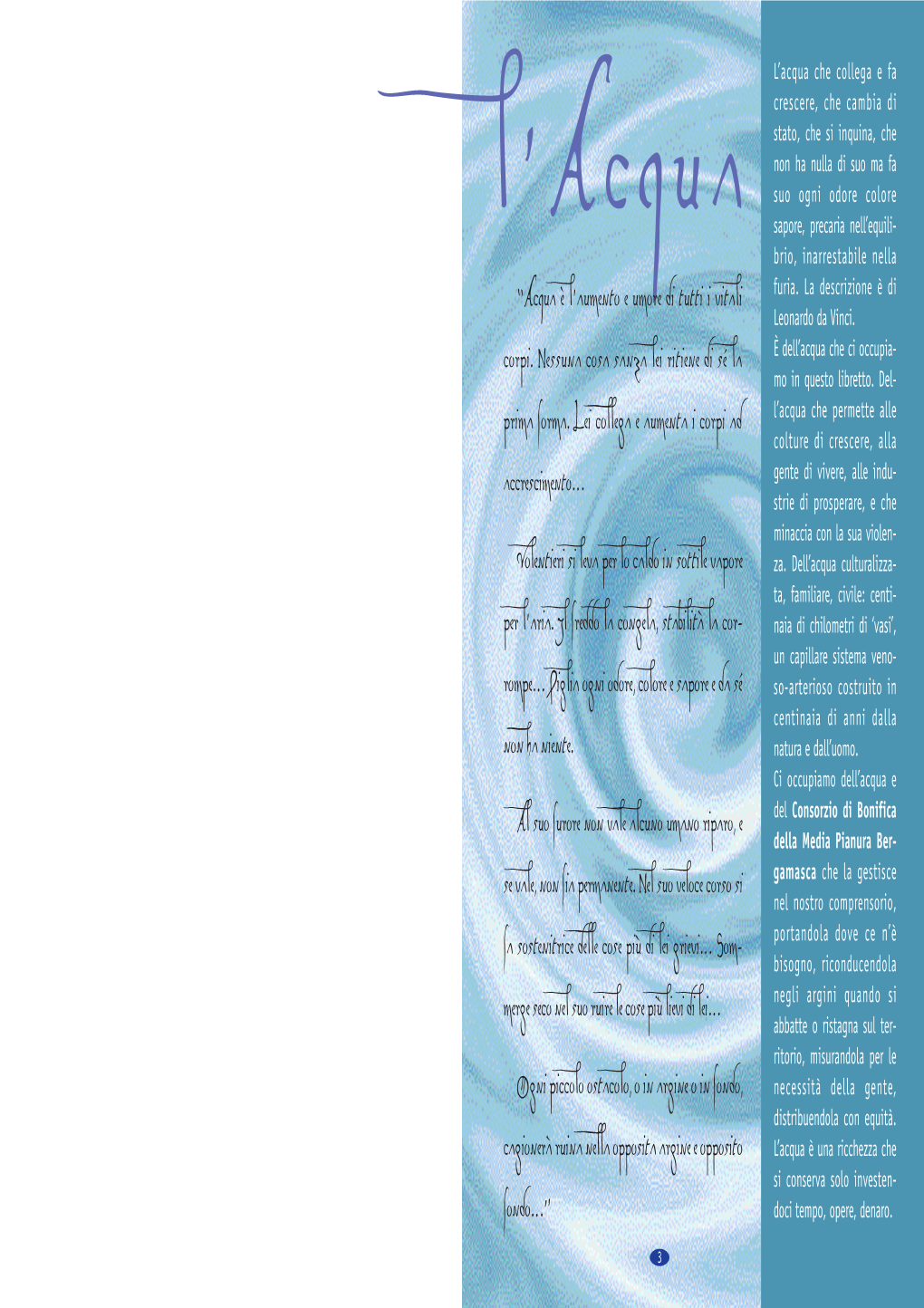
Load more
Recommended publications
-

ATLANTE DEGLI UCCELLI DI BERGAMO a Cura Di Enrico Cairo E Roberto Facoetti
ATLANTE DEGLI UCCELLI DI BERGAMO a cura di Enrico Cairo e Roberto Facoetti Specie nidificanti e specie svernanti (2001-2004) disegni di Simone Ciocca Mario Guerra Rivista del Museo Civico di Scienze Naturali “Enrico Caffi” Volume 23 (2004) Bergamo 2006 edizioni junior © 2006 Comune di Bergamo Rivista del Museo Civico di Scienze Naturali “Enrico Caffi” di Bergamo Volume 23 (2004) Registrazione presso il Tribunale di Bergamo al n. 19 (16 settembre 1999) Direttore Responsabile Dott. Marco Valle ISSN 0393-8700 © 2006 Sull’edizione: Edizioni Junior srl Viale dell’Industria, 24052 Azzano S. Paolo (BG) Tel. 035/534123 - Fax 035/534143 e-mail: [email protected] www.edizionijunior.it ISBN 88-8434-292-9 Tutti i diritti riservati Prima edizione: dicembre 2006 Edizioni: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2010 2009 2008 2007 2006 Questo volume è stato stampato presso Tecnoprint, Romano di Lombardia (BG) Stampato in Italia - Printed in Italy Sommario PRESENTAZIONE .................................................................................................... 5 INTRODUZIONE ...................................................................................................... 7 L’ATLANTE ORNITOLOGICO ................................................................................ 9 Valore e significato...................................................................................................... 9 L’ecosistema urbano .................................................................................................... 10 Metodologia e criteri di -

Relazione “Studio Paesistico”
INDICE 1 PREMESSA E INQUADRAMENTO NORMATIVO ............................................................... 4 1.1 Struttura dello studio paesistico ..................................................................................... 5 1.2 Dati di base e metodologia di lavoro............................................................................... 6 2 INTRODUZIONE ................................................................................................................... 6 2.1 Il concetto di paesaggio ................................................................................................... 6 2.1.1 Le componenti del paesaggio ........................................................................................ 7 2.1.2 La tutela del paesaggio .................................................................................................. 8 3 IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.................................................... 11 3.1 Premessa ......................................................................................................................... 11 3.2 La pianificazione regionale ............................................................................................ 11 3.3 La pianificazione provinciale ......................................................................................... 13 3.3.1 Caratteri generali del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)....... 13 3.3.2 La pianificazione ambientale e paesistica del P.T.C.P................................................ -

Sp0 Relazione
P G T COMUNE DI BERGAMO R G A E M AREA POLITICHE DEL TERRITORIO B O P iano di DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA UFFICIO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO Governo del C E I L T L T I erritorio M T A ' D E I COORDINAMENTO UFFICIO PGT ARCH. GIORGIO CAVAGNIS TEAM DI PROGETTAZIONE ARCH. GIORGIO CAVAGNIS ARCH. GIANLUCA DELLA MEA ARCH. MARINA ZAMBIANCHI RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. ARCH. BRUNO GABRIELLI CONSULENZA ARCHITETTONICA PROF. ARCH. AURELIO GALFETTI UFFICIO PGT ARCH. SILVIA PERGAMI ARCH. ALESSANDRO SANTORO DOTT. SERGIO APPIANI DOTT. ANDREA CALDIROLI DOTT. RAFFAELE PICARIELLO DOTT. LARA ZANGA con DOTT. SILVIA CIVIDINI CONSULENZA ASPETTI AMBIENTALI E PAESISTICI E VAS ARCH. MARGHERITA FIORINA CONSULENZA ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI DOTT. GEOL. RENATO CALDARELLI DOTT. GEOL. MASSIMO ELITROPI CONSULENZA ASPETTI LEGALI AVV. FORTUNATO PAGANO AVV. PAOLO BONOMI SIT (SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE) Modificato e approvato con atto di rettifica non comportante variante (art 13 c.14bis della L.R. 12/05 e s.m.i.): - ARPGT00 (Del. C.C. n. 6 Reg./60-2010 Prop. Del. in data 24/01/2011) - ARPGT01 (Del. C.C. n. 146 Reg./46-2011 Prop. Del. in data 19/07/2011) - ARPGT02 (Del. C.C. n. 99 Reg./25-2011 Prop. Del. in data 30/05/2011) AGGIORNATO AL 21.09.2011 Pubblicato su Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 38 in data 21/09/2011. S T U D I D I S E T T O R E S T U D I O P A E S I S T I C O D I D E T T A G L I O ( a i s e n s i d e l l ' a r t . -

Variante Ptc - 2018 Parco Dei Colli Di Bergamo
VARIANTE PTC - 2018 PARCO DEI COLLI DI BERGAMO NORME DI ATTUAZIONE ALLEGATO 1 – INDIRIZZI PER AMBITI DI PAESAGGIO maggio 2018 Arch. F. Thomasset, R. Gambino, NQA Nuova Qualità ambientale, dott. S. Assone, dott. F. Valfrè di Bonzo Variante al PTC del Parco dei Colli di Bergamo Norme di attuazione maggio 2018 ELENCO AMBITI: 1. Valli montane del Giongo, Badereni e Olera 2. Versante di Ranica e Torre Boldone 3. Versante di Valtesse e Monte Rosso 4. Versante di Ponteranica 5. Crinale di Sorisole e Azzonica 6. Valle del Rigos e del Rino 7. Collina di Bruntino e Monte Bastia 8. Valle del Petos 9. Piana di Valbrembo 10. Versante di Monte dei Gobbi 11 Valle d'Astino 12. Città Alta 13. Valmarina individuazione cartografica degli ambiti di paesaggio 2 Variante al PTC del Parco dei Colli di Bergamo Norme di attuazione maggio 2018 Legenda delle schede grafiche relative agli ambiti di paesaggio (redatte ortofoto Agea 2012 in scala 1:10000 e riprodotte fuori scala) 3 Variante al PTC del Parco dei Colli di Bergamo Norme di attuazione maggio 2018 1. VALLI MONTANE DEL GIONGO, BADERENI E OLERA OBIETTIVI DI QUALITA’ PAESISTICA DA RAGGIUNGERE conservare (CO) - ripristinare (RE) - qualificare (Q) - potenziare (P) Paesaggio naturale di prioritario di interesse ecologico ed escursionistico, costituente ambito portante della rete ecologica, da orientare ad una gestione prettamente naturalistica, con il mantenimento delle aree aperte e il recupero delle malghe a fini naturalistici e pastorali, e con l’introduzione di ulteriori destinazioni a supporto dell'escursionismo -

Proposta Di Rapporto Ambientale
Via Valmarina, 25 24123 Bergamo tel. 035/4530401 P.E.C. : [email protected] PROPOSTA DI RAPPORTO AMBIENTALE Progettisti: Raffaella Gambino Federico Valfrè di Bonzo NQA Nuova Qualità Ambientale Srl Federica Thomasset Stefano Assone Gruppo di Lavoro Valutazione Ambientale Strategica: Elisa Carturan – Dottore Forestale Daniele Piazza – Dottore Agronomo Valentina Carrara – Pianificatore territoriale Niccolò Mapelli – Dottore Agronomo jr. Maggio 2018 Soggetto Proponente VAS : Parco Regionale dei Colli di Bergamo Autorità Competente VAS: Ing. Francesca Caironi – Servizio Urbanistico Autorità Procedente VAS: Rag. Manuela Corti – Direttore del Parco dei Colli di Bergamo in collaborazione con: P.a. Pasqualino Bergamelli, responsabile area tutela dell’ambiente e del verde Arch. Pierluigi Rottini, responsabile del servizio urbanistico Per le versioni successive alla prima: Versione Data Modifiche 2 INDICE 1. PREMESSA ..................................................................................................................... 5 2. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ............................................................. 6 2.1 Il contesto normativo ............................................................................................................................................... 7 3. L’ITER METODOLOGICO E PROCEDURALE ................................................................... 9 3.1 Le fasi del processo di VAS della Variante generale al PTC del Parco dei Colli e al PTC del Parco Naturale dei Colli -

GENIO CIVILE XX Secolo Inventario Sommario (1874-2002)
ARCHIVIO DI STATO DI BERGAMO GENIO CIVILE XX secolo inventario sommario (1874-2002) Il servizio del Genio Civile trova le sue origini agli inizi del XIX secolo, durante il periodo della dominazione franco-napoleonica e si caratterizza come risposta tecnica a esigenze territoriali di progettazione e gestione delle opere pubbliche: acque, strade, ponti, edifici e proprietà erariali in genere. Con il passare del tempo, subisce trasformazioni delle competenze e variazioni nell’ordinamento, pur restando fedele alla missione originaria. Successivamente all’Unità d’Italia, il servizio del Genio Civile è posto alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici; di norma ha sede in ogni capoluogo di provincia, con competenze sul territorio provinciale. Il regio decreto 2 marzo 1931 n. 287 stabilisce, tra le altre cose, che in ogni sede provinciale ordinaria siano presenti otto sezioni : servizio generale, derivazioni d'acqua e linee elettriche, opere idrauliche, bonifiche, opere stradali, opere marittime, opere edilizie, opere e servizi speciali dipendenti da pubbliche calamità. Nel 1945, per la realizzazione dei programmi eccezionali di opere pubbliche dovuti alle necessità della ricostruzione post bellica, vengono istituiti i Provveditorati Regionali alle Opere Pubbliche; a essi viene demandata la gestione tecnica, amministrativa ed economica dei lavori e dei servizi di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Tale decentramento viene sancito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1534 del 30 giugno 1955. Occorre ricordare l'attività del Genio Civile quale corpo tecnico dello stato, con mansioni di consulenza e controllo: gli uffici provvedono alla revisione dei progetti di opere riguardanti gli enti locali, collaudi di lavori eseguiti con mutui e sussidi dello stato, istruttorie tecniche per concessioni di derivazioni di acque pubbliche, sorveglianza di polizia fluviale, espropriazioni di pubblica utilità e consulenza alle prefetture. -

Reticolo Idrico
RETICOLO IDRICO CRITERI DI INDIVIDUAZIONE D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015 In collaborazione con Giugno 2016 Revisione n. 1 - Dicembre 2016 Comune di Bergamo CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE, CONSORTILE E MINORE GRUPPO DI LAVORO rif. Accordo di Collaborazione n. I 41198 P.G., n. 138 Reg. Settore del 13/06/2003 ing. Diego Finazzi Comune di Bergamo arch. Nicola Cimmino Comune di Bergamo dr. Giovanni Giupponi Consorzio di Bonifica Media Pianura Bergamasca sig. Riccardo Marengoni Consorzio di Bonifica Media Pianura Bergamasca ing. Giovanni Filippini EST s.r.l. (incaricata da C.B.M.P.B.) ing. Francesca Bertuletti EST s.r.l. (incaricata da C.B.M.P.B.) ing. Giovanni Sonzogni EST s.r.l. (incaricata da C.B.M.P.B.) ing. Alberto Fara EST s.r.l. (incaricata da C.B.M.P.B.) xcod.216102di314_3002 erbmeciD 6102 Comune di Bergamo CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE, CONSORTILE E MINORE INDICE 0. PREMESSE ............................................................................................................ 1 1. INQUADRAMENTO NORMATIVO E DEFINIZIONI ................................................. 2 2. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE ........................ 4 3. RETICOLO IDRICO PRINCIPALE .......................................................................... 9 4. RETICOLO IDRICO MINORE ............................................................................... 10 5. RETICOLO DI COMPETENZA CONSORZIO DI BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA .................................................................................................... -

Sommario Parte Prima
SOMMARIO PARTE PRIMA 1 – PREMESSA pagina 3 1 - 1 – LINEE GENERALI pagina 3 1 - 2 – MOTIVAZIONI pagina 4 1 - 3 – BENEFICIARI pagina 5 1 - 4 – VANTAGGI ECONOMICI pagina 5 1 - 5 – RIFERIMENTI NORMATIVI pagina 5 1 - 6 – OBBLIGO DI PROGETTO E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ pagina 6 PARTE SECONDA 2 - RILIEVO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI pagina 6 2 - 1 - QUADRI ELETTRICI pagina 7 2 - 2 - TIPOLOGIE CORPI ILLUMINANTI pagina 10 2 - 3 - LAMPADE pagina 10 2 - 4 - CONSISTENZA ATTUALE IMPIANTO pagina 11 2 - 5 – CONSISTENZA IMPIANTO DA ADEGUARE pagina 29 2 - 6 – SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA pagina 43 2 - 7 – CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI FATTO pagina 43 PARTE TERZA 3 - STESURA DEL PIANO pagina 43 3 - 1 – INDIVIDUAZIONE AREE OMOGENEE pagina 44 3 - 2 – STRADE A TRAFFICO MOTORIZZATO pagina 44 3 - 3 – CLASSIFICAZIONE DELLE VIE DEL COMUNE DI SORISOLE IN FUNZIONE DEL TIPO DEL TRAFFICO SECONDO LA UNI 10.439 - 2001 pagina 47 3 - 4- INTERVENTO DI ADEGUAMENTO pagina 50 3 – 5 SCELTA DELLE LAMPADE pagina 50 3 – 6 VANTAGGI ECONOMICI pagina 52 1 PARTE QUARTA 4 – SCELTE TECNICHE E PROGETTUALI pagina 52 4.1 – CRITERI GENERALI ED AGGIUNTIVI pagina 52 4.2 – GRADI DI PROTEZIONE E CLASSI D’ISOLAMENTO pagina 54 4.3 – GEOMETRIA E TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI pagina 54 4.3.1 – LAMPADE pagina 54 4.3.2 – SOSTEGNI pagina 55 4.4 – CORPI ILLUMINANTI 4.4.1 - SCELTA DEL CORPO ILLUMINANTE pagina 57 4.5 - Scelte per la protezione degli impianti pagina 57 4.6 - Posa delle linee elettriche 4.6.1 - LINEE IN CAVO pagina 58 4.6.2 – Derivazioni pagina 59 4.6.3 – QUADRI ELETTRICI E REGOLATORI DI FLUSSO pagina 59 PARTE QUINTA 5 - STIMA DI MASSIMA DEI COSTI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLE PRESCRIZIONI DELLA L.R. -

SG0 Allegato 4
P G T COMUNE DI BERGAMO R G A E M AREA POLITICHE DEL TERRITORIO B O P iano di DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA Governo del UFFICIO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO C E I L T L erritorio T I M T A ' D E I COORDINAMENTO UFFICIO PGT ARCH. GIORGIO CAVAGNIS TEAM DI PROGETTAZIONE ARCH. GIORGIO CAVAGNIS ARCH. GIANLUCA DELLA MEA ARCH. MARINA ZAMBIANCHI RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. ARCH. BRUNO GABRIELLI CONSULENZA ARCHITETTONICA PROF. ARCH. AURELIO GALFETTI UFFICIO PGT ARCH. SILVIA PERGAMI ARCH. ALESSANDRO SANTORO DOTT. SERGIO APPIANI DOTT. ANDREA CALDIROLI DOTT. RAFFAELE PICARIELLO DOTT. LARA ZANGA con DOTT. SILVIA CIVIDINI CONSULENZA ASPETTI AMBIENTALI E PAESISTICI E VAS ARCH. MARGHERITA FIORINA CONSULENZA ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI DOTT. GEOL. RENATO CALDARELLI DOTT. GEOL. MASSIMO ELITROPI CONSULENZA ASPETTI LEGALI AVV. FORTUNATO PAGANO AVV. PAOLO BONOMI SIT (SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE) Modificato e approvato con atto di rettifica non comportante variante (art 13 c.14bis della L.R. 12/05 e s.m.i.): - ARPGT00 (Del. C.C. n. 6 Reg./60-2010 Prop. Del. in data 24/01/2011) - ARPGT01 (Del. C.C. n. 146 Reg./46-2011 Prop. Del. in data 19/07/2011) AGGIORNATO AL 21.09.2011 - ARPGT02 (Del. C.C. n. 99 Reg./25-2011 Prop. Del. in data 30/05/2011) Pubblicato su Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 38 in data 21/09/2011. STUDIDISETTORE STUDIO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO (ai sensi della D.G.R. 8/7374 del 28 maggio 2008) INTEGRAZIONI E SG0 APPROFONDIMENTI allegato 4 Elaborazioni cartografiche: Ufficio PGT studio associato Via Giorgio e Guido Paglia, n° 21 – 24122 BERGAMO – e-mail: [email protected] Tel. -

AVVENIMENTI Cultura E Turismo in Città E Provincia
NOVEMBRE 2018 BERGAMO AVVENIMENTI cultura e turismo in città e provincia dal 20 novembre al 2 dicembre ERGAMO B DI TEATRO SOCIALE CO BERGAMO L’E DE DONIZETTI ODIERNO Opera MERO U N AL pag. 6 allegato pag. 12 pag. 20 pag. 22 SPETTACOLO FOLCLORE FOLCLORE LA PROSA MERCATINI LA CASA BERGAMASCA AL CREBERG TEATRO DI NATALE DI BABBO NATALE dal 15 novembre dal 17 novembre dal 17 novembre Bergamo Castione della Presolana Gromo www.bergamoavvenimenti.it 2 BERGAMO EDITORE MOMA COMUNICAZIONE srl AVVENIMENTI viale Papa Giovanni XXIII, 124 Bergamo Non sai dove trovarci? DIRETTORE RESPONSABILE Emanuele Falchetti Siamo in tutte le edicole // NOVEMBRE // in allegato a STAMPA «L'Eco di Bergamo» Litostampa Istituto Grafico srl e in altri punti via A. Corti, 51 Bergamo sul territorio. BERGAMO AVVENIMENTI Inquadra redazione@ il QR Code bergamoavvenimenti.it e scopri tel. 035.358754 tutti i luoghi fax 035.358770 AUT. DEL TRIBUNALE DI BERGAMO n° 2 del 15/01/02 ANNO XVII _ N°184 BERGAMO AVVENIMENTI BERGAMO ISSN 1723 -1299 Decliniamo ogni Il prossimo numero in uscita responsabilità per quanto riguarda le variazioni di date VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018 e orari di avvenimenti, per l’utilizzo di marchi, slogans, immagini fornite e usate dagli inserzionisti. La rivista riporta esclusivamente gli avvenimenti confermati entro il 15 del mese precedente. Ci riserviamo inoltre il diritto di selezionare gli annunci e di modificarli senza alterare www.bergamoavvenimenti.it i dati degli utenti, in base agli Sempre aggiornato con tutti gli eventi di città standard di pubblicazione. e provincia, sul nostro portale è possibile registrarsi, creare un profilo personale o a nome di un’associazione e pubblicare eventi e manifestazioni. -

Salvi Per. Ind. Giuseppe
SStttuuddiiioo TTeerrmmoottteeccnniiiccoo SSaallvvii PPeerr.. IInndd.. GGiiuusseeppppee VViiiaa AAlllbbeerrtttoo ddaa PPrreezzzzaatttee,,, 2299 --- 2244112266 BBeerrggaammoo TTeelll... 003355///3311...8811...5500 --- FFAAXX... 003355///007777...0022...3333 eemmaaiiilll::: ggiiiuussseeppppee...ssstttuuddiiioosssaalllvviii@@ggmmaaiiilll...ccoomm Spett.le Società “UNIACQUE S.p.A.” Via delle Canovine, 21 24126 Bergamo Bergamo, 06 dicembre 2019 Oggetto: Curriculum professionale aggiornato dicembre 2017. 1.1 Dati anagrafici Cognome Salvi nome Giuseppe nato a Bergamo il 15 agosto 1970 con domicilio professionale in Bergamo, Via Alberto da Prezzate, 29 tel. 035/318150 fax. 035.0770233 email [email protected] pec [email protected] codice fiscale SLVGPP70M15A794L Partita IVA 02382590160 Esercente la libera professione dal 1995. 1.2 Titoli di studio e professionali - Diplomato Geometra il 17 luglio 1989, presso l’Istituto L.R. V. Alfieri di Bergamo. - Diplomato Perito Industriale Capotecnico Termotecnico il 13 luglio 1992, presso l’I.T.I.S. “G. Riva” di Saronno. - Abilitato alla libera professione di Perito Industriale dal 29 dicembre 1994, presso l’I.T.I.S. “P. Paleocapa” di Bergamo. - Iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Bergamo dal 07 febbraio 1995 al N. 1152. - Abilitato alla progettazione e al coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (ex. D.Lgs. 494/96), dal 24 giugno 1997, presso il Collegio dei Periti Industriali della provincia di Bergamo. - Abilitato al controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici secondo la Legge 10/91, dal 31 marzo 1998, previo esame ENEA. - Iscritto nell’elenco dei Periti Industriali del Ministero degli Interni per i servizi Antincendi con n. BG01152 P 00155. -

Protocollo Intesa Torrente QUISA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE per la redazione di uno studio idrogeologico, idraulico e ambientale a scala di sottobacino idrografico del Torrente Quisa e delle rogge ad esso connesse finalizzato alla definizione degli interventi di sistemazione idraulica, di riqualificazione ambientale e manutenzione fluviale. TRA I RAPPRESENTANTI di Regione Lombardia, nella persona del Direttore Generale della Direzione Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo, Paolo Baccolo, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù della d.g.r. ………….. dei Comuni di Almè, Bergamo, Curno, Mozzo, Paladina, Sorisole, Valbrembo, Ponteranica Ponte San Pietro, nelle persone dei rispettivi Sindaci o loro rappresentanti; del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, nella persona del Presidente protempore Franco Gatti; di Parco dei Colli nella persona del Presidente Oscar Locatelli; di UNIACQUE S.p.A., nella persona del Direttore Generale, ing. Marco Milanesi; PREMESSO CHE la legge 7 agosto 1990, n 241, all’art. 15 consente la definizione di accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività comuni; la l.r. 11 marzo 2005, n. 12, e s.m.i., prevede all’art. 55 la definizione da parte di Regione Lombardia del quadro delle conoscenze delle caratteristiche fisiche del territorio in materia di tutela ed uso delle acque e di difesa del suolo; il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, all’art. 61, prevede nelle competenze delle regioni la definizione di “proposte per la formazione di programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici”; Accordo di collaborazione - Torrente Quisa Pag. 1 di 5 con decreto d.d.u.o.