Atti Accademia Ligure Di Scienze E Lettere
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
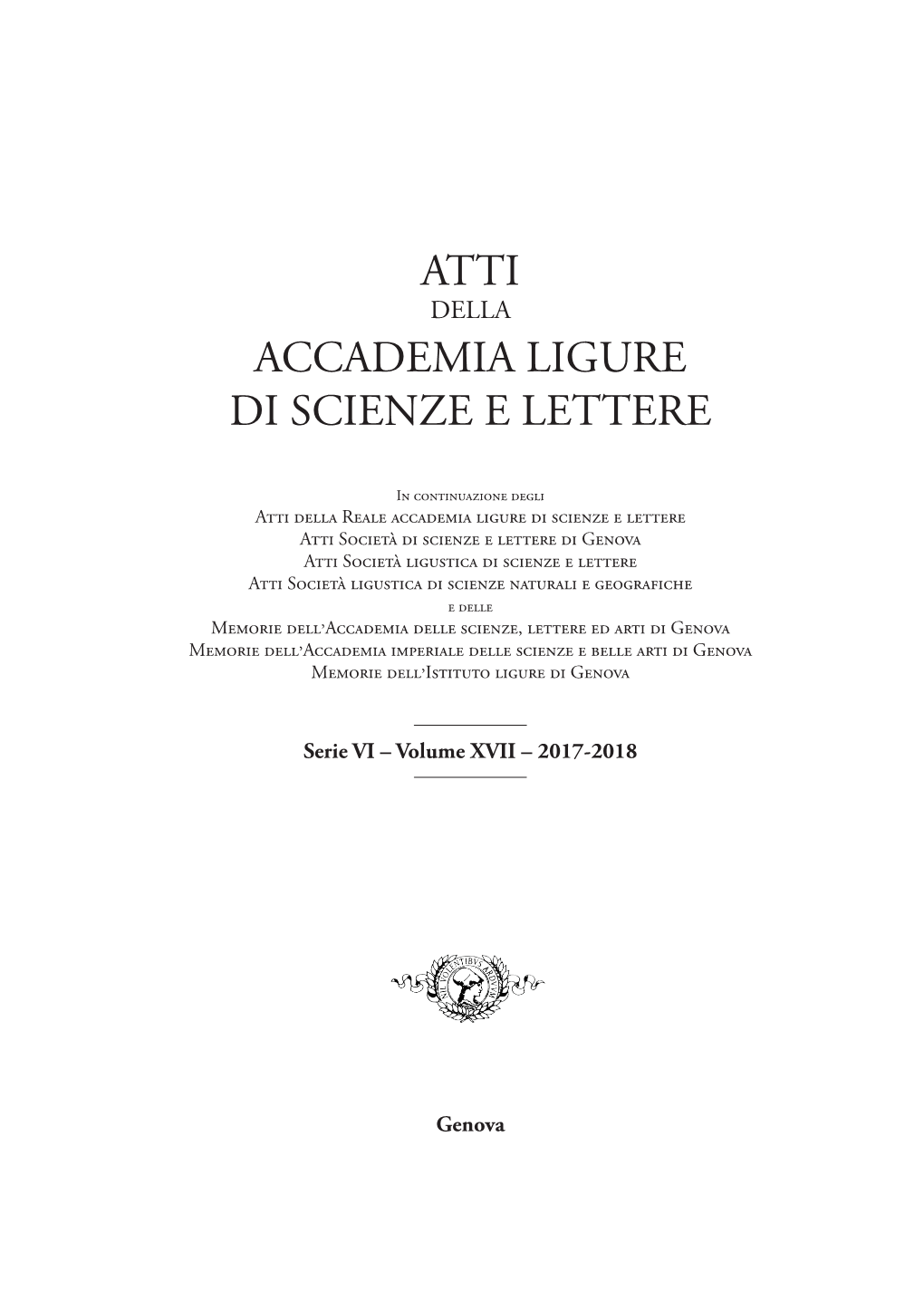
Load more
Recommended publications
-

Storia Di Una Villa Scomparsa E Dell'urbanizzazione Del Colle Di Carignano
Armando Di Raimondo Storia di una villa scomparsa e dell’urbanizzazione del colle di Carignano La “casa di villa” di Minetta Serra a Genova Armando Di Raimondo Storia di una villa scomparsa e dell’urbanizzazione del colle di Carignano La “casa di villa” di Minetta Serra a Genova Storia di una villa scomparsa e dell’urbanizzazione del colle di Carignano 3 Sommario Premessa 5 Le famiglie de Fornari e Serra 7 La nuova villa di Minetta Serra 8 La famiglia Squarciafico 11 Scipione Squarciafico: l’erede di Minetta 11 La crisi finanziaria 13 La numerosa famiglia di Giuseppe Squarciafico 14 Il Biografo 15 Il “ribelle” 16 Il morigerato e ... le bombe del Re Sole 18 Maria Anna Grillo: due volte vedova 19 La famiglia da Passano, signori del pedaggio 22 I Conti di Occimiano 23 Il Conservatorio Interiano 27 Il Comune di Genova 32 Conclusioni 35 APPENDICE 37 Una Santa in famiglia: Virginia Centurione Bracelli 37 Cenni storici sulla Chiesa e Monastero di Santa Chiara in Carignano 41 Passaggi di proprietà della Villa di Carignano 45 Ricostruzione genealogica dei possessori della Villa di Carignano 46 Bibliografia essenziale 47 4 Armando Di Raimondo Ringraziamenti Giovanni Battista Canepa Giovanni Ferrero Stefano Finauri Francesca Musante Giustina Olgiati e il paziente Staff dell’Archivio di Stato di Genova Italo Pucci Suor M. Daniela, Madre Superiore di N.S. del Rifugio in Monte Calvario. Abbreviazioni ASGe: Archivio di Stato di Genova ASCGe: Archivio Storico Comune di Genova ADG: Archivio Doria Dipartimento di Economia di Genova ASAl: Archivio di Stato di Alessandria APSG: Archivio Parrocchiale di San Giacomo e Sacro Cuore di Genova Storia di una villa scomparsa e dell’urbanizzazione del colle di Carignano 5 Premessa “È tempo per noi di guadagnar l’erta di Carignano, colle d’antichissimo nome intorno alla cui etimologia stancarono con vane congetture il cervello e la penna i più rinomati scrittori di cose genovesi. -

Repertorio Di Fonti Sul Patriziato Genovese
Soprintendenza Archivistica per la Liguria Repertorio di fonti sul Patriziato genovese scheda n° 4 compilatore: Andrea Lercari, aggiornata al 21/09/2010 famiglia: Airolo Altre forme del nome: Airoli, de Airolo, Ayrolo, Ayrolus, de Ayrolis, Ayrollo. Albergo: Negrone Titoli: Patrizio genovese, marchese di Rivalta, conte consignore di Sala Famiglie aggregate (solo per le famiglie capo-albergo): Feudi: Rivalta Scrivia; Sala (Monferrato) Arma gentilizia: «D’azzurro alla quercia terrazzata sul terreno di verde, sinistrata da un leone d’oro». Nota storica: Famiglia di origine popolare, tradizionalmente considerata originaria della villa di Godano, in Val di Vara nell’entroterra di Levanto, gli Airolo ebbero ascrizione al patriziato genovese in vari rami, riconducibili a un comune stipite ma sostanzialmente distanti e indipendenti tra loro, i quali con diversa fortuna e in epoche differenti si affermarono nella vita politica, nell’economia e più in generale nella società genovesi. Quali che siano le origini più remote della famiglia, è accertato dal XVI secolo il suo radicamento nella villa di Granarolo, che la tradizione vuole derivare il proprio nome dall’originario toponimo Airolo, da cui Grande Airolo e infine Granarolo, un’area collinare agricola sulle alture di Genova, fuori la porta di San Tomaso, ove sorgevano numerose residenze estive di facoltosi cittadini genovesi e contraddistinta da tre importanti fondazioni ecclesiastiche: la chiesa di Santa Maria (la parrocchiale, nella parte alta), quella di San Rocco (nella parte bassa) e il convento dei Padri di San Francesco da Paola, nella cui chiesa, dedicata a Gesù e Maria, gli Airolo ebbero i propri sepolcri gentilizi. La linea dei primi Airolo ascritti nel 1528 La prima linea della famiglia fu ascritta al Liber Civilitatis sin dal 1528 con Nicolò de Ayrolo, aggregato all’albergo Negrone. -

Rolli Days Rolli Days
ROLLI DAYS ROLLI DAYS strade e palazzi da vivere strade e palazzi da vivere Genova, 1 - 2 aprile 2017 Genova, 1 - 2 aprile 2017 Le due edizioni dei Rolli Days 2017 sono dedicate al Professor Ennio Poleggi, i cui studi hanno reso noto il Sistema dei Rolli e hanno portato, insieme al suo impegno, al riconoscimento UNESCO Sabato 1 e domenica 2 aprile dalle ore 10 alle ore 19 accesso gratuito ai palazzi, salvo eccezioni segnalate nel programma. From Saturday 1 to Sunday 2, April from 10 am to 7 pm, free admission to the palaces, exceptions are t i . a reported in the program. d i u l f a c i f Il programma completo della manifestazione sarà disponibile presso gli IAT di Genova e scaricabile dai a r g @ siti web / The full program with all the events will be available at the Tourist Information Centers (IAT) i s e r in Genoa and for free download on the websites : r a b : t www.visitgenoa.it r a - i www.rolliestradenuove.it - www.palazzoducale.genova.it t t e r a www.museidigenova.it - www.unige.it g i B . C : Informazioni | Information h p IAT : Via Garibaldi 12r e Porto Antico, Palazzina Santa Maria +39 010.5572903 - [email protected] - www.visitgenoa.it Sono previste visite guidate gratuite per persone non vedenti e sorde Per informazioni sull'accessibilità alle persone disabili For information on disabled access see: www.rolliestradenuove.it - www.museidigenova.it www.visitgenoa.it/it/app @GenovaEventi Genova Eventi e Cultura | GenovaTurismo #rollidays @genovamorethanthis Genova More Than This La prossima edizione dei Rolli Days: 14-15 -

Genoa and Its Treasures
Comune di Genova - Ufficio sviluppo e Promozione del Turismo Palazzo delle Torrette - Via Garibaldi, 12r [email protected] www.genova-turismo.it Tourist Information Centres (T.I.C.) IAT Via Garibaldi Useful info: Via Garibaldi 12r Ph. +39 010 55 72 903/ 751 Genoa Aquarium Fax +39 010 55 72 414 www.acquariodigenova.it (7/7 - h. 9.00 - 18.30) C. Colombo Airport [email protected] Ph. +39 010 60 151 - www.airport.genova.it IAT De Ferrari City sightseeing open top bus Largo Pertini 13 Genova in Tour Pesci Viaggi Ph. +39 010 86 06 122 Ph. +39 010 53 05 237 - Mobile +39 328 98 55 419 Fax +39 010 86 06 476 www.pesciviaggi.it (7/7 - h. 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30) [email protected] Hop-on hop-off city tour CITYSIGHTSEEING GENOVA IAT C. Colombo Airport (arrivals area) Ph. +39 010 86 91 632 Genova - Sestri Ponente www.genova.city-sightseeing.it Ph./Fax +39 010 60 15 247 (7/7 - h. 9.00 - 13.00 / 13.30 - 17.30) Genoa Museums [email protected] www.museidigenova.it - www.rolliestradenuove.it Radio Taxi Walking guided tour to the historical centre Ph. +39 010 5966 - www.cooptaxige.it and the Palazzi dei Rolli, UNESCO World Heritage Visit of the city with little train Every weekend you can visit the historical city Trenino Pippo centre and discover the fascination of some of Ph. +39 328 69 42 944 - www.treninopippo.it the famous Palazzi dei Rolli. Trains More information about costs and languages Ph. -

Lomellino" Di Pegli
Gandolfo da Lomello, capostipite della famiglia "Lomellino" di Pegli. Un discendente dell'imperatore Arnolfo, Luciano, Conte Palatino, ebbe un figlio di nome Enrico, il quale, a sua volta, ebbe un figlio di nome Gandolfo, nato in Lomello ed appartenente alla famiglia dei Conti Palatini. Costui, secondo le memorie delle uniche rappresentanti della famiglia Lomellini, fu l'antenato che per primo mise piede a Genova e sicuramente a Pegli. La documentazione dell'avvenimento andò distrutta in un incendio avvenuto nella loro abitazione, durante l'ultima guerra. L'arrivo a Genova di Gandolfo, che, a seguito della sua provenienza, fu detto "Lomellino", fu originato dal suo matrimonio con la figlia di Guglielmo Embriaco, ingegnere ed ammiraglio, capostipite della famiglia degli Embriaci, che nel 1099 prese parte alla conquista di Gerusalemme. Il matrimonio dei rappresentanti delle due grandi e potenti famiglie, portò, come probabile conseguenza, all'unione dei loro beni; quella dei Lomellini a Genova e nel ponente, cioè Pegli; quella degli Embriaci a Genova e nel medio oriente. Nello stesso anno della venuta a Genova di Gandolfo, cioè nel 1102, morì Guglielmo Embriaco. Da questo momento la fortuna della famiglia si accresce notevolmente, sia per l'avveduta loro politica economica, sia per lasciti e donazioni, sino al 1700, quando i Lomellini, ritiratisi a Genova, alienano i loro beni Pegliesi. La famiglia Lomellini sta alla pari, se a volte non supera, con le grandi famiglie pegliesi quali: i Grimaldi, i Durazzo, i Centurione, i Doria, i Cambiaso, i Della Chiesa ed i Pallavicini. Alcuni di essi occuparono cariche significative nella storia della Repubblica di Genova: Leonardo Lomellino, governatore della Corsica dal 1369 al 1370; e dal 1393 al 1394; poi nominato Conte feudale dell'isola dal 1401 al 1409. -

I GESUITI a GENOVA NEI SECOLI XVII E XVIII Storia Della Casa
I GESUITI A GENOVA NEI SECOLI XVII E XVIII Storia della Casa Professa di Genova della Compagnia di Gesù dall’anno 1603 al 1773 Introduzione e traduzione dal manoscritto latino di GIULIANO RAFFO S.I. Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2016 Abbreviazioni: AGSI = Archivimi Genuense Societatis Iesu. ARSI = Archivum Romanum Societatis Iesu. ATSI = Archivum Taurinense Societatis Iesu (manoscritti non catalogati). ISI = Institutum Societatis Iesu, Florentiae 1982-1984. MHSI = Monumenta Histórica Societatis Iesu C.S.I. = Chronicon Societatis Iesu, Matritii 1893-1897. L.M. = LainiiMonumenta, Matritii 1912-1917. M.I. = Monumenta Ignatiana, series I, Matritii 1903-1911. BCJ = Bibliothèque de la Compagnie de Jesus par CARLOS SOMMERVOGEL S,J., Paris 1890-1932, Supplement, Louvain, 1960. COM = Compendio dell'origine delle 28 famiglie nobili di Genova (ms. in AGSI IX, 7 - Storia Genovese 1562). MEN = Menologio di pie memorie d'alcuni Religiosi della Compagnia di Gesù, raccolte dal padre Giuseppe Patrignam della medesima Compagnia e distribuite per quei giorni dell’anno ne' quali morirono, dall’anno 1538 all’anno 1728, Venezia 1730. Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2016 PRESENTAZIONE Nelle comunità dei gesuiti lo Scriptor historiae domus è il padre incarica to di tenere il diario di casa, con le notizie più importanti sulla famiglia reli giosa e le sue attività pastorali. Nell’archivio dell’istituto Storico della Compagnia di Gesù in Roma si conserva il manoscritto latino dell ’Historia dom us della casa professa di Ge nova, dalla fondazione della residenza (1603) alla soppressione della Compa gnia (1773). Questo manoscritto è un codice di carta filigranata a linee chiare, con pagine di mm. -

IL CAPITALE CULTURALE Studies on the Value of Cultural Heritage
23 IL CAPITALE CULTURALE Studies on the Value of Cultural Heritage eum Rivista fondata da Massimo Montella Il capitale culturale Rossi, Simonetta Stopponi, Cecilia Tasca, Andrea Studies on the Value of Cultural Heritage Ugolini, Frank Vermeulen, Alessandro Zuccari n. 23, 2021 Web ISSN 2039-2362 (online) http://riviste.unimc.it/index.php/cap-cult e-mail Direttore / Editor in chief [email protected] Pietro Petraroia Editore / Publisher Co-direttori / Co-editors eum edizioni università di macerata, Corso Tommy D. Andersson, Elio Borgonovi, della Repubblica 51 – 62100 Macerata Rosanna Cioffi, Stefano Della Torre, Michela tel (39) 733 258 6081 di Macco, Daniele Manacorda, Serge Noiret, fax (39) 733 258 6086 Tonino Pencarelli, Angelo R. Pupino, Girolamo http://eum.unimc.it Sciullo [email protected] Coordinatore editoriale / Editorial coordinator Layout editor Giuseppe Capriotti Roberta Salvucci Coordinatore tecnico / Managing coordinator Progetto grafico / Graphics Pierluigi Feliciati +crocevia / studio grafico Comitato editoriale / Editorial board Giuseppe Capriotti, Mara Cerquetti, Francesca Coltrinari, Patrizia Dragoni, Pierluigi Feliciati, Costanza Geddes da Filicaia, Maria Teresa Gigliozzi, Enrico Nicosia, Francesco Pirani, Mauro Saracco, Emanuela Stortoni Rivista accreditata WOS Comitato scientifico - Sezione di beni Rivista riconosciuta SCOPUS culturali / Scientific Committee - Division of Rivista riconosciuta DOAJ Cultural Heritage Rivista indicizzata CUNSTA Giuseppe Capriotti, Mara Cerquetti, Rivista indicizzata SISMED Francesca Coltrinari, -

Repertorio Di Fonti Sul Patriziato Genovese
Soprintendenza Archivistica per la Liguria Repertorio di fonti sul patriziato genovese scheda n° 92 compilatore: Andrea Lercari famiglia: Brignole Altre forme del nome: Albergo: Cicala Titoli: Patrizio genovese, marchese di Groppoli Famiglie aggregate (solo per le famiglie capo-albergo) Feudi: Groppoli (Lunigiana) Arma gentilizia: «D’azzurro all’albero di prugna terrazzato di verde, fruttato di rosso, sinistrato da un leone di rosso coronato d’oro» Nota storica: Nel 1528 venne ascritto al Liber Civilitatis e aggregato all’albergo Cicala, Giovanni. A questa prima ascrizione seguirono quelle dei suoi figli, Antonio e Teramo (ascritto il 23 dicembre 1573). Antonio Brignole fu Giovanni sposò Maddalena Sale del patrizio Nicolò e fu padre di Gio. Francesco, primo esponente della famiglia ad assurgere al dogato, e di Giovanni Battista. Giovanni Battista del magnifico Antonio e della magnifica Maddalena sua moglie, fu ascritto il 16 dicembre 1591, all’età di circa undici anni. il 5 maggio 1590 avevano testimoniato i magnifici Giovanni Battista isola fu Francesco, di cinquantanni, e Ambrogio e Gregorio fratelli Giussani fu Giacomo, rispettivamente di sessanta e cinquantaquattro. Antonio Brignole aveva cinquantaquattro anni, come si qualifica testimoniando per Giovanni Battista Giussano di Gregorio fu Giacomo il 5 maggio. Un secondo decreto di ascrizione fu emanato il 28 novembre 1597, quando testimoniarono Giovanni Battista Isola fu Francesco e Ambrogio Giussano, suo padrino di cresima. Giovanni Battista sposò una dama della nobiltà nuova, Geronima Merello fu Agostino, avendone il figlio Gio. Carlo, ascritto il 19 novembre 1626, all’età di ventun’anni, avendo testimoniato in suo favore i patrizi Giulio Rapallo fu Giovanni Battista e Giovanni Battista Bargagli fu Giovanni Battista. -

LA VIA DEI CAVALIERI the Way of the Knights
E ON R A U Q AC a E A I i Piazza o A Via P. DO A L L V V RI O A A L s NAR L A RI B O E i O L ACQUAVERDE I RB r C S d A A E C D a N I . i R B so o P v r A F M L E E Co C O ia A . T C a U V A Giardini O ON i R N R R T A V O O I R T I Via T. ROSINA I L U ROCC A M a ’ O Piazza L L i Q A C E V I . ET V a L E M D t AC N ia i F E D PRINCIPE l IN A R A A B a E a E I a i . A s N C L H Biblioteca Orto I V DO E C O C Vi T LB C R A A I D R BEN A Universitaria E Botanico C B T I a E A i N N C a ET E V G t a i V L o SA t A CH N l i i A C a l a O A ia N r E F O a S S C V A s o N S I T Z . o M U o p r a c Piazza delle Piazza dei G C Piazza della i N i PRINCIPE I I u Quartiere N V s TRUOGOLIDI SANTA BRIGIDA MARINELLE M S O A R COMMENDA C V E R o a NIN R T del CARMINE Piazza B t A A E T i T O R I A l P SANT’ANNA E N N P a I e I R a r I i E O Vi i o A H A G S C F COMUNE DI GENOVA d s V V G A H a O ia I AG n ADU G OC a B e M a R R A. -

II Gli Interventi. Materiali Ed Elementi Costruttivi Ricorrenti E Palazzi Compresi Nel Sito UNESCO
II Gli interventi. Materiali ed elementi costruttivi ricorrenti e Palazzi compresi nel sito UNESCO Rollidagando Progetto finanziato a valere sui fondi Legge 20 febbraio 2006, n. 77 «Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella “Lista del patrimonio mondiale”, posti sotto la tutela dell'UNESCO» II. Gli interventi. Materiali ed elementi costruttivi ricorrenti e Palazzi compresi nel sito UNESCO Rollidagando Progetto finanziato a valere sui fondi Legge 20 febbraio 2006, n. 77 «Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella “Lista del patrimonio mondiale”, posti sotto la tutela dell'UNESCO» L’attività di ricerca relativa allo stato di conservazione dei palazzi dei rolli compresi nel sito UNESCO di Genova, nonché di quelli appartenenti all’area di rispetto, è stata impostata sulla base dell’accordo di collaborazione tra Dipartimento Architettura e Design (dAD) dell’Università degli Studi di Genova (Direttore prof. Arch. Niccolò Casiddu) e la Direzione Urbanistica del Co- mune di Genova (Direttore arch. Laura Petacchi). L’accordo è stato sottoscritto in data 31/07/2019 a seguito del finanziamento del progetto “Rol- lindagando” in base alla Legge n. 77 del 20/02/2006 - Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO. Hanno svolto la ricerca gli arch.tti Cecilia Moggia e Francesca Segantin (specialiste in Beni Archi- tettonici e del Paesaggio nonché assegniste di ricerca per l’accordo in oggetto), coadiuvate per alcuni aspetti dall’ing. -

Génova Y Sus Tesoros
Comune di Genova - Ufficio sviluppo e Promozione del Turismo Palazzo delle Torrette - Via Garibaldi, 12r [email protected] www.genova-turismo.it Officinas de Información Turistica IAT Via Garibaldi Informaciones utiles: Via Garibaldi 12r Tél. +39 010 55 72 903/ 751 Acuario de Génova Fax +39 010 55 72 414 www.acquariodigenova.it (7/7 - h. 9.00 - 18.30) Aeropuerto C. Colombo [email protected] Tél. +39 010 60 151 - www.airport.genova.it IAT De Ferrari Visita de la ciudad con autobus turistico Largo Pertini 13 descapotable Tél. +39 010 86 06 122 Genova in Tour Pesci Viaggi Fax +39 010 86 06 476 Tél. +39 010 53 05 237 - Móvil +39 328 98 55 419 (7/7 - h. 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30) www.pesciviaggi.it [email protected] Tour en bus “hop-on hop-off” IAT aeropuerto C. Colombo CITYSIGHTSEEING GENOVA (planta llegadas) Tél. +39 010 86 91 632 Genova - Sestri Ponente www.genova.city-sightseeing.it Tél./Fax +39 010 60 15 247 (7/7 - h. 9.00 - 13.00 / 13.30 - 17.30) Museos de Génova [email protected] www.museidigenova.it - www.rolliestradenuove.it Radio Taxi Visitas guiadas del casco antiguo y de Tél. +39 010 5966 - www.cooptaxige.it algunos de sus Palacios dei Rolli Cada fin de semana serà posible descubrir Visita de la ciudad con un pequeño tren caminando la ciudad antigua y el fascino de Trenino Pippo algunos de sus Palacios dei Rolli. Tél. +39 328 69 42 944 - www.treninopippo.it Màs informaciones sobre precios y idiomas Tren en nuestras oficinas de turismo. -

Bibliografia Ligure 1995 Quaderni Franzoniani, Anno X, N. 1, Gennaio-Giugno 1997
Bibliografia Ligure 1995 Quaderni Franzoniani, anno X, n. 1, gennaio-giugno 1997 Il decimo appuntamento con la Bibliografia Ligure presenta i materiali riguardanti il nostro territorio pubblicati nel 1995. Il volume raccoglie 1522 schede bibliografiche: oltre ai volumi monografici sono stati presi in esame oltre 1100 periodici e 500 volumi miscellanei e di atti di convegni. Tale ampia ricerca propone all„attenzione del lettore gli studi scientifici ed eruditi, i contributi divulgativi e tutto quanto illustra la tradizione culturale della Liguria. Indice Preistoria - Storia Antica (schede nn. 1-189)>> Secoli VII-XIV (schede nn. 190-420)>> Secoli XV-XVI (schede nn. 421-634)>> Secoli XVII-XVIII (schede nn. 635-908)>> Secoli XIX-XX (schede nn. 909-1368)>> Varia (schede nn. 1369- 1522)>> Indice degli autori e delle opere>> Indice tematico>> © 1997, Associazione Amici della Biblioteca Franzoniana - Genova eBook pubblicato nel mese di gennaio 2014 disponibile on line sul sito www.quadernifranzoniani.it scansione OCR, editing: Andrea Lavaggi PREISTORIA - STORIA ANTICA indice>> 1. 3500 anni fa a Millesimo. Bric Tana: un sito dell‟età del Bronzo, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza Archeologica della Liguria 1995, pp. 4. Pieghevole realizzato in occasione della mostra allestita nella Sala didattica a Palazzo Reale a Genova (15 dicembre 1994-15 gennaio 1995) per presentare i risultati delle indagini effettuate, tra il 1987 e il 1992, al Bric Tana di Millesimo e per ricostruire la storia dell‟ambiente e delle attività umane del sito. E.S. 2. Analisi e classificazione dei dati (parte IV), in La monetazione preromana dell‟Italia Settentrionale: approvvigionamento del metallo, coniazione, circolazione.