Rafał Kaniecki
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
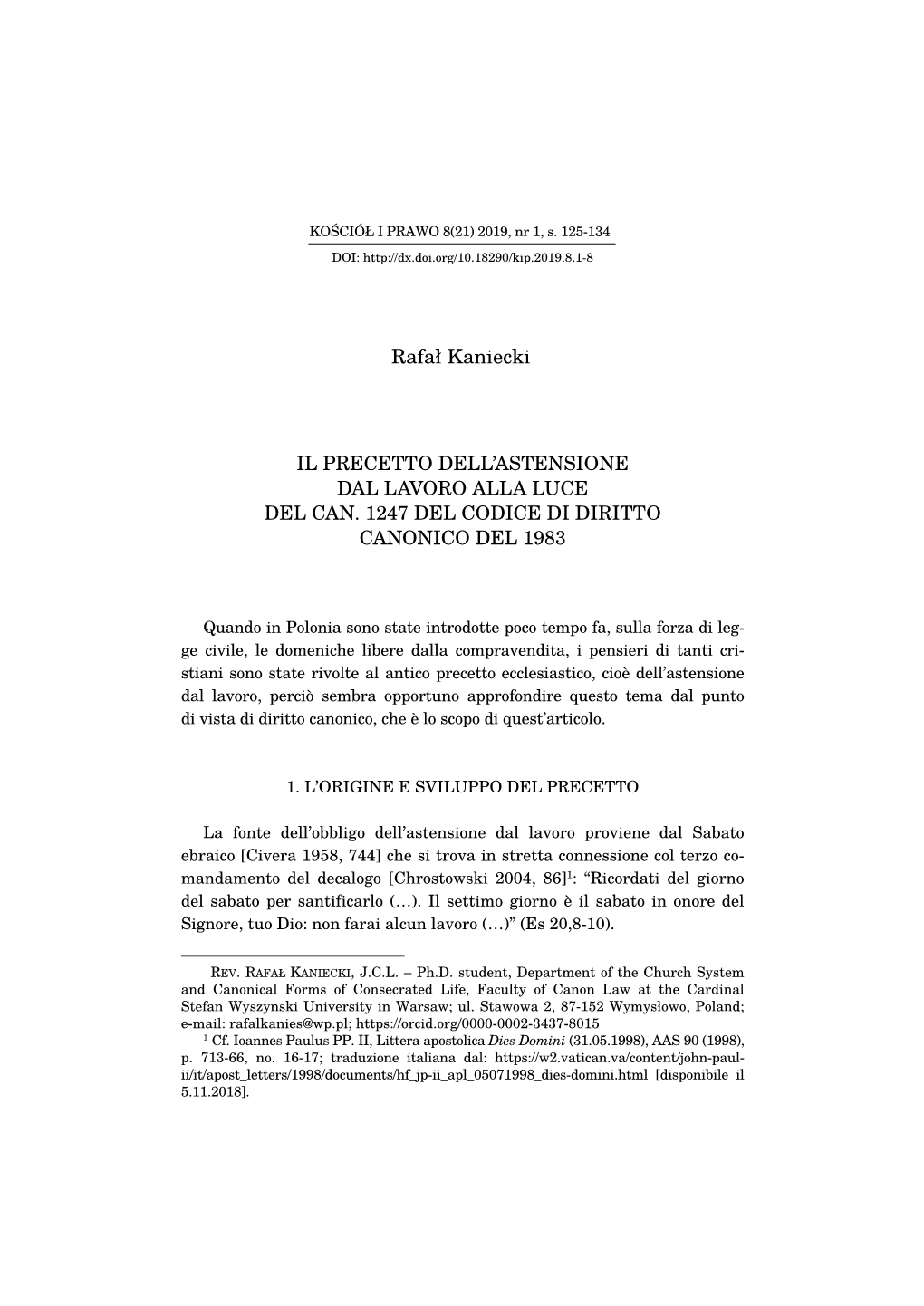
Load more
Recommended publications
-

JCD Dissertation Zielonka
THE CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA The Influence of the Second Vatican Council on the Function of Papal Legates. Comparative Analysis of the 1917 and 1983 Codes of Canon Law and Selected Special Faculties. A DISSERTATION Submitted to the Faculty of the School of Canon Law Of The Catholic University of America In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree Doctor of Canon Law © Copyright All Rights Reserved By Dariusz J. Zielonka Washington, D.C. 2013 i This dissertation by Dariusz J. Zielonka fulfills the dissertation requirement for the doctoral degree in canon law approved by Kurt Martens, J.C.D., as Director, and by Robert Kaslyn, S.J., J.C.D., and Sean Sheridan, T.O.R., J.C.D., J.D., as Readers. !!!!!!____________________________________ !!!!!!Kurt Martens, J.C.D., Director !!!!!!____________________________________ !!!!!!Robert Kaslyn, S.J., J.C.D., Reader !!!!!!____________________________________ !!!!!!Sean Sheridan, T.O.R., J.C.D., J.D., Reader ii In memoriam: Tadeusz and Alina Zielonka My parents. May they rest in peace. iii Table of Contents ACKNOWLEDGMENTS! viii INTRODUCTION! 1 CHAPTER 1! 5 Papal Legates in the 1917 Code of Canon Law! 5 1.1. Introduction! 5 1.2. A Brief Historical Overview of the Office of Papal Legates! 6 1.2.1. Roman Republic! 6 1.2.2. The First Papal Legates! 9 1.2.3. Papal Legation in the Middle Ages / Gratian! 13 1.2.4. The First Permanent Papal Diplomatic Posts! 26 1.2.5. Shaping of Modern Papal Legation! 30 1.2.6. Papal Legation in the Twentieth Century and Today! 36 1.3. -

Acta Nuntiaturae Polonae
ACTA NUNTIATURAE POLONAE ACADEMIA SCIENTIARUM ET LITTERARUM POLONA SUMPTIBUS FUNDATIONIS LANCKOROŃSKI ACTA NUNTIATURAE POLONAE TOMUS LII ANGELUS MARIA DURINI (1767-1772) * Volumen 1 (12 IV 1766 – 20 IV 1768) edidit WOJCIECH KĘDER CRACOVIAE 2016 CONSILIUM EORUM, QUI EDITORIBUS ACTORUM NUNTIATURAE POLONAE SUADENT: Marco Jačov, Ioannes Kopiec, Iosephus Korpanty, Vanda Lohman, Marius Markiewicz, Anna Michalewicz (secretarius), Stanislaus Wilk, Georgius Wyrozumski (praeses) Volumen hoc edendum curavit Vanda Lohman Summaria, studia et fontes auxiliarii in linguam Anglorum vertit Petrus Pieńkowski Indicem confecit Krzysztof W. Zięba Textum ad imprimendum composuit MKBB © Copyright by Polska Akademia Umiejętności Kraków 2016 ISBN 978-83-7676-259-3 LIST OF CONTENTS Introduction .................................................. VII I. Angelo Maria Durini’s early years in Rome and in France ............................................ VII II. Angelo Maria Durini in Warsaw ........................... X III. Angelo Maria Durini in Avignon and in Lombardy ........................................ XXVI Sources of Angelo Maria Durini’s Nunciature .................... XXIX Index of sources published in present volume .................... XXXIII Works which contain Angelo Maria Durini’s letters and documents ........................................... XXXV Primary and secondary sources ................................. XXXVII Index of notas ................................................. XLV TEXT ........................................................ 1 Index of names and places ...................................... 383 INTRODUCTION I. Angelo Maria Durini’s early years in Rome and in France 1. The Durini family of Como Angelo Maria Durini came from the family living in Lombardy and known already in the Middle Ages. Lazzaro de Durino, who apparently lived in the vicinity of the town of Moltrasio at Como Lake at the beginning of the 15th century, can be considered the family founder. In the seventies of the 15th century his son Teobaldo moved to Como with his children. -

Missions De La Congrégation
MISSIONS DE LA CONGRÉGATION DES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE __________ N° 193. — Mars 1911. _______ ROME ______ Bref de Pie X approuvant nos saintes Règles _______ LITTERÆ APOSTOLICÆ A. S. D. N. PIO PP. X CONCESSÆ AD CONFIRMATIONEM INSTITUTI NECNON REGULARUM ET CONSTITUTIONUM CONGREGATIONIS OBLATORUM SANCTISSIMÆ ET IMMACULATÆ VIRGINIS MARIÆ CUM APPROBATIONE ADDITIONUM ET IMMUTATIONUM QUÆ DECREVIT CAPITULUM GENERALE ANNO 1908 CELEBRATUM PIUS Papa X AD PERPETUAM REI MEMORIAM Decessorum nostrorum vestigiis insistentes, ad religiosorum virorum Congregationes, ex quibus Ecclesia Dei tot tantaque emolumenta nanciscitur, singulari paternæ Nostræ voluntatis studio oculos convertimus, vigili cura prospicientes, ut eædem illis omnibus præsidiis muniantur, — 2 — quæ ad ipsarum utilitatem, bonum atque incrementum magis accomodata atque opportuna Nobis videantur. Frugiferas has inter Congregationes jure meritoque accensenda est, quæ a Missionariis Oblatis Mariæ Immaculatae nomen habet, et ad Aquas Sextias in Provincia jam inde ab anno MDCCCXVI fundata, per Apostolicas Literas eadem hac forma die XXI Martii mensis anno MDCCCXXVI datas a Leone PP. XII rec. me., Praedecessore Nostro, tum Instituti tum regularum adprobationem obtinuit. Haec enim Congregatio, quæ sibi quasi titulum pro certamine bono certando assumpsit divini Magistri verba : « Evangelizare pauperibus misit me », nullo umquam tempore destitit in agri Dominici messem multos eosque sedulos cultores mittere, qui strenue laborantes laeti tandem cum exultatione portarent manipulos suos. Brevi in universum terrarum orbem, Deo favente, diffusa, novem in præsens ipsa Congregatio provinciis pollet. Quatuordecim Apostolici Vicariatus et in America Septentrionali et in Africa Meridionali et in Asia manent Oblatorum Missionariorum a Virgine Immaculata curis concrediti : ipsa tam vasto terrarum marisque intervallo dissita Australia plura ab hac Congregatione accepta referre debet beneficia. -

Acta Apostolicae Sedis
ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE ANNUS V. - VOLUMEN V. ROMAE TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS MDCCCCXIII Annus V. - Vol. V. Die 25 Ianuarii 1913. Num. 1. ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTAEIUM OFFICIALE ACTA PII PP. X MOTU PROPRIO QUO PROVIDETUR REGIMEN ORDINIS FRATRUM MINORUM CONVENTUALIUM DU RANTE INFIRMA VALETUDINE MINISTRI GENERALIS. Supremum officium in universa Ecclesia humilitati Nostrae commissum rei sacrae procurationis gerendae postulat, ut rectae cuiuscumque Ordinis actioni pro videamus. Quum porro dilecto filio Victori Mariae Sottaz, Fratrum Minorum Conventualium generali Ministro, diuturna invaletudo a laboribus quiescendi necessitatem faciat; ipso in Ministri generalis munere perma nente, ad totius Ordinis Conventualium administrationem re ligiosum virum Franciscum Mariam Dall'Olio, eiusdem Ordinis Procuratorem, etiam in Vicarium generalem cum omnibus facultatibus eidem debitis eligimus. Duobus vero modo Adsi- stentibus, dilectis Hieronymo Mariae Mileta et Stephano Mariae Ignudi, duos alios adiungimus, dilectos Aloisium Mariam San toro, in Basilica Vaticana Poenitentiarium, et Dominicum Ma riam Tavani in collegio seraphico S. Theodori de Urbe modera torem, qui in officio, quod obtinent, permanentes, eidem Vica rio generali in cunctis praesto erunt, et quorum ipse vota deli berativa exposcere tenebitur. In omnibus vero Curiae generalis conventibus etiam religiosi Francisci Mariae Formenti consilia et vota erunt exquirenda, praecipue si de sacris expeditionibus populis ad pietatem excolendis aliquid erit pertractandum. 6 Acta Apostolicae Sedis. - Commentarium Officiale. Haec a Nobis, uti supra, decreta et statuta, usque ad Congre gationem generalem anno 1913 habendam ab universis Ordinis Conventualium sodalibus ita erunt servanda, ut unicuique reli giosum sit moderatorum voluntati morem gerere, iisdemque obedientiam et reverentiam prompto hilarique animo in omni bus praestare : non obstantibus Constitutionibus et Ordinatio nibus apostolicis, etiam speciali mentione dignis, ceterisque contrariis quibuscumque. -

Acta Apostolicae Sedis Commentarium Officiale Annus I I I
ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE ANNUS I I I . - VOLUMEN I I I. T Y P I S P O L Y G L O T T I S V A T I C A N IS MDGCCGXI f Annus III. - Vol. III. Die 16 Ianuarii 1911. Num. 1. AGTAIPOSTOIJGAEIEIÌ COMMENTARIUM OFFICIALE ACTA PII PP. X L I T T E R A E A P O S T O L I C AE I. S I N G U L A R I A P R I V I L E G I A A T Q U E I N D U L G E N T I A E P R O A R G H I S O D A L I T A TE A B A D O R A T I O N E N O C T U R N A , O C C A S I O N E P R I M I C E N T E N A R I I A B E R E C T I O N E. PIUS PP. x Ad futuram rei memoriam. Cum omnia in Christo Nobis instaurare cupientibus antiquius nihil magis sit quam ut Christiani populi erga Divini Amoris Mysterium pietas, hoc potissimum tam gravi Ecclesiae tempore excitetur atque amplificetur, pias fidelium societates ad hunc frugiferum finem institutas tum debito laudis praeconio prosequi, tum singularibus gratiis locupletare, libenti quidem gratoque animo satagimus. Nobiles hos inter coetus, quorum socii religionis tuendae spiritu ducti, ante Sanctissimam Eucharistiam publicae adorationi propositam convenire pie solent, coelestem opem supplices impetratum, principem procul dubio locum obtinet Archiconfraternitam ab Adoratione nocturna Sanctissimi Sacratissimi in forma Quadraginta Horarum expositi, quae in hac Alma Urbe floret. -

THE BAROQUE PAPACY Ary Papal Court, the Roman Curia and the Papal State Were Constructed
is work leads the reader into one of the most exciting chapters of the history of the papacy. It delineates the behaviour and dilemmas of ❧ Rome in the ghts against the Turks, in the irty Years’ War, and in ) the struggles with the Protestants and the numerous con icts with the éter usor Catholic States. In addition, the book describes in detail the rst real example of globalisation, namely the worldwide spread of missions, in addition to providing accounts of the formation of new religious move- – ments, Galileo’s trial and the ordeals of the Institute of the Blessed Virgin ( Mary. Furthermore, the chapters o er insights into the nature of papal nepotism, how the Roman inquisition worked, and how the contempor- THE BAROQUE PAPACY ary papal court, the Roman Curia and the Papal State were constructed. (–) Péter Tusor, PhD, DSc, was born in 1967. He is currently an Associate Professor at the Institute of History at the Péter Pázmány Catholic Uni- versity and a Research Group Leader at the Hungarian Academy of Sci- ences. THE BAROQUE PAPACY THE BAROQUE ISBN 978-88-7853-715-6 éter usor 9 788878 537156 , Sette Città Barokk pápaság.indb 2 2016.05.24. 9:52:59 Péter Tusor THE BAROQUE PAPACY (1600–1700) Sette Città 2016 Barokk pápaság.indb 3 2016.05.24. 9:52:59 All rights reserved. Reproduction in any form, storage or transcription by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or in any other ways, including movie, radio, television or internet) is prohibited without the written permission of the publisher. -

The Vatican Council from Its Opening to Its Prorogation : Official
' <: * ' f ' - L * * * f < ' : V- A* v ''^'V <* '- *Y- V>'r ' <\ ? l'"f^KI v ' " : ' ' -' y '" '- - -"''' <: , . > ',' ^ i< - < ^' f S v^ /' <* v C \'-' '.' S,i -W^i^tt^'-W:': t '. < ^ ( ,/A.-':;./;vv/;v;^^'/X;^>;o-; ; - <l ,. THE VATICAN COUNCIL, FROM ITS OPENING TO ITS PROROGATION, OFFICIAL DOCUMENTS, DIARY, LISTS OF BISHOPS, &c., &c., &c. PART THE SECOND. ''TABLET OFFICE," 27, WELLINGTON STREET, STRAND BURNS, GATES, AND Co., PORTMAN STREET. INDEX, Preface . I Allocution of Pope Pius IX on the 2nd of December, 1869 . 2 Official Notice of the Opening of the Council . 7 Analysis of the Ordo Concilii CEcumenici . 9 Allocution of Pope Pius IX on the 8th December, 1869, the First Public Session .... Apostolic Letter Multiplies inter of Pope Pius IX of the 27th November, 1869 . Preamble . .21 Chap. I. On the Manner of Life to be followed by those present at the Council . 22 Chap. II. On the Right to bring forward Questions and the manner of so doing . 24 Chap. III. On the Secrecy to be observed in the Council 25 Chap. IV. On the Order of Sitting . 26 Chap. V. Of the Judges of Excuses and Complaints . 28 Chap. VI. Of the Officers of the Council . 29 Chap. VII. Of the General Congregations of the Fathers 31 Chap. VII. Of the Public Sessions . -35 Chap. IX. Of not Leaving the Council . 37 Chap. X. Apostolic Indult concerning Non-residence on the part of those who assist at the Council . .- -37 The Oath taken by the Officials of the Council . 38 Sermon of the Archbishop of Iconium on the 8th December, 1869 39 Ordo Concilii CEcumenici . -
Ordination of a Bishop, of Priests, and of Deacons
ORDINATION OF A BISHOP, OF PRIESTS, AND OF DEACONS ENGLISH TRANSLATION ACCORDING TO THE SECOND TYPICAL EDITION March 2018 The International Commission on English in the Liturgy A MIXED CO M M ISSIO N O F CA TH O LIC BISHO PS’ CO N FEREN CES 1100 Connecticut Avenue, NW, Suite 710 The MostReverend Arthur Serratelli Washi ngton, DC 20036-4101 USA BISHOP OF PATERSON, CHAIRMAN TELEP HON E 202-347-0800 The Revd Mgr Andrew Wadsworth FAX 202-347-1839 EXECUTIVE DIRECTOR EMAIL [email protected] www.icelweb.org 30 March 2018 Your Eminence, Your Excellency, It gives me great pleasure to send you the attached Gray Book of Ordination of a Bishop, of Priests, and of Deacons, for a Canonical vote by the Bishops of your Conference. The translation of De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum has been altered as a result of comments received from the Conferences of Bishops on the same text in Green Book format last year. We are very grateful for the careful study of this important liturgical text. In evaluating the comments from the Conferences of Bishops, the ICEL Bishops noted three general principals that you will want to convey to the Bishops of your Conference: The Roman Missal provided a base text that would guide the work of translation of the remaining texts of the Roman Rite. Consistency with the Roman Missal and with other liturgical documents such as the Catechism, the Code of Canon Law, and other instructions and directives of the Holy See is highlighted in the texts in the form of notes. -

Doctrinas Y Parroquias Del Obispado De Quito En La Segunda Mitad Del Siglo Xvi
DOCTRINAS Y PARROQUIAS DEL OBISPADO DE QUITO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI Mons. Augusto E. Albuja Mateus DOCTRINAS Y PARROQUIAS DEL OBISPADO DE QUITO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI Mons. Augusto E. Albuja Mateus Ediciones Abya-Yala 1998 DOCTRINAS Y PARROQUIAS DEL OBISPADO DE QUITO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI Mons. Augusto E. Albuja Mateus 1a Edición 1998 © Ediciones Abya-Yala Av. 12 de Octubre 14-30 y Wilson Casilla 17-12-719 Télf: 562-633/506-217/506-251 Fax: (593 2) 506255 Quito, Ecuador E-mail: [email protected] Página electrónica: http://www.abyayala.org Autoedición: Abya-Yala Editing Quito, Ecuador ISBN: 9978-04-321-7 Impresión Digital: Docutech U.P.S. / XEROX Quito-Ecuador Impreso en Quito-Ecuador, 1998 ÍNDICE Principales Abreviaturas .................................................................. 11 Prólogo .......................................................................................... 13 Introducción .................................................................................. 17 CAPÍTULO I LA ENCOMIENDA Y LA REAL AUDIENCIA DE QUITO .................... 21 La Encomienda .............................................................................................. 21 Naturaleza - historia - vicisitudes - aspecto jurídico - Encomenderos: sus deberes y derechos. La Real Audiencia de Quito .......................................................................... 32 Descripción - divisiones civiles - Encomiendas - Encomenderos - tributos de los indios. CAPÍTULO II LA DIÓCESIS DE QUITO Y SUS PRIMEROS -

Nepotism in the Seventeenth-Century Catholic Church and De Luca's
CARDINAL GIOVANNI BATTISTA DE LUCA: NEPOTISM IN THE SEVENTEENTH- CENTURY CATHOLIC CHURCH AND DE LUCA’S EFFORTS TO PROHIBIT THE PRACTICE H. Lee Cowan, A.S., B.S., MA.CL., M.DIV Dissertation Prepared for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF NORTH TEXAS August 2012 APPROVED: Laura Stern, Major Professor Denis Paz, Committee Member Randolph B. Campbell, Committee Member Sarah E. Fredericks, Committee Member Richard B. McCaslin, Chair of the Department of History Mark Wardell, Dean of the Toulouse Graduate School Cowan, H. Lee, Cardinal Giovanni Battista de Luca: Nepotism in the Seventeenth-Century Catholic Church and de Luca's Efforts to Prohibit the Practice. Doctor of Philosophy (History), August 2012, 361 pages, references, 464 titles. This dissertation examines the role of Cardinal Giovanni Battista de Luca in the reform of nepotism in the seventeenth-century Catholic Church. Popes gave very large amounts of money to their relatives and the burden of nepotism on the Catholic Church was very onerous. The Catholic Church was crippled by nepotism and unable to carry out its traditional functions. Although Cardinal de Luca and Pope Innocent XI worked tirelessly to end nepotism, they were thwarted in their attempts by apprehension among the Cardinals concerning conciliarism and concerning the use of reform measures from the Council of Trent; by Gallicanism and the attempts of the French King to exercise power over the French Church; and by the entrenchment of nepotism and its long acceptance within the Church. Cardinal de Luca and Innocent XI were not able to push through reforms during their lifetimes but Pope Innocent XII was able to complete this reform and pass a reform Bull. -

1. Prelimary Pages FINAL
THE CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA The Provenance and Purpose of Personal Ordinariates Erected under the Auspices of the Apostolic Constitution Anglicanorum Cœtibus A DISSERTATION SubmiFed to the Faculty of the School of Canon Law Of The Catholic University of America In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree Doctorate in Canon Law © Copyright All Rights Reserved By James Daniel Bradley Washington, D.C. 2017 The Provenance and Purpose of Personal Ordinariates Erected under the Auspices of the Apostolic Constitution Anglicanorum Cœtibus James Daniel Bradley, J.C.D. Director: Kurt Martens, J.C.D. The apostolic constitution Anglicanorum Cœtibus is a response to petitions from groups of Anglicans to be received into communion with the Holy See in a corporate manner. This dissertation examines the origin of such petitions, the development of the principles guiding the response, and an analysis of the legislation. Chapter One traces the origins of corporate reunion from Newman to the Second Vatican Ecumenical Council, in particular the Association for Promoting the Unity of Christendom and the Malines Conversations. Chapter Two discusses the Second Vatican Ecumenical Council with respect to ecumenism and Anglicanism. It examines the establishment of relations between Anglicans and the Holy See, the Anglican-Roman Catholic International Commission (ARCIC), and proposals for the corporate reunion of Anglicans in the Diocese of Amritsar, the United States, the Diocese of Matabeleland, and the United Kingdom. Chapter Three considers the overtures made by groups of Anglicans from 2005 to 2009. This includes the Anglican Church in North America (ACNA), Church of England bishops, and the Traditional Anglican Communion. -

History Education and the School Textbook in Fascist Italy: Fascist National Identity and Historiography in the Libro Unico Di Stato
Royal Holloway School of Modern Languages, Literatures and Cultures Italian History Education and the School textbook in Fascist Italy: Fascist National Identity and Historiography in the Libro unico di Stato by Jun Young Moon Supervisor Dr. Fabrizio De Donno Advisor Dr. Giuliana Pieri A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy Royal Holloway College, University of London 2015 DECLARATION OF AUTHORSHIP I, , hereby declare that this thesis and the work presented in it is entirely my own. Where I have consulted the work of others, this is always clearly stated. Signed: Date: ABSTRACT The Fascist government in Italy monopolised the textbook for primary schools in 1930. This act was the regime’s bid to cultivate the Italiano nuovo and to transform Italy into a Fascist nation. By differentiating its education from the conventional contents and practices in Liberal Italy, the Fascist regime aimed at imbuing Italian children with a new national identity, which was expected to be a cornerstone of the Fascist Empire. History was regarded as one of the most crucial subjects for this goal and was high on the list of the regime’s priorities when the state school textbook, the Libro unico di Stato, was written. This research is a study of the historiography in the Fascist state textbook. Despite the importance of history education and the school textbook in the project to Fascistise Italy, few studies are entirely devoted to analysing Mussolini regime’s view of history in the Libro unico di Stato. This thesis attempts to redress this gap. By analysing the Libro unico’s historical narrative –its messages, tropes, symbolism, thematic concerns, narrative strategies, languages, and periodization in all 9 volumes-, this thesis demonstrates what ideological messages and values were taught by Fascist schools via history textbooks, how the textbook narrative transmitted Fascism’s world view and its historical interpretation to pupils, and what the characteristic of the Fascist historiography in education was.