Portella Della Ginestra Illustrazioni Di Chiara Di Vivona
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
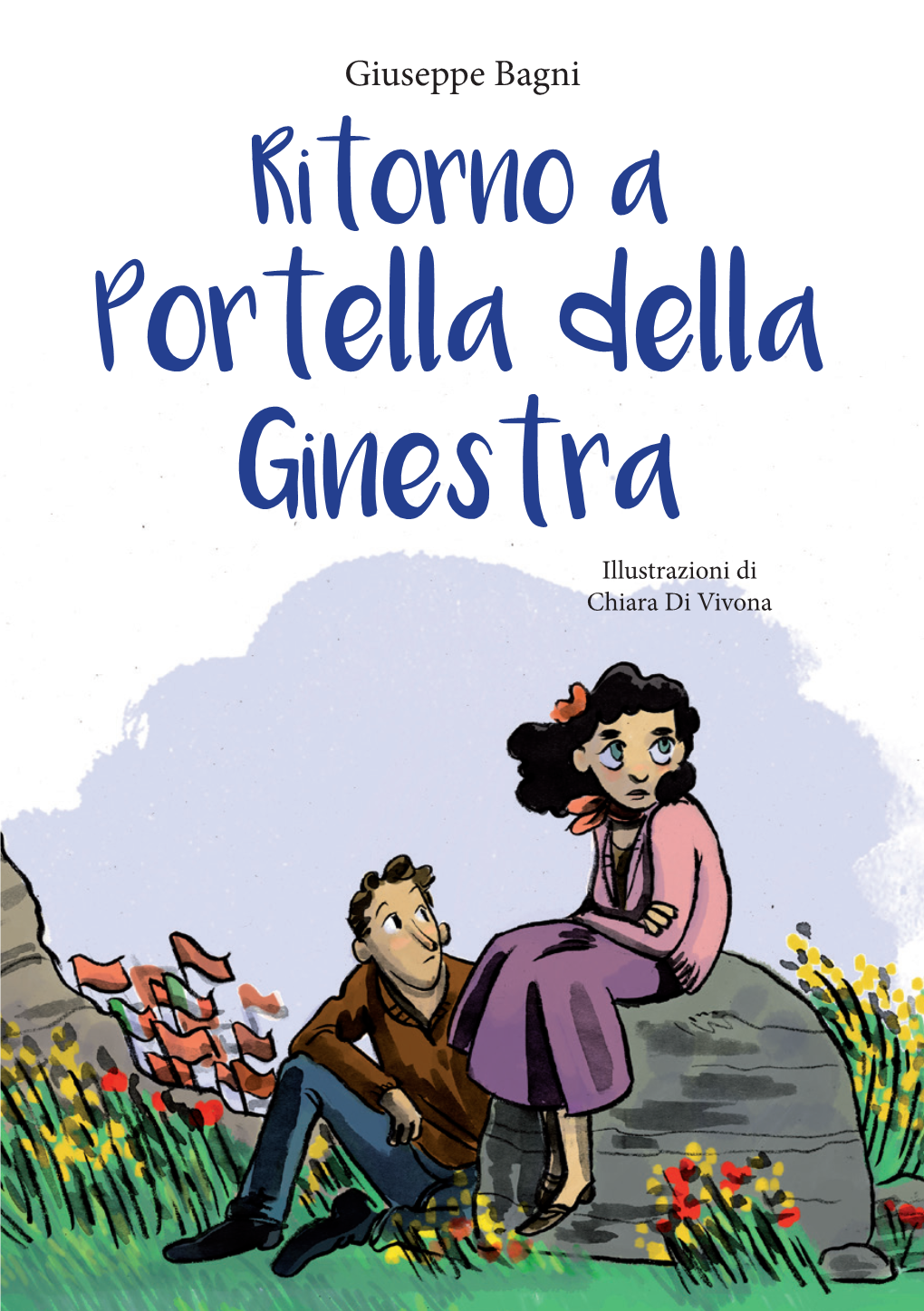
Load more
Recommended publications
-

COMUNE DI MONTELEPRE (Provincia Di Palermo)
COMUNE DI MONTELEPRE (Provincia di Palermo) STATUTO COMUNALE (Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2006) Parte I IDENTITÀ ISTITUZIONALE PRINCIPI E FUNZIONI FONDAMENTALI Titolo I IDENTITA’ ISTITUZIONALE E PRINCIPI GENERALI Art. 1 Identità e ambito giuridico-amministrativo 1. Il Comune di Montelepre é ente territoriale autonomo, rappresentante la comunità locale, ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 114 della Costituzione della Repubblica. 2. Opera nell'ambito giuridico-amministrativo della Regione siciliana e della Provincia di Palermo. Art. 2 Territorio del Comune 1. Il Comune di Montelepre si trova in una posizione collinare che va dai 300 ai 600 metri dal livello del mare, è un territorio articolato e non eccessivamente ampio rispetto ai comuni viciniori. 2. Il territorio comunale è quello determinato dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. 3. Confina, con il Territorio dei Comuni di Giardinello, Carini e Monreale. 4. La sua estensione è Kmq. 9,89. 5. Al fine di assicurare il diritto all’abitazione, il Comune predispone piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica e privata, nonché l’allargamento dei confini del territorio comunale. Art. 3 Sede del Comune 1. Il Comune ha sede in via Castrenze di Bella n. 60. 2. Taluni Uffici sono distaccati nelle sedi di via Francesco Purpura (L/go Ospedale), via Castrenze di Bella n. 14 e in Piazza della Vittoria. 3. Possono essere istituiti ulteriori uffici distaccati dalla sede centrale. 4. Gli organi collegiali del Comune, in casi eccezionali e per particolari esigenze, previa determinazione del relativo Presidente, possono riunirsi anche in sedi diverse con le modalità previste dal regolamento del relativo organo collegiale. -

Allegato a FORNITORI
Allegato A Elenco aggiornato delle ditte cui affidare lavori in economia o cottimo fiduciario ai sensi dell’art 125 comma 8 e 12 del D. Lgs 163/06 e s.m.i. (per importi inferiori o pari ad€ 150.000,00), e delle ditte cui affidare i lavori per importo superiore ad € 150.000,00 e fino ad €. 1.000.000,00) ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; SOGLIA N° SOPRA + DITTA INDIRIZZO CITTA' SOTTO - 1 + 3C. COSTRUZIONI S.r.l. Corso Aldo Moro, 113 90031Belmonte Mezzagno (PA) 2 + A.C.S. IDROSYSTEM S.r.l. Via Sollima, 84 94018 Troina (EN) 3 - A.D. COSTRUZIONI s.r.l. Fondo Chiusa Grande, 23/A - 90146 Palermo 4 + A.K.7 S.r.l. Via Segni, 17 92026 Favara (AG) 5 + A.R. IMPIANTI S.r.l. Via Umberto Giordano, 116 90144 Palermo 6 + A.T.I. Group s.r.l. Via Dante, 70 90011 Bagheria (PA) 7 - Accardo Costruzioni Via M. Toselli, 11 - 91021 Campobello di Mazara (TP) 8 - AG Impianti s.r.l. Via Gaetano Amoroso, 13 90128 Palermo 9 + AKAB S.r.l. Via Roma, 103 98069 Sinagra (ME) 10 - Alexandro Costruzioni s.r.l. Viale Europa, 546 - 90036 Misilmeri (PA) 11 + Alfano S.r.l. Via Giorgio La Pira, 1/G 92012 Cianciana (AG) 12 + Alkazan S.r.l. Via Albergheria, 175 90134 Palermo 13 - ALL SERVICES Costruzioni e Forniture di G.M. Via Provvidenza, 17 90014 Casteldaccia (PA) 14 - ALVA System s.a.s. Via Leonardo Sciascia, 29 92100 Agrigento 15 - Amedeo Belli Architetto Impr. -

DISPONIBILITA' SOSTEGNO I GRADO.Pdf
USR SICILIA UFFICIO I - AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO POSTI DISPONIBILI PER SUPPLENZE - I GRADO SOSTEGNO * CODICE SCUOLA DENOMINAZIONE SCUOLA COMUNE ORGANICO DI FATTO a.s. 2021/2022 EH CH DH POSTI ORE POSTI ORE POSTI ORE PAMM89501D CONVITTO NAZIONALE G. FALCONE PALERMO 1 PAMM89401N EDUCANDATO MARIA ADELAIDE PALERMO 3 11 1 PAMM847014 I.C. A. CAPONNETTO PALERMO 2 PAMM8AN01L I.C. A. GENTILI PALERMO PAMM81601C I.C. A. GIORDANO LERCARA FRIDDI 4 14 PAMM87701X I.C. A. UGO PALERMO 8 14 PAMM89901R I.C. ABBA - ALIGHERI PALERMO 5 11 PAMM82802Q I.C. ALIA - ROCCAPALUMPA - VALLEDOLMO ALIA 12 PAMM811019 I.C. ALTAVILLA MILICIA ALTAVILLA MILICIA 7 PAMM898011 I.C. AMARI - RONCALLI - FERRARA PALERMO 4 12 PAMM8AW01C I.C. ARCHIMEDE - LA FATA PARTINICO 4 9 PAMM84301R I.C. ARMAFORTE ALTOFONTE 4 14 1 PAMM86501N I.C. BAGHERIA - BUTTITTA BAGHERIA 10 14 PAMM83601N I.C. BAGHERIA - T. AIELLO BAGHERIA 8 PAMM84901Q I.C. BAGHERIA IV ASPRA BAGHERIA 10 14 PAMM8AF01C I.C. BARBERA CACCAMO 2 PAMM838019 I.C. BELMONTE MEZZAGNO BELMONTE MEZZAGNO 15 PAMM8A401R I.C. BIAGIO SICILIANO CAPACI 7 PAMM85601V I.C. BOCCADIFALCO - TOMASI DI LAMPEDUSA PALERMO 6 13 PAMM81401R I.C. BORGETTO PARTINICO 6 9 PAMM81001D I.C. CAMPOFELICE - LASCARI - COLLESANO CAMPOFELICE DI ROCCELLA 1 PAMM840019 I.C. CAMPOREALE CAMPOREALE 4 1 PAMM8BA01X I.C. CARDUCCI - GRAMSCI BAGHERIA 13 PAMM86001E I.C. CARINI - VILLAGRAZIA GUTTUSO CARINI 9 PAMM8AG018 I.C. CARINI CALDERONE - TORRETTA CARINI 14 9 1 USR SICILIA UFFICIO I - AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO POSTI DISPONIBILI PER SUPPLENZE - I GRADO SOSTEGNO * CODICE SCUOLA DENOMINAZIONE SCUOLA COMUNE ORGANICO DI FATTO a.s. -

Prefettura Di Palermo Ufficio Territoriale Del Governo
Prefettura di Palermo Ufficio Territoriale del Governo ELENCO FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (Art.1, commi dal 52 al 57, della legge n.190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) Sezione VIII Autotrasporti per conto di terzi Sede secondaria con Codice fiscale Data di scadenza Aggiornamento Ragione Sociale Sede legale Data di iscrizione rappresentanza Partita I.V.A. iscrizione in corso in Italia Bagheria (PA) AEMME LOGISTICA Via Sant’Isidoro Monte 06332540829 15 marzo 2020 15 marzo 2021 S.r.l.s. s.n.c. AF TRASPORTI Termini Imerese (PA) Aggiornamento 06560620822 10 aprile 2019 10 aprile 2020 S.r.l. C.da San Cristoforo in corso AGLIATA GLTGNN57B27G792Z Polizzi Generosa (PA) Aggiornamento GIOVANNI 25 marzo 2019 25 marzo 2020 Via Collesano n. 107 in corso GIUSEPPE 02869140828 Isola Delle Femmine AIELLO (PA) 05358250826 31 marzo 2020 31 marzo 2021 SALVATORE Via Michelangelo n. 41 ALBATROS S.n.c. di Ustica (PA) GIARDINO Giovanni 04827300825 26 maggio 2020 26 maggio 2021 Via Confusione n.33 & C. Polizzi Generosa LSANNN60B26A958Q ALISEO ANTONINO (PA) 12 ottobre 2019 12 ottobre 2020 Via Cefalù n. 26 04285800829 AL.TA. SERVIZI Borgetto (PA) Aggiornamento 03487270823 18 marzo 2019 18 marzo 2020 S.r.l. Via Pio n. 50 in corso AL.TO. S.n.c. di Alia (PA) ALESSANDRA Contrada Balatazze 03451380822 12 giugno 2020 12 giugno 2021 Piero Angelo s.n.c. MTAGLC91D06G273P Palermo Aggiornamento AMATO GIANLUCA 14 settembre 2018 14 settembre 2019 Cortile Patania n. 2 in corso 06527690827 Palermo AMBIECO S.n.c. -

Guida All'ospitalità
Altofonte Belmonte Mezzagno Bisacquino Bolognetta Campofiorito Camporeale Cefalà Diana Chiusa Sclafani Contessa Entellina Corleone Giuliana Godrano Marineo Mezzojuso Monreale Palazzo Adriano Piana degli Albanesi Prizzi Roccamena San Cipirello San Giuseppe Jato Santa Cristina Gela Villafrati Alto Belice Corleonese Guida dell’ospitalità Hospitality guide L’Alto Belice Corleonese Cenni storici L’Alto Belice Corleonese si estende a Sud di Palermo, verso l’interno. Le prime notizie storiche lo danno popolato dalla popolazione indigena degli Elimi, a Nord-Ovest, e dai Sicani, a Sud. Questi ultimi daranno il nome alla catena montuosa che interessa l’area meridionale dell’Alto Belice Corleonese. In epoca classica e medioevale,il comprensorio segue le vicende storiche siciliane:la colonizzazione greca e cartaginese,le guerre puniche,l’af- fermazione dei Romani,le invasioni barbariche,la presenza bizantina,la conquista araba. I Normanni fondano Monreale (sec. XII), la città più importante del distretto, e la dotano di un ampio territorio, nucleo fondante di quello dell’Alto Belice Corleonese. L’imperatore Federico II di Svevia nel Duecento distrugge le ultime roccaforti dei ribelli arabi,asserragliati presso antiche città,oggi importanti siti archeologici,come Ietas ed Entella. Al tempo dei Vespri siciliani (sec.XIII),il Senato di Palermo e la città di Corleone si alleano contro gli Angioini,e il vessillo che issano porta il colo- re giallo di Palermo e quello rosso della rivoluzione,scelto da Corleone.Questi colori diventeranno quelli della bandiera siciliana. Alla fine del Quattrocento,gruppi di coloni albanesi,in fuga dall’invasione turca,fondano i centri abitati di Piana degli Albanesi,Palazzo Adriano, Contessa Entellina,Mezzojuso,Santa Cristina Gela,conservando sino ad oggi la lingua,le tradizioni,il rito religioso greco. -

ORARI in VIGORE DAL 29.06.2020 Internet
ORARI ESTIVI PROVVISORI IN VIGORE DAL 29 - 06 - 2020 Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. Struttura Territoriale Occidentale - Sede di Palermo A U T O L I N E E CO L L E G A M E N T I 1 Altavilla/Casteldaccia/A.19/Palermo 2 Altavilla/San Nicola/Trabia/Termini Imerese 3 Altofonte/Palermo 4 Sant'Elia/Aspra/Bagheria/Palermo 5 Bagheria/Santa Flavia/Casteldaccia/Altavilla 6 Burgio/Prizzi/Palazza A./Chiusa S./Corleone/Marineo/Palermo O 7 Campofelice di Fitalia/Mezzojuso/Villafrati/Palermo 8 Carini/Torretta/Capaci/Isola/Sferracavallo/Palermo R 9 Castelbuono/Isnello/Collesano/Campofelice di Roccella/Cefalù 10 Castelbuono/Collesano/Termini Imerese/Palermo A 11 Corleone/S.Cipirello/S.Giuseppe/Partinico 12 Godrano/Cefalà Diana/Villafrati/Bolognetta/Misilmeri/Villabate/Palermo 13 Monreale/Palermo R E 14 Montevago/S.Margherita/Salaparuta/S.S. 624/S.Giuseppe /Palermo 15 Partanna/A.29/Palermo I S 17 Partinico/Borgetto/Pioppo/Palermo 18 Partinico/Giardinello/Montelepre/Palermo T 2 19 Palazzo Adriano/Prizzi/Castronovo/Lercara/Vicari/Palermo 20 Roccamena/Camporeale/S.Cipirrello/S.Giuseppe/Pioppo/S.S. 624/Palermo I 0 21 Termini Imerese/Ventimiglia/Ciminna/Baucina/Misilmeri/Palermo 22 Terrasini/Cinisi/Capaci/Palermo 23 Modica-Palermo V 2 I 0 Informazioni: Direzione via Ugo La Malfa, 40 - Palermo -Tel. 091.6800011 Biglietteria Piazzale J. Lennon Palermo -Tel. 091.6858015 internet: www.aziendasicilianatrasporti.it Direzione Via Ugo La Malfa Palermo - Tel. 091.6800011 ORARIO FERIALE ESTIVO PROVVISORIO N° 1 Biglietteria Piazzale Lennon Palermo -Tel. 091.6858015 AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.p.A. IN VIGORE DAL 15.06.2020 www.aziendasicilianatrasporti.it Autolinea: PALERMO-A 19-CASTELDACCIA-ALTAVILLA 5436 8701 8703 turni 8701 5436 8703 senso senso FERMATE 1 2 3 marcia marcia 4 5 6 NOTE A 13:10 18:00 PALERMO LENNON 7:55 16:40 7:30 13:35 18:25 PALERMO G.CESARE 7:30 9:00 16:15 8:00 14:05 18:55 CASTELDACCIA 7:00 8:30 15:45 8:15 14:30 19:10 ALTAVILLA 6:45 8:15 15:30 Prescrizioni di esercizio: A) Prosegue per via Ernesto Basile. -

Indirizzi MMG PLS 12 05 2021
Cod_Regle Tipologia Medico Cognome Nome Indirizzo Studio Distretto/PPTTAA 129231 MMG AGNELLO VINCENZO Via Umberto I° 26, 90016 Collesano DS_33_Cefalu' 145282 PLS ALLEGRA GIUSEPPINA C.le Ventimiglia, 3 - 90013 Castelbuono DS_33_Cefalu' 126675 MMG BERTOLA MARIA Via Garibaldi 23, 90013 Castelbuono DS_33_Cefalu' 135836 MMG BOSCO NICOLETTA MARIA Via E. Fermi 3, 90015 Cefalù DS_33_Cefalu' 132892 MMG CANGELOSI GIOVANNA Via Libertà 9, 90010 Lascari DS_33_Cefalu' 131968 MMG CANGEMI CLAUDIO Via Spinuzza 65, 90015 Cefalù DS_33_Cefalu' 132756 MMG CAPUANA GIUSEPPE Via Viola 12, 90013 Castelbuono DS_33_Cefalu' Via Di Bernardo 2, 90016 Collesano 140161 PLS CARMINA GRAZIA DS_33_Cefalu' Via Mazzini 7, 90010 Campofelice di Roccella 144609 MMG CASTELLI ANTONINO Via Roma, 11/A - 90010 Campofelice di Roccella DS_33_Cefalu' 141074 MMG CAVALLARO SALVATORE Via Libertà 24, 90010 Lascari DS_33_Cefalu' Via L. Pirandello 6, 90015 Cefalù 116966 PLS CESARE VINCENZA DS_33_Cefalu' Via Roma 32, 90010 Lascari 139646 MMG CICERO DINA Via Cannizzaro 4, 90015 Cefalù DS_33_Cefalu' 145112 MMG CIPOLLA ROSARIA Via Vittimaro, 3 - 90013 Castelbuono DS_33_Cefalu' 143457 MMG CIRRITO FRANCESCO Corso Umberto, 111 DS_33_Cefalu' 128831 PLS DI PAOLA ROSA MARIA Via XXV Novembre, 6 - 90015 Cefalu' DS_33_Cefalu' 132642 MMG DI VINCENZO ARMANDO Via Umberto I° 32, 90015 Cefalù DS_33_Cefalu' 125933 MMG DOLCE ANTONINO FELICE Via Conca D'Oro 1, 90010 Campofelice di Roccella DS_33_Cefalu' 133464 MMG FERRARA TERESA Via Prestisimone 17/a, 90015 Cefalù DS_33_Cefalu' 139190 MMG FIASCONARO MARIA Via -

10. La Strage Di Portella Della Ginestra
10. La strage di Portella della Ginestra La vittoria della sinistra nelle elezioni regionali del 20 aprile 1947 provocò nel mondo politico una certa inquietudine, anche perché si andava disegnando nel quadro politico internazionale e nazionale un nuovo scenario dopo che il Presidente degli Stati Uniti Harry Truman a marzo aveva formulato una nuova «dottrina» sulle relazioni interna- zionali, che di lì a poco avrebbe portato alla guerra fredda tra le na- zioni vincitrici della seconda guerra mondiale, gli USA e l’URSS, e la conseguente rottura dell’unità antifascista che governava il paese. È in questo contesto politico nazionale ed internazionale, aggravato a livello regionale dall’aspro conflitto sociale, che aveva provocato una lunga scia di sangue nelle file del sindacato, che le Camere del Lavoro di Piana degli Albanesi, San Giuseppe Jato e San Cipirello organizza- rono nel 1947 la festa del Primo Maggio a Portella della Ginestra. A quel tradizionale appuntamento politico e sindacale i lavoratori arrivavano dopo due anni di dure lotte sindacali e significative vit- torie elettorali. I contadini, nei mesi precedenti, in applicazione del decreto Se- gni, avevano ottenuto in concessione centinaia di ettari di terra in- colta, ed erano in attesa di nuove assegnazioni che avrebbero colpi- to ancora di più duramente gli interessi degli agrari e dei mafiosi del circondario, tra i quali Ciccio Cuccia. Alle lotte sindacali seguirono le vittorie elettorali dei partiti della sinistra, sia nelle elezioni amministrative dell’autunno ’46 sia nelle regionali del 20 aprile 1947. A San Giuseppe Jato e San Cipirello nel 1946 per la prima volta, con il voto democratico, furono cacciati dall’amministrazione comunale gli uomini legati alla mafia. -

Disponibilità COMUNE GPS II FASCIA I GRADO Per Calendario
USR SICILIA UFFICIO I - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PALERMO POSTI COMUNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2020-2021 DISPONIBILITA' PER LE CONVOCAZIONI GPS II FASCIA I GRADO DEL 22 e 23 settembre 2020 POSTI COMUNE CATTEDRE AL 31 POSTO SCUOLA CDC TIPOLOGIA COMPLETAMENTO AGOSTO ORARIO COMPLETA CON PAMM811019 ALTAVILLA- G. VASI CORLEONE A001 COE 16+2+6 MONS.GAGLIANO + PAMM09900R MISILMERI-GUASTELLA SI COMPLETA CON PAMM89501D CONITTO NAZIONALE G. S.M. A. DA MESSINA A001 COE 14+4 FALCONE SMS DON LORENZO MILANI A001 18 SALVATORE QUASIMODO A001 18 IC ABBA ALIGHIERI A001 18 Educandato M.Adelaide A001 6 Giovan Battista Cinà - Campofelice A001 2 I.C. CIVICO CERVELLO A001 4 ic ospedale di cristina A001 4 sede i. c. s.s profeta - Ustica A001 4 IC DON MILANI A001 10 SMS GRAMSCI A001 2 ic prizzi A001 2 ic russo raciti A001 2 CORSO PER LAVORATORI - BUTTITTA A022 18 BAGHERIA C.T. VASI CORLEONE A022 18 SI CT CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - A022 18 PARTINICO SI COMPLETA CON PAMM09900R MISILMERI ORE 4 + I.C. CAMPOFELICE ROCCELLA A022 COE 8+4+6 PAMM81701B VILLAFRATI ORE 6 COMPLETA CON PAMM82702X - PETRALIA SOTT. + IC CASTELLANA POLIZZI A022 COE 7+6+5TP PAMM8AH014 - CASTELBUONO MINA' PALUMBO MONTEMAGGIORE BELSITO A022 COE 11+7 COMPLETA CON PAMM81901X - CALTAVUTURO IC ORESTANO ALIA A022 COE 15+3 COMPLETA CON PAMM88201B - PRIZZI IC BELMONTE MEZZAGNO A022 18 IC RISO ISOLA DELLE FEMMINE A022 COE 12+6 COMPLETA CON PAMM884013 SAN GIUSEPPE JATO COMPLETA CON PAMM85901A - VENEZIANO MONREALE + IC ARMAFORTE ALTOFONTE A022 COE 8+2+8 PAMM86401T - GUGLIELMO II MONREALE ASPRA BAGHERIA A022 18 MANZONI MONTELEPRE A022 18 SI TERRASINI-GIOVANNI XXIII A022 18 IC CARINI GUTTUSO A022 COE 16+2 COMPLETA CON PAMM85901A - VENEZIANO MONREALE SMS MORVILLO MONREALE A022 10+8 COMPLETA CON PAMM88101G PIANA DEGLI ALBANESI SI SMS PRIVITERA PARTINICO A022 COE 14+4 COMPLETA CON PAMM846018 - CINISI CASA DEL FANCIULLO A022 18 SI VASI CORLEONE A022 COE 16+2 COMPLETA CON PAMM811019 - ALTAVILLA MILICIA ALTOFONTE AMARFORTE A022 18 COMPLETA CON PAMM06400T SMS SCIANNA C. -
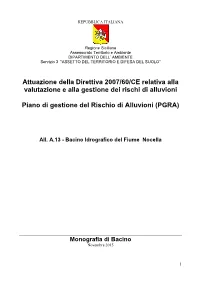
Bacino Idrografico Del Fiume Nocella
REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente DIPARTIMENTO DELL’ AMBIENTE Servizio 3 "ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO” Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni Piano di gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) All. A.13 - Bacino Idrografico del Fiume Nocella Monografia di Bacino Novembre 2015 1 Sommario PREMESSA ......................................................................................................................................... 3 1 AMBIENTE FISICO ................................................................................................................... 4 1.1 Inquadramento geografico e amministrativo ....................................................................... 4 1.2 Morfologia ........................................................................................................................... 6 1.3 Idrografia .............................................................................................................................. 6 1.4 Uso del suolo ........................................................................................................................ 7 1.5 Cenni di climatologia ........................................................................................................... 8 1.5.1 Stazioni........................................................................................................................... 8 1.5.2 Regime termico ............................................................................................................. -

AVVISO Sito Natura 2000 ITA020049 Monte Pecoraro E Pizzo Cirina
REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE SERVIZIO 3 GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO U.O.2 ESERCIZIO VENATORIO AVVISO Prot. n° 22400 Palermo 18.09.2017 Oggetto : Stagione Venatoria 2017/2018. Esercizio dell’attività venatoria nel Sito Natura 2000 ITA020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina, ITA020023 Raffo Rosso, M. Cuccio e Vallone Sagana. Si comunica che nelle more dell'emanazione del Decreto Assessoriale che regolamenta l'esercizio dell'attività venatoria nel sito Natura 2000, ITA020023 Raffo Rosso, M. Cuccio e Vallone Sagana ed anche nella porzione di territorio coincidente con il sito ZPS ITA020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina, è consentito presentare le istanze di ammissione. In applicazione di quanto previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 sono ammessi esclusivamente i cacciatori residenti nei comuni di Capaci, Carini, Giardinello, Isola delle Femmine, Monreale, Montelepre, Palermo e Torretta e precisamente: • n. 4 cacciatori residenti a Capaci; • n. 6 cacciatori residenti a Carini; • n. 9 cacciatori residenti a Giardinello • n. 1 cacciatori residenti a Isola Delle Femmine; • n. 19 cacciatori residenti a Monreale; • n. 4 cacciatori residenti a Montelepre; • n. 20 cacciatori residenti a Palermo; • n. 22 cacciatori residenti a Torretta; I cacciatori che intendono esercitare l’attività venatoria all’interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino venatorio della stagione venatoria 2017/2018, devono fare pervenire la domanda di ammissione, redatta in carta bollata di € 16,00, alla Ripartizione Faunistica Venatoria (R.F.V.) di Palermo entro il 22 settembre 2017. -

San Giuseppe Jato - Guida Ai Comuni
S. Martino delle Scale Castellaccio Monreale Gibilrossa Altofonte Belmonte Mezzagno COMMUNES GUIDE SAN GIUSEPPE JATO - GUIDA AI COMUNI San Giuseppe Jato 9.300 abitanti circa (about 9,300 inhabitants) RISERVA DI SERRE DELLA PIZZUTA M. Belliemi SP67 936 640 MMadonnaadonna M. della Fiera ddellaella PProvvidenzarovvidenza Piana degli Albanesi 968 SR4 SP SP2 SR4 ex traz.2 SP20 S. Cristina Gela SSanan GGiuseppeiuseppe JJatoato SP30 SP34 Bolognetta JJetasetas M. Jato SP2 853 SP2 SP138 SSanan CCipirelloipirello SP4 Makella ex C.le 60 SP20 Marineo M. Madonna della Dayna SP20 ex C.le 33 SP4 SP138 ex C.le 56 Terme Montagnola Arabe SP71 RISERVA DI BAGNI DI CEFALÀ DIANA Caratteristico abbeveratorio About 30 kilometres from Palermo,also E CHIARASTELLA A circa 30 km da Palermo, anch’essa A typical trough all’ombra di Monte Jato, sorge in una in the shade of Monte Jato,it stands in Cefalà Diana zona collinare a 463 m. slm, lungo la a hilly area 463 metres above sea level, Torre statale 624 Palermo-Sciacca. Il suo along the Palermo-Sciacca state high- del Bosco Villafrati territorio fa parte delle Zone Natura- way 624.Its territory is part of Special Palazzo listiche a Protezione Speciale di Protection Nature Area of “Monte Jato, Godrano Filangeri Camporeale “Monti Jato, Kumeta, Maganoce e Kumeta,Maganoce and Pizzo Parrino” Madonna Palazzo Principi di Camporeale Pizzo Parrino” e “Monti Matassaro, and that of “Monte Matassaro,Monte di Tagliavia Gradara e Signora”. Gradara and Monte Signora”. Pulpito Nel tardo Settecento,incamerati i beni In the late eighteenth