Scienze E Storia Dell'ambiente Padano N. 23/2008
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
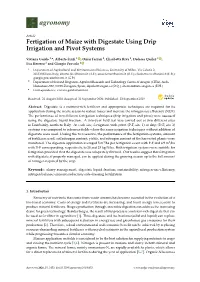
Fertigation of Maize with Digestate Using Drip Irrigation and Pivot Systems
agronomy Article Fertigation of Maize with Digestate Using Drip Irrigation and Pivot Systems Viviana Guido 1,*, Alberto Finzi 1 , Omar Ferrari 1, Elisabetta Riva 1, Dolores Quílez 2 , Eva Herrero 2 and Giorgio Provolo 1 1 Department of Agricultural and Environmental Sciences, University of Milan, Via Celoria 2, 20133 Milano, Italy; alberto.fi[email protected] (A.F.); [email protected] (O.F.); [email protected] (E.R.); [email protected] (G.P.) 2 Department of Soil and Irrigation, Agrifood Research and Technology Centre of Aragon (CITA), Avda. Montañana 930, 50059 Zaragoza, Spain; [email protected] (D.Q.); [email protected] (E.H.) * Correspondence: [email protected] Received: 22 August 2020; Accepted: 21 September 2020; Published: 23 September 2020 Abstract: Digestate is a nutrient-rich fertilizer and appropriate techniques are required for its application during the maize season to reduce losses and increase the nitrogen use efficiency (NUE). The performance of two different fertigation techniques (drip irrigation and pivot) were assessed using the digestate liquid fraction. A two-year field test was carried out at two different sites in Lombardy, northern Italy. At each site, fertigation with pivot (P-F, site 1) or drip (D-F, site 2) systems was compared to reference fields where the same irrigation techniques without addition of digestate were used. During the two seasons, the performance of the fertigation systems, amount of fertilizers used, soil nitrogen content, yields, and nitrogen content of the harvested plants were monitored. The digestate application averaged 5 m3/ha per fertigation event with P-F and 4.9 m3/ha with D-F corresponding, respectively, to 28 and 23 kg N/ha. -

Master Plan of the Northern Italy Waterway System Abstract And
Master Plan of the Northern Italy Waterway System Abstract and Executive Summary INSTITUTIONAL COORDINATION: Province of Mantua and Coordination for the functional development of the Northern Italy and Northern Adriatic inland waterway system. TECHNICAL COORDINATION: ALOT s.c.a.r.l (Chiara Bresciani) AUTHORS: Province of Mantua (Roberto Grassi, Giancarlo Leoni, Giovanni Mazzieri, Emanuela Medeghini, Gabriele Negrini, Paola Rossetti). AIPO (Luca Crose, Luigi Fortunato, Ivano Galvani, Luigi Mille, Marcello Moretti, Federica Pellegrini, Mirella Vergnani), Special Authority for Chioggia Port (Pietro Boscolo Nale, Oscar Nalesso), Consorzio Aussa Corno (Alberto Cozzi), Venice Port Authority*, CONSVIPO (Giuseppe Moretto, Fabio Volpe), Rovigo Intermodal Terminal (Giuseppe Fini), Province of Cremona (Giorgio Rodighiero, Maurizio Rossi), Province of Rovigo (Paola Fantinato, Chiara Monesi, Roberto Todaro), Province of Reggio Emilia (Maurizio La Macchia, Eliana Porreca), Rete Autostrade del Mare S.p.A. (Tommaso Affinita), Sistemi Territoriali S.p.A. (Alessandro Bonvicini), UNII‐SCIP (Mario Borgatti, Manuela Tommasi). ALOT s.c.a.r.l. (Chiara Bresciani, Giorgio Casoni, Francesca Costa, Alessandro Maghella, Nikolina Mandić, Tiziana Massaro, Alberto Milotti, Nicola Pascal, Guido Piccoli, Marco Popolizio, Elisa Sabbadini, Giuseppe Siciliano, Claudio Tonini, Roberto Zaglio). The following experts have collaborated in the Master Plan of the Northern Italy Waterway System preparation: Dott. Massimo Lazzarini (1), T‐Bridge S.p.A.(2), A.S.T. Engineering s.r.l.(3‐4‐5‐6), Ing. Giovanni Righini Consorzio Crema Ricerche (7), Essencial Supply Chain Architects Vremde e Vrije Universiteit Brussel (6‐8), Arch. Paolo Sartor (6), Port of Koper (6), Dott. Danilo Stevanato (6). And as decision‐makers and relevant stakeholders: Abibes S.p.A. -

Agriturismi+Provincia+Di+Cremona.Pdf
Provincia di The province of / Die Provinz Cremona La provincia di Cremona è compresa tra i due grandi fiumi lombardi: il Po (a sud) e l’Adda (ad ovest). Interamente pianeggiante, il suo territorio offre tutto il ventaglio delle ricchezze padane: grandi aziende agricole, allevamenti modernissimi, grandi riserve di caccia, ma anche industrie e manifatture tra le più moderne. Cremona, città ricca di storia e di pregevoli monumenti, offre uno stile di vita capace di far gioire delle cose belle della vita, a partire da quelle che si gustano a tavola... The province of Cremona is wedged between the two large rivers of Lombardy: the Po (to the south) and the Adda (to the west). Totally flat, its land offers the whole range of riches of the Po: large commercial farms, the latest methods in livestock farming, large hunting reserves, but also some of the most modern industries and factories. Cremona, a city steeped in history and precious monuments, offers a lifestyle encouraging you to delight in the beautiful things of life, starting with those enjoyed at the table... Die Provinz Cremona liegt zwischen den beiden großen Flüssen der Lombardei: dem Po (im Süden) und dem Adda (im Westen). Ihre zur Gänze flache Landschaft bietet eine große Bandbreite an Reichtümern der Poebene: große Agrarbetriebe, hypermoderne Zuchtbetriebe, große Jagdreviere, aber auch Industrie und modernste Manufakturbetriebe. Cremona, eine geschichtsträchtige Stadt mit sehenswerten Denkmälern, bietet einen Lebensstil, der die schönen Dinge des Lebens hervorhebt, beginnend bei jenen, die man bei Tisch genießen kann... 85 Provincia di Cremona Agricola “Motta” di Franzoni Agriturismo Sant’Alessandro Giacinta & C. -

Three Essays in Italian Economic History
Sapienza University of Rome Doctoral Thesis Three essays in italian economic history This dissertation is submitted for the degree of Doctor of Philosophy at the european Phd program in Socio-economic and statistical studies Candidate Advisor Vitantonio Mariella Prof. Mauro Rota iii Declaration of Authorship I declare that this thesis titled Three essays in italian economic history and the work presented in it are my own. I confirm that except where specific reference is made to the work of others, the contents of this dissertation are original and have not been submitted in whole or in part for consideration for any other degree or qualification in this, or any other university. This dissertation contains nothing which is the outcome of work done in collaboration with others, except as specified in the text and Acknowledgements. To my father v Acknowledgements I would like to express my sincere gratitude to Prof. Mauro Rota for his precious guidance, mentorship and support, without whom the research would not have been possible. A special thank goes to Prof. David Chilosi, whose help made my Visiting experience particularly fruitful. I would also like to thank Francesco S.L, Francesco B., Paolo, Teresa, Lucrezia, Serena, Luigi and my cousins Peppone and Peppino. Without them my life would have been much sadder. My biggest thanks goes to my family for all the support shown me through this research experience. My most sincere gratitude goes to Costanza for her patience, support and love, who makes my life a wonderful adventure. And sorry for being even grumpier than normal whilst I wrote this thesis! All of you stimulated my mind to move beyond its limits. -
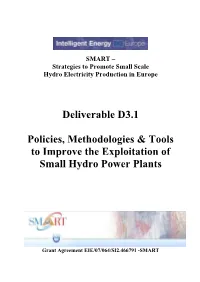
Exploitation of Small Hydro Power Plants
SMART – Strategies to Promote Small Scale Hydro Electricity Production in Europe Deliverable D3.1 Policies, Methodologies & Tools to Improve the Exploitation of Small Hydro Power Plants Grant Agreement EIE/07/064/SI2.466791 -SMART Policies, Methodologies & Tools to Improve the Exploitation of SHP DISCLAIMER The project SMART (Strategies to promote small scale hydro electricity production in Europe) is supported by the “Intelligent Energy – Europe” Programme (Contract N°: EIE-07-064). The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not represent the opinion of the Community. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. AUTHO RS: Province of Cremona (Italy) Marco Antoniazzi Province of Attica (Greece) Lilly Christoforidou Thaya County (Austria) Otmar Schlager Thomas Waldhans NTNU (Norway) Anna Carmen Masoliver Verdaguer Sølvi Eide Idun Schjerven Østgård Ole Gunnar Dahlhaug FSBUZ (Croatia) Zvonimir Guzović Branimir Matijašević Karlovac County (Croatia) Marinko Maradin ERSE (Italy) Julio Alterach Giuseppe Stella Stefano Maran Maximo Peviani Policies, Methodologies & Tools to Improve the Exploitation of SHP Table of contents 1 Introduction 2 Policies, Methodologies and Best Practice 2.1 Province of Cremona, Italy Summary 2.1.1 The Development Pa ct 2.1.1.2 Definition 2.1.1.2 The course of the project 2.1.1.3 Means of implementation 2.1.1.4 The Pact and the young 2.1.2 The Environmental En e rg y Plan 2.1.2.1 Introduction 2.1.2.2 PEAP structure -
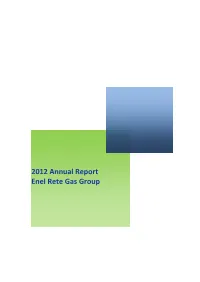
2012 Annual Report Enel Rete Gas Group
2012 Annual Report Enel Rete Gas Group Enel Rete Gas Group – Annual Report 2012 I. Contents I. Contents ................................................................................................................... 2 II. Company directors and auditors ................................................................................. 5 2 Foreword ........................................................................................................................................ 7 3 Key figures ...................................................................................................................................... 7 4 Enel Rete Gas Group: local distribution .......................................................................................... 9 5 Significant share capital transactions during the year ............................................................ 10 6 2012 consolidation scope ........................................................................................................... 10 7 Results of the Enel Rete Gas Group........................................................................................... 11 8 Development activities and management of concessions ...................................................... 14 8.1 Regulatory framework .......................................................................................................... 19 8.2 Tariff framework ................................................................................................................... 22 8.3 Regulatory -

Del Giardino Di Ludovico Zappa a Cremona in Una Lettera Al Conte Bresciano Lucrezio Gambara (1531)
verdenero SOMMARIO 24 F. B ONALI “Arbori e simplici” del giardino di Lodovico Zappa a Cremona in una lettera al conte bresciano Lucrezio scienze e storia Gambara (1531) pag. 3 dell’ambiente padano L. SHESTANI,A.MORISI, Analisi qualitativa della fauna macrobentonica di fontanili S. FENOGLIO e risorgive della pianura cuneese pag. 25 n. 24 / 2009 E.ARNAUD,A.LODA La comunità delle diatomee bentoniche come indicatore della qualità delle acque del fiume Tormo pag. 47 ISSN 1722 - 5493 P. C AVAGNA, L.C. CAVAGNA Il capriolo, la coronilla ed il melo: frequentazioni fauni- stiche e scelte alimentari invernali a Castello di Nivione, Valle Staffora pag. 71 E. CAIRO Indagine sullo svernamento di pettirosso (Erithacus rubecula) e scricciolo (Troglodytes troglodytes) a Bergamo:censimento dei territori e preferenze ecologiche pag. 95 N. GRATTINI Distribuzione, consistenza ed espansione territoriale di sparviere, Accipiter nisus, e lodolaio, Falco subbuteo,ni- dificanti in provincia di Mantova pag. 103 F. F ERLINI Le comunità ornitiche nei prati di erba medica,Medicago sativa, dell'Oltrepò Pavese pag. 111 S. COREZZOLA, M.G. BRAIONI, Monitoraggio della fauna ropalocera (Lepidoptera) in un PIANURA S. HARDERSEN nuovo impianto boschivo e in una fascia ripariale pag. 127 G. D'AMICO Farfalle diurne e interventi naturalistici:il caso della Riserva naturale integrale Bosco Siro Negri e di un rimboschimen- to limitrofo (Lepidoptera Hesperioidea e Papilionoidea) pag. 139 R. GROPPALI Odonati come prede degli uccelli pag. 151 D. PERSICO Rinvenimento di resti fossili di Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) in un clasto di torba del fiume Po: indagine paleoambientale pag. 157 V. F ERRARI Contributi toponomastici all’interpretazione del paesag- gio della provincia di Cremona. -
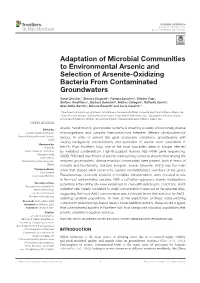
Adaptation of Microbial Communities to Environmental Arsenic and Selection of Arsenite-Oxidizing Bacteria from Contaminated Groundwaters
fmicb-12-634025 March 13, 2021 Time: 16:38 # 1 ORIGINAL RESEARCH published: 19 March 2021 doi: 10.3389/fmicb.2021.634025 Adaptation of Microbial Communities to Environmental Arsenic and Selection of Arsenite-Oxidizing Bacteria From Contaminated Groundwaters Sarah Zecchin1, Simona Crognale2, Patrizia Zaccheo3, Stefano Fazi2, Stefano Amalfitano2, Barbara Casentini2, Matteo Callegari1, Raffaella Zanchi1, Gian Attilio Sacchi3, Simona Rossetti2 and Lucia Cavalca1* 1 Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente (DeFENS), Università degli Studi di Milano, Milano, Italy, 2 Water Research Institute, National Research Council of Italy (IRSA-CNR), Rome, Italy, 3 Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali—Produzione, Territorio, Agroenergia (DiSAA), Università degli Studi di Milano, Milano, Italy Arsenic mobilization in groundwater systems is driven by a variety of functionally diverse Edited by: Gonzalo Durante-Rodriguez, microorganisms and complex interconnections between different physicochemical Spanish National Research Council, factors. In order to unravel this great ecosystem complexity, groundwaters with Spain varying background concentrations and speciation of arsenic were considered in Reviewed by: Pinaki Sar, the Po Plain (Northern Italy), one of the most populated areas in Europe affected Indian Institute of Technology by metalloid contamination. High-throughput Illumina 16S rRNA gene sequencing, Kharagpur, India Jagat Rathod, CARD-FISH and enrichment of arsenic-transforming consortia showed that among the National Cheng Kung University, analyzed groundwaters, diverse microbial communities were present, both in terms of Taiwan diversity and functionality. Oxidized inorganic arsenic [arsenite, As(III)] was the main *Correspondence: driver that shaped each community. Several uncharacterized members of the genus Lucia Cavalca [email protected] Pseudomonas, putatively involved in metalloid transformation, were revealed in situ in the most contaminated samples. -

The Area Desk of Cremona Province Where We Are
The Area Desk of Cremona Province Where we are Lombardy Province of Cremona Italy Who is REI – Reindustria Innovazione www.reindustria.com Local development agency, public funded REI is an actor in territorial marketing and promote innovation. Plays a synaptic and pivot role in the relation between Institution, business world with University and research center. Key Word : Territorial Attractiveness To be cultivated in harmony between territorial interests and Territorial Innovation Innovative the methodological approach given by the regional regulatory Marketing and Research Startup framework and instruments (Unioncamere Lombardia system and Lombardy Region). Transversal and broad approach, inclusive, subsidiary Attrattività; Lombardia è Ricerca; S3 - Smart Specialisation Strategy; Open Innovation Platform, Cluster Tecnologici REI’ s value: public-private partenership Local Authorities Trade associations . Camera di Commercio di Cremona . Libera Associazione Artigiani Cremaschi . SCRP – Società Cremasca Reti Patrimonio . Confartigianato Imprese Crema . Associazione Industriali Cremona Municipalities . CNA Cremona . Cremasca Servizi (Comune Crema) . Confartigianato Cremona . Comune di Cremona . ASCOM Crema . Comune di Casalmaggiore . A.Svi.Com Cremona Banks . Confcooperative . Banco Popolare di Cremona Trade Unions . Banca Cremasca . Banca Cremonese Cigl – Cisl – Uil . Credito Cooperativo dell'Adda e Cremoso . Cassa Padana Exibithion Organization(CremonaFiere) 4 Presentation of ’’Area Desk’’ Cremona, Giovedì 5 Ottobre 2017, ore 16.00, -

The Effect of Biogas Production on Farmland Rental Prices: Empirical Evidences from Northern Italy
energies Article The Effect of Biogas Production on Farmland Rental Prices: Empirical Evidences from Northern Italy Eugenio Demartini 1,*, Anna Gaviglio 1, Marco Gelati 1 and Daniele Cavicchioli 2 1 Department of Health, Animal Science and Food Safety (VESPA), University of Milan, 20133 Milan, Italy; [email protected] (A.G.); [email protected] (M.G.) 2 Department of Economics, Management, and Quantitative Methods (DEMM), University of Milan, 20133 Milan, Italy; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +39-02-5031-6462 Academic Editor: Thomas E. Amidon Received: 8 June 2016; Accepted: 25 October 2016; Published: 18 November 2016 Abstract: In the last decade, increased environmental awareness has prompted the adoption of incentives for exploiting renewable energy sources. Among these, biogas production has received a certain attention in developed countries. Nonetheless, the subsidies provided have posed the problem of an activity (the production of bioenergy) that engages in direct competition with food and feed production for limited resources, like agricultural land. Even if this competition may be softened by allocating marginal land and/or using dedicated non-agricultural crops, empirical evidence shows that biogas plants have been developed in highly-productive agricultural areas, using increasing amounts of maize silage as feedstock. Thus, studies aimed at measuring the effect of biogas production on agricultural activities are needed in order to avoid this socially undesirable outcome. The paper presents an econometric estimation of the impact of biogas plants on farmland rental values of a Northern Italian rural area. Results show that biogas has a non-linear effect on rental prices, suggesting that incentive schemes specifically accounting for plants’ dimensions and technologies would improve the social sustainability of the bioenergy sector and its coexistence with agricultural activity. -

13 Annual Meeting of the South-East
13th Annual Meeting of the South - E a s t European Experts Network on Intangible C u l t u r a l H e r i t a g e “Safeguarding ICH at local level: governance frameworks and community engagement” Cremona, Italy 16-18 June 2019 CONCEPT NOTE B a c k g r o u n d The South-East European Experts Network on Intangible Cultural Heritage (ICH) was established in 2007 by UNESCO, through its Regional Bureau for Science and Culture in Europe, in order to support the implementation of the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in the region. Annual meetings of the network took place so far in Arbanasi, Bulgaria (2007); Safranbolu, Turkey (2008); Zagreb, Croatia (2009); Râmnicu- Vâlcea, Romania (2010); Belgrade, Serbia (2011); Athens, Greece (2012); Sofia, Bulgaria (2013); Limassol, Cyprus (2014); Venice, Italy (2015); Supetar, Croatia (2016); Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (2017); and Ljubljana, Slovenia (2018). These meetings contributed to enhance a common understanding of opportunities and challenges linked to the safeguarding of the ICH as a key asset of South-East European cultural diversity, promoting the sharing of knowledge and good practices on national measures to implement the Convention, and serving as a platform to develop regional and cross-border cooperation. The 13th annual meeting is hosted by the City of Cremona, Italy, and organized by UNESCO (Regional Bureau for Science and Culture in Europe, in cooperation with the Living Heritage Entity), thanks to the generous support of the Italian Ministry for Cultural Heritage and Activities and of the Regional Centre for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in South-East Europe (Category 2 Centre operating under the auspices of UNESCO, based in Sofia, Bulgaria). -
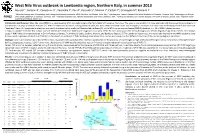
Presentazione Standard Di Powerpoint
West Nile Virus outbreak in Lombardia region, Northern Italy, in summer 2013 Rovida F1, Sarasini A1, Campanini G1, Percivalle E1, Pan A2, Possenti S3, Manzini L4, Castelli F5, Gramegna M6, Baldanti F1 1Molecular Virology Unit, Microbiology and Virology Department, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia, Italy. 2 Infectious and Tropical Diseases Unit, Istituti Ospitalieri di Cremona, Cremona, Italy. 3Nephrology and Dialysis P0462 Unit, Istituti Ospitalieri di Cremona, Cremona, Italy. 4 Infectious Diseases Unit, Azienda Ospedaliera Carlo Poma, Mantova, Italy. 5 Institute of Infectious and Tropical Diseases, University of Brescia, Brescia, Italy. 6Regional Health Authority of Lombardy, Milan, Italy. Introduction and Purpose: West Nile virus (WNV) is a positive-sense RNA virus belonging to the Flaviviridae family (genus Flavivirus). The virus is now endemic in many countries and has caused large outbreaks in recent years in Europe and North America [1]. WNV is maintained in nature, cycling between birds, the main WNV vertebrate hosts and mosquitoes. Humans and horses are incidentally infected and represent “dead-end” hosts [2]. Symptomatic infections are mostly characterized by a mild, self-limiting febrile illness [2], while WNV neuroinvasive disease (WNND) develops in < 1% of WNV-infected persons. In Italy, on summer 2008 the first human cases of WNND and WNV fever (WNF) were diagnosed in an area of the Po river valley across the Emilia-Romagna and Veneto Regions [3-4]. From 2009 to 2012 human cases of WNV infections were detected in Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sardinia, Marche, and Basilicata Regions [5].The Lombardy Region was only marginally involved in the WNV epidemics (two human cases) in province of Mantua in 2008 [6].