Relazione Generale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Roma, 17 Novembre 2017 Comuni
Roma, 17 novembre 2017 Ufficio Provinciale di Roma - Territorio ______________ Il Direttore Comuni di: - BELLEGRA - CAPENA - CAPRANICA PRENESTINA - CARPINETO ROMANO - CASTELNUOVO DI PORTO - CASTEL SAN PIETRO ROMANO - CAVE - CIVITELLA SAN PAOLO - COLLEFERRO - FIANO ROMANO - FILACCIANO - GALLICANO NEL LAZIO - GAVIGNANO - GENAZZANO - GORGA - LABICO - MONTELANICO - MORLUPO - NAZZANO - OLEVANO ROMANO - PALESTRINA - PISONIANO - POLI - PONZANO ROMANO - RIANO - RIGNANO FLAMINIO - ROCCA DI CAVE - SACROFANO - SANT’ORESTE L’originale del documento è conservato presso l’Ufficio emittente Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Roma - Territorio – Via Raffaele Costi 58/60 – 00155 Roma Tel. 06.7240.2530-2557 - Fax 06.7240.2534 – e-mail: [email protected] pec: [email protected] - SAN VITO ROMANO - SEGNI - TORRITA TIBERINA - ZAGAROLO e.p.c. - Restanti Comuni della Provincia di Roma - Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Roma - Associazioni Agricole della Provincia di Roma - Agenzia delle Entrate Direzioni Provinciali - Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio Ufficio Attività Immobiliari Prot. All. 1 OGGETTO: Conservazione del Catasto Terreni - verificazioni quinquennali gratuite artt.118 e 119 del Regolamento n.2153/1938. II DPR 917/1986 consente, con cadenza quinquennale, ai possessori di richiedere la variazione del reddito dominicale per sostituzione della qualità di coltura o per diminuzione della capacità produttiva ascrivibile a specifiche cause; l'Agenzia dell'Entrate verifica gratuitamente tali segnalazioni. Per godere del beneficio della verificazione quinquennale gratuita i possessori interessati, i cui beni ricadono nei Comuni oggetto di verifica periodica, devono presentare, entro il 31 gennaio 2018, la denuncia dei cambiamenti al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio utilizzando gli stampati disponibili in Ufficio o sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it, seguendo il percorso: Cosa devi fare – Aggiornare dati catastali e ipotecari - Variazioni colturali. -

Anno Scolastico 2018-19 LAZIO AMBITO 0013
Anno Scolastico 2018-19 LAZIO AMBITO 0013 - ROMA PROVINCIA Elenco Scuole Primaria Ordinato sulla base della prossimità tra le sedi definita dall’ufficio territoriale competente SEDE DI ORGANICO ESPRIMIBILE DAL Altri Plessi Denominazione altri Indirizzo altri Comune altri PERSONALE Scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole Codice Istituto Denominazione Istituto DOCENTE Denominazione Sede Caratteristica Indirizzo Sede Comune Sede Istituto Istituto Istituto stesso Istituto RMIC89000B IC V TIVOLI BAGNI RMEE89001D TIVOLI - BAGNI NORMALE VIA NERI, 11 TIVOLI RMEE89002E TIVOLI B.GO VIA DELL'AERONAUTICA TIVOLI NUOVO-COLONNELLE RMEE89003G TIVOLI - G. RODARI VIA COLLODI TIVOLI RMIC8G0006 IC TIVOLI III - VILLA RMEE8G0018 M. TERESA DI CALC. - V. NORMALE VIA LEONINA, 6 TIVOLI RMEE8G0029 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA G. A. CROCE TIVOLI ADRIANA LEONINA TIVOLI III RMIC892003 I.C TIVOLI IV-VINCENZO RMEE892037 MARIA NORMALE VIA PATERNO,28 TIVOLI RMEE89206A CASAPE VIA PIETRO TESTI CASAPE PACIFICI MONTESSORI - VIA PATERNO RMEE892048 IQBAL MASIH - VIA VIA ROSOLINA,136-138 TIVOLI ROSOLINA RMEE892059 S.GREGORIO DA VIA BORGO PIO SNC SAN SASSOLA GREGORIO DA SASSOLA RMIC89300V IC TIVOLI II - TIVOLI RMEE893033 TIVOLI II GIORDANI NORMALE VIALE PICCHIONI TIVOLI RMEE893011 TIVOLI - S. POLO SCALO VIA DEI PLATANI SNC TIVOLI CENTRO RMEE893022 MANLIO BATTISTINI VIA I MAGGIO SNC SAN POLO DEI CAVALIERI RMIC8F600E TIVOLI I - TIVOLI CENTRO RMEE8F601L TIVOLI I - SANDRO NORMALE VIA COLLEGIO 2 TIVOLI RMEE8F602N TIVOLI I - DON NELLO VIA F. BULGARINI 36 TIVOLI PERTINI DEL RASO RMVC02000V CONVITTO NAZ."A.DI RMEE27801N SC.EL.ANNESSA NORMALE PIAZZA GARIBALDI N.1 TIVOLI SAVOIA,DUCA D'AOSTA" C.N."A.DI SAVOIA" RMIC8BF004 I.C.C.B. -

The Long-Term Influence of Pre-Unification Borders in Italy
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics de Blasio, Guido; D'Adda, Giovanna Conference Paper Historical Legacy and Policy Effectiveness: the Long- Term Influence of pre-Unification Borders in Italy 54th Congress of the European Regional Science Association: "Regional development & globalisation: Best practices", 26-29 August 2014, St. Petersburg, Russia Provided in Cooperation with: European Regional Science Association (ERSA) Suggested Citation: de Blasio, Guido; D'Adda, Giovanna (2014) : Historical Legacy and Policy Effectiveness: the Long-Term Influence of pre-Unification Borders in Italy, 54th Congress of the European Regional Science Association: "Regional development & globalisation: Best practices", 26-29 August 2014, St. Petersburg, Russia, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/124400 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. -

Curriculum Di Giuditta Silvia Liantonio
Curriculum di Giuditta Silvia Liantonio Dati anagrafici e formazione • nata il 18/07/69 a Bari, residente a Tivoli (Rm), via Rodolfo Lanciani n°7, tel. 0774/313025, cell. 347/1983608; • Maturità linguistica conseguita nel 1987; • Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, conseguita il 25/06/93 con votazione 110/110 e Lode, discutendo una tesi in Scienza delle finanze dal titolo: “ Il principio di competenza del reddito di impresa ”, relatore il Chiar.mo prof. Nicola d’Amati; • Corso di specializzazione per curatore fallimentare presso il Tribunale di Bari; • Abilitazione alla professione di Avvocato conseguita presso la Corte di Appello di Bari in data 03.10.2000; • Diploma di specializzazione post-laurea biennale in “Relazioni industriali e del lavoro” conseguito presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bologna nel 2001; • Superamento del corso di formazione per Segretari comunali “N.I.A.- Nuovi iscritti all’Albo”, con votazione 29/30 nel 2001; • Nel 2004 conseguimento dell’idoneità a Segretario generale, fascia professionale B, a seguito del superamento del corso – concorso di cui al D.P.R. 465/97 ; • Frequenza del corso organizzato dalla SSPAL – Puglia denominato: “Enti locali: Struttura, Progettazione Organizzativa e Fondi Strutturali”; • Frequenza del corso organizzato dalla SSPAL – Lazio sul nuovo codice dei contratti pubblici, periodo gennaio – marzo 2007; • Frequenza del corso organizzato dalla SSPAL – Lazio sulla formazione del bilancio di previsione 2011 alla luce della legge di stabilità -
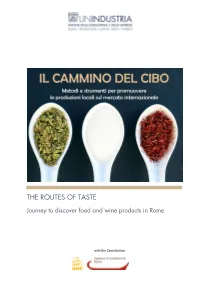
The Routes of Taste
THE ROUTES OF TASTE Journey to discover food and wine products in Rome with the Contribution THE ROUTES OF TASTE Journey to discover food and wine products in Rome with the Contribution The routes of taste ______________________________________ The project “Il Camino del Cibo” was realized with the contribution of the Rome Chamber of Commerce A special thanks for the collaboration to: Hotel Eden Hotel Rome Cavalieri, a Waldorf Astoria Hotel Hotel St. Regis Rome Hotel Hassler This guide was completed in December 2020 The routes of taste Index Introduction 7 Typical traditional food products and quality marks 9 A. Fruit and vegetables, legumes and cereals 10 B. Fish, seafood and derivatives 18 C. Meat and cold cuts 19 D. Dairy products and cheeses 27 E. Fresh pasta, pastry and bakery products 32 F. Olive oil 46 G. Animal products 48 H. Soft drinks, spirits and liqueurs 48 I. Wine 49 Selection of the best traditional food producers 59 Food itineraries and recipes 71 Food itineraries 72 Recipes 78 Glossary 84 Sources 86 with the Contribution The routes of taste The routes of taste - Introduction Introduction Strengthening the ability to promote local production abroad from a system and network point of view can constitute the backbone of a territorial marketing plan that starts from its production potential, involving all the players in the supply chain. It is therefore a question of developing an "ecosystem" made up of hospitality, services, products, experiences, a “unicum” in which the global market can express great interest, increasingly adding to the paradigms of the past the new ones made possible by digitization. -

Det.Resp.CUC 5-2018. Indizione Porocedura Aperta Projiet Financing
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA IX° COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO Comuni di Tivoli, Casape, Castel San Pietro Romano, Ciciliano, Marcellina, Poli, San Vito Romano, Castel Madama, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri Direttore Responsabile: Dott. Stefano Petrucci Sede legale e amministrativa: Tivoli (RM), Via Tiburtina, n. 2 Sito Internet: www.comunitamontanativoli.org DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE Atto n° 5 Data 18/01/2019 OGGETTO : Comune di Casape (RM). Procedura aperta di proj ect financing per l’affidamento della con cessione per la progettazione esecuti va , l’esecuzione dei lavori di riqualificazion e, gestione e manutenzione, adeguame nto e messa a norma dell’impianto di pu bblica illuminazione dell’intero territo rio di CASAPE finalizzato al risparmio energetico ed al rispetto degli standar d di sicurezza e diminuzione dell’inquiname nto luminoso, ivi compresa la fornit ura di energia elettrica. Codice CIG : 7296111. Codice CUP: G17B18000090005 L’anno duemiladiciannove , il giorno diciotto del mese di gennaio in Tivoli e nella sede della Comunità Montana dei Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini, in Tivoli, Via Tiburtina, n° 2, nell’Ufficio destinato alla CUC, IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA CUC Vista la convenzione istituiva della Centrale Unica di Committenza -C.U.C tra i Comuni di Marcellina, San Vito Romano, Poli, Casape e Castel San Pietro Romano e la Comunità Montana dei Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini, sottoscritta in data 12 febbraio 2015 ed alla quale int egralmente si rimanda. Dato atto cha alla CUC hanno formalmente e successivamente aderito i Comuni di Ciciliano, Tivoli, Castel Madama, San Gregorio da Sassola e San Polo dei Cavalieri Visto il Regolamento per il funzionamento della Centrale di Committen za allegato alla Convenzione predetta per farne parte integrante e sostanziale. -

Si Comunicano Le Variazioni Intervenute Nell'organizzazione Dell'istituto a Seguito Di Scorporo O Di Collocazione Sul Territorio Di Unità Operative
Organo: INAIL Documento: Circolare n. 25 del 22 marzo 1991 Oggetto: Variazione nell'organizzazione periferica dell'Istituto. - Unità istituite in Roma e provincia. - Sede di Barletta (già Bari 3) - Sede di Cagliari 2. - Sede di Cirie (già Torino 4) - Sede di Pinerolo - Sede di Massa (già Massa Carrara 2) Si comunicano le variazioni intervenute nell'organizzazione dell'Istituto a seguito di scorporo o di collocazione sul territorio di Unità operative. SEDE DI ROMA 1 Piazza delle Cinque Giornate, 3 - 00192 ROMA TEL.: 06/ 675901 FAX : 06/3225992 COD. AMM. : 24400 U.S.L. di competenza: 16-17-18-19-20 Comune di Roma - Linea prestaz. Via Salaria, 456 - 00199 - ROMA TEL.: 06/8380037 FAX: 06/8380084 COD. AMM.: 24400 - Linea rendite Via Palestro, 45 - 00185 - ROMA TEL.:06/4453686/7/8/9 FAX: 06/4940466 COD. AMM.: 24400 SEDE DI ROMA 2 Piazza delle Cinque Giornate, 3 - 00192 - ROMA TEL.: 06/675901 FAX :06/3225992 COD.AMM.:24470 USL: 5-7-24 Comuni: Roma, Mentana e Monterotondo - Linea prestaz. Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 - ROMA TEL.: 06/4514820/830/851/678 FAX : 06/4514737 COD. AMM.: 24470 SEDE DI ROMA 3 Via dell'Acqua Bullicante, 312 - 00177 - ROMA TEL.: 06/2715330/1/2 FAX: 06/274308 COD.AMM.: 24440 USL: 6-9 Comune di Roma SEDE DI ROMA 4 Via Michele De Marco,18/20 ang. Via Torre Spaccata - 00169 - ROMA (ha incorporato lo Sportello Prestazioni di Via Savona) TEL.:06/2678146/149/175 FAX:06/2675944 COD. AMM.: 24441 USL: 8-10-29-32 Comuni: Roma e Ciampino Lo Sportello Prestazioni di Via Savona, 12 in Roma è stato soppresso. -

GUADAGNOLO Il Borgo Di Guadagnolo È Una Frazione Del Comune Di Capranica Prenestina
INFORMAZIONI SU GUADAGNOLO Il borgo di Guadagnolo è una frazione del Comune di Capranica Prenestina. È il centro abitato più alto della Provincia di Roma ed è posto al limite occidentale dei monti Prenestini cHe si trovano quasi al centro del Lazio, a circa 20 cHilometri a Est di Roma. Da qui si gode una vista sublime sulle valli dell’Aniene e del Sacco, verso i monti Simbruini, Ernici e Lepini. La montagna è caratterizzata da varietà botaniche così uniche da essere inserite nella carta regionale del Lazio fra gli ecosistemi da salvaguardare. La sua storia è strettamente collegata con il Santuario della Mentorella, situato su una rupe a picco sulla valle del Giovenzano, che risale al IV sec. d.C., che è ritenuto il più antico Santuario mariano d'Italia e forse d'Europa, meta abituale di fedeli che salgono a deporre le loro preghiere ai piedi della Vergine, oltre che a S. EustacHio (un martire locale) e San Benedetto. Il villaggio si dice nato all'epoca delle incursioni barbaricHe, quando i romani, fuggiascHi, si sarebbero stanziati nei pressi di un antichissimo fortilizio, del quale restano solo i ruderi di una torre precedente il V secolo. Secondo altri il nucleo originario sarebbe stato costruito dai contadini che lavoravano le terre di appartenenza dei Monaci del Santuario, come avvenne negli antichissimi Monasteri di Cassino, di Subiaco e vari altri luoghi. Secondo lo studioso Padre Atanasio Kircher, un insigne monaco del XVII sec., il nome Guadagnolo deriverebbe dai piccoli guadagni cHe locandieri e osti ricavavano dai pellegrini cHe si recavano a visitare il Santuario. -

La Sedimentazione Di Rampa Carbonatica Dei Monti Prenestini (Miocene Inferiore, Appennino Centrale): Sedimentologia, Stratigrafi
Geologica Romana 37 (2003-2004), 79-96 LA SEDIMENTAZIONE DI RAMPA CARBONATICA DEI MONTI PRENESTINI (MIOCENE INFERIORE, APPENNINO CENTRALE): SEDIMENTOLOGIA, STRATIGRAFIA SEQUENZIALE E STRATIGRAFIA DEGLI ISOTOPI DELLO STRONZIO Mario Barbieri*°, Francesca Castorina*°, Giacomo Civitelli*°, Laura Corda*, Sergio Madonna**, Goffredo Mariotti*°, Salvatore Milli*° (*) Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma ° CNR, Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria, Sezione di Roma “La Sapienza” (**) Dipartimento di Geologia e Ingegneria Meccanica, Naturalistica e Idraulica per il Territorio, Università degli Studi della Tuscia, Via S. Camillo de Lellis - 01100 Viterbo *° e-mail: [email protected] RIASSUNTO - La successione calcareo-marnosa e calcarea d’età Aquitaniano-Serravalliano che affiora sui Monti Prenestini (Italia centrale) è riferibile alla Formazione di Guadagnolo che, nell’area considerata, presenta spessori variabili da 30 fino a 600 metri. Sulla sua porzione mediana (Aquitaniano superiore-Burdigaliano), è stata condotta una dettagliata analisi di facies e stratigrafico-sequenziale e sono stati inoltre utilizzati 48 campioni per la misura delle variazioni del rapporto isotopico 87Sr/86Sr. Queste misure hanno consentito una più precisa definizio- ne cronostratigrafica dell’intera successione sedimentaria e allo stesso tempo hanno permesso di definire l’età delle principali superfici di discontinuità che sono state individuate al suo interno. La successione esaminata è caratterizzata da una ripetizione ciclica di unità deposizionali shallowing e coarse- ning-upward che danno luogo a corpi sedimentari di spessore da metrico a decametrico estesi lateralmente anche diversi chilometri. Queste unità sono costituite da un numero limitato di litofacies rappresentate da marne e marne calcaree spongolitiche, calcari marnosi finemente detritici e calcari bioclastici. -

Elenco Codici Uffici Territoriali Dell'agenzia Delle Entrate
ROMA Le funzioni operative dell'Agenzia delle Entrate sono svolte dalle: • Direzione Provinciale I di ROMA articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di ROMA 1 - TRASTEVERE , ROMA 2 - AURELIO , ROMA 3 - SETTEBAGNI • Direzione Provinciale II di ROMA articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di ROMA 5 - TUSCOLANO , ROMA 6 - EUR TORRINO , ROMA 7 - ACILIA , POMEZIA • Direzione Provinciale III di ROMA articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di ROMA 4 - COLLATINO , ALBANO LAZIALE , TIVOLI , FRASCATI , PALESTRINA , VELLETRI Direzione Provinciale I di ROMA Sede Comune: ROMA Indirizzo: VIA IPPOLITO NIEVO 36 CAP: 00153 Telefono: 06/583191 Fax: 06/50763637 E-mail: [email protected] PEC: [email protected] TK2 Municipi di Roma : I, III, XII, XIII, XIV, XV. Comuni : Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Fonte Nuova, Formello, Magliano Romano, Manziana, Mazzano Romano, Mentana, Monterotondo, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Trevignano Romano. Comune: ROMA Indirizzo: VIA IPPOLITO NIEVO 36 CAP: 00153 Telefono: 06/583191 Fax: 06/50763636 E-mail: [email protected] TK3 Indirizzo: VIA IPPOLITO NIEVO 36 CAP: 00153 Telefono: 06/583191 Fax: 06/50763635 E-mail: [email protected] TK3 Mappa della Direzione Provinciale I di -

Regione Lazio Deliberazione N
REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 18898 DEL 27/11/2020 Direzione: INCLUSIONE SOCIALE STRUTTURA Area: PROPONENTE Prot. n. ___________________ del ___________________ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19. Finalizzazione di ulteriori euro 15.000.000,00, a favore di Roma Capitale e dei Comuni del Lazio. ___________________________(GIORDANO BARBARA) ___________________________(MASSIMI GIANCARLO) ___________________________ ___________________________(O. GUGLIELMINO) ___________________________ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI, WELFARE ED ENTI LOCALI ___________________________(Troncarelli Alessandra) PROPONENTE L'ASSESSORE DI CONCERTO ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ IL DIRETTORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio Data dell' esame: con osservazioni senza osservazioni ___________________________ SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 27/11/2020 prot. 995 ISTRUTTORIA: ____________________________________ ____________________________________ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE ____________________________________ ____________________________________ IL SEGRETARIO -

Parte Prima Inquadramento
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE (RM) ( Allegato 1° ) PARTE PRIMA INQUADRAMENTO GENERALE DEL TERRITORIO PA GI NA 1 PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE (RM) Parte Prima: Inquadramento Generale del Territorio 1.1 Dati di base Dati di base Comune MONTE PORZIO CATONE Codice ISTAT Comune 058064 Provincia ROMA Codice ISTAT Provincia 058 Elenco delle Frazioni del Comune (se elenco delle Frazioni appartenenti al Comune: presenti) ARMETTA, CAMALDOLI, FONTANA CANDIDA, MASSAROSA, MONTE CIUFFO, PILOZZO, PRATONE-BELVEDERE, SAN MARCO, SELVE DI MONDRAGONE, SUORE DOMENICANE DI BETANIA, VILLA VECCHIA Autorità di Bacino di appartenenza BACINO DEL TEVERE 2 Estensione Territoriale in Km Kmq 9,13 Comune di ROMA Comune di FRASCATI Comuni confinanti Comune di GROTTAFERRATA Comune di MONTECOMPATRI Comunità Montana di appartenenza elenco dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana: XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini CAVE, COLONNA, FRASCATI, GALLICANO NEL LAZIO, GENAZZANO,GROTTAFERRATA, MONTE PORZIO CATONE, MONTECOMPATRI, PALESTRINA, ROCCA DI PAPA, ROCCA PRIORA, SAN CESAREO, ZAGAROLO elenco dei Comuni appartenenti al COI: Appartenenza al COI secondo la ex FRASCATI, MONTE PORZIO CATONE, GROTTAFERRATA, ROCCA DI PAPA, ROCCA PRIORA, MONTECOMPATRI DGR 29 febbraio 2000, n.569 (denominazione COI) elenco dei Comuni appartenenti all’Unione di Comuni: Appartenenza a Unione di Comuni NON APPARTENENTE A NESSUNA UNIONE DI COMUNI (denominazione UdC, se presente) PAGI NA 2 PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE (RM) Appartenenza ad altre aggregazioni elenco dei Comuni appartenenti all’aggregazione: comunali (denominazione AC, se --------------------------- presente) Zona di allerta meteo (in riferimento alla E – ANIENE classificazione del CFR, ex DGR Data di validazione del Livello 1 di Microzonazione Sismica (se validato) Determinazione n.