R1 Documento Operativo Strategico
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Progetto "UN TUTOR PER AMICO"
ITALIA SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA TITOLO DEL PROGETTO: UN TUTOR PER AMICO SETTORE e AREA DI INTERVENTO: “Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport” - “07: Attività di tutoraggio scolastico DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI OBIETTIVI DEL PROGETTO Il progetto ha come principale obiettivo quello di ridurre e prevenire il fenomeno della dispersione e dell’abbandono scolastico precoce, erogando servizi di tutoraggio scolastico ATTIVITA’ D’IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI Il progetto prevede azioni che consistono in un supporto del volontario alle attività rivolte ai singoli utenti o ai gruppi, condotte dalle diverse figure professionali, alle quali è affidata la gestione degli interventi e la relativa responsabilità di tutte le azioni. Nello specifico, le loro attività saranno: • Sostegno e recupero di discipline scolastiche; • Partecipazione agli incontri con il corpo docente • Partecipazione agli interventi di sostegno psicologico, finalizzati a sostenere i nuovi impegni scolastici. • Partecipazione alla realizzazione dei laboratori didattici, volti a stimolare e potenziare le capacità dell’alunno, oltrechè sviluppare hobby e passioni (laboratorio multimediale, di lingua inglese, di attività espressive, ecc.); • Ausilio nell’organizzazione e realizzazione di incontri con le strutture sociali e territoriali (Parrocchia, agenzie ricreative, sportive, educative, volontariato, ecc.) • Ausilio nell’organizzazione e realizzazione di incontri con i gruppi giovanili locali. • Accompagnamento degli studenti alle gite, visite a musei, picnic, escursioni, cineforum, parchi- acquatici, ecc. • Ausilio nell’organizzazione e realizzazione di manifestazioni ricreative e spettacoli. • Ausilio nell’organizzazione e realizzazione di campus estivi. • Partecipazione agli incontri di mediazione familiare • Ausilio nell’attivazione di nuove collaborazioni con le agenzie socio-educative locali. -

Step Into Strode to Get You Goin G…… .. Naples – Caught in a Volcanic
Step into Strode Course Title: A Level Geography Welcome to Step into Strode at Strode College. In the table below, you will find questions to consider, tasks to complete and some background research to undertake. This is a 4-week programme that will enable you to engage with your future study programme and teaching team. Please read the instructions below and have a go at the activities, remember you are capable. If you struggle at any point, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) section at the bottom for guidance and help. To Our focus for these sessions is going to be volcanic hazards of the Bay of Naples. get you WEEK 1 Watch Napoli SSC fans recreate an eruption of their local volcano, whose outline is goin the symbol of the city: g…… https://www.youtube.com/watch?v=o129p8lgj58 .. I will give an introductory talk after which you will be able to complete this quiz: Naples – Caught in a Volcanic Sandwich Somma-Vesuvius and the Campi Flegrei Find the right answer (answers next session): 1. Vesuvius last erupted in 1631, 1944, AD79. 2. The biggest killer eruption was 3780 BP, 1631, 1944. 3. The red zone population is 60,000, 600,000, 6m. 4. The most recent volcanic fatalities were in: Naples, Vesuvius, Campi Flegrei. 5. The prevailing wind is from the west, east, south. 6. Naples Airport is called Capodichino, Galileo, Leonardo da Vinci. 7. The local motorway is called Autostrada del Pizza, Autostrada del Sud, Autostrada del Sole. 8. The most vulnerable town is Sorrento, Sarno, Acerro, Torre del Greco. -

Human Responses to the 1906 Eruption of Vesuvius, Southern Italy
ÔØ ÅÒÙ×Ö ÔØ Human responses to the 1906 eruption of Vesuvius, southern Italy David Chester, Angus Duncan, Christopher Kilburn, Heather Sangster, Carmen Solana PII: S0377-0273(15)00061-X DOI: doi: 10.1016/j.jvolgeores.2015.03.004 Reference: VOLGEO 5503 To appear in: Journal of Volcanology and Geothermal Research Received date: 19 December 2014 Accepted date: 4 March 2015 Please cite this article as: Chester, David, Duncan, Angus, Kilburn, Christopher, Sangster, Heather, Solana, Carmen, Human responses to the 1906 eruption of Vesu- vius, southern Italy, Journal of Volcanology and Geothermal Research (2015), doi: 10.1016/j.jvolgeores.2015.03.004 This is a PDF file of an unedited manuscript that has been accepted for publication. As a service to our customers we are providing this early version of the manuscript. The manuscript will undergo copyediting, typesetting, and review of the resulting proof before it is published in its final form. Please note that during the production process errors may be discovered which could affect the content, and all legal disclaimers that apply to the journal pertain. ACCEPTED MANUSCRIPT March 3 2014 Human responses to the 1906 eruption of Vesuvius, southern Italy David Chestera,b, Angus Duncanb, Christopher Kilburnc, Heather Sangsterb and Carmen Solanad,e a Department of Geography and Environmental Science, Liverpool Hope University, Hope Park Liverpool L16 9JD, UK; bDepartment of Geography and Planning, University of Liverpool, Liverpool L69 3BX, UK; cAon Benfield UCL Hazard Research Centre, University College London, Gower Street, London WC1E 6BT, UK; dSchool of Earth and Environmental Sciences, University of Portsmouth, Portsmouth PO1 2UP; eInstituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), Puerto de la Cruz, Canary Islands, Spain. -

Orari E Percorsi Della Linea Bus
Orari e mappe della linea bus EAV EAV Nola - Castellammare di Stabia Visualizza In Una Pagina Web La linea bus EAV (Nola - Castellammare di Stabia) ha 7 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Castellammare Di Stabia: 06:15 - 09:40 (2) Nola Capolinea: 08:00 - 19:30 (3) Nola Capolinea (-> Boscoreale): 06:40 (4) Nola Interporto (-> Palma): 07:35 (5) Ottaviano: 18:15 (6) Torre Annunziata FS: 12:40 (7) Torre Annunziata FS (-> Ist. Ragioneria): 14:20 - 18:05 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus EAV più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus EAV Direzione: Castellammare Di Stabia Orari della linea bus EAV 39 fermate Orari di partenza verso Castellammare Di Stabia: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 06:15 - 09:40 martedì 06:15 - 09:40 Nola - Capolinea mercoledì 06:15 - 09:40 Nola - Via Feudo, 91 SP257, Nola giovedì 06:15 - 09:40 Saviano - Via Sant'Erasmo, 48 venerdì 06:15 - 09:40 sabato 06:15 - 09:40 Saviano - Stazione Via 11 Agosto 1867, Saviano domenica Non in servizio Saviano - Via Torre, 2 Via Torre, Saviano Saviano - Via Torre, 40 Informazioni sulla linea bus EAV Direzione: Castellammare Di Stabia Nola - Via Castellammare, 72 Fermate: 39 Durata del tragitto: 90 min Nola - Piazzolla La linea in sintesi: Nola - Capolinea, Nola - Via Feudo, 91, Saviano - Via Sant'Erasmo, 48, Saviano - Nola - Via Castellammare, 260 Stazione, Saviano - Via Torre, 2, Saviano - Via Torre, 40, Nola - Via Castellammare, 72, Nola - Piazzolla, S. Gennaro Vesuviano - Via Castellammare, 162 Nola - Via Castellammare, 260, S. -
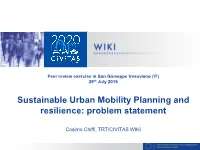
Problem Statement
Peer review exercise in San Giuseppe Vesuviano (IT) 29th July 2015 Sustainable Urban Mobility Planning and resilience: problem statement Cosimo Chiffi, TRT/CIVITAS WIKI The Volcano: Vesuvio The most famous eruption of AD 79 Recent severe eruptions occurred in 1660, 1682, 1694, 1698, 1707, 1737, 1760, 1767, 1779, 1794, 1822, 1834, 1839, 1850, 1855, 1861, 1868, 1872, 1906, 1926, 1929, and 1944 2 PRE in San Giuseppe Vesuviano (IT) - 29th July 2015 Cities, towns and road links in the Vesuvian Area 3 PRE in San Giuseppe Vesuviano (IT) - 29th July 2015 The Vesuvian Area: a densely populated area 2.140.000 inhabitants in the Greater Neapolitan Area (without city of Naples) 2.670 inh/km2 4 PRE in San Giuseppe Vesuviano (IT) - 29th July 2015 National Emergency Plan for the Vesuvian Area • The Red Zone directly involved in case of eruption and the Yellow Zone under the potential influence of Vesuvio eruption 5 PRE in San Giuseppe Vesuviano (IT) - 29th July 2015 Hydrogeological risk for the Vesuvian Area • Other Risks maps of the Vesuvian Area: 1. Landslide 2. Hydraulic 6 PRE in San Giuseppe Vesuviano (IT) - 29th July 2015 2013 Regional Mobility Plan For this area there are no provisions made to reorganise the mobility 7 PRE in San Giuseppe Vesuviano (IT) - 29th July 2015 Who is working on the idea of resilient SUMP? San Giuseppe Vesuviano, Striano e Terzigno • 53.000 inhabitants •High quality agricolture products •Tertiary industry productions •Vesuvio National Park 2020 Objectives •CO2 emissions reduction beyond 20% (between 26% and 29%) •Increased -

Herculaneum Archaeology
The Fifth Herculaneum Congress - Robert Fowler Talks at the Villa Maiuri as part of the Fifth Herculaneum Congress - Richard Janko Other News Suburban Baths - tetrastyle atrium - herm of Apollo the newsletter of the Friends of Herculaneum Society - Issue 18 Summer 2014 of the Friends Herculaneum the newsletter herculaneum archaeology herculaneum The Fifth Herculaneum Congress1 Robert Fowler Henry Overton Wills Professor of Greek Bristol University One first-timer commented that you can tell this meeting is a success by the number of return attendees. Several veterans thought the Fifth was the best yet, and so it was said about all the previous ones. We like to think it’s because we are learning to do things better, rather than that an Olympic- style ritual declaration of the ‘best ever Games’ is taking hold. Yet that would be no bad thing, either; the pronouncement, however much expected, always meets with gleeful and often justified assent. Things nearly got off to a very bad start. Something not far short of an official hurricane (‘poco ci mancava’, said my taxi driver, ‘there wasn’t much in it’) struck the Monday before arrival and, though it miraculously harmed no one in Ercolano and damaged no archaeology, it did uproot trees, mangle safety barriers and create other hazards such that the site had been closed all week, only opening again on the morning we intended to visit. The Superintendency, which this year has been particularly disorganised in the matter of issuing permits, had not yet issued ours, and there was much anxiety Thursday night as to what would happen the next day. -

Citta' Di SOMMA VESUVIANA Provincia Di NAPOLI Numero Pag
Citta' di SOMMA VESUVIANA Provincia di NAPOLI Numero Pag. 1 d'ordine GENERALITA' 103 ALLOCCA ANNA MARIA Sez. 23 nata il 14/09/1975 a POMIGLIANO D'ARCO (NA) VIA ALLOCCA N. 18 148 ALLOCCA MARIA Sez. 15 nata il 27/02/1987 a POLLENA TROCCHIA (NA) VIA ALLOCCA N. 49 183 AMATO ANNUNZIATA Sez. 24 nata il 18/03/1969 a PORTICI (NA) VIA MERCATO VECCHIO N. 14 P. 1 205 ANGARELLI LAURA Sez. 29 nata il 01/05/1974 a CERCOLA (NA) VIA MICCO N. 12 303 AURIEMMA GIUSEPPINA Sez. 2 nata il 03/01/1970 a NAPOLI (NA) VIA S.MARIA DEL POZZO N. 155 402 BIANCO GIUSEPPINA Sez. 21 nata il 10/06/1982 a NAPOLI (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE N. 11 571 CAPUANO MARIAROSARIA Sez. 24 nata il 30/06/1974 a NAPOLI (NA) VIA COSTANTINOPOLI N. 32 648 CAU NADIA Sez. 4 nata il 07/10/1983 a NAPOLI (NA) VIA COL. GAETANO ALIPERTA N. 9 676 CERCIELLO ESTER Sez. 11 nata il 31/10/1983 a NAPOLI (NA) VIA MARIGLIANO N. 17/A 686 CERCIELLO IMMACOLATA Sez. 6 nata il 30/04/1973 a NAPOLI (NA) VIA MERCATO VECCHIO N. 85 687 CERCIELLO LAURA Sez. 27 nata il 05/03/1983 a OTTAVIANO (NA) VIA MALATESTA N. 11 P. T 693 CERCIELLO MARIA GRAZIA Sez. 20 nata il 24/01/1952 a SOMMA VESUVIANA (NA) VIA PIZZONE CASSANTE N. 12 694 CERCIELLO MICHELA Sez. 18 nata il 16/02/1974 a TORRE DEL GRECO (NA) CORSO ITALIA N. 3 Citta' di SOMMA VESUVIANA Provincia di NAPOLI Numero Pag. -

Ambito Territoriale N26 Graduatoria Provvisoria Manifestazione D’Interesse Di Cui Al D
COMUNE DI POGGIOMARINO - c_g762 - 0015050 - Ingresso - 16/06/2020 - 11:48 AMBITO TERRITORIALE N26 GRADUATORIA PROVVISORIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DI CUI AL D. REGIONE CAMPANIA N. 232/2020 PER L’EROGAZIONE DI UN BONUS IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ ANCHE NON GRAVE, CON PRIORITÀ AI BAMBINI CON DISABILITÀ (ANCHE AUTISTICA) IN ETÀ SCOLARE A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALLA PRIORITA' 9 IV DEL POR CAMPANIA FSE 2014/2020 DOMANDE AMMESSE Comune che ha trasmesso N. N. e data protocollo istanza istanza 1 12579 del 18/05/2020 POGGIOMARINO 2 13223 del 25/05/2020 POGGIOMARINO 3 14774 del 19.05.2020 TERZIGNO 4 12926 del 21/05/2020 POGGIOMARINO 5 20006 del 14/05/2020 SAN GIUSEPPE VESUVIANO 6 12716 del 22/05/2020 OTTAVIANO 7 13030 del 22/05/2020 POGGIOMARINO 8 13295 del 25/05/2020 POGGIOMARINO 9 14085 del 12.05.2020 TERZIGNO 10 21051 del 25/05/2020 SAN GIUSEPPE VESUVIANO 11 14958 del 20.05.2020 TERZIGNO 12 20591 del 20/05/2020 SAN GIUSEPPE VESUVIANO 13 12584 del 20/05/2020 OTTAVIANO 14 7525 del 14/05/2020 SAN GENNARO VESUVIANO 15 12718 del 22/05/2020 OTTAVIANO 16 20996 del 25/05/2020 SAN GIUSEPPE VESUVIANO 17 13247 del 25/05/2020 POGGIOMARINO 18 13194 del 25/05/2020 POGGIOMARINO 19 21017 del 25/05/2020 SAN GIUSEPPE VESUVIANO 20 7424 del 12/05/2020 SAN GENNARO VESUVIANO 21 7785 del 20/05/2020 SAN GENNARO VESUVIANO 22 13211 del 25/05/2020 POGGIOMARINO 23 20025del 14/05/2020 SAN GIUSEPPE VESUVIANO 24 20904 del 22/05/2020 SAN GIUSEPPE VESUVIANO 25 12206 del 13/05/2020 POGGIOMARINO 26 12565 del 18/05/2020 POGGIOMARINO 27 7616 del 15/05/2020 SAN -

Comune Di Somma Vesuviana (Napoli) Voucher Farmaceutici - Vii Edizione Graduatoria Beneficiari Ammessi
COMUNE DI SOMMA VESUVIANA (NAPOLI) VOUCHER FARMACEUTICI - VII EDIZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI AMMESSI N. COGNOME NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA PUNTEGGIO 1 P. M. 29/10/1979 Napoli 11 2 B. F. 26/03/1977 Napoli 11 3 S. C. 21/11/1981 Napoli 11 4 S. R. 18/08/1987 Somma Vesuviana 11 5 F. A. 23/03/1956 Pimonte 11 6 R. N. 01/01/1972 Marocco 11 7 D. L. A. 17/10/1975 Napoli 11 8 M. A. 24/10/1964 Marigliano 11 9 R. P. 17/11/1976 Napoli 11 10 D. S. M. 16/09/1981 Napoli 11 11 M. A. 06/06/1983 Napoli 11 12 P. R. 21/11/1990 Torre del Greco 11 13 F. B. 24/03/1975 Napoli 11 14 C. A. M. 13/06/1980 San Giuseppe Vesuviano 11 15 D. M. I. 30/05/1969 Napoli 11 16 M. E. 08/09/1991 Ottaviano 11 17 C. R. 02/01/1984 S.Felice a Cancello 11 18 M. L. 06/01/1963 Cercola 11 19 B. R. 14/04/1971 Napoli 11 20 Z. L. 15/05/1983 Napoli 11 21 S. V. 03/05/1974 San Giuseppe Vesuviano 11 22 B. G. 03/10/1981 Napoli 11 23 M. G. 11/10/1989 Napoli 11 24 E. A. 22/07/1973 Roma 11 25 A. A. 01/01/1969 Somma Vesuviana 11 26 C. M. 07/10/1979 San Giuseppe Vesuviano 11 27 V. A. 20/09/1979 Napoli 11 28 B. A. 29/12/1992 Pollena Trocchia 11 29 D. -

Service Charter of the National Antiquarium
SPECIAL SUPERINTENDENCY FOR THE ARCHAEOLOGICAL HERITAGE OF NAPLES AND POMPEII SERVICE CHARTER OF THE NATIONAL ANTIQUARIUM ‘Man and Environment in the Vesuvian Area’ AND OF THE ARCHAEOLOGICAL AREA OF VILLA REGINA IN BOSCOREALE NATIONAL ANTIQUARIUM OF BOSCOREALE Via Settetermini 15, 80041 Boscoreale Telephone: +39 081 5368796 Fax: +39 081 5368796 E‐mail address: [email protected] Website: www.pompeiisites.org PRESENTATION WHAT IS THE SERVICE CHARTER The Service Charter establishes principles and rules governing the relations between the central and local government authorities providing the services and the citizens that use them. The Charter is an agreement between the provider and the users. It is a tool to communicate with and inform users about the services offered, and the procedures and standards set. It also ensures that any commitments are fulfilled, and that any suggestions or complaints may be made by filling out the appropriate forms if necessary. The Service Charter was adopted by the institutes of the Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism as part of a series of initiatives aimed at promoting a greater enhancement of the cultural heritage being preserved, and at meeting the expectations of the users about the organisation of events while respecting the requirements of preservation and research. The Charter will be periodically updated to consolidate the quality levels reached and record any positive changes produced by running improvement projects. Such improvements may also be a result of user feedback. THE PRINCIPLES In performing their institutional activity, the National Antiquarium of Boscoreale and the adjacent Archaeological Area of Villa Regina draw inspiration from the “fundamental principles” set out in the Directive issued by the President of the Council of Ministers on 27th January 1994: Equality and Fairness In providing our services, we are committed to the principle of fairness, ensuring an equality for all citizens regardless of origin, sex, language, religion, or political persuasion. -

Informazioni Personali Nome Emanuela Punzo Indirizzo Abitazione Telefono 081 7881224 – E-Mail [email protected] E
CURRICULUM VITAE La sottoscritta Punzo Emanuela, nata a Napoli, il 03.05.1980, C.F.: PNZ MNL 80E43 F839 N , consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false o mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, e uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, DICHIARA sotto la propria responsabilità, i seguenti stati, fatti e qualità personali: Informazioni personali Nome Emanuela Punzo Indirizzo abitazione Telefono 081 7881224 – E-mail [email protected] [email protected] Nazionalità Italiana Data di nascita 03.05.1980 Esperienza lavorativa attuale: Data 01/12/2017 – ad oggi Committente Comune di Ercolano (NA) Tipo di impiego Istruttore direttivo tecnico - cat. D1 -a tempo pieno e indeterminato, in servizio presso il settore Lavori Pubblici. Principali mansioni e Responsabile del servizio Opere Pubbliche Secondarie responsabilità Titolare di P.O. dal 01/01/2018 ; Data 01/10/2018 – ad oggi Committente Comune di Ercolano (NA) Tipo di impiego Istruttore direttivo tecnico - cat. D1 -a tempo pieno e indeterminato, in servizio presso il settore Lavori Pubblici. Principali mansioni e Responsabile dell’Ufficio Paesaggio – Decreto Sindacale n. 19/2019 responsabilità Data 29/03/2019 – ad oggi Committente Comune di Ercolano (NA) Tipo di impiego Istruttore direttivo tecnico - cat. D1 -a tempo pieno e indeterminato, in servizio presso il settore Lavori Pubblici. Principali mansioni e Responsabile VAS – Decreto Sindacale n. 99/2018 responsabilità Esperienza lavorativa precedente nella Pubblica Amministrazione: Data 02/11/2017 – 30/11/2017 Committente Comune di Somma Vesuviana (NA) Tipo di impiego Istruttore direttivo tecnico - cat. D1 -a tempo pieno e indeterminato, in servizio presso il settore Urbanistica. -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2009
Ufficio del territorio di NAPOLI Data: 22/03/2010 Ora: 10.25.20 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2009 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.- del - n.47 del 27/07/2009 REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 COLLINE DI ROCCARAINOLA E VISCIANO COLLINE LITORANEE DI NAPOLI Comuni di: CASAMARCIANO, ROCCARAINOLA, TUFINO, VISCIANO Comuni di: BACOLI, BOSCOTRECASE, CASORIA, CERCOLA, MONTE DI PROCIDA, NAPOLI, OTTAVIANO, POLLENA TROCCHIA, PORTICI, POZZUOLI, ERCOLANO, SAN GIORGIO A CREMANO, SAN GIUSEPPE VESUVIANO, S SEBASTIANO AL VESUVIO, SANT`ANASTASIA, SOMMA VESUVIANA, TERZIGNO, TORRE DEL GRECO, VOLLA, TRECASE, MASSA DI SOMMA COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) AGRUMETO 83800,00 AGRUMETO IRRIGUO 89100,00 BOSCO CEDUO 5800,00 8900,00 BOSCO D`ALTO FUSTO 11400,00 CASTAGNETO 13300,00 10900,00 FRUTTETO 40000,00 52500,00 SI SI FRUTTETO IRRIGUO 57100,00 71400,00 INCOLTO PRODUTTIVO 2700,00 4600,00 INCOLTO STERILE 2100,00 3000,00 NOCCIOLETO 54200,00 SI SI 54200,00 NOCCIOLETO VIGNETO 47800,00 NOCETO 34900,00 40800,00 Pagina: 1 di 9 Ufficio del territorio di NAPOLI Data: 22/03/2010 Ora: 10.25.20 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2009 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.- del - n.47 del 27/07/2009 REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 COLLINE DI ROCCARAINOLA E VISCIANO COLLINE LITORANEE DI NAPOLI Comuni di: CASAMARCIANO, ROCCARAINOLA, TUFINO, VISCIANO Comuni di: BACOLI, BOSCOTRECASE, CASORIA, CERCOLA, MONTE DI PROCIDA, NAPOLI, OTTAVIANO, POLLENA TROCCHIA, PORTICI, POZZUOLI, ERCOLANO, SAN GIORGIO A CREMANO, SAN GIUSEPPE VESUVIANO, S SEBASTIANO AL VESUVIO, SANT`ANASTASIA, SOMMA VESUVIANA, TERZIGNO, TORRE DEL GRECO, VOLLA, TRECASE, MASSA DI SOMMA COLTURA Valore Sup.