Il Villaggio Della Fine Del Iii Millennio A
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

9. Mobility and Transitions: the South-Central Mediterranean on the Eve of History
Davide Tanasi and Nicholas C. Vella (eds), Site, artefacts and landscape - Prehistoric Borġ in-Nadur, Malta, 251-282 ©2011 Polimetrica International Scientific Publisher Monza/Italy 9. Mobility and transitions: the south-central Mediterranean on the eve of history Nicholas C. Vella – Department of Classics and Archaeology, University of Malta, Malta [email protected] Davide Tanasi – Arcadia University, The College of Global Studies, MCAS, Italy [email protected] Maxine Anastasi – Department of Classics and Archaeology, University of Malta, Malta [email protected] Abstract. This paper reviews the evidence for maritime connections between Malta and Sicily in the second millennium BC and considers their social implications. Since much of what has been written by antiquarians and archaeologists about the islands was often the result of more modern maritime connections and knowledge transfer between local and foreign scholars, we begin by arguing for the relevance of a spatially oriented history of archaeological thought and practice. 9.1. Introduction Mobility is the hallmark of the Bronze and early Iron ages, not only movement of humans across the Mediterranan but with them ideas, beliefs, and ways of doing. The invention of the sail somewhere along the eastern shores of the Middle Sea resulted in what Broodbank has called ‘the shrinkage of the Mediterranean’, a process which brought easterners ever closer to the islands and coastal regions of the centre of that sea from about the mid-second 252 Nicholas C. Vella, Davide Tanasi, Maxine Anastasi millennium BC1. This is not to say that mobility did not occur in earlier periods in prehistory: the obsidian exchange system tells us much about movement in the Neolithic2 whereas the phenomenon related to the distribution of Beaker pottery during the Chalcolithic/Early Bronze Age is now being explained in part by reference to a structured interaction involving small-scale population movements between regions3. -

Sicily Before the Greeks. the Interaction with Aegean and the Levant in the Pre-Colonial Era
Open Archaeology 2020; 6: 172–205 Review Article Davide Tanasi* Sicily Before the Greeks. The Interaction with Aegean and the Levant in the Pre-colonial Era https://doi.org/10.1515/opar-2020-0107 received April 17, 2020; accepted July 1, 2020. Abstract: The relationship between Sicily and the eastern Mediterranean – namely Aegean, Cyprus and the Levant – represents one of the most intriguing facets of the prehistory of the island. The frequent and periodical contact with foreign cultures were a trigger for a gradual process of socio-political evolution of the indigenous community. Such relationship, already in inception during the Neolithic and the Copper Age, grew into a cultural phenomenon ruled by complex dynamics and multiple variables that ranged from the Mid-3rd to the end of the 2nd millennium BCE. In over 1,500 years, a very large quantity of Aegean and Levantine type materials have been identified in Sicily alongside with example of unusual local material culture traditionally interpreted as resulting from external influence. To summarize all the evidence during such long period and critically address it in order to attempt historical reconstructions is a Herculean labor. Twenty years after Sebastiano Tusa embraced this challenge for the first time, this paper takes stock on two decades of new discoveries and research reassessing a vast amount of literature, mostly published in Italian and in regional journals, while also address the outcomes of new archaeometric studies. The in-depth survey offers a new perspective of general trends in this East-West relationship which conditioned the subsequent events of the Greek and Phoenician colonization of Sicily. -

Campania/Rv Schoder. Sj
CAMPANIA/R.V. SCHODER. S. J. RAYMOND V. SCHODER, S.J. (1916-1987) Classical Studies Department SLIDE COLLECTION OF CAMPANIA Prepared by: Laszlo Sulyok Ace. No. 89-15 Computer Name: CAMPANIA.SCH 1 Metal Box Location: Room 209/ The following slides of Campanian Art are from the collection of Raymond V. Schader, S.J. They are arranged alpha-numerically in the order in which they were received at the archives. The notes in the inventory were copied verbatim from Schader's own citations on the slides. CAUTION: This collection may include commercially produced slides which may only be reproduced with the owner's permission. I. PHELGRAEA, Nisis, Misenum, Procida (bk), Baiae bay, fr. Pausilp 2. A VERNUS: gen., w. Baiae thru gap 3. A VERNUS: gen., w. Misenum byd. 4. A VERN US: crater 5. A VERN US: crater 6. A VERNUS: crater in!. 7. AVERNUS: E edge, w. Baths, Mt. Nuovo 1538 8. A VERNUS: Tunnel twd. Lucrinus: middle 9. A VERNUS: Tunnel twd. Lucrinus: stairs at middle exit fl .. 10. A VERNUS: Tunnel twd. Lucr.: stairs to II. A VERNUS: Tunnel twd. Lucrinus: inner room (Off. quarters?) 12. BAIAE CASTLE, c. 1540, by Dom Pedro of Toledo; fr. Pozz. bay 13. BAIAE: Span. 18c. castle on Caesar Villa site, Capri 14. BAIAE: Gen. E close, tel. 15. BAIAE: Gen. E across bay 16. BAIAE: terrace arch, stucco 17. BAIAE: terraces from below 18. BAIAE: terraces arcade 19. BAIAE: terraces gen. from below 20. BAIAE: Terraces close 21. BAIAE: Bay twd. Lucrinus; Vesp. Villa 22. BAIAE: Palaestra(square), 'T. -

Relations Between Greek Settlers and Indigenous Sicilians at Megara Hyblaea, Syracuse, and Leontinoi in the 8Th and 7Th Centuries BCE
It’s Complicated: Relations Between Greek Settlers and Indigenous Sicilians at Megara Hyblaea, Syracuse, and Leontinoi in the 8th and 7th Centuries BCE Aaron Sterngass Professors Farmer, Edmonds, Kitroeff, and Hayton A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for a Degree of Bachelor of Arts in the Departments of Classical Studies and History at Haverford College May 2019 i Table of Contents Table of Contents ................................................................................................................................ i Acknowledgements........................................................................................................................... iii Abstract ............................................................................................................................................ iv I. INTRODUCTION ............................................................................................................................... 1 II. BACKGROUND INFORMATION PRE-750 BCE .................................................................................... 2 Greece ....................................................................................................................................................... 2 Euboea ...................................................................................................................................................... 4 Corinth ..................................................................................................................................................... -

Bridging the Gap. New Data on the Relationship Between Sicily, The
University of South Florida Scholar Commons History Faculty Publications History 2010 Bridging the Gap. New Data on the Relationship between Sicily, the Maltese Archipelago and the Aegean in the Middle Bronze Age Davide Tanasi University of South Florida, [email protected] Follow this and additional works at: http://scholarcommons.usf.edu/hty_facpub Scholar Commons Citation Tanasi, Davide, "Bridging the Gap. New Data on the Relationship between Sicily, the Maltese Archipelago and the Aegean in the Middle Bronze Age" (2010). History Faculty Publications. 32. http://scholarcommons.usf.edu/hty_facpub/32 This Article is brought to you for free and open access by the History at Scholar Commons. It has been accepted for inclusion in History Faculty Publications by an authorized administrator of Scholar Commons. For more information, please contact [email protected]. MARE INTERNUM ARCHEOLOGIA E CULTURE DEL MEDITERRANEO An International, Yearly and Peer-Reviewed Journal * Direttore Nicola Bonacasa Comitato scientifico Mostafa el-Abbadi · Saleh R. Agab Abdalha Anthony Bonanno · Mounir Bouchenaki Francesco D’Andria · Antonino Di Vita Mhamed H. Fantar · Vassos Karageorghis Vincenzo La Rosa · Marc Mayer i Olivé Dimitrios Pandermalis · François Queyrel Donald White Redazione Antonella Mandruzzato * Centro di Ricerca per l’Archeologia del Mediterraneo, Dipartimento di Beni Culturali, Sezione Archeologica, Facoltà di Lettere, Viale delle Scienze (Edificio 12), Università degli Studi, I 90128 Palermo, tel. +39 091 6560267/264, fax +39 091 6560289, [email protected] MARE INTERNUM ARCHEOLOGIA E CULTURE DEL MEDITERRANEO 2 · 2010 PISA · ROMA FABRIZIO SERRA EDITORE MMX Amministrazione e abbonamenti Fabrizio Serra editore® Casella postale n. 1, succursale n. 8, I 56123 Pisa, tel. -

Archaeological Data on the Foundation of Megara Hyblaea. Certainties and Hypotheses Henri Treziny
Archaeological data on the foundation of Megara Hyblaea. Certainties and hypotheses Henri Treziny To cite this version: Henri Treziny. Archaeological data on the foundation of Megara Hyblaea. Certainties and hypotheses . DONNELAN L.; NIZZO V.; BURGERS G.-J. Conceptualising early Colonisation, Brepols, pp.167- 178, 2016, 978-90-74461-82-5. halshs-01434820 HAL Id: halshs-01434820 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01434820 Submitted on 13 Jan 2017 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. C onceptualising early Colonisation L ieve Donnellan, ed. Valentino Nizzo Gert-Jan Burgers B ruxelles - Brussel - Roma Belgisch Historisch Instituut te Rome Institut Historique Belge de Rome Istituto Storico Belga di Roma 2016 98110_Donnellan_voorwerk.indd 3 17/03/16 09:45 © 2016 IHBR - BHIR No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the copyright owner. D/2016/351/2 ISBN 978-90-74461-82-5 98110_Donnellan_voorwerk.indd 4 17/03/16 09:45 Table of content Acknowledgments ............................................................................................................................... 7 L. Donnellan & V. Nizzo, Conceptualising early Greek colonisation. Introduction to the volume .. -

Stanford Excavations at Monte Polizzo, Sicily
Stanford Excavations at Monte Polizzo, Sicily Project handbook 4th edition, 2004 Table of Contents 1 Introduction (PDF Document) 1.1 The purpose of the handbook 1.2 Contact information (important!) 1.3 Timetable 2 Safety (PDF Document) 2.1 General concerns 2.2 Hygiene 2.3 Consideration 3 Maps and plans- Part I (PDF Document) 3 Maps and plans - Part II (PDF Document) 4 Project aims (PDF Document) 5 A very brief history of Sicily (PDF Document) 5.1 Earliest prehistory 5.2 Bronze Age Sicily 5.3 Colonial/archaic Sicily 5.4 Classical Sicily 5.5 Hellenistic and Roman Sicily 5.6 The end of the Roman Empire 5.7 Medieval Sicily 5.8 Modern Sicily 6 The excavation so far (PDF Document) 6.1 Project history 3.2 Summary of results (2000-2003) and goals for 2004 7 Excavation Part I (PDF Document) 7.1 Teaching goals 7.2 Digging 2.1 Site formation processes 2.2 Stratigraphy 2.3 Organization 2.4 Tools 2.5 Sampling 2.6 Interpretation Part II (PDF Document) 7.3 Recording 3.1 Introduction 3.2 Recording sheets 3.3 Notebooks Part III (PDF Document) 3.4 Profiles 3.5 Plans 3.6 Elevations 3.7 Triangulation 3.8 The Harris matrix 3.9 Working with Total Stations 3.10 Photography Part IV (PDF Document) 7.4 On-site finds handling 7.5 Schedule 5.1 Calendar 5.2 Daily schedule 7.6 Project staff 7.7 Organizational structure 8 The lab (PDF Document) 8.1 Finds processing 8.2 Finds from Monte Polizzo 9 Preparation for publication (PDF Document) 10 Practical matters (PDF Document) 11 Glossary of archaeological terms (PDF Document) 12 Bibliography (PDF Document) 13 Recording sheets (PDF Document) 14 Harris matrices (PDF Document) 14.1 A1-A4 area 1.1 Key 1.2 Reverse key 14.2 A5 area 2.1 Key 2.2 Reverse key Illustrations Artifact 2423, an incised dipper found in place on the bedrock in area A1/4, sealed by layer A1.111. -
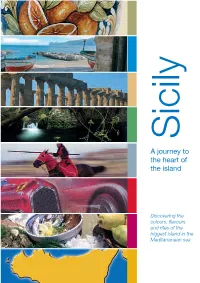
A Journey to the Heart of the Island
Sicily A journey to the heart of the island Discovering the colours, flavours and rites of the biggest island in the Mediterranean sea Regione Siciliana POR Sicilia UNIONE EUROPEA Assessorato Turismo, 2000-2006 Fondo Europeo Trasporti e Comunicazioni Misura 4.18 a/b Sviluppo Regionale www.regione.sicilia.it/turismo A journeySicily to the heart of the island Discovering the colours, flavours and rites of the biggest island in the Mediterranean sea index Knowing Sicily A paradise made of sea and sun island Treasure oasi Green pag 04 pag 12 pag 22 pag 54 Language ......................... 6 Among shores, The early settlements ..... 24 Regional parks ............... 56 cliffs and beaches .......... 14 Documents and Exchange . 6 The Greek domination .... 26 Reserves and The fishing villages, the protected areas .............. 58 The weather and what The Roman civilization ... 32 fishing tourism and wearing ............................ 6 The Arab-Norman period .. 34 Outdoor sports................ 60 the sea cooking .............. 16 Festivities ......................... 7 Frederick II and the Country tourism Minor Islands and marine Swabians ....................... 38 and baths ...................... 62 Trasportation .................... 7 protected areas: a paradise Medieval Sicily ............... 42 Roads ............................... 8 for diving and snorkelling .. 18 The explosion of Emergency numbers ........ 8 Marina Charters, tourist 02 harbours and the Baroque..................... 45 Geography ........................ 8 aquatic sports ................. 20 Bourbon’s age ................ 48 History ............................ 10 The Florio’s splendour .... 50 The museums ................ 52 The memory of the Island An island opened all the year Master in hosting Maps of the provinces pag 64 pag 76 pag 86 pag 100 The non-material Religious celebrations .... 78 The routes of wine ......... 88 Palermo ........................ 102 heritage register ............. 66 Theatre and Gastronomy ................... -

Sicily (Sicilia)
Sicily (Sicilia) General Sicily (Italian: Sicilia) is an autonomous region of Italy, in Southern Italy along with surrounding minor islands, officially referred to as Regione Siciliana. Sicily is located in the central Mediterranean Sea, south of the Italian Peninsula, from which it is separated by the narrow Strait of Messina. Its most prominent landmark is Mount Etna, the tallest active volcano in Europe, and one of the most active in the world, currently 3,329 m (10,922 ft.) high. The island has a typical Mediterranean climate. Administrative Divisions Administratively, Sicily is divided into 9 administrative provinces, each with a capital city of the same name as the province. The areas and populations of these provinces are: Province of Agrigento ......................................... 3,042 km2 ....... pop. 453,594 Province of Caltanissetta .................................... 2,128 km2 ....... pop. 271,168 Province of Catania ............................................ 3,552 km2 .... pop. 1,090,620 Province of Enna ................................................ 2,562 km2 ....... pop. 172,159 Province of Messina ........................................... 3,247 km2 ....... pop. 652,742 Province of Palermo ........................................... 4,992 km2 .... pop. 1,249,744 Province of Ragusa ............................................ 1,614 km2 ....... pop. 318,980 Province of Siracusa ........................................... 2,109 km2 ....... pop. 403,559 Province of Trapani ............................................. 2,460 km2 ....... pop. 436,240 The City of Palermo is the Capital City of the region Small surrounding islands are also part of various Sicilian provinces: Aeolian Islands (Messina), The isle of Ustica (Palermo), Aegadian Islands (Trapani), The isle of Pantelleria (Trapani) and Pelagian Islands (Agrigento). Geography Sicily is the largest island in the Mediterranean Sea. It has a roughly triangular shape, earning it the name Trinacria. -

Akhaian Late Geometric and Archaic Pottery in South Italy and Sicily
HESPERIA 70 (200I) MAG N A AC H A E A Pages373-46° AKHAIANLATE GEOMETRIC ANDARCHAIC POTTERY IN SOUTHITALY AND SICILY In memoryofEmilyToionsend ABSTRACT Vermeule ImportedAkhaian and locallyproduced Akhaian-style pottery occurs in SouthItaly, Sicily, and beyond, found not only in the Akhaianapoikiai, but also in other settlements.The most characteristicAkhaian shape the kantharos is discussedwithinthe contextof its homeregion, including Elis. Examplesof ArchaicAkhaian pottery in theWest are assembled and the dis- tributionis comparedto thatof Akhaianand West Greek imports in the Late BronzeAge. A patternemerges that suggests a complexreality of interaction andmovement of people,commodities, and ideas between Greece and Italy in the pre- and protohistoricperiods, thus contributingto a betterunder- standingof the firstwestern Greeks. AIMSAND SCOPE OF THE STUDY Thispaper emerged from a studyof thepottery from the site at Francavilla Marittima,the extramuralsanctuary of theAkhaian apoikia of Sybarison the siteof an earlierindigenous settlement (Fig. 1).1 In dealingwith the potteryfrom the sanctuaryon the Timponedella Motta (see below),I discovereda largenumber of plainbanded and monochrome kantharoi, manyof whichwere locally produced, either in the plainof Sybarisor elsewherein SouthItaly, while others were imported. These are not iso- latedexamples, but together form one of themost numerous categories of potteryafter Corinthian. In shapeand style, these kantharoi are closest to a seriesof vesselsfrom various sites in the northwestPeloponnese, par- ticularlyAkhaia. Despite the factthat Sybaris was traditionally founded by Akhaians,the Peloponnesiancharacter of thismaterial has not previ- ouslybeen recognized in studiesof Greekpottery in SouthItaly and Sic- ily.The relevantmaterial from Francavilla will be fullypublished else- where.Comparative material from other sites in SouthItaly and Sicily formsthe basisof this article,the aimof whichis to track,as faras is 1. -

Achaean Colonial Pottery Production Between 8 and 6Th Century BC* I Will Briefly Summarize Part Of
Material koinai in the West: Achaean colonial indications on urban structures during these pottery production between 8th and 6th initial periods. Traces of the archaic city have century BC been found in several areas of Sybaris, but the information that we have about the I will briefly summarize part of a wider spatial organization of the settlement are research conducted on colonial pottery still very lacking. 3 Rescue excavations coming from Sybaris, Kroton and Kaulonía conducted in Kroton during the last thirty and dated between the second half of the 8th years, especially in the southern part of the and the end of the 6th centuries BC.1 modern city, allow us to reconstruct the In archaeological terms, we know very little sketch of a urban plan designed since the about the phases of birth and growth of end of the 7th century BC, as the dislocation these three colonial centers, due to the of the necropolis that will be maintained paucity of excavations that have reached the during all the life of the city seems to oldest levels or to the lack of published data, confirm.4 We know of the existence of walls while historiographical sources concentrate and roads starting from the second half of their attention on the aitia and chronologies the seventh century BC in Kaulonía, together of foundation and on the wars of the 6th with a clear functional definition of the century BC. So there is a vacuum essentially different parts of the city attested by the for the 7th century BC, namely a crucial distribution of houses and sacred spaces.5 period of development in which the colonies In this situation, pottery studies are one of try to reach their complete individual the principal sources to refer to try to appearance.2 Archaeological data give more reconstruct the first two centuries of life of first generation Achaean colonies. -

(2017) Sicily Without Mycenae: a Cross-Cultural Consumption Analysis of Connectivity in the Bronze Age Central Mediterranean
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Enlighten: Publications Russell, A. (2017) Sicily without Mycenae: a cross-cultural consumption analysis of connectivity in the Bronze Age Central Mediterranean. Journal of Mediterranean Archaeology, 30(1), pp. 59-83. (doi:10.1558/jmea.32914) This is the author’s final accepted version. There may be differences between this version and the published version. You are advised to consult the publisher’s version if you wish to cite from it. http://eprints.gla.ac.uk/143971/ Deposited on: 26 July 2017 Enlighten – Research publications by members of the University of Glasgow http://eprints.gla.ac.uk Sicily without Mycenae: A Cross-Cultural Consumption Analysis of Connectivity in the Bronze Age Central Mediterranean Anthony Russell Affiliate Researcher, Archaeology, Department of Humanities, University of Glasgow, Glasgow G12 8QQ, Scotland, UK e-mail: [email protected] Abstract During the Middle Bronze Age in Sicily, there is evidence for material contact with several extra-insular societies, not least with the contemporary Mycenaean culture based in the Aegean. This Mycenaean connection typically receives the most attention, and has been used as the basis to posit the broad acculturation of Sicilian society to Aegean norms, despite a rather limited amount of evidence. To complement the empirical data of genuine imports, interpretations of Aegean influence have also been applied to Sicilian material expressions. In this study, I argue that such acculturation frameworks are too limited to analyse properly the material changes that occur in Sicily, as they rely heavily on the uncertain physical presence of ‘Mycenaeans’ on the island, and do not engage with Sicilian agency or motivations.