Abstract Sessioni Parallele
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Problems in Translating Pessoa's Poetry Into English
Problems in translating Pessoa’s poetry into English John Pedro Schwartz* Keywords Translation, Rhyme, Meter, Personal infinitive, Verb tense. Abstract This paper focuses on five problems all translators of Fernando Pessoa’s poetry into English must grapple with. The first is whether or not to distinguish the poetry of Pessoa (orthonym), Álvaro de Campos, Alberto Caeiro and Ricardo Reis through the use of stylistic and lexical markers. The second is: to what degree should the translator imitate Pessoa’s occasional labyrinthine constructions? Third, every translator must decide at the outset whether or not to use rhyme and meter, where these occur in Pessoa’s poetry. The final two problems concern Portuguese grammar: how to translate the pretérito perfeito do indicativo [simple past tense], which lends itself in English to both simple past and present perfect tenses; and how to translate the personal infinitive, a form unique among all languages for handling a change in subject within a sentence. Palavras-chave Tradução, Rima, Métrica, Infinitivo pessoal, Tempo verbal. Resumo Este artigo foca-se nos cinco problemas com os quais qualquer tradutor da poesia pessoana tem de batalhar quando traduz para inglês. O primeiro é distinguir ou não a poesia de Pessoa (ortónimo), da de Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis através de indicações estilísticas e lexicais. O segundo é até que ponto o tradutor deve imitar as construções labirínticas ocasionais. Terceiro, o tradutor tem de decidir no início se deve usar rima e métrica ou não, quando e onde estas ocorram na poesia de Pessoa. Os dois problemas finais referem-se à gramática portuguesa: como traduzir o pretérito perfeito do indicativo, que em inglês empresta-se ambos ao simple past tense e ao present perfect tense; e como traduzir o infinitivo pessoal, uma forma única de todos os idiomas para lidar com uma mudança de sujeito dentro de uma frase. -

Introduction
Introduction Cindy Stanphill, Editor-in-Chief La logica dell’engagement […] parte dalla certezza che la propria coscienza politico- letteraria del presente è il prin- cipio da cui dedurre un solo modo storicamente corretto di risolvere il rapporto fra realtà sociale, imperativi politici, forme letterarie.1 Alfonso Berardinelli Oggi, in genere, quando si parla di ‘letteratura impegnata’ ci se ne fa un’idea sbagliata, come di una letteratura che serve da illustrazione a una tesi già definita a priori, indip- endentemente dall’espressione poetica. Invece, quello che si chiamava l’‘engagement’, l’impegno, può saltar fuori a tutti i livelli; qui vuole innanzitutto essere immagini e parola, scatto, piglio, stile, sprezzatura, sfida.2 Italo Calvino Parallel to the littérature engagée of André Gide, Jean-Paul Sartre, and Albert Camus during the interwar and post-WWII period in French letters, Italian letteratura impegnata reflecting the country’s rich, mul- ticultural literary and political tradition emerged in tandem. Today, renewed interest in the concept of impegno in literature reconnects with that tradition in Jennifer Burn’s recent Fragments of impegno: Interpreta- tions of Commitment in Contemporary Italian Narrative 1980-2000. Here Burns traces the development of various political commitments in Italian literary history, from the early debates on committed literature in the works of Elio Vittorini, Italo Calvino and Pier Paolo Pasolini to contemporary texts by authors such as Antonio Tabucchi and Fabrizia Ramondino.3 Her innovative examination linking canonical texts of impegno to contemporary writers has sparked fresh consideration of the Italian letteratura impegnata at the cusp of the twenty-first century. -

The RUTGERS LIBRETTO Newsletter of the Italian Department IV N
RUTGERS DEPARTMENT OF ITALIAN SPRING 2015 The RUTGERS LIBRETTO Newsletter of the Italian Department IV n. 1 Letter from the Chair TABLE OF CONTENTS am delighted to report that the Italian front cover I FROM THE CHAIR Department at Rutgers is in excellent shape, Paola Gambarota in spite of the recent ups and downs of the 2 HIGHLIGHTS Humanities in the US. We just celebrated the Sheri La Macchia & graduation of 21 seniors, out of 46 majors, during Carmela Scala a joyful evening attended by 74 people. Three 4 UNDERGRADUATE NEWS ABOVE: Paola Gambarota among our seniors completed an honors thesis. & ITALIAN NIGHT We were very impressed when students attending Prof. Rhiannon Welch’s senior 6 LECTURES & IGS seminar organized a two-day conference on the topic of “New and Old Italian 8 RUTGERS DAY Identities,” demonstrating a strong commitment to explore timely issues of 10 GRADUATE NEWS citizenship and immigration. One of these students, Nicoletta Romano, continued to study these questions with the support of the Lloyd Gardner Fellowship Program 12 ALUMNI REUNION & NEWS in Leadership and Social Policy, under the guidance of Professor Welch. Another 16 FACULTY NEWS Italian major, Mihaela Sanderson, was selected as the author of the “Best Poster” for back cover the Humanities portion of the Aresty Symposium, the result of a research project DEPARTMENT INITIATIVES developed with the support of her mentor Prof. Andrea Baldi. This is the second consecutive time that a student majoring in Italian is recognized in this way. There have been some changes in our department, and we miss our former friends and colleagues, our beloved Carol Feinberg, our kindhearted Robin Rogers, and our former language coordinator Daniele de Feo. -

Language and Monstrosity in the Literary Fantastic
‘Impossible Tales’: Language and Monstrosity in the Literary Fantastic Irene Bulla Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2018 © 2018 Irene Bulla All rights reserved ABSTRACT ‘Impossible Tales’: Language and Monstrosity in the Literary Fantastic Irene Bulla This dissertation analyzes the ways in which monstrosity is articulated in fantastic literature, a genre or mode that is inherently devoted to the challenge of representing the unrepresentable. Through the readings of a number of nineteenth-century texts and the analysis of the fiction of two twentieth-century writers (H. P. Lovecraft and Tommaso Landolfi), I show how the intersection of the monstrous theme with the fantastic literary mode forces us to consider how a third term, that of language, intervenes in many guises in the negotiation of the relationship between humanity and monstrosity. I argue that fantastic texts engage with monstrosity as a linguistic problem, using it to explore the limits of discourse and constructing through it a specific language for the indescribable. The monster is framed as a bizarre, uninterpretable sign, whose disruptive presence in the text hints towards a critique of overconfident rational constructions of ‘reality’ and the self. The dissertation is divided into three main sections. The first reconstructs the critical debate surrounding fantastic literature – a decades-long effort of definition modeling the same tension staged by the literary fantastic; the second offers a focused reading of three short stories from the second half of the nineteenth century (“What Was It?,” 1859, by Fitz-James O’Brien, the second version of “Le Horla,” 1887, by Guy de Maupassant, and “The Damned Thing,” 1893, by Ambrose Bierce) in light of the organizing principle of apophasis; the last section investigates the notion of monstrous language in the fiction of H. -

Agazzoni, Debora (2017) Syntax and Style in Alberto Arbasino's Early Works (1957-1963)
Agazzoni, Debora (2017) Syntax and style in Alberto Arbasino's early works (1957-1963). PhD thesis. http://theses.gla.ac.uk/8122/ Copyright and moral rights for this work are retained by the author A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge This work cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the author The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the author When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given Enlighten:Theses http://theses.gla.ac.uk/ [email protected] Syntax and Style in Alberto Arbasino’s Early Works (1957-1963) Debora Agazzoni Submitted in fulfilment of the requirements for the Degree of PhD School of Modern Languages and Cultures College of Arts University of Glasgow January 2017 3 Abstract This thesis examines the syntax of the sentence and the style of three of Alberto Arbasino’s early works: Le piccole vacanze (1957), Il ragazzo perduto (1959) and Fratelli d’Italia (1963). The period in which these works were written and published was one of great linguistic changes, with Italian starting to become the language spoken by the majority of the population and the consequent formation of a new variety, the italiano dell’uso medio. This social evolution has also consequences for the language of narrative: whereas some authors embrace the lingua media and a clear, communicative style (stile semplice), others reject it and opt for linguistic experimentation. -

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA 1986-87 a Cura Di Anthony Verna
RASSEGNA BIBLIOGRAFICA 1986-87 a cura di Anthony Verna - 139- COMPILATORI E COLLABORATORI Raffaele Aufiero Diana Iuele-Colilli Roma University of Toronto Salvatore Bancheri Michael Lettieri University of Toronto University of Toronto Paul Colilli Rachele Longo-Lavorato Laurentian University, University of Toronto Sudbury Bruno Magliocchetti Marcel Danesi University of Toronto University of Toronto Nicole Prunster Diane Dyer La Trobe University, McMaster University, Victoria (Australia) Hamilton Manuela Scarci Antonio Fama University of Toronto University of Waterloo, Waterloo Anne Urbancic University of Toronto Corrardo Federici Brock University, Enrico Vicentini St. Catharines University of Toronto Francesco Guardiani University of Toronto - 140 - PERIODICI LISTA DEGLI ACRONIMI PER ORDINE ALFABETICO 1) AA American Anthropologist 2) AANL Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti della Classe di Scienze Morali, Storiche, e Filologiche 3) AAST Atti dell' Accademia di Scienze di Torino 4) Aba Antologia di belle arti 5) ABI Accademie e Biblioteche d'Italia 6) Ac Acme: Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia 7) AdI Annali d'Italianistica 8) Aev Aevum: Rassegna di Scienze Storiche, Linguistiche, Filologiche 9) Ag Agenda 10) AGI Archivio Glottologico Italiano 11) AHSI Archivum Historicum Societatis Iesu 12) AION Annali Istituto Universitario Orientale (Napoli) Sezione Romanza 13) AIV Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Venezia. Classe di Scienze morali e lettere 14) ALASH Acta Linguistica Academiae Scientiarum -

{Dоwnlоаd/Rеаd PDF Bооk} the Place (Italian) Kindle
THE PLACE (ITALIAN) Author: Gary M Douglas Number of Pages: 164 pages Published Date: 15 Sep 2014 Publisher: Access Consciousness Publishing Company Publication Country: none Language: Italian ISBN: 9781939261939 DOWNLOAD: THE PLACE (ITALIAN) The Place (Italian) PDF Book In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. ), Saint Cyprian (Bishop of Carthage. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such historical works. Protagonista assoluto della storia è l'irresistibile burattino dal naso lungo, nel difficile tentativo di superare mille difficoltà e trasformarsi in un bambino vero. Das Standardwerk ein Muss für jeden, der Italien und seine Küche liebt. The Place (Italian) Writer Nuova edizione aggiornata. Da leggere ai propri figli nei momenti di più profonda intimità e amorevole vicinanza. Pietro Sino Ai Nostri Giorni. B 1. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. O conosci qualcuno che è stato nel peggior scenario. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. Immagina una vita in cui amate il modo in cui si guarda e si sente. -

Quaderni D'italianistica : Revue Officielle De La Société Canadienne
Recensioni L'Europa che comincia efinisce: la Sicilia, a cura di Dagmar Reichardt. Italien in Geschichte und Gegenwart, 25. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2006. Pp. 446, illus. ISBN 978-3-631-54941-4. €60.70, £42.50, US $72.95 Alla Sicilia come oggetto di studio non mancano pubblicazioni di tipo svariatissi- mo: teorici, storici, letterari, sociologici, e via dicendo. Il libro qui recensito pre- senta alcune diversità rispetto ai lavori già pubblicati. Prima di tutto, è frutto di collaborazione di 33 studiosi e studiose di 12 paesi diversi che scrivono in italiano, in inglese o in tedesco; secondariamente, il contenuto accosta alla critica letteraria la medicina, la politologia, la sociologia, la didattica disciplinare, la storia e le scienze dell'informazione, del teatro e della cultura. Inoltre, come scrive la cura- trice nella Premessa, "Con la presente raccolta di saggi s'intende promuovere una visione della Sicilia come un terzo spazio trasnazionale..." e si vuole contribuire alla realizzazione di "un progetto di una mappa mentale della sicilianità (9). Il volume viene suddiviso in cinque sezioni tematiche; ogni saggio è seguito da una bibliografìa e da un riassunto nelle tre lingue. La prima sezione {Storia-Società-Scrittura) conta sei saggi. Michael Bernsen apporta ulteriori dimostrazioni al fatto che i poeti siciliani, con il sonetto, non can- tano la donna ma analizzano il sentimento dell'amore ("Die Entstehung des lyrischen Subjekts in der Dichtung Giacomo da Lentinis", 15-24). Pasquale Hamel suggerisce alcune caratteristiche fìlosofìche, morali e politiche che com- promettono la creatività dei poeti siciliani appunto perché condizionati dagli atteggiamenti centralizzanti dell'imperatore ("Federico II e la Scuola Poetica Siciliana come progetto politico", 25-29). -

L'archivio Di Bufalino: Una (Auto) Biografia a Futura Memoria in La
GIULIA CACCIATORE L’archivio di Bufalino: una (auto) biografia a futura memoria In La letteratura italiana e le arti, Atti del XX Congresso dell’ADI - Associazione degli Italianisti (Napoli, 7-10 settembre 2016), a cura di L. Battistini, V. Caputo, M. De Blasi, G. A. Liberti, P. Palomba, V. Panarella, A. Stabile, Roma, Adi editore, 2018 Isbn: 9788890790553 Come citare: Url = http://www.italianisti.it/Atti-di- Congresso?pg=cms&ext=p&cms_codsec=14&cms_codcms=1039 [data consultazione: gg/mm/aaaa] La letteratura italiana e le arti © Adi editore 2018 GIULIA CACCIATORE L’archivio di Bufalino: una (auto) biografia a futura memoria Il contributo si propone di indagare il rapporto dello scrittore Gesualdo Bufalino con le sue carte attraverso l’analisi trasversale del patrimonio da lui donato all’archivio di Comiso. La lettura di alcuni documenti, come le minute redatte per le interviste concesse lungo la sua carriera, rivela come Bufalino abbia messo a disposizione degli studiosi diversi elementi utili a ricostruire la sua precedente (e segreta) attività scrittoria. Lo studio dei documenti, infatti, non solo consente di completare la biografia dello scrittore ma, al contempo, di leggere le sue opere — soprattutto quelle maggiormente legate alla sua storia personale, come ‘Diceria dell’untore’ — attraverso nuove chiavi interpretative che ne modificano, o ampliano, il messaggio complessivo. «… oppure sarà bello passeggiare all’antica nella corte ariosa del vecchio Mercato del pesce, ora adibito a più spirituali mansioni che con la sua fontanella al centro e le loggette d’intorno, fuori da ogni traffico cittadino, rinnova il raccoglimento d’una Villa dei Misteri o d’un minuscolo chiostro…».1 Così Gesualdo Bufalino descriveva i luoghi che oggi accolgono la Fondazione di Comiso a lui intitolata (istituita nel 1999),2 un luogo a lui familiare, eletto a meta quotidiana delle sue passeggiate e dove sovente si recava per consegnare le sue carte, le lettere ricevute, i ritagli di giornale riguardanti le sue opere o le interviste concesse, i suoi libri. -

Tomo Ii Corretto
«GIÀ TROPPE VOLTE ESULI» LETTERATURA DI FRONTIERA E DI ESILIO a cura di Novella di Nunzio e Francesco Ragni Tomo II Università degli studi di Perugia Culture Territori Linguaggi – 3 2014 «GIÀ TROPPE VOLTE ESULI» LETTERATURA DI FRONTIERA E DI ESILIO a cura di Novella di Nunzio e Francesco Ragni Tomo II Università degli Studi di Perugia Indice del tomo II TESTIMONIANZE D’AUTORE DIEGO ZANDEL La mia frontiera…………………………………………………………………...p. 7 IN FUGA DA… ESILIO VOLONTARIO ELISABETH KERTESZ-VIAL Luigi Pirandello dal 1929 al 1935: un improbabile esiliato volontario…...….p. 15 ILARIA DE SETA Autoesilio americano e World Republic nei diari inediti di Giuseppe Antonio Borgese……………………………………………………………………..……..p. 23 ANDREA PAGANINI La letteratura italiana in Svizzera durante la seconda guerra mondia- le………………………………………………………………………...................p. 39 CRISTINA TERRILE Il «dispatrio» di Luigi Meneghello: la polarità come fondamento di poeti- ca……………………………………………………………...……………….…..p. 53 ERRANTI NOVELLA DI NUNZIO La funzione letteraria dell’ebreo errante e l’ebraismo come dispositivo narra- tivo e critico………………………………………………………...…………….p. 65 VALENTINA SARDELLI «La vera patria è la lingua». Gli intellettuali ebreo-tedeschi da minoranza pra- ghese a comunità esule…………….……………………………………………p. 89 MARTA MĘDRZAK-CONWAY New York Exiles, Triestine Exiles: Affinities Between American-Jewish and Svevian Protagonists.……………………………….……………….……….….p. 97 FORME DI ESILIO, MIGRAZIONE, FRONTIERA: TEATRO PAOLO PUPPA La grazia/disgrazia di essere straniero a teatro……………………………...p. 107 MARTINA DAMIANI – FABRIZIO FIORETTI L’esilio degli intellettuali italiani dai territori asburgici: il percorso di Nanni Mocenigo……………………………………………………………………...…p. 123 ANNE-MARIE LIEVENS L’arcangelo dall’ala spezzata: l’esilio di Alberti in Noche de guerra en el Museo del Prado ……………………………………………………………………….….p. 131 MARIA ESTER BADIN Migrazione e teatro……………………………………………………………..p. -
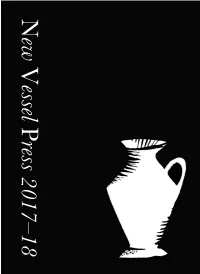
Ew V Essel P Ress
i New Vessel Press 2017 –18 New Vessel Press, founded in New York City in 2012, is an independent pub- lishing house specializing in the translation of foreign literature into English. By bringing readers foreign literature and narrative non-fiction, we offer cap- tivating, thought-provoking works with beautifully designed covers and high production values. We scour the globe looking for the best stories, knowing that only about three percent of the books published in the United States each year are translations. That leaves a lot of great literature still to be discovered. At New Vessel Press, we believe that knowledge of foreign cultures and litera- tures enriches our lives by offering passageways to understand and embrace the world. We regard literary translation as both craft and art, enabling us to tra- verse borders and open minds. We are committed to books that offer erudition and enjoyment, stimulate and scintillate, transform and transport. And of course, what matters most is not where the authors hail from, or what language they write in. The most important thing is the quality of the work itself. And hence our name. We publish great books, just in a new vessel. Our books have received a wide array of accolades, from The New York Times and The Wall Street Journal to The New Yorker and O, The Oprah Magazine. We are confident that our 2017-18 offerings will continue to make their mark and look forward to bringing the world’s great literature to ever more readers. 1 2 THE MADELEINE PROJECT By Clara Beaudoux / France Translated by Alison Anderson NONFICTION September 2017 5 ½ x 8 ¼ / 304 pp Trade Paper $23.95 978-1-939931-49-8 “Tells history in a brilliant, original way for the 21st century .. -

L'italia Ponte Di Un Nuovo Umanesimo
L’Italia ponte di un nuovo umanesimo PROGRAMA Salamanca, 17, 18 y 19 mayo 2018 2 | XVII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Italianistas __________________________________ ____________________________________ Salamanca, 17, 18 y 19 mayo 2018. Universidad de Salamanca | 3 C. DANTE Y PETRARCA I (Aula 01). JUEVES Moderadora: Carmen Blanco Valdés. Giulia Fasano (Universidad de Salamanca): 17 MAYO 2018 Marginalia figurata e ricezione testuale della Commedia dantesca. Linda Garosi (Universidad de Córdoba): L’adattamento culturale e la costruzione delle biografie esemplari 9:00 Recogida de material y acreditaciones (Sala de Juntas). nel volgarizzamento dei Fiori di filosafi e d’altri savi e d’imperadori. Augusto Nava Mora (Universidad Complutense de Madrid): 9:45 Inauguración a cargo de autoridades (Aula Magna). El ojo y el ‘Termine’ de lo humano en el ‘Convivio’ de Dante. · Excmo. y Magfco. D. Ricardo Rivero Ortega, Francisco José Rodríguez Mesa (Universidad de Córdoba): Rector de la Universidad de Salamanca. La presenza di Didone nel Canzoniere di Petrarca: un problema di fonti. · Excmo. Sr. D. Stefano Sannino, Embajador de Italia en España. D. MUJER Y LITERATURA I (Aula A11). · Excmo. Sr. Alfonso Fernández Mañueco, Alcalde de Salamanca. Moderadora: Mercedes González de Sande. · Sr. Decano D. Vicente González Martín, Facultad de Filología. José García Fernández (Universidad de Oviedo): 11:00 Descubrimiento del Vítor del Doctor Honoris Causa D. Giovanni Puglisi. Mujeres olvidadas: retrato literario de la represión religiosa femenina en los albores del nacimiento de Italia. 11:15 Pausa café. Eva Moreno Lago (Universidad de Sevilla): La sociedad rural de la Romagna 11:30 Sesiones simultáneas de comunicaciones. vista por la escritora Giovanna Righini Ricci.