COMUNE DI LORO CIUFFENNA Provincia Di Arezzo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tabelle Viciniorità
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HA-XXO25 27/02/16 TABELLA DI VICINIORITA' PAG. 1 PROVINCIA DI: AREZZO IDENTIFICATIVO ZONALE A291 030 DESCRIZIONE ANGHIARI PRG DENOMINAZIONE IDZ CAP PRG DENOMINAZIONE IDZ CAP 1 SANSEPOLCRO I155 030 52037 2 MONTERCHI F594 030 52035 3 CAPRESE MICHELANGELO B693 030 52033 4 PIEVE SANTO STEFANO G653 030 52036 5 AREZZO A390 031 52100 6 CAPOLONA B670 031 52010 7 SUBBIANO I991 031 52010 8 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA C774 031 52040 9 BADIA TEDALDA A541 030 52032 10 CASTIGLION FIORENTINO C319 032 52043 11 MONTE SAN SAVINO F628 031 52048 12 CASTIGLION FIBOCCHI C318 031 52029 13 MARCIANO DELLA CHIANA E933 032 52047 14 FOIANO DELLA CHIANA D649 032 52045 15 LUCIGNANO E718 032 52046 16 CORTONA D077 032 52044 17 LATERINA E468 028 52020 18 PERGINE VALDARNO G451 028 52020 19 CHIUSI DELLA VERNA C663 029 52010 20 BUCINE B243 028 52021 21 MONTEVARCHI F656 028 52025 22 SAN GIOVANNI VALDARNO H901 028 52027 23 CASTEL FOCOGNANO C102 029 52016 24 BIBBIENA A851 029 52011 25 CHITIGNANO C648 029 52010 26 POPPI G879 029 52014 27 SESTINO I681 030 52038 28 PRATOVECCHIO STIA M329 029 52017 29 TALLA L038 029 52010 30 ORTIGNANO RAGGIOLO G139 029 52010 31 LORO CIUFFENNA E693 028 52024 32 TERRANUOVA BRACCIOLINI L123 028 52028 33 CAVRIGLIA C407 028 52022 34 CASTELFRANCO PIANDISCO M322 028 52020 35 CASTEL SAN NICCOLO' C263 029 52018 36 MONTEMIGNAIO F565 029 52010 SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HA-XXO25 27/02/16 TABELLA DI VICINIORITA' PAG. -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2017
Ufficio del territorio di AREZZO Data: 16/03/2017 Ora: 14.41.13 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2017 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.1 del 28/02/2017 n.- del - REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 CASENTINO ALTO TEVERE Comuni di: BIBBIENA, CASTEL FOCOGNANO, CASTEL SAN NICCOLO, Comuni di: BADIA TEDALDA, CAPRESE MICHELANGELO, PIEVE CHITIGNANO, CHIUSI DELLA VERNA, MONTEMIGNAIO, SANTO STEFANO, SESTINO ORTIGNANO RAGGIOLO, POPPI, PRATOVECCHIO, STIA, SUBBIANO, TALLA, PRATOVECCHIO STIA COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO E MISTO 4000,00 SI SI 4000,00 SI SI BOSCO D`ALTO FUSTO 4600,00 4400,00 CASTAGNETO DA FRUTTO 5000,00 5800,00 COLTURE IN SERRA 50000,00 11-DA VALUTARE A PARTE 50000,00 11-DA VALUTARE A PARTE GLI IMPIANTI E GLI IMPIANTI E ATTREZZATURE FISSE) ATTREZZATURE FISSE) COLTURE ORTIVE A PIENO CAMPO 50000,00 50000,00 FRUTTETO SPECIALIZZATO 18000,00 11-DA VALUTARE A PARTE 13000,00 7-TRATTASI DI IMPIANTI DI GLI IMPIANTI E ETA MEDIA A PARTIRE ATTREZZATURE FISSE) DALLA MESSA IN DIMORA) 7-TRATTASI DI IMPIANTI DI 11-DA VALUTARE A PARTE ETA MEDIA A PARTIRE GLI IMPIANTI E DALLA MESSA IN DIMORA) ATTREZZATURE FISSE) Pagina: 1 di 12 Ufficio del territorio di AREZZO Data: 16/03/2017 Ora: 14.41.13 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2017 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.1 del 28/02/2017 n.- del - INCOLTO PRODUTTIVO E STERILE 1500,00 9-TERRENO NON IDONEO 1500,00 6-TERRENO NON IDONEO ALLA COLTIVAZIONE CHE, ALLA COLTIVAZIONE CHE SENZA INTERVENTO DELLA DIA SPONTANEAMENTE UN MANO DELL UOMO, DIA UN PRODOTTO VALUTABILE PRODOTTO VALUTABILE ANCHE MINIMO) ANCHE MINIMO. -

Regione Toscana Giunta Regionale
Regione Toscana Giunta regionale Principali interventi regionali a favore della zona aretina – Casentino - Valtiberina Anni 2015-2020 Anghiari Montemignaio AREZZO Monterchi Badia Tedalda Monte San Savino Bibbiena Ortignano Raggiolo Capolona Pieve Santo Stefano Caprese Michelangelo Poppi Castel Focognano Pratovecchio Stia Castel San Niccolò Sansepolcro Castiglion Fibocchi Sestino Chitignano Subbiano Chiusi della Verna Talla Civitella in Val di Chiana Direzione Programmazione e bilancio Settore Controllo strategico e di gestione Settembre 2020 INDICE ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA .................................................................................................. 3 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA ................................................................................................................. 3 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA ..................................................................................................... 3 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO .......................................................................................... 3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI .......................................... 4 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE ............................................................. 4 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO .......................................................................... 4 SPORT E TEMPO LIBERO ................................................................................................................................... -

Comune Di Castel San Niccolò Provincia Di Arezzo
Comune di Castel San Niccolò Provincia di Arezzo ALLEGATO B REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI (AI SENSI DELL’ART. 20, C. 1, DEL D. LGS. 175/2016) Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2019 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Si richiama il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (G.U. 8 settembre 2016, n. 210), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (G.U. 26 giugno 2017, n. 147). Possono essere acquisite, detenute e quindi mantenute le partecipazioni societarie che rientrino nelle categorie di cui all’art. 4 del Testo unico, ossia: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs n. 50/2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs n. 50/2016 con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. -
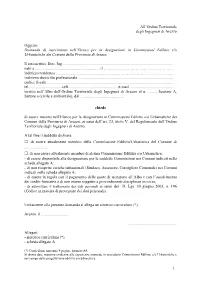
Regolamento Interno Del C
All’Ordine Territoriale degli Ingegneri di Arezzo Oggetto: Domanda di inserimento nell’Elenco per la designazioni in Commissioni Edilizie e/o Urbanistiche dei Comuni della Provincia di Arezzo. Il sottoscritto, Dott. Ing. .............................................................................................................. nato a ................................................................. il ……………………………………………. indirizzo residenza ................................................................………………………………….. indirizzo domicilio professionale ................................................................................................ codice fiscale ............................................................................................................................... tel..................................cell...................................................e-mail ............................................. iscritto nell’Albo dell’Ordine Territoriale degli Ingegneri di Arezzo al n. ........, Sezione A, Settore a (civile e ambientale), dal .........................................., chiede di essere inserito nell’Elenco per la designazioni in Commissioni Edilizie e/o Urbanistiche dei Comuni della Provincia di Arezzo, ai sensi dell’art. 23, titolo V, del Regolamento dell’Ordine Territoriale degli Ingegneri di Arezzo. A tal fine il suddetto dichiara: □ di essere attualmente membro della Commissione Edilizia/Urbanistica del Comune di ......................; □ di non essere attualmente membro di alcuna Commissione -

Actes Dont La Publication Est Une Condition De Leur Applicabilité)
30 . 9 . 88 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 270/ 1 I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CEE) N° 2984/88 DE LA COMMISSION du 21 septembre 1988 fixant les rendements en olives et en huile pour la campagne 1987/1988 en Italie, en Espagne et au Portugal LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, considérant que, compte tenu des donnees reçues, il y a lieu de fixer les rendements en Italie, en Espagne et au vu le traité instituant la Communauté économique euro Portugal comme indiqué en annexe I ; péenne, considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil, du 22 grasses, septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) A ARRÊTÉ LE PRESENT REGLEMENT : n0 2210/88 (2), vu le règlement (CEE) n0 2261 /84 du Conseil , du 17 Article premier juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive , et aux organisa 1 . En Italie, en Espagne et au Portugal, pour la tions de producteurs (3), modifié en dernier lieu par le campagne 1987/ 1988 , les rendements en olives et en règlement (CEE) n° 892/88 (4), et notamment son article huile ainsi que les zones de production y afférentes sont 19 , fixés à l'annexe I. 2 . La délimitation des zones de production fait l'objet considérant que, aux fins de l'octroi de l'aide à la produc de l'annexe II . -

Pagina 1 AZIENDA USL TOSCANA SUD EST COMODATI/ALTRO AL 31/12/2019
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST COMODATI/ALTRO AL 31/12/2019 AREA ARETINA ZONA Comune Indirizzo Denominazione-attività prevalente Proprietario Scadenza TITOLO ARETINA Arezzo Via Guido Monaco, 13 Sede DSM Provincia di Arezzo accordo in corso Accordo Centro Socio Sanitario Palazzo del ARETINA Arezzo Loc. Palazzo del Pero 61/B Comune di Arezzo 31/10/2022 Comodato Pero Comodato - approvato schema ARETINA Arezzo Loc. Rigutino Ovest n. 122 Centro Socio Sanitario di Rigutino Comune di Arezzo 01/09/2016 comodato con deliberazione DG n. 110/2017 - ARETINA Arezzo Via Donizetti n. 7/D Centro Socio Sanitario “San Leo” Comune di Arezzo 18/06/2025 Comodato ARETINA Arezzo Loc. San Giuliano 47/B Centro Socio Sanitario San Giuliano Proprietà A.F.M. 03/05/2023 Comodato Ambulatori medici ed Infermieristici ARETINA Arezzo Via Garibaldi, 259 presso Casa Circondariale “San Amministrazione Penitenziaria dal 22/05/2013 senza scadenza Comodato Benedetto” Comodato – in corso approvazione ARETINA Arezzo Loc. Casenuove di Ceciliano, 73/2 Centro Socio Sanitario "Ceciliano" Comune di Arezzo 01/09/2016 schema comodato per rinnovo - Comodato – in corso approvazione ARETINA Arezzo Loc. Quarata, 243/B Centro Socio Sanitario "Quarata" Centro di Aggregazione Sociale 21/04/2016 schema comodato per rinnovo - ARETINA Arezzo Loc. Ponte alla Chiassa, 314 Punto Prelievi Ponte alla Chiassa Sig. Redi Umberto 15/04/2021 Comodato ARETINA Capolona Loc.Castelluccio Punto Prelievi di Castelluccio Comune di Capolona trattative in corso Comodato Centro Socio Sanitario Castiglion ARETINA Castiglion Fibocchi Piazza delle Fiere, 1 Comune Cast. Fibocchi 31/12/2021 Comodato Fibocchi ARETINA Monte San Savino Via Nebbiaie n.25/b-25/d, Loc. -
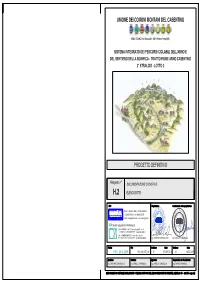
P017-Def H-02 Rev02 Elenco Ditte
Progetto Definitivo : SISTEMA INTEGRATO DEI PERCORSI CICLABILI DELL’ARNO E DEL SENTIERO DELLA BONIFICA TRATTO FIUME ARNO CASENTINO – 2° STRALCIO Lotto 2 Documentazione Catastale UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO PROGETTO DEFINITIVO SISTEMA INTEGRATO DEI PERCORSI CICLABILI DELL’ARNO E DEL SENTIERO DELLA BONIFICA TRATTO FIUME ARNO CASENTINO 2° STRALCIO – LOTTO 2 DOCUMENTAZIONE CATASTALE Elenco Ditte ESSE.I.A. - Cod. Prog.: ARNO CASENTINO\P017-DEF - Cod. Doc.: P017-DEF_H-00_ Documentazione Catastale .doc SISTEMA INTEGRATO DEI PERCORSI CICLABILI DELL’ARNO E DEL SENTIERO DELLA BONIFICA – TRATTO FIUME ARNO CASENTINO 2° STRALCIO – LOTTO 2 ELENCO DITTE TRATTO 1: DA INIZIO INTERVENTO A POPPI DATI CATASTALI INDENNITA' DI SERVITU' OCCUPAZIONE TEMPORANEA POSIZIONE Progr. Lunghezza Larghezza Superficie Indennità INDENNITA' Indennità INDENNITA' COMUNE FOGLIO MAPPALE SUPERFICIE QUALITA' PROPRIETA' Superficie (m) (m) (mq) unitaria (ha) TOTALE unitaria (ha) TOTALE 1 Castel San Niccolò 31 81 9795 bosco alto 322,00 3,50 1.127,00 6.000,00 676,20 50,00 2.000,00 10,00 84,00 3,50 294,00 6.000,00 176,40 10,00 2.000,00 2,00 2 Castel San Niccolò 31 82 2160 prato arb. 1 S.A.C.I. SRL con sede in POPPI 214,00 6.000,00 128,40 3 Poppi 61 312 490 pascolo 22,00 3,50 77,00 2.600,00 20,02 50,00 866,67 4,33 4 Poppi 61 311 2220 seminativo 49,00 3,50 171,50 6.000,00 102,90 5 Poppi 63 127 7240 bosco alto FANI CRISTINA 85,00 3,50 297,50 6.000,00 178,50 260,00 2.000,00 52,00 2 6 Poppi 63 128 X X 52,00 6.000,00 31,20 7 Poppi 65 1 3140 seminativo 258,00 3,50 903,00 6.000,00 541,80 260,00 2.000,00 52,00 8 Poppi 65 126 3010 pascolo cesp. -

Progetto “Banda Ultralarga Nelle Aree a Fallimento Di Mercato”
Foglio1 Progetto “Banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato” Comuni in cui sono disponibili i servizi in banda ultralarga FTTH e FWA limitatamente alle unità immobiliari localizzati in area “bianca” (a fallimento di mercato) Aggiornamento al 22/07/2021 Il presente report è da ritenersi non definitivo: nei Comuni elencati potranno essere raggiunte ulteriori unità immobiliari. Le informazioni sono state comunicate da OpEn Fiber S.p.A. (“OF”). Al link https://openfiber.it/ è possibile verificare gli operatori disponibili ed i relativi prezzi per il collegamento ai servizi in banda ultralarga del proprio numero civico. (*) L’asterisco indica i Comuni nei quali il numero di unità immobiliari raggiunte dal servizio FWA è inferiore a 10. Provincia Comune Tecnologia Anghiari FTTH FWA Capolona FTTH Castel Focognano FTTH FWA Castel San Niccolò FTTH Chiusi della Verna * FWA Foiano della Chiana FWA Loro Ciuffenna FTTH FWA Arezzo Lucignano FTTH FWA Marciano della Chiana * FWA Monte San Savino FTTH FWA Monterchi FTTH Ortignano raggiolo FTTH Sansepolcro FTTH Talla FTTH FWA Terranuova Bracciolini FTTH FWA Campi Bisenzio FWA Certaldo FTTH Firenzuola FTTH FWA Lastra a Signa FTTH Firenze Londa FTTH Palazzuolo sul Senio FTTH FWA Signa FWA Vinci FWA Arcidosso FWA Campagnatico FTTH Grosseto Castell'Azzara FWA Cinigiano FTTH Pagina 1 Foglio1 Provincia Comune Tecnologia Grosseto FTTH Magliano in Toscana FTTH FWA Manciano FTTH FWA Montieri FTTH Pitigliano FTTH Roccalbegna FTTH FWA Grosseto Santa Fiora FTTH FWA Scansano FTTH FWA Scarlino FTTH Seggiano -

Protezione Civile Arezzo
PROVINCIA DI AREZZO Elenco delle Associazioni aderenti al "Coordinamento Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile" n. iscrizione Albo Regionale Organizzazione di Volontariato Sede nel Comune di 1 257/03 A.N.A. SEZIONE FIRENZE - GRUPPO VALDARNO SUPERIORE Terranuova Bracciolini 2 56/01 C.I.S.O.M. GRUPPO DI AREZZO Arezzo 3 432/01 CISAR TOSCANA PROTEZIONE CIVILE RNRE Arezzo 4 42/05 CENTERVOL - SANSEPOLCRO Sansepolcro 5 42/04 CENTERVOL – GRUPPO COMUNALE SESTINO Sestino 6 42/02 CENTERVOL - GRUPPO SOMMOZZATORI AREZZO Arezzo 7 116/01 GRUPPO COMUNALE SANSEPOLCRO ALTOTEVERE VOLONTARI DI P.C. Sansepolcro 8 231/01 CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI BUCINE Bucine 9 411/01 NUCLEO VOLONTARIATO E PROT. CIVILE ANC MONTEVARCHI Montevarchi 10 505/01 NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANC AREZZO Arezzo 11 599/01 PROTEZIONE CIVILE MONTEVARCHI ODV Montevarchi 12 177/07 VAB CASTIGLION FIORENTINO Castiglion Fiorentino 13 177/09 VAB CORTONA Cortona 14 206/01 VOLONTARI SALVAGUARDIA AMBIENTE (V.S.A.) Monte San Savino 15 449/01 GUCS GRUPPO UNITA’ CINOFILE DA SOCCORSO Terranuova Bracciolini 16 582/01 ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA AVIS Foiano della Chiana 17 582/02 ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA AVIS FOIANO Marciano della Chiana 18 268/01 C.R.I. COMITATO AREZZO Arezzo 19 286/01 C.R.I. COMITATO BIBBIENA Bibbiena 20 269/01 C.R.I. COMITATO CASTIGLION FIORENTINO Castiglion Fiorentino 21 270/01 C.R.I. COMITATO CHIUSI DELLA VERNA Chiusi della Verna 22 416/01 C.R.I. COMITATO FOIANO DELLA CHIANA Foiano della Chiana 23 271/01 C.R.I. COMITATO MONTE SAN SAVINO Monte San Savino 24 272/01 C.R.I. -

Unione Dei Comuni Montani Del Casentino
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Bando di iscrizione al Servizio di nido d’infanzia comunale per i nidi d’infanzia di Castel San Niccolò, Poppi, Ortignano Raggiolo e per la sezione distaccata di Corezzo (Chiusi della Verna) Castel Anno educativo 2018‐2019 Focognano IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto la Legge Regionale n. 32/2002 e il Regolamento d’esecuzione (D.P.G.R. 30 luglio 2013, n. 41/R) e ss.mm.ii.; Visto che ai sensi dello Statuto dell’Unione di Comuni Montani del Casentino questo ente gestisce la funzione Castel San fondamentale dei servizi sociali per conto dei Comuni aderenti, comprensiva degli asili nido comunali; Niccolò Visto il Regolamento Unico del Sistema Integrato dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino n.21 del 08/07/2014; Visto la Delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino n. 74 del 08/06/2017 denominata “Funzione fondamentale dei servizi sociali – Unificazione sistema tariffario tra i nidi di Poppi e di Ortignano Raggiolo”; Chitignano Visto la Delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino n.93 del 10/07/2017 con la quale, in relazione al nido d’infanzia di Castel San Niccolò si prevedeva, tra le altre cose, l’adozione del sistema tariffario in essere nell’a.e. 2017/2018 nei nidi di Poppi e Ortignano Raggiolo; Chiusi della Vista la propria determinazione n. 580 del 14/05/2018 .con la quale veniva approvato il presente avviso; Verna RENDE NOTO CHE Dal giorno lunedì 14 maggio 2018 sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia di Castel San Niccolò, Ortignano Raggiolo, Poppi e Sezione distaccata di nido d’infanzia di Corezzo per l’anno educativo 2018/2019. -

Casentino E Val Tiberina
12 casentino e val tiberina PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE Comuni di: Anghiari (AR), Badia Tedalda (AR), Bibbiena (AR), Capolona (AR), Caprese Michelan- CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO gelo (AR), Castel Focognano (AR) Castel San Niccolo (AR), Chitignano (AR),Chiusi della Verna (AR), Montemignaio (AR), Monterchi (AR), Ortignano Raggiolo ( AR), Pieve Santo Stefano (AR), Poppi (AR), Pratovecchio Stia (AR), Sansepolcro (AR), Sestino (AR), Subbiano (AR), Talla (AR) 1. profilo dell’ambito 2. descrizione interpretativa 3. invarianti strutturali 4. interpretazione di sintesi 5. indirizzi per le politiche 6. disciplina d’uso SCHEDA AMBITO DI PAESAGGIO ASSESSORATO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE DEL TERRI- CARTOGRAFIA, ATLANTE REGIONALE, VISIBILITÀ E CARATTERI MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TU- Soprintendente – Dirigente Alessandra Marino TORIO E PAESAGGIO PERCETTIVI RISMO Referenti Gabriele Nannetti Assessore Anna Marson Responsabile scientifico - Fabio Lucchesi (DIDA/UNIFI) in base al Protocollo di intesa 23 gennaio 2007 e relativi Discipli- Gruppo di lavoro - Franco Filippelli, Emanuele Masiello, Gior- Christian Ciampi, Michele De Silva, Michele Ercolini, Emanuela nari di attuazione gio Elio Pappagallo, Lia Pescatori, Luigi Rosania, Hosea Scelza, DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO Loi, Michela Moretti, Fabio Nardini, Ilaria Scatarzi Sergio Sernissi, Valerio Tesi, Vincenzo Vaccaro, Stefano Veloci, Responsabile Maria Sargentini Elaborazione congiunta del piano sulla base del Disciplinare di at- Fulvia Zeuli SCHEDE