Rapporto Ambientale VA
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lago Maggiore
Lago Maggiore Lago Maggiore (Verbano) Paese/i: Italia, Svizzera Regione/i: Ticino (CH), Piemonte (IT), Lombardia (IT) Provincia/e: Ticino: Distretto di Locarno Varese, Novara, Verbano-Cusio- Ossola Superficie: 212 km² Altitudine: 193 m s.l.m. Profondità 370 m massima: Immissari Ticino, Maggia, Toce, principali: Tresa Emissari Ticino principali: Bacino imbrifero: 6.599 km² « Se hai un cuore e una camicia, vendi la camicia e visita i dintorni del Lago Maggiore » (Stendhal) Il lago Maggiore o Verbano (indicato anche come lago di Locarno, Lach Magiur in dialetto lombardo occidentale) è un lago prealpino di origine glaciale, il secondo in Italia come superficie. Le sue rive sono condivise tra Svizzera (Canton Ticino) e Italia (province di Varese, Verbano- Cusio-Ossola e Novara). Morfologia Il lago Maggiore si trova ad un'altezza di circa 193 m s.l.m., la sua superficie è di 212 km² di cui circa l'80% è situata in territorio italiano e il rimanente 20% in territorio svizzero. Ha un perimetro di 170 km e una lunghezza di 54 km (la maggiore tra i laghi italiani); la larghezza massima è di 10 km e quella media di 3,9 km. Il volume d'acqua contenuto è pari a 37,5 miliardi di m³ di acqua con un tempo teorico di ricambio pari a circa 4 anni. Il bacino imbrifero è molto vasto, pari a circa 6.599 km² divisi quasi equamente tra Italia e Svizzera (il rapporto tra la superficie del bacino e quella del lago è pari 31,1), la massima altitudine di bacino è Punta Dufour nel massiccio del Monte Rosa (4.633 m s.l.m.) quella media è invece di 1.270 m s.l.m. -

Commissione Internazionale Per La Protezione Delle Acque Italo-Svizzere
ISSN: 1013-8099 Commissione Internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere Ricerche sull'evoluzione del Lago Maggiore Aspetti limnologici Programma quinquennale 1998 – 2002 Campagna 2002 e Rapporto quinquennale 1998 - 2002 a cura di Roberto Bertoni Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto per lo Studio degli Ecosistemi Sezione di Idrobiologia ed Ecologia delle Acque Interne Verbania Pallanza I dati riportati nel presente volume possono essere utilizzati purché se ne citi la fonte come segue: C.N.R.-I.S.E. Sezione di Idrobiologia ed Ecologia delle Acque Interne- 2004. Ricerche sull'evoluzione del Lago Maggiore. Aspetti limnologici. Programma quinquennale 1998-2002. Campagna 2002. Commissione Internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere (Ed.): 153 pp. ISSN: 1013-8099 Commissione Internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere Ricerche sull'evoluzione del Lago Maggiore Aspetti limnologici Programma quinquennale 1998 - 2002 Campagna 2002 e Rapporto quinquennale 1998 - 2002 a cura di Roberto Bertoni Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto per lo Studio degli Ecosistemi Sezione di Idrobiologia ed Ecologia delle Acque Interne Verbania Pallanza RIASSUNTO Vengono qui riportati i risultati ottenuti dalle ricerche sul Lago Maggiore realizzate dalla Sezione di Idrobiologia ed Ecologia delle Acque Interne del CNR-ISE (già Istituto Italiano di Idrobiologia) per conto della Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere. Trattandosi dell’ultimo anno del quinto ciclo quinquennale, vengono anche illustrate le tendenze evolutive emerse nel corso del quinquennio, con- frontate con quanto osservato negli ultimi 50 anni. I risultati ottenuti evidenziano che la tendenza del lago ad evolvere verso una condi- zione di oligotrofia, già osservata nel precedente quinquennio, può essere confermata. -
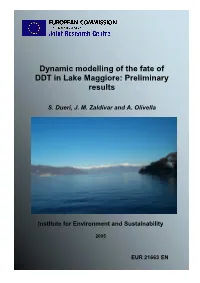
Dynamic Modelling of the Fate of DDT in Lake Maggiore: Preliminary Results
Dynamic modelling of the fate of DDT in Lake Maggiore: Preliminary results S. Dueri, J. M. Zaldívar and A. Olivella Institute for Environment and Sustainability 2005 EUR 21663 EN 1 The mission of the Institute for Environment and Sustainability is to provide scientific and technical support to EU policies for the protection of the environment contributing to sustainable development in Europe. European Commission Directorate-General Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability Contact information Address:Via E. Fermi 1, TP 272 E-mail: [email protected] Tel.:+39-0332789202 Fax: +39-0332785807 http://ies.jrc.cec.eu.int http://www.jrc.cec.eu.int Legal Notice Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for the use which might be made of this publication. A great deal of additional information on the European Union is available on the Internet. It can be accessed through the Europa server http://europa.eu.int EUR 21663 EN Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities © European Communities, 2005 Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Printed in Italy 2 CONTENTS 1. INTRODUCTION 4 2. FATE AND TRANSPORT OF DDT: MASS BALANCE MODEL 5 2.1 Sorptium equilibria 7 2.2 Air-Water Exchange 8 2.3 Dry and wet deposition 12 2.4 Sediment deposition: Settling 13 2.5 Sediments-Water Exchange 13 2.6 Resuspension and burial 15 2.7 Pore water diffusion 16 2.8 Sediment biodiffusion 16 2.9 Chemical loss rate 17 3. LAKE MAGGIORE PARAMETERS AND BOUNDARY DATA 17 3.1. -

Repertorio Corpi Idrici: Tipo, Natura, Stato
Repertorio Corpi Idrici: tipo, natura, stato Allegato 1.5 all’Elaborato 1 Versione del 24 Febbraio 2010 Piano di Gestione Repertorio Corpi Idrici: tipo, natura, stato ALLEGATO 1.5 ALL ’E LABORATO 1 Versione 2 Data Creazione: 30_06_09 Modifica: 15_03_10 Tipo Allegato all’Elaborato 1 del PdG Formato Microsoft Word – dimensione: pagine 245 Identificatore PdG_Po_Allegato_1_5_100224.doc Lingua it-IT Gestione dei diritti CC-by-nc-sa Metadata estratto da Dublin Core Standard ISO 15836 Indice Premessa 1 1. Generalità 2 1.1. Criteri per l’individuazione dei corpi idrici 2 1.1.1. Acque superficiali 2 1.1.2. Acque sotterranee 4 1.2. Criteri per l’individuazione dei tipi 5 1.3. Criteri per la definizione dello stato del corpo idrico 6 1.4. Criteri per l’individuazione della natura del corpo idrico 7 2. Informazioni sulla lettura delle tabelle 10 2.1. Corpi idrici superficiali 10 2.2. Corpi idrici sotterranei 12 3. Corpi idrici fluviali 13 3.1. Il sistema dei sottobacini nel distretto del fiume Po 13 3.2. Sintesi dei risultati 15 3.3. Po Piemontese 17 3.4. Asta Po 21 3.5. Sarca – Mincio 25 3.6. Adda 38 3.7. Oglio 55 3.8. Lambro - Olona 78 3.9. Ticino 85 3.10. Toce 90 3.11. Terdoppio 93 3.12. Agogna 95 3.13. Sesia 98 3.14. Dora Baltea 103 3.15. Orco 126 3.16. Malone 128 3.17. Stura Di Lanzo 130 3.18. Sangone - Chisola – Lemina 132 3.19. Pellice – Chisone 134 3.20. Varaita 136 3.21. -

List of Rivers of Italy
Sl. No Name Draining Into Comments Half in Italy, half in Switzerland - After entering Switzerland, the Spöl drains into 1 Acqua Granda Black Sea the Inn, which meets the Danube in Germany. 2 Acquacheta Adriatic Sea 3 Acquafraggia Lake Como 4 Adda Tributaries of the Po (Left-hand tributaries) 5 Adda Lake Como 6 Adige Adriatic Sea 7 Agogna Tributaries of the Po (Left-hand tributaries) 8 Agri Ionian Sea 9 Ahr Tributaries of the Adige 10 Albano Lake Como 11 Alcantara Sicily 12 Alento Adriatic Sea 13 Alento Tyrrhenian Sea 14 Allaro Ionian Sea 15 Allia Tributaries of the Tiber 16 Alvo Ionian Sea 17 Amendolea Ionian Sea 18 Amusa Ionian Sea 19 Anapo Sicily 20 Aniene Tributaries of the Tiber 21 Antholzer Bach Tributaries of the Adige 22 Anza Lake Maggiore 23 Arda Tributaries of the Po (Right-hand tributaries) 24 Argentina The Ligurian Sea 25 Arno Tyrrhenian Sea 26 Arrone Tyrrhenian Sea 27 Arroscia The Ligurian Sea 28 Aso Adriatic Sea 29 Aterno-Pescara Adriatic Sea 30 Ausa Adriatic Sea 31 Ausa Adriatic Sea 32 Avisio Tributaries of the Adige 33 Bacchiglione Adriatic Sea 34 Baganza Tributaries of the Po (Right-hand tributaries) 35 Barbaira The Ligurian Sea 36 Basentello Ionian Sea 37 Basento Ionian Sea 38 Belbo Tributaries of the Po (Right-hand tributaries) 39 Belice Sicily 40 Bevera (Bévéra) The Ligurian Sea 41 Bidente-Ronco Adriatic Sea 42 Biferno Adriatic Sea 43 Bilioso Ionian Sea 44 Bisagno The Ligurian Sea 45 Biscubio Adriatic Sea 46 Bisenzio Tyrrhenian Sea 47 Boesio Lake Maggiore 48 Bogna Lake Maggiore 49 Bonamico Ionian Sea 50 Borbera Tributaries -

Trends in the Chemistry of Atmospheric Deposition and Surface Waters in the Lake Maggiore Catchment
Hydrology and Earth SystemTrends Sciences, in the chemistry 5(3), 379–390 of atmospheric (2001) deposition © EGS and surface waters in the Lake Maggiore catchment Trends in the chemistry of atmospheric deposition and surface waters in the Lake Maggiore catchment M. Rogora, A. Marchetto and R. Mosello C.N.R. Istituto Italiano di Idrobiologia, L.go Tonolli 50-52, I-28922 Verbania Pallanza, Italy Email for corresponding author: [email protected] Abstract The Lake Maggiore catchment is the area of Italy most affected by acid deposition. Trend analysis was performed on long-term (15-30 years) series of chemical analyses of atmospheric deposition, four small rivers draining forested catchments and four high mountain lakes. An improvement in the quality of atmospheric deposition was detected, due to decreasing sulphate concentration and increasing pH. Similar trends were also found in high mountain lakes and in small rivers. Atmospheric deposition, however, is still providing a large and steady flux of nitrogen compounds (nitrate and ammonium) which is causing increasing nitrogen saturation in forest ecosystems and increasing nitrate levels in rivers. Besides atmospheric deposition, an important factor controlling water acidification and recovery is the weathering of rocks and soils which may be influenced by climate warming. A further factor is the episodic deposition of Saharan calcareous dust which contributes significantly to base cation deposition. Keywords: trend, atmospheric deposition, nitrogen, stream water chemistry. Introduction For several decades, northern Italy has been affected by acid towards an improvement in atmospheric deposition deposition which carries high amounts of sulphur (S) and chemistry, mainly as a result of the agreements which have nitrogen (N) compounds. -

Modelling the Effects of Atmospheric Sulphur and Nitrogen Deposition on Selected Lakes and Streams of the Central Alps (Italy) M
Modelling the effects of atmospheric sulphur and nitrogen deposition on selected lakes and streams of the Central Alps (Italy) M. Rogora, A. Marchetto, R. Mosello To cite this version: M. Rogora, A. Marchetto, R. Mosello. Modelling the effects of atmospheric sulphur and nitrogen deposition on selected lakes and streams of the Central Alps (Italy). Hydrology and Earth System Sciences Discussions, European Geosciences Union, 2003, 7 (4), pp.540-551. hal-00304898 HAL Id: hal-00304898 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00304898 Submitted on 1 Jan 2003 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. HydrologyM. Rogora, andA. Marchetto Earth System and R.Sciences, Mosello 7(4), 540551 (2003) © EGU Modelling the effects of atmospheric sulphur and nitrogen deposition on selected lakes and streams of the Central Alps (Italy) M. Rogora, A. Marchetto and R. Mosello CNR Institute of Ecosystem Study, Section of Hydrobiology and Ecology of Inland Waters, L.go Tonolli 50, I-28922 Verbania Pallanza, Italy E-mail for corresponding author: [email protected] Abstract The dynamic model MAGIC was calibrated and applied to selected sites in north-western Italy (3 rivers, 10 alpine lakes) to predict the future response of surface water to different scenarios of atmospheric deposition of S and N compounds. -

And Surrounding Mountains Sales Guide 2016
Lake Ma GGiore and SurroundinG MountainS Sales Guide 2016 . 2017 Sales Guide Highlights Quick Guide 2016 / 2017 Contents BORROMEO ISLANDS Central Lago incontrovertibly the heart of Lago Maggiore and a place of art “par excellence”: isola Bella, isola Madre and isola dei Pescatori. Situated in the Gulf of Borromeo, all three of them have fascinated people throughout history: with the art and culture of a great ruling dynasty: the General information 4 Borromeo family. there are so many attractions for the visitor to wonder at: grandiose ter- Map raced gardens with palazzo, an authentic fishing village with picturesque houses, one of the most spectacular botanic gardens anywhere in the world with many exotic plants – and so Travel information Isola dei Pescatori much more. Taxiboats, Shipyards and Boat Rental Services Coach Rental Services VILLA TARANTO Verbania-Pallanza Golf Courses a villa built in the 1830s by a Scot, Captain neil Mceacharn, and in the meantime one of the richest botanical gardens in the world. With thousands of plant species – eucalyptus, azalea, Events rhododendron, magnolia, maple, camellia and dahlia, it stretches over an area measuring 16 hectares. upper Lago 9 PARcO NAzIONALE VAL GRANDE Ossola Valleys Central Lago 13 this national park situated between the Val d’ossola, the Val Vigezzo and Lago Maggiore the Gardens of Villa Taranto measures 15,000 hectars and is noted as the largest integrated natural wild reserve in italy; Lower Lago 19 here nature has been preserved in all its primal wildness. east Shore and Varese 22 ISOLA DI S. GIuLIO Lake Orta Legend has it that S. -

Codice A1409A D.D. 8 Aprile 2019, N. 251 Decreto 30 Marzo 2010
REGIONE PIEMONTE BU21S1 23/05/2019 Codice A1409A D.D. 8 aprile 2019, n. 251 Decreto 30 marzo 2010. Individuazione delle zone utilizzabili e non utilizzabili ai fini balneari per l’anno 2019 nel territorio della Regione Piemonte. Premesso che: Il Decreto 30 marzo 2010 definisce modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 116 di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla qualità e alla gestione delle acque di balneazione. Ai sensi del Decreto su citato la Regione Piemonte, sulla base dei campionamenti effettuati dall’Arpa Piemonte con la frequenza e per i parametri fissati dallo stesso, individua per ogni stagione balneare le zone utilizzabili ai fini balneari. La Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera e) del d.lgs. 30 maggio 2008 n. 116, stabilisce che la stagione balneare 2019 inizia il 15 maggio 2019 e finisce il 30 settembre 2019 per tutte le zone utilizzabili ai fini balneari. Il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 116 stabilisce inoltre che, qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica, le Regioni provvedano ad effettuare un monitoraggio adeguato per consentire l’individuazione tempestiva di eventuali rischi per la salute. Ai sensi dell’art. 5, lettera d), del d.lgs. 116/2008 i Sindaci dei Comuni con zone risultate temporaneamente non balneabili nel corso della stagione hanno l’obbligo di apporre idonea e ben visibile segnaletica che indichi il divieto di balneazione. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Decreto 30 marzo 2010 i Sindaci dei Comuni con zone risultate, nel corso della stagione, temporaneamente non balneabili, hanno l’obbligo di inviare al Ministero della Salute le ordinanze di divieto di balneazione e di eventuale revoca del divieto, secondo le nuove modalità indicate nella circolare ministeriale di prossima emanazione. -

MOSELLO*, Aldo MARCHETTO, Maria C
J. Limnol., 59(1): 47-54, 2000 Results from the Italian participation in the International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Acidification of Rivers and Lakes (ICP Waters) Rosario MOSELLO*, Aldo MARCHETTO, Maria C. BRIZZIO, Michela ROGORA and Gabriele A. TARTARI CNR Istituto Italiano di Idrobiologia, L.go V. Tonolli 50, 28922 Verbania Pallanza, Italy *e-mail corresponding author: [email protected] ABSTRACT This paper describes the research activity carried out by the Istituto Italiano di Idrobiologia of the CNR, on behalf of the Minis- tero dell'Ambiente, Servizio Inquinamento Atmosferico e Acustico, in the context of the Italian participation in the International Co- operative Programme on Assessment and Monitoring of Acidification of Rivers and Lakes (ICP Waters). Atmospheric deposition chemistry shows that nitrate increased and sulphate decreased in the 70's and 80's, while acidity started to decrease in the early 90's. The studied rivers and lakes show variations in sulphate and nitrate in agreement with those of atmospheric deposition. Alkalinity is mainly determined by watershed geo-lithology and is always present in the studied lakes and streams; the lowest values of 0-10 µeq l-1 are measured in the high altitude Lake Paione Superiore, which however shows an increasing trend of alkalinity and pH. Key words: North Italy, acidification, nitrate, surface water, trend data collected over the last two decades on several lakes 1. INTRODUCTION and rivers located in the northern part of Italy and con- In 1995 the Istituto Italiano di Idrobiologia of the sidered in various research projects, still in progress. -

Maggiore Orta Mergozzo
PRINTED ON 100% RECYCLED PAPER RECYCLED 100% ON PRINTED Via Pio VII, 9 – 10135 Turin – Italy – Turin 10135 – 9 VII, Pio Via Copyright © 2008, Arpa Piemonte Arpa 2008, © Copyright Printed in June 2008 at Litografia Viscardi, Alessandria Viscardi, Litografia at 2008 June in Printed www.arpa.piemonte.it Graphic project Graphic Art Café Adv, Turin Adv, Café Art @ arpa.piemonte.it urp.vco Editing Elisa Bianchi – Arpa Piemonte, Institutional Communications Institutional Piemonte, Arpa – Bianchi Elisa Revision Sonia Naretto - Arpa Piemonte, Institutional Communications Institutional Piemonte, Arpa - Naretto Sonia 518800 800 Translation ACTA, Turin ACTA, Wednesday from 14.00 to 16.00 to 14.00 from Wednesday Photographs Arpa Piemonte Archives Piemonte Arpa from 10.00 to 12.00 to 10.00 from Maps Maps Paolo Demaestri – Arpa Piemonte, Department of Verbano Cusio Ossola Cusio Verbano of Department Piemonte, Arpa – Demaestri Paolo Monday, Tuesday Thursday, Friday Thursday, Tuesday Monday, Arpa Piemonte, Department of Verbano Cusio Ossola Cusio Verbano of Department Piemonte, Arpa Public Information Desk Office Desk Information Public Authors Paola Botta, Patrizia Comoli, Paolo Demaestri, Luigi Guidetti, Silvia Padulazzi Padulazzi Silvia Guidetti, Luigi Demaestri, Paolo Comoli, Patrizia Botta, Paola FOR FURTHER INFORMATION FURTHER FOR which have the potential for being dangerous. being for potential the have which ical point of view. This allows to identify conditions of environmental degradation, as well as situations as well as degradation, environmental of conditions identify to allows This view. of point ical The monitoring plan is aimed to check water conditions, both from a microbiological and physical-chem- and microbiological a from both conditions, water check to aimed is plan monitoring The grations thereto) implementing Directive 76/160/EEC. -

Piano Di Emergenza Intercomunale Di Protezione Civile
Piano di Emergenza Intercomunale di Protezione Civile Approfondimento Comune di Luino Febbraio 2016 Revisione 02/2017 Questo Approfondimento, in quanto parte integrante del Piano Intercomunale, deve mantenere un costante rapporto con la Relazione Generale senza la quale risulterebbe incompleto e limitato. Piano di Emergenza Intercomunale di Protezione Civile Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Comunità Montana Valli del Verbano – Geom. Danilo Bevilacqua Responsabile del Progetto e Referente Tecnico del Progetto: Comunità Montana Valli del Verbano – Geom. Fabio Bardelli Coordinamento Amministrativo del Progetto: Comunità Montana Valli del Verbano – Sig.ra Antonella Brusamolin Supervisione e Stesura del Piano: Dott. Pianificatore Angelo Campoleoni Iscritto all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese, N°2479 Leggiuno (VA) Tel. 329.7458779 Email. [email protected] http://www.pianiemergenza.it Piano redatto ai sensi della Legge 100/2012 e della D.G.R. n.VIII/4732 del 16 maggio 2007 Cassano Valcuvia (VA), febbraio 2016 Il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Piano di Emergenza può essere effettuato solo ed esclusivamente per fini istituzionali, nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dalla Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni 1 PIANO DI EMERGENZA I NTERCOMUNALE APPROFONDIMENTO COMU N E D I LUINO AGGIORNAMENTO 3 A N N O 2 0 1 6 STRUTTURA E INDICE Aggiornamenti del Piano Sequenza Aggiornamenti Data Atto di Approvazione 00 12/2005 01 12/2010