Di Manipolare Con De
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Press Release
Press Release Automobili Lamborghini is celebrating the Miura's 50th Anniversary with Automobili Lamborghini S.p.A. an art exhibit entitled, “Velocità e Colore” (Speed and Color) at its historic museum Communications Department Gerald Kahlke Sant’Agata Bolognese, 06 April 2016 - Automobili Lamborghini is kicking off celebrations for the Phone +39 051 6817711 [email protected] 50th Anniversary of the Miura with an art exhibit entitled, “Velocità e Colore” (Speed and Color), which will be on display from April 28 to June 30 at Lamborghini's historic museum in Press Office – Italy and Southern Europe Clara Magnanini Sant’Agata Bolognese, Italy. Local artist Alfonso Borghi from Campegine (Reggio Emilia) was Phone +39 051 6817711 invited to interpret the Miura and the marque of the Raging Bull. Their spirit, essence and colors [email protected] are expressed in his ten works on display. Press Office – Squadra Corse Chiara Sandoni Distinguished by an artistic language that is informal and abstract, Mr. Borghi's painting is the Phone +39 051 6817711 product of an unconscious revision of the dynamic shapes, the stylistic elements of fine design, [email protected] and the innovations in color that have traditionally characterized Lamborghini super sports cars. Press Office – Events and With their strong interplays of color and three-dimensional effects, ten canvasses in a large size Collezione Automobili Lamborghini (eight in a size of 200 x 150 cm, and two in a size of 180 x 180 cm) gradually reveal specific Rita Passerini Phone +39 051 6817711 details of the Lamborghinis of today and yesteryear - from the iconic Miura to the Reventón, [email protected] Sesto Elemento and Aventador. -

Brave New World Embarking on a New Era of Excitement in the Fia World Rally Championship
INTERNATIONAL JOURNAL OF THE FIA: Q4 2016 ISSUE #17 THE BRAWN AGENDA 20 UNDER 20 As Formula One prepares for At the end of a fascinating year major technical change, famed in motor sport, experts from team boss Ross Brawn on why racing and rallying choose their the devil is in the detail P28 stars of the near future P58 SAFETY ON DISPLAY UNFLAPPABLE GURNEY Ahead of the launch of a major From racing to running race FIA road safety campaign, AUTO teams, from great car control to reveals the key visuals and the inspired car design, Dan Gurney stars behind the messages P34 was the complete competitor P68 P38 BRAVE NEW WORLD EMBARKING ON A NEW ERA OF EXCITEMENT IN THE FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP ISSUE #17 THE FIA Dear reader, The Fédération Internationale de l’Automobile is the governing An enthralling year of motor sport has just come to body of world motor sport and an end, but already fans are looking forward to next the federation of the world’s leading motoring organisations. season when some disciplines will be embracing Founded in 1904, it brings significant changes. INTERNATIONAL together 236 national motoring JOURNAL OF THE FIA and sporting organisations from The World Rally Championship will have a new over 135 countries, representing look, with more powerful and exciting cars, and our Editorial Board: millions of motorists worldwide. In motor sport, it administers cover story examines its new rules and the challenges JEAN TODT, OLIVIER FISCH the rules and regulations for all they will bring. Despite the unexpected departure of GERARD SAILLANT, international four-wheel sport, SAUL BILLINGSLEY including the FIA Formula One Volkswagen, I am sure next season will provide a great Editor-in-chief: LUCA COLAJANNI World Championship and FIA spectacle and attract an even wider audience. -

LAMBORGHINI MIURA 50Th ANNIVERSARY at 2016 AMELIA ISLAND CONCOURS D'elegance
LAMBORGHINI MIURA 50th ANNIVERSARY AT 2016 AMELIA ISLAND CONCOURS d'ELEGANCE Photos courtesy of Mr. Jerry Brubaker The 21st annual Amelia Island Concours d'Elegance will celebrate the 50th anniversary of the legendary Lamborghini Miura the car that changed the exotic car universe forever. The landmark Miura was introduced as a rolling chassis at the 1965 Turin Auto Salon. The new, mid-engine Lamborghini was a huge hit and remarkably, even without coachwork, orders were placed during the show. That vindicated the three men who conspired to create the Miura. Lamborghini engineers Bob Wallace, Gian Paolo Dallara and Paolo Stanzani worked secretly after hours to create the Miura. They had a tough sell to bring their clandestine mid-engine supercar project to life simply because the Miura concept was at odds with founder Ferruccio Lamborghini's original philosophy. But it worked. Lamborghini gave his engineers a free hand believing that the the Miura was radical and exotic enough that it might become a potent marketing tool even if it didn't sell. He was correct beyond his wildest dreams. Named for an especially ferocious strain of Spanish fighting bull, the Miura made its debut at the 1966 Geneva motor show. The advanced P400 (its model number: posteriori four-liter with its V12 engine mounted transversely) stole the show. When it was parked in front of the Casino in Monte Carlo during Grand Prix weekend alarm bells sounded from Stuttgart to Coventry and especially in Maranello and Modena. "The Miura rewrote the rules," said Bill Warner, founder and Chairman of the Amelia Island Concours d'Elegance. -

Corso Di Laurea in Strategia, Management E Controllo
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA FACOLTÀ DI ECONOMIA CORSO DI LAUREA IN STRATEGIA, MANAGEMENT E CONTROLLO TESI DI LAUREA MAGISTRALE RICERCA DELL’ECCELLENZA E STRATEGIE DI OUTSOURCING: IL CASO PAGANI AUTOMOBILI S.P.A. RELATORE: Chiar.ma Prof.ssa Lucia TALARICO CANDIDATO: Gianluca PISANI ANNO ACCADEMICO 2013 - 2014 Ai miei genitori, Letizia ed Elena INDICE Prefazione………………………………………………………………… 11 1. L’OUTSOURCING 1.1 Definizione di outsourcing e di core business……………………….. 13 1.1.1 Definizione di outsourcing……………………………………... 13 1.1.2 Definizione di core business …………………………………… 20 1.2 La storia……………………………………………………………... 23 1.3 La teoria economica…………………………………………………. 33 1.3.1 Esternalizzazione e teoria dell’impresa……………………….. 33 1.3.2 Esternalizzazione e costi di produzione………………………. 34 1.4 Gli attori coinvolti…………………………………………………... 39 1.5 Motivi per cui si esternalizza……………………………………….. 40 1.6 Quando e cosa si esternalizza……………………………………….. 47 1.7 Distinzione tra outsourcing e altre forme di esternalizzazione……… 58 1.8 Tipologie di outsourcing…………………………………………….. 60 1.9 Tre macro-categorie: esternalizzazioni sempre più spinte………….. 65 1.10 Chi decide………………………………………………………….. 71 1.11 Le fasi di implementazione di una strategia di outsourcing……….. 73 1.11.1 L’identificazione e la scelta dell’outsourcer…………………. 78 1.11.2 La negoziazione……………………………………………… 83 1.11.3 Il contratto di esternalizzazione……………………………… 89 1.11.4 I controlli……………………………………………………... 104 1.12 I vantaggi…………………………………………………………… 109 1.13 I rischi organizzativi, strategici, economici e operativi…………….. 117 1.14 Da fornitore a partner……………………………………………….. 133 2. IL CASO PAGANI AUTOMOBILI S.P.A 2.1 La storia……………………………………………………………… 137 2.1.1 Horacio Pagani: le origini e gli studi ………………………… 137 2.1.2 L’arrivo in Italia: Ferrari e Lamborghini ……………………. -
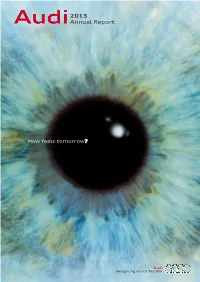
2013 Annual Report
2013 Annual Report How feels tomorrow? PHOTOS : Hubertus Hamm The technologies of the future are intelligent systems that adapt perfectly to different situations. Like our Audi Matrix LED headlights. 01_Portfolio_ENG.indd 3 17.02.14 20:00 01_Portfolio_ENG.indd 4 17.02.14 20:00 For more than 33 years, it has stood for a dynamic and safe driving sensation – and is always reinventing itself. Our quattro drive. 01_Portfolio_ENG.indd 5 20.02.14 08:45 Smart, informative and focused on the driver. The Audi virtual cockpit allows you to experience Vorsprung durch Technik. 01_Portfolio_ENG.indd 6 17.02.14 20:00 01_Portfolio_ENG.indd 7 17.02.14 20:00 Zero local emissions and an impressive range. With tron technologies we are shaping the transition to sustainable mobility. Without any compromises. 01_Portfolio_ENG.indd 8 17.02.14 20:00 We feel tomorrow. 01_Portfolio_ENG.indd 9 17.02.14 20:00 THINK … Innovations that make a statement for the next generation. Which ideas will we use to shape the future ? CONTENTS 010 … LIGHT 01 Making light work of it New materials, sustainable production processes. That’s the Audi lightweight construction principle. // 022 … FORWARD Time for a one-two 02 Prof. Rupert Stadler, Chairman of the Board of Management of AUDI AG, and Pep Guardiola, star coach of FC Bayern Munich, talk about victory and defeat. // 028 … URBAN 03 A leap in time How urban mobility might look if the vision becomes reality. // 035 … FUTURE 04 Driving by heart Nicole Zdebel normally flies a Boeing 777. For us she tests piloted driving. -

Diapositiva 1
Italian Design | 1945 - 2016 | Made in Italy The Italian design saw, from the Post-war period to the end of the century, a series of remarkable mutations dued to the change of the economic conditions, to the new technological discoveries (materials and construction techniques) and to a few cultural developments, particularly in the relationship with the past, expressing itself in different fields (from furniture to lighting, from living to mobility) and according to different approaches and languages. A synthetic selection of 20 historical projects highlights that, even in their heterogeneity, the project processes are determined by four recurring conceptions: the product as an emblem of cultural and social mutations, the product as a life- quality enhancing device, the product as a rielaboration of historical references, the product as a research of the detail. design as c r e at i v e i n tu iti o n Designer figure F i r s t ly b a s e d on personal creativity a n d c o m pa n y k n o w h o w D e s i g n wa s t r i a l product Design M a d e i n i t a ly TS502 RADIO The development of the radio broadcastings in the Sixties, the request of new devices and the definition of new technological and aesthetic principles grows up very quickly. From this point of view, the TS502 radio experiments innovative principles: it consists in two cubic plastic caps, joined through an hinge, that can rotate allowing different configurations between the open and the close one, with an extractable antenna and an handle that permits a more comfortable transportation. -

Ws Renault 3.5 Aerodynamics Simulator
Nr. 23 Year 2012 MAGAZINE PUBLISHED BY DALLARA "Periodico regolarmente registrato presso il Tribunale di Parma (n.16, 03/09/2010)" WS RENAULT 3.5 THE CATEGORY, BASED ON A SUCCESSFUL COLLABORATION BETWEEN DALLARA AND THE FRENCH MOTOR MANUFACTURER, CONTINUES TO GROW AS PERFORMANCE LEVELS REACH THOSE OF THE MORE PRESTIGIOUS COMPETITIONS. VITTORIO GHIRELLI, THE YOUNG ITALIAN DRIVER, WHO HAS ALSO RACED IN GP3 IN THE PAST, EXPLAINS THE CHARACTERISTICS OF THE NEW CAR, AND THE AERODYNAMICS COMMITMENT NECESSARY TO TAKE IT TO THE LIMIT THE APPEAL AND THE DIFFICULTIES OF DESIGN, IN THE WORDS OF DIALMA ZINELLI, THE ENGINEER WHO WAS ACCLAIMED THE “BEST AERODYNAMIC DESIGNER IN THE WORLD” IN 2008. IN A WORLD OF MOTORSPORTS THAT IS INCREASINGLY COMMITTED TO TECHNOLOGICAL INNOVATION, COMPUTERS AND TALENT COME TOGETHER TO OFFER TEAMS AND CUSTOMERS TOP PERFORMANCE, AT COMPETITIVE PRICES SIMULATOR THE FUTURISTIC MACHINE CAPABLE OF REPRODUCING TRACK CONDITIONS TO A HIGH DEGREE OF ACCURACY AT VARANO, NOW PROVIDES DRIVERS WITH AN EXTRAORDINARILY REALISTIC RACING EXPERIENCE IN THE COMPLETE RANGE OF DALLARA CARS. AND WITH A DATABASE THAT COVERS ALL THE MOST IMPORTANT CIRCUITS IN THE WORLD DALLARA AUTOMOBILI WAS FOUNDED IN 1972 IN VARANO DE’ MELEGARI. BUT THE YOUNG ENGINEER, GIAN PAOLO DALLARA, HAD ALREADY GAINED IMPORTANT EXPERIENCE AT FERRARI, MASERATI AND LAMBORGHINI, THREE KEY NAMES IN ITALIAN MOTORING. TO CELEBRATE THE 40TH ANNIVERSARY OF A COMPANY THAT HAS BECOME A SIGNIFICANT PLAYER IN NATIONAL AND INTERNATIONAL MOTORSPORTS IN ITS OWN RIGHT, WE PRESENT A FASCINATING EXTRACT FROM THE INTERVIEW WITH GIAN PAOLO DALLARA PUBLISHED IN THE BOOK “E’ UNA BELLA STORIA” (“IT’S A BEAUTIFUL STORY”) Engineer, you graduated in aeronautical who owned a road construction firm, often I wasn’t involved in the racing activities, but engineering, so what prompted the took me to see the races. -

Dallara Automobili Has Been Described As
160 180 200 140 220 120 240 100 260 80 280 60 300 km/h 40 20 0 Customer case | DALLARA AUTOMOBILI Dallara Automobili has been described as “the most successful racing car builder of modern time.” What’s its secret? TEXT CLAUDIA FLISI PHOTO MAURIZIO CAMAGNA Maximum velocity 10 evolution.skf.com #4 2012 ngineer Gian Paolo Dallara has Gothenburg, Sweden, in an apprenticeship at SKF. never been afraid of speed, on or off The experience served to improve his English and the racetrack. Quite the contrary: introduce him to SKF’s corporate culture. He built a company by seeking it “I saw how they worked,” he says, “and since then, out. Today, Dallara Automobili is bearings and SKF are synonymous in my mind. “theE world’s largest, most influential and most Throughout my career, whenever I had a choice successful racing car builder of modern time,” among components, I saw that it always paid to according to Motor Sport magazine. choose the high-quality option.” Although the company’s reach is global, its roots Quality has been a hallmark of Dallara’s own echo those of its founder, who was born a few metres career path. After graduation, he started at Ferrari from the company’s current headquarters in Varano in the technical department. Here, his nascent pas- Melegari, near Parma in northern Italy – and he still sion for car racing was fanned, and three years later lives in the same house. he followed it to Maserati. His first job there was to Gian Paolo Dallara earned his engineering follow the Cooper-Maserati Sebring 12 Hours. -

20130511 Conclusione Grande Giro Lamborghini 50 Anniversario EN
Automobili Lamborghini S.p.A. Press Release Lamborghini’s 50th Anniversary: a nnn extraordinary evening in Sant’Agata Bolognese for over 1,000 guests Communications and External Relations • Stephan Winkelmann, President and CEO of Automobili Raffaello Porro Lamborghini S.p.A., said: ‘‘‘‘‘‘I‘‘ I would like to thank all those people [email protected] whose perseverance and dedication contributed to creatingcreating the Lamborghini legendlegend....’’’’’’’’ Press Office - Italy and Southern • Rupert Stadler, Chief Executive Officer of AUDI AG, announced: Europe ‘‘‘‘‘‘Lamborghini‘‘ Lamborghini Urus will be produced in 2017.2017.’’’’’’’’ Chiara Sandoni • The 50th Anniversary Aventador LP 720720----44 Roadster displayed at [email protected] its woworldwiderldwide debut • Walter De Silva’s tribute: the Lamborghini Egoista Press Office - Northern Europe Gerald Kahlke [email protected] Sant’Agata Bolognese, May 131313,13 , 2013 - The Lamborghini 50th Anniversary Grande Giro came to an end Saturday, 11 May. 350 super sports cars made their triumphal entry at Lamborghini headquarters after travelling from Press Office --- UK and Middle East Bologna to Sant’Agata Bolognese, past staring onlookers, flashing cameras and applauding citizens and enthusiasts. Juliet Jarvis [email protected] Guests Over 1,000 people were invited to the exclusive gala dinner at the factory. Many were illustrious guests, including Prof. Rupert Stadler, Chief Executive Press Office - North and South Officer of AUDI AG, together with other members of the Board of America Management and the Supervisory Board of AUDI AG and Volkswagen Group, Kevin Fisher and people who contributed to creating the Lamborghini legend: Gian Paolo Dallara, Mauro Forghieri, Paolo Stanzani, designers Marcello Gandini and [email protected] Filippo Perini, former Commercial Director Ubaldo Sgarzi, former tester Valentino Balboni, Fabio Lamborghini and Claudio Domenicali, CEO of Ducati. -

Beltrami Dallara Golfo Dei Poeti 12 Marzo 2015
Noi di 23/03/2015 1 Gian Paolo Dallara Gian Paolo Dallara • Laurea in ingegneria aeronautica (1959) al Politecnico di Milano a 23 anni • Ferrari (1959): assistente dell’ingegner Carlo Chiti, all’epoca direttore tecnico del Reparto Corse di Maranello • Maserati (1961): progettazione della vettura Sport Tipo 64 e della vettura GT Tipo 151. • Lamborghini (1963): dirige l’equipe di tecnici Ferrari e Dallara prima di una gara a Varano che nel 1966 fa nascere una delle più belle Gran Turismo del Toro, la Miura. • De Tomaso (1969): Formula 2 e l’anno dopo la F.1, gestita in pista da Frank Williams. Nel 1973-74, è consulente per monoposto di Formula 1 Marlboro Williams • “Dallara Automobili da Competizione” (1972): fonda la sua azienda a Varano de’ Melegari La Miura davanti allo stabilimento Dallara 23/03/2015 2 Le competenze distintive Le competenze chiave Dallara: 1. Progettazione usando materiali compositi Produzione e sviluppo prototipi - Testing esterno Stile/ Concept / Regolamenti 2. Aerodinamica: CFD e galleria 3. Dinamica veicolo: testing e simulatore Dove lo facciamo Varano Melegari (Parma) 23/03/2015 4 Dove lo fa Indianapolis (Indiana) 23/03/2015 5 La nostra mission “Il nostro scopo è progettare e produrre le vetture da competizione più veloci e sicure al mondo” Gian Paolo Dallara 23/03/2015 6 Come si è evoluta l’azienda 1972 Dallara, prototipo sport (1000-cc) 1975 Dallara X 1/9 1978 Lancia Beta Montecarlo 1982-83 Lancia LC1 – LC2 23/03/2015 7 Come si è evoluta l’azienda 1978 Prima F3 e primo titolo italiano nel 1980 1984 Prima galleria -

Il Sale» Dell'economia
Lunedì, 1 Giugno 2015 www.corrieredibologna.it L’intervista Il punto Il trend Nerio Alessandri Fondazioni al bivio, Attenzione ai clienti, stage (Technogym): «Wellness come ridurre e chilometro zero: nuovo Rinascimento» le quote nelle Casse i bar cambiano pelle 5 7 12 IMPRESE L’ECONOMIA, GLI AFFARI, LE STORIE DELL’EMILIA-ROMAGNA L’analisi Manifattura, «il sale» dell’economia di Franco Mosconi ono davvero ragguardevoli i numeri dell’operazione Audi-Lamborghini Ssullo stabilimento di Sant’Agata Bolognese: 700- 800 milioni di investimenti, La parata delle 350 500 nuovi posti di lavoro Lamborghini che diretti (più l’indotto), il hanno sfilato nel raddoppio della superficie 2013 a Bologna per dagli attuali 80.000 metri il 50esimo quadrati, 3.000 unità anniversario della all’anno prodotte, a regime, casa di Sant’Agata del nuovo suv. Bolognese Di più: l’operazione, giustamente celebrata dal mondo politico- istituzionale, imprenditoriale e sindacale, rappresenta un nuovo anello — un prezioso anello — di una ormai lunga catena di investimenti diretti esteri (Ide) «in entrata», qui, nella nostra regione. L’inchiesta pubblicata da questo giornale dà conto di questo flusso. Ognuna di queste operazioni ha, innanzitutto, un grande valore in sé. Per restare all’ultimissima, si pensi all’ennesimo balzo tecnologico, con la «gran parte» dei più di 500 neo- assunti che — per dirla con le parole di Stephan Winkelmann, presidente e ad di Lamborghini — saranno «impiegati nel settore ricerca e sviluppo, nell’area ingegneristica e Non solo Lamborghini nella produzione». Le stesse considerazioni potrebbero essere ripetute per l’altra notissima operazione L’investimento dell’Audi nella casa del Toro per il nuovo suv Urus non è che l’ultimo di una bolognese condotta in porto da Philip Morris; per quella degli americani di lunga serie: le multinazionali hanno riscoperto l’Emilia. -

Les Lamborghini a L'honneur Chez Osenat !
LES LAMBORGHINI A L’HONNEUR CHEZ OSENAT ! 845 000€ POUR L’UNE DES PLUS AUTHENTIQUES LAMBORGHINI MIURA P400S A FONTAINEBLEAU 206 400 € POUR UNE LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640-4 ROADSTER La Lamborghini Miura fait partie de ces mythes automobiles ! « L’on achète une Ferrari lorsque l’on veut devenir quelqu’un, l’on achète une Lamborghini lorsque l’on est déjà quelqu’un » Franck Sinatra Le Mercredi 27 Mai 2020, la Maison de ventes Osenat a organisé une importante vente d’automobiles de collection qui a suscité un vif intérêt auprès des collectionneurs internationaux avec 80% de produit vendu. Toutes les nationalités étaient représentées dont des italiens, belges, allemands, espagnols mais aussi des américains, suisses, australiens, chinois, Dubaïotes et bien d’autres. L’automobile la plus attendue était, sans conteste, La Lamborghini Miura P400S qui fait partie de ces mythes automobiles et qui a été vendue 850 000 € (lot 128). Une Lamborghini Murcielago LP640-4 Roadster obtenait, quant à elle, 206 400 €. La Lamborghini Miura fait partie de ces mythes automobiles qui marquèrent l’histoire de l’évolution mécanique… Elle est la première « supercar » de route à adopter un moteur en position centrale arrière, un V12 qui plus est, la plus noble des mécanique, le tout, dans le but de faire un pied de nez au Commendatore Enzo Ferrari et ses GT à moteur avant. Car oui, d’une altercation naquit une légende, celle des automobiles signées Ferruccio Lamborghini. La première apparition publique de celle qui deviendra Miura s’est faite en 1965, jetant un pavé dans la mare de la voiture de sport italienne.