Documento Di Orientamento, Parte II
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
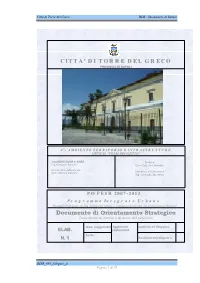
Documento Di Sintesi Torre Del Greco
Città di Torre del Greco DOS - Documento di Sintesi CITTA’ DI TOR R E DEL GR ECO PROVINCIA DI NAPOLI 4 A - AMBIENTE TERTERRITORIO R ITOR IO E INFRINFRASTRUTTURE ASTR UTTUR E UFFICIO “TEAM PROGETTO” COORDINATORE 4a AREA Sindaco Ing. Giovanni Salerno On.le Dott. Ciro Borriello Documento elaborato da: Assessore all’Urbanistica Arch. Michele Sannino Sig. Giuseppe Speranza PO FESR 2007- 2013 ProgrPr ogr amma Int egr at o UrbanoUr bano “Riqualificazione della zona portuale e connessioni con la struttura urbana” Documento di Orientamento Strategico Documento di sintesi e di avvio del processo Data: maggio/2008 Aggiornato Sostituisce l’allegato n. ELAB. ottobre/2008 Scala: N. 1 Sostituito dall’allegato n. DDD_464_Allegato_A Pagina 1 di 79 Città di Torre del Greco DOS - Documento di Sintesi CITTÀ DI TORRE DEL GRECO (PROVINCIA DI NAPOLI) 4a AREA AMBIENTE TERRITORIO E INFRASTUTTURE Ufficio “Team Progetto” PO FESR 2007-2013 Programma Integrato Urbano “Riqualificazione della zona portuale e connessioni con la struttura urbana” Documento di Orientamento Strategico Documento di sintesi e di avvio del processo Ottobre 2008 DDD_464_Allegato_A Pagina 2 di 79 Città di Torre del Greco DOS - Documento di Sintesi INDICE PREMESSA 1. ANALISI DI CONTESTO 1.1 Descrizione del contesto urbano 1.1.1 Caratteristiche generali del territorio 1.1.2 Rete dei trasporti 1.1.3 Patrimonio storico-architettonico ed ambientale 1.1.4 Aspetti demografici 1.1.5 Andamento socio-economico 1.2 Analisi SWOT 1.3 Conclusioni dell’analisi di contesto 2. CONTESTO DI RIFERIMENTO E STRUMENTI NORMATIVI 2.1 Contesto di riferimento 2.2 Regime urbanistico e vincolistico vigente 2.3 Strumenti di pianificazione sovracomunali 2.4 Programmazione regionale in materia di PIU’ 3. -

Ministero Della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Regionale Per La Campania Allegato Profilo Professionale
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA ALLEGATO PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTE TECNICO 0001) ABETE VINCENZO nato il 28/10/1951 a SANT'ANASTASIA CODICE FISCALE: BTAVCN51R28I262W SEDE DI TITOLARITA': NAIS001001 I.S. - ITC - IPC - "L. PACIOLI COMUNE DI : SANT'ANASTASIA DATA DI DECORRENZA DEL BENEFICIO: 01/09/2006 0002) ACCARINO PASQUALE nato il 06/05/1946 a NAPOLI CODICE FISCALE: CCRPQL46E06F839E SEDE DI TITOLARITA': NAIS051002 I.S. CASANOVA-NAPOLI- COMUNE DI : NAPOLI DATA DI DECORRENZA DEL BENEFICIO: 01/09/2006 0003) ACUNZO EDOARDO nato il 29/07/1951 a NAPOLI CODICE FISCALE: CNZDRD51L29F839O SEDE DI TITOLARITA': NARI22000P IPIA -MIANO-NAPOLI- COMUNE DI : NAPOLI DATA DI DECORRENZA DEL BENEFICIO: 01/09/2006 0004) ALFIERI GIOVANNI nato il 04/02/1957 a PALMA CAMPANIA CODICE FISCALE: LFRGNN57B04G283H SEDE DI TITOLARITA': NAIS01800A I.S. - IPCT - ITC - ITAGR - SA COMUNE DI : SAVIANO DATA DI DECORRENZA DEL BENEFICIO: 01/09/2006 0005) ALTAMURA SERGIO nato il 02/08/1945 a NAPOLI CODICE FISCALE: LTMSRG45M02F839C SEDE DI TITOLARITA': NATF130009 ITI L.GALVANI-GIUGLIANO- COMUNE DI : GIUGLIANO IN CAMPANIA DATA DI DECORRENZA DEL BENEFICIO: 01/09/2006 0006) ALTOBELLI GIUSEPPE nato il 18/03/1954 a ACERRA CODICE FISCALE: LTBGPP54C18A024X SEDE DI TITOLARITA': NATF18000A ITI "CARLO EMILIO GADDA" COMUNE DI : NAPOLI DATA DI DECORRENZA DEL BENEFICIO: 01/09/2006 PAG. 1 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 0007) AMATO MARINA nata il 24/04/1962 a NAPOLI CODICE FISCALE: MTAMRN62D64F839C SEDE DI TITOLARITA': NAIS051002 I.S. CASANOVA-NAPOLI- COMUNE DI : NAPOLI DATA DI DECORRENZA DEL BENEFICIO: 01/09/2006 0008) AMMIRATI FRANCESCO nato il 09/08/1953 a PALMA CAMPANIA CODICE FISCALE: MMRFNC53M09G283Q SEDE DI TITOLARITA': NATF07000V L. -

Step Into Strode to Get You Goin G…… .. Naples – Caught in a Volcanic
Step into Strode Course Title: A Level Geography Welcome to Step into Strode at Strode College. In the table below, you will find questions to consider, tasks to complete and some background research to undertake. This is a 4-week programme that will enable you to engage with your future study programme and teaching team. Please read the instructions below and have a go at the activities, remember you are capable. If you struggle at any point, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) section at the bottom for guidance and help. To Our focus for these sessions is going to be volcanic hazards of the Bay of Naples. get you WEEK 1 Watch Napoli SSC fans recreate an eruption of their local volcano, whose outline is goin the symbol of the city: g…… https://www.youtube.com/watch?v=o129p8lgj58 .. I will give an introductory talk after which you will be able to complete this quiz: Naples – Caught in a Volcanic Sandwich Somma-Vesuvius and the Campi Flegrei Find the right answer (answers next session): 1. Vesuvius last erupted in 1631, 1944, AD79. 2. The biggest killer eruption was 3780 BP, 1631, 1944. 3. The red zone population is 60,000, 600,000, 6m. 4. The most recent volcanic fatalities were in: Naples, Vesuvius, Campi Flegrei. 5. The prevailing wind is from the west, east, south. 6. Naples Airport is called Capodichino, Galileo, Leonardo da Vinci. 7. The local motorway is called Autostrada del Pizza, Autostrada del Sud, Autostrada del Sole. 8. The most vulnerable town is Sorrento, Sarno, Acerro, Torre del Greco. -

Human Responses to the 1906 Eruption of Vesuvius, Southern Italy
ÔØ ÅÒÙ×Ö ÔØ Human responses to the 1906 eruption of Vesuvius, southern Italy David Chester, Angus Duncan, Christopher Kilburn, Heather Sangster, Carmen Solana PII: S0377-0273(15)00061-X DOI: doi: 10.1016/j.jvolgeores.2015.03.004 Reference: VOLGEO 5503 To appear in: Journal of Volcanology and Geothermal Research Received date: 19 December 2014 Accepted date: 4 March 2015 Please cite this article as: Chester, David, Duncan, Angus, Kilburn, Christopher, Sangster, Heather, Solana, Carmen, Human responses to the 1906 eruption of Vesu- vius, southern Italy, Journal of Volcanology and Geothermal Research (2015), doi: 10.1016/j.jvolgeores.2015.03.004 This is a PDF file of an unedited manuscript that has been accepted for publication. As a service to our customers we are providing this early version of the manuscript. The manuscript will undergo copyediting, typesetting, and review of the resulting proof before it is published in its final form. Please note that during the production process errors may be discovered which could affect the content, and all legal disclaimers that apply to the journal pertain. ACCEPTED MANUSCRIPT March 3 2014 Human responses to the 1906 eruption of Vesuvius, southern Italy David Chestera,b, Angus Duncanb, Christopher Kilburnc, Heather Sangsterb and Carmen Solanad,e a Department of Geography and Environmental Science, Liverpool Hope University, Hope Park Liverpool L16 9JD, UK; bDepartment of Geography and Planning, University of Liverpool, Liverpool L69 3BX, UK; cAon Benfield UCL Hazard Research Centre, University College London, Gower Street, London WC1E 6BT, UK; dSchool of Earth and Environmental Sciences, University of Portsmouth, Portsmouth PO1 2UP; eInstituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), Puerto de la Cruz, Canary Islands, Spain. -

Arch. Stefania DURACCIO – Via Salute N°19 Portici (NA)
Arch. Stefania DURACCIO – via Salute n°19 Portici (NA) INFORMAZIONI PERSONALI CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM Arch. Stefania Duraccio VIA SALUTE 19 – PORTICI (NA) [email protected] ITALIANA FIRENZE - 17/09/1964 ORDINE ARCHITETTI DELLA PROV. DI NAPOLI N. 4897 ESPERIENZA LAVORATIVA ALL’ATTUALITÀ Dirigente ex art. 110 del D.Lgs 267/2010 dei settori LL.PP. - tutela ambiente e Urbanistica – assetto del territorio del comune di Nola 01 FEBBRAIO 2015 AL 2.05.2015 Dirigente ex art.110 del D.Lgs. 267/200, ad interim dei Settori Lavori pubblici - urbanistica ed Ambiente del Comune di Nola ; 01 FEBBRAIO 2013 AL 31.01.2015 Dirigente, ex art.110 del D.Lgs. 267/200, del Settore Ambiente del Comune di Giugliano in Campania (NA) e responsabile dell’ufficio VAS FEBBRAIO 2005 AL GENNAIO 2013; Funzionario (categoria D3) con posizione apicale e qualifica di Capo Servizio Urbanistica – Settore gestione del territorio del Comune di San Giorgio a Cremano - Responsabile degli uffici che afferiscono alle UOC del Servizio con delega di alcuni provvedimenti di competenza dirigenziale ; 1.07.2005 al 1.07.2006 Incarico di P.O. servizio Urbanistica - Settore gestione del territorio del Comune di San Giorgio a Cremano 2011-2013 Membro del COC (Centro Operativo Comunale ) Servizio Protezione Civile del Comune di San Giorgio a Cremano – Responsabile del censimento danni DICEMBRE 1998 AL GENNAIO 2005 Albo Architetti prov. di Napoli n. 4897 – CF DRC SFN 64P57 D612L Cell. 3388316091 - mail [email protected] Arch. Stefania DURACCIO – via Salute n°19 Portici (NA) Funzionario ( categoria D3) con posizione apicale e qualifica di Capo Servizio Lavori Pubblici del Comune di San Giorgio a Cremano con responsabilità afferente l’organizzazione degli uffici del Servizio per il raggiungimento obiettivi assegnati con delega di presidente di gara in molteplici procedure di appalto ; DAL 1992 1998 Svolge attività di Libero professionista con incarico da parte di P.A. -

Arcidiocesi Di Napoli Necrologio Diocesano Ottobre Giorno Anno Morte Cognome Nome Luogo Nascita Data Nascita Scheda Personale
ARCIDIOCESI DI NAPOLI NECROLOGIO DIOCESANO OTTOBRE GIORNO ANNO COGNOME NOME LUOGO DATA NASCITA SCHEDA MORTE NASCITA PERSONALE 1 1847 SCALCINO GAETANO 1817 *2 1912 ASCIONE BERNARDINO Torre del Greco 1839 *2 1935 PAPOFF FRANCESCO Napoli 1888 *2 1938 BIONDI DOMENICO Mugnano 1853 *2 1943 CAPASSO NICOLA *1 1943 IMPERATORE PASQUALE *1 1943 ROSSETTI ROLANDO Cagliari 15.09.1915 *1 1943 VALLEFUOCO LUIGI *1 1975 MALASOMMA VINCENZO Napoli 12.12.1898 *1 2 1844 DE ANGELIS ANGELA Casandrino 1774 *2 MARIA tod 1891 DE MARCO VINCENZO Napoli 1820 *2 1912 SCHETTINO BIAGIO Napoli 1836 *2 1915 VECCHIONE FRANCESCO Napoli 1859 *2 1918 RAIOLA LUIGI Napoli 1836 *2 1930 FUORTO ALFONSO Napoli 1871 *2 1932 D’ACUNTO GIORGIO S. Giorgio a 1881 *2 Cremano 1936 GIARDINO FORTUNATO 1860 *2 3 1816 CHIRMENTI NICOLA Napoli 1741 *2 1853 ANNICELLI LUIGI Napoli 1817 *2 1855 PASCA GENNARO Napoli 23.01.1778 *2 1870 GALIANO GAETANO Napoli 1808 *2 1918 IORIO MARCO Afragola 1867 *2 1941 CESA VINCENZO Napoli 28.01.1870 *2 1998 GIANNINI VITO c. m. 1926 *1 4 1602 GIACOMO ofm capp *2 1917 BORZACCHIELLO Casalnuovo 1853 *2 DOMENICO 1922 CIPOLLETTA DOMENICO Mugnano 07.10.1865 *1 1924 CACACE GENNARO Napoli 1843 *1 5 1874 PALUMBO LUIGI Napoli 1820 *2 1907 SOLOFRANO SALVATORE Napoli - 1839 *2 Posillipo 1925 RICCARDI GIOVANNI Napoli 1837 *2 1926 RICCARDI GIOVANNI Napoli 1838 *2 1943 DI PALMA ANTONIO 1869 *2 1995 MUSELLA GENNARO 10.09.1925 *2 6 1963 CAPUTO LUIGI Afragola 08.12.1899 *2 7 1852 AMATO GIOVANNI 1764 *2 1882 D’AMATO GIUSEPPE Torre del Greco 1833 *2 1897 PINTO ANDREA Torre del Greco -

Registro Praticanti Abilitati ACA
Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata - Registro Praticanti Abilitati ACA COGNOME E NOME Luogo e data di nascita RECAPITI PROFESSIONALI RECAPITI TELEFONICI Codice Fiscale e Partita IVA email Data scadenza abilitazione ACAMPORA VALERIO C/O AVV. TEODORO ANASTASIO 081/8783675 PIANO DI SORRENTO - 25/09/1990 VIA CARACCIOLO 110 333/8300455 CMPVLR90P25G568P - 80062 - META 14/07/2022 [email protected] ALFANO MASSIMO C/O AVV. PASQUALE SERGIO 081/8703861 CASTELLAMMARE DI STABIA - 12/07/1985 VIA TAVERNOLA 41/B 393/5233260 LFNMSM85L12C129U - 80053 - CASTELLAMMARE DI STABIA 10/02/2022 [email protected] AMARANTE ANNA C/O AVV. NICOLA VERDE 338/6356683 SCAFATI - 05/03/1988 VIA G. ROCCA 24 MRNNNA88C45I483N - 80041 - BOSCOREALE 08/09/2022 [email protected] ANGELLOTTI MARIANNA C/O AVV. ANNA D'ANTUONO 081/8702672 GRAGNANO - 13/08/1986 VIA SANTA CATERINA 15 320/7747367 NGLMNN86M53E131H - 80054 - GRAGNANO 18/03/2023 [email protected] ANNUNZIATA FAUSTA C/O AVV. SERGIO NITRATO IZZO 081/8585473 CASTELLAMMARE DI STABIA - 29/05/1988 CORSO VITTORIO EMANUELE III 365 338/9673052 NNNFST88E69C129V - 80058 - TORRE ANNUNZIATA 15/09/2022 [email protected] AVELLINO MARILENA C/O AVV. ALFREDO FIORENTINO 081/8787008 VICO EQUENSE - 14/08/1982 VIA LUIGI DE MAIO 5 333/1782039 VLLMLN82M54L845Y - 80067 - SORRENTO 31/05/2022 [email protected] Pagina 189 Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata - Registro Praticanti Abilitati BIL COGNOME E NOME Luogo e data di nascita RECAPITI PROFESSIONALI RECAPITI TELEFONICI Codice Fiscale e Partita IVA email Data scadenza abilitazione BILOTTA UMBERTO C/O AVV. SEVERINO IVAN MARCELLO 081/7751070 TORRE DEL GRECO - 18/08/1973 VIA IGNAZIO SORRENTINO 20 347/7915603 BLTMRT73M18L259I - 80059 - TORRE DEL GRECO 10/02/2022 [email protected] BORRELLI BRUNO C/O AVV. -

Scarica Il Documento
DATI CATASTALI DEGLI INTERI APPEZZAMENTI SUPERFICIE DA OCCUPARE SUPERFICIE DITTA CATASTALE ha are ca FOGLIO NATURA N.ro DI PIANO N.ro D'ORDINE PARTICELLA al C.F. - SUB. Deviazioni Aree relitteAree temporanea Aree a Aree verde Occupazione Occupazione Asservimenti strade strade e canali Sede FerroviariaSede e sue e sue dipendenze I° parte BENI PRIVATI SOCIETA' AGRICOLA SAN SILVESTRO S.R.L. c.f. 1 1 15 8 SEMINATIVO 4 30 10 170 02514211214 PROPRIETA' SEMINATIVO CAPUTO ANGELO n. a AFRAGOLA il 04/04/1946 c.f. 2 2 16 698 IRRIGUO 3 64 55 215 CPTNGL46D04A064Q PROPRIETA' ARBORATO CALIENDO GAETANO n. a CASALNUOVO DI NAPOLI il SEMINATIVO 20/11/1961 c.f. CLNGTN61S20B905F LIVELLARIO, 3 3 17 457 IRRIGUO 14 16 25 PORRICELLI MADDALENA n. a POLLENA TROCCHIA il ARBORATO 20/06/1935 c.f. PRRMDL35H60G795J USUFRUTTO CALIENDO GIOVANNI n. a CASALNUOVO DI NAPOLI il 29/10/1963 c.f. CLNGNN63R29B905D LIVELLARIO, SEMINATIVO 4 4 17 453 26 83 110 PORRICELLI MADDALENA n. a POLLENA TROCCHIA il IRRIGUO 20/06/1935 c.f. PRRMDL35H60G795J USUFRUTTO DI PALO GIUSEPPE n. a TORRE DEL GRECO il SEMINATIVO 5 5 16/04/1973 c.f. DPLGPP73D16L259F PROPRIETA' 15 18 1 43 10 55 IRRIGUO 162/162 FRONTOSO ANNA n. a ACERRA il 21/04/1923 c.f. FRNNNA23D61A024M USUFRUTTUARIO PARZIALE SEMINATIVO PER, SEPE FRANCESCA n. a AFRAGOLA il 08/02/1957 6 6 15 12 IRRIGUO 1 39 50 370 c.f. SPEFNC57B48A064S PROPRIETA' 1/2, SEPE ARBORATO MARIA CONCETTA n. a AFRAGOLA il 08/01/1955 c.f. SPEMCN55A48A064U PROPRIETA' 1/2 BARRA DOMENICO n. -

Two Recent Developments in Italy Illustrate How Boeing Is Working
n FEATURE STORY Two recent developments in Italy illustrate how Boeing is working with top technology providers around the world—and helping strengthen a nation’s aerospace industry in support of Boeing’s cross-enterprise efforts OTO.COM H ISTOCKP Magnifico! 38 December 2007/January 2008 BOEING FRONTIERS n FEATURE STORY BY MAUREEN JENKINS Inside or Boeing, doing business in Italy is about more than Advanced research activities: Boeing and Alenia Aeronautica merely selling commercial airplanes or military aircraft. It’s recently signed a memorandum of understanding that calls for the Falso about leveraging the country’s high-tech and aerospace companies to jointly develop research activities in advanced materials infrastructure—and that includes its scientists and engineers— and integrated fuselage aircraft structures. Page 39 so that Italian companies can better compete in the global market- Educational collaboration: Through its connections and support, place. And with Italian corporations of all sizes partnering on key Boeing is helping strengthen the high-tech skill base of southern Italy Boeing programs, it’s critical that they be involved in the creation by facilitating a partnership between a university in the United States and development of advanced technologies. and one in Italy. Page 40 The next step in the frequent collaboration between Alenia Aeronautica and Boeing is a newly signed memorandum of un- derstanding, one where they’ll jointly develop research activities in advanced materials and integrated fuselage aircraft structures. The agreement also provides for the opening of a small Boeing Italian Research Office in the southern region of Campania, an area where government officials are keen on strengthening the high-tech skill base and creating jobs. -

CALENDARIO DEFINITIVO Campionato: Under 13 Maschile Elite Fase : Prima Fase - Italiana Girone : Girone a Gara N Squadra a Squadra B Giorno Data Ora
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO CR CAMPANIA Pagina 1 COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 21/10/2019 UFFICIO GARE Data: 21/10/2019 N. 97 Ora: 10:04:00 CALENDARIO DEFINITIVO Campionato: Under 13 Maschile Elite Fase : Prima Fase - Italiana Girone : Girone A Gara N Squadra A Squadra B Giorno Data Ora 1 Giornata di andata 3639 Kioko Basket Caserta Basket Team Stabia Lun 11/11/2019 20:00 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIALE MEDAGLIE D'ORO - CASERTA - (CASERTA) 3640 Sporting Portici Pol. Virtus Monte di Sab 09/11/2019 16:00 Procida Tendostruttura - C.so Umberto 1° Villa Comunale - PORTICI - (NAPOLI) 3641 75' Basket Casalnuovo ACSI Basket 90 Mer 13/11/2019 19:45 Palazzetto - Viale Dei Cedri, 66 - CASALNUOVO DI NAPOLI - (NAPOLI) 3642 Basket Casapulla S.S. Felice Scandone Sab 09/11/2019 18:00 Tendostruttura - Via Kennedy - CASAPULLA - (CASERTA) 2 Giornata di andata 3643 Pol. Virtus Monte di 75' Basket Casalnuovo Dom 17/11/2019 18:00 Procida PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Bellavista - MONTE DI PROCIDA - (NAPOLI) 3644 ACSI Basket 90 Kioko Basket Caserta Gio 21/11/2019 18:00 Palestra Ist. Amatucci - Viale Italia - AVELLINO - (AVELLINO) 3645 Basket Team Stabia Basket Casapulla Dom 17/11/2019 10:00 Tendostruttura Liceo Severi - L. D'orsi - CASTELLAMMARE DI STABIA - (NAPOLI) 3646 S.S. Felice Scandone Sporting Portici Dom 17/11/2019 12:00 Palestra Comunale Stadio Partenio - Via Zoccolari - AVELLINO - (AVELLINO) 3 Giornata di andata 3647 75' Basket Casalnuovo Sporting Portici Lun 25/11/2019 19:45 Palazzetto - Viale Dei Cedri, 66 - CASALNUOVO DI NAPOLI - (NAPOLI) 3648 Kioko Basket Caserta Pol. -

Torre Annunziata Centrale(05:05)
Categoria Corsa Origine Ora di partenza Destinazione Ora di arrivo Periodicità Provvedimento Note Si effettua giornalmente dal 10 maggio al 4 TORRE ANNUNZIATA CENTRALE(05:05); TORRE DEL GRECO(05:29-05:30); PORTICI-ERCOLANO(05:39-05:40); Bus NA02G Torre Annunziata Centrale 5:05 Napoli San Giovanni Barra 5:55 Confermato luglio 2021 PIETRARSA(05:49-05:50); NAPOLI S.GIOVANNI BARRA(05:55) Si effettua giornalmente dal 10 maggio al 4 NAPOLI S.GIOVANNI BARRA(05:10); PIETRARSA(05:14-05:15); PORTICI-ERCOLANO(05:14-05:25); TORRE DEL Bus NA01G Napoli San Giovanni Barra 5:10 Torre Annunziata Centrale 6:00 Confermato luglio 2021 GRECO(05:34-05:35); TORRE ANNUNZIATA CENTRALE(06:00) Si effettua giornalmente dal 10 maggio al 4 Bus NA12H Torre Annunziata Centrale 5:10 Napoli Centrale 5:50 Confermato TORRE ANNUNZIATA CENTRALE(05:10); TORRE A. CITTA'(05:19-05:20);NAPOLI CENTRALE (05:50) luglio 2021 Si effettua giornalmente dal 10 maggio al 4 Bus NA09H Napoli Centrale 5:15 Torre Annunziata Centrale 5:55 Confermato NAPOLI CENTRALE (05:15); TORRE A. CITTA'(05:44-05:45); TORRE ANNUNZIATA CENTRALE(05:55); luglio 2021 Si effettua giornalmente dal 10 maggio al 4 TORRE ANNUNZIATA CENTRALE(05:25); TORRE DEL GRECO(05:49-05:50); PORTICI-ERCOLANO(05:59-06:00); Bus NA04G Torre Annunziata Centrale 5:25 Napoli San Giovanni Barra 6:15 Confermato luglio 2021 PIETRARSA(06:09-06:10); NAPOLI S.GIOVANNI BARRA(06:15) Si effettua giornalmente dal 10 maggio al 4 NAPOLI S.GIOVANNI BARRA(05:30); PIETRARSA(05:34-05:35); PORTICI-ERCOLANO(05:44-05:45); TORRE DEL Bus NA03G Napoli San Giovanni Barra 5:30 Torre Annunziata Centrale 6:20 Confermato luglio 2021 GRECO(05:54-05:55); TORRE ANNUNZIATA CENTRALE(06:20) Si effettua giornalmente dal 10 maggio al 4 Bus NA14H Torre Annunziata Centrale 5:40 Napoli Centrale 6:20 Confermato TORRE ANNUNZIATA CENTRALE(05:40); TORRE A. -

Nature [April J 9, I 906
sss NATURE [APRIL J 9, I 906 THE ERUPTION OF VESUVIUS. During the first three or four days the dust plunged the towns in the immediate vicinity of the volcano into utter HE eruption of Vesuvius has quieted down since darknPss, and materially increased the panic that had T last week, though scorice and ash continue to alreadv set in. Even Naples was in a state of semi-dark be ejected and there still seems to be a slow flow of ness, from which it had hardly emerged on April 12. The lava, but in comparison with the activity of the erup roofs and roads seem to he inches deep in an extraor tion on April 8 the volcano is next time. dinarily fine, reddish-grey dust, which rises in dense clouds How soon or how long deferred this may be cannot behinu every carriage and foot passenger. be predicted, but the pause has enabled us to take In some places the drift of ash seems ·fully a yard deep; stock of events and form some estimate of this out at Ottajano and San Giuseppe in the lightest deposits it burst as compared with previous ones. The most must measure three inches. The great danger in both indeed, in most of the towns on the slopes important qualification of earlier reports is in regard of Vesuvius-would be a heavy rainfall and the formation to the reported flow of lava through the streets of of mud-torrents, which will more than complete the ruin Ottajano; an outburst of lava on the outer slope of already• begun by the lapilli.