Marianna Candidi Dionigi Tra Letteratura E Antiquaria
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Graduatoria Definitiva Mobilità Personale Educativo 2015-2016
GRADUATORIA DEFINITIVA MOBILITÀ PERSONALE EDUCATIVO A .S. 2015/2016 TRASFERIMENTI PROVINCIALI xxx PUNTEGGIO PUNTEGGIO PER DATA DI ORDINE DI PER ALTRI COMUNE COGNOME E NOME TITOLARITA ’ PRECEDENZA SEDI RICHIESTE NASCITA PREFERENZA COMUNI RICONGIUNGIMENTO RICCI ANTONIO 01/01/1962 ARPINO 173 IPSSAR Cassino - IPSSEOA Fiuggi ANAGNI PARSENA AURELIO 21/04/1959 154 IPSSEOA Fiuggi IPSSAR “M. BUONARROTI” – FIUGGI LANZA MAURO 05/12/1970 ARPINO 118 .I.S. “S. Benedetto” Cassino ARPINO GIANFRANCO 25/12/1960 ARPINO I.I.S. “S. Benedetto” Cassino - IPSSEOA Fiuggi 111 ANAGNI IPSSEOA Fiuggi BIANCHI ANTONIO 24/06/1960 101 107 ARPINO IPSSEOA Fiuggi - I.I.S. “S. Benedetto” Cassino GERMANI ORAZIO 20/09/1958 98 104 SACCO FERNANDA 01/08/1958 ANAGNI IPSSAR CASSINO - IPSSEOA FIUGGI 94 100 MORMILE RICCARDO 11/09/1959 ARPINO 90 IPSSAR “M. BUONARROTI” – FIUGGI IPSSEOA FIUGGI MANNI FERNANDO 11/06/1952 ANAGNI 70 Convitto Nazionale “Tulliano “ di Arpino DE ARCANGELIS MARCO 20/10/1962 ANAGNI 61 67 PROVINCIA DI Convitto Naz. Regina Margherita – Anagni D’A MICO MANUELA 20/11/1974 FROSINONE 48 54 - IPSSEOA Fiuggi - I.I.S. “S. Benedetto” Cassino IPSSEOA Fiuggi COPPOLA GIOVANNA 11/09/1956 ANAGNI 46 52 1 GRADUATORIA DEFINITIVA MOBILITÀ PERSONALE EDUCATIVO A .S. 2015/2016 TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI xxx PUNTEGGIO PUNTEGGIO PER DATA DI ORDINE DI COGNOME E NOME TITOLARITA ’ PER ALTRI COMUNE SEDI RICHIESTE NASCITA PREFERENZA COMUNI RICONGIUNGIMENTO Convitto “A. di Savoia Ipssar – Fiuggi – TURRIZIANI ERNESTO 31/01/1959 Duca d’Aosta”Tivoli Conv. Naz. “Reg. Margherita” – Anagni (RM) 151 157 I.C. “M.T. Cicerone” Arpino – Iis San Benedetto - Cassino Iis San Benedetto – Cassino Convitto Nazionale AVELLINO – CASERTA Convitto Annesso Cassino DE MARCO ROSARIO 02/07/1972 “Cicognini” - Prato - FROSINONE Convitto Tulliano – Arpino Ipsseoa “Buonarroti” – Fiuggi 63 Convitto “Regina Margherita” - Anagni Convitto “V. -

Plio-Pleistocene Proboscidea and Lower Palaeolithic Bone Industry of Southern Latium (Italy)
Plio-Pleistocene Proboscidea and Lower Palaeolithic bone industry of southern Latium (Italy) I. Biddittu1, P. Celletti2 1Museo Preistorico di Pofi, Frosinone, Italia, Istituto Italiano di Paleontologia Umana, Roma, Italy - [email protected] 2Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Rome, Italy [email protected] SUMMARY: Elephant remains were first reported from the Valle Latina, in inner southern Latium, in 1864, by O.G. Costa. Since, they have been discovered at some 20 sites, ranging in age from the Middle Villafranchian (Costa S. Giacomo, with both Anancus arvernensis and Mammuthus (Archidiskodon) meri- dionalis), to the Late Pleistocene (S. Anna near Veroli, with Mammuthus primigenius). Most of the relevant faunal record, however, is of Middle Pleistocene age, and is characterised by Elephas antiquus. This species was discovered, most notably, at several archaeological sites, in association with Acheulean industry, starting with Fontana Ranuccio near Anagni, which is dated to c. 450 ka bp by K/Ar. At such sites, bones of Elephas antiquus were sometimes knapped to produce bone tools, including bone handaxes. 1. PROBOSCIDEA IN THE VALLE LATINA Stephanorhinus cfr. S. etruscus, Equus stenon- is, Pseudodama cfr P. lyra, Eucladoceros cfr. E. The quaternary deposits in the Valle Latina tegulensis, Leptobos sp., Gazella borbonica, are rich in faunal finds. These include frequent Gazellospira torticornis, Canis cfr. C. etruscus, elephant bones that have been the subject of Vulpes cfr. V. alopecoides, Hyaenidae gen. sp. scientific interest since the second half of the indet. and Hystrix cfr. H. refossa (Cassoli & nineteenth century. Segre Naldini 1993; Palombo et al. -

Ponte Dell'immacolata in Ciociaria 5 – 6 – 7 – 8 Dicembre 2009 Arpino
Ponte dell’Immacolata in Ciociaria 5 – 6 – 7 – 8 dicembre 2009 Arpino, Alatri, Trisulti (FR) Sabato 5 dicembre Pomeriggio: arrivo nell’area di sosta Giardini dell’Acropoli – borgo di Civitavecchia di Arpino; Visita guidata del borgo Domenica 6 dicembre Mattina: Visita guidata di Arpino; Pomeriggio: Festival del mandolino di Arpino; Sera: trasferimento ad Alatri. Lunedi 7 dicembre Mattina: Visita guidata di Alatri; Pomeriggio: trasferimento a Trisulti Martedi 8 dicembre Mattina: Visita alla Certosa di Trisulti; Pomeriggio: Partenza per ritorno a casa Distanze percorse Salerno – Arpino: 185 km; Arpino – Alatri: 48 km; Alatri – Trisulti: 14 km; Trisulti – Salerno: 215 km (Totale: 462 km) Partecipanti circa 60 equipaggi in camper di cui 12 del “Salerno Camper Club” e 48 del club “Camperisti senza frontiere” Costi area di sosta, navetta e guide turistiche: 20 euro/equipaggio Sabato 5 dicembre Tempo bello, freddo, non piove. Verso le ore 15 usciamo da casa ed un’ora dopo siamo in camper pronti per partire. Ci godiamo questo comodo viaggio in solitaria con la mente proiettata alla “folla” di camper che ci attende: abbiamo notizia di una nutrita partecipazione del nostro “Salerno Camper Club” e trascorreremo questa piccola vacanza con gli amici di “Camperisti senza frontiere”. All’imbrunire siamo davanti all’area di sosta proprio mentre tutti i partecipanti si avviano verso il vicino borgo di Civitavecchia accompagnati, come previsto, dalla guida. Ci aiutano a sistemarci (per fortuna c’è ancora qualche posto comodo) ed in breve tempo anche noi siamo pronti per la prima visita dei luoghi. Ci avviciniamo al gruppo raggiungendoli sotto la Torre di Cicerone (in ristrutturazione e praticamente invisibile per i ponteggi allestiti e perchè completamente al buio). -

Analisi Della Disponibilità Idrica 2020
Analisi della Disponibilità Idrica 2020 Acea Ato 5 S.p.A. Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici (OPUI) Videoconferenza - 20 aprile 2020 1 Fonti Acea Ato5 S.p.A. VOLUME EMUNTO 2019 Volume emunto Altre fonti; = 108 Mln 33.525.259; 31% 10 fonti principali su Fonti principali; 109 74.656.388; 69% Comuni gestisti: 86 Fonti principali di prelievo 19,3 13,3 Popolazione servita: 9,6 9,4 473.096 ab. 7,2 6,6 3,3 2,4 1,9 1,6 MLN MC MEDI MC MLN Km di rete: 5.381 2 Fonti principali – inquadramento e Comuni serviti COMUNI APPROVVIGIONATI DA QUESTA SORGENTE Sora, Broccostella CARPELLO COMUNI APPROVVIGIONATI DA QUESTA SORGENTE Posta Fibreno, Broccostella, Sora, Vicalvi, Fontechiari POSTA Isola Liri, Arpino, Castelliri, Monte San Giovanni Campano, FIBRENO Veroli, Boville, Frosinone, Torrice, Ripi, Strangolagalli, Arnara, Ceccano, Pofi CAPO D’ACQUA DI CASTROCIELO COMUNI APPROVVIGIONATI DA QUESTA SORGENTE Castrocielo, Aquino, Piedimonte, Villa Santa Lucia Posta Fibreno Pontecorvo, Roccasecca, Colfelice, Arce, Fontana Liri, Ceprano Capo d’Acqua di Castrocielo Carpello 3 Disponibilità idrica 2020 CAPOD'ACQUA DI CASTROCIELO 5 POSTA FIBRENO 1600 260 Carpello : 2000 750 1400 240 Il trend delle portate ci dice che nel periodo critico a 700 1200 220 partire da giugno si è sempre verificato un aumento della 1500 650 1000 200 portata da emungere. L’anno 2019 ha visto il verificarsi di 600 800 180 una riduzione delle precipitazioni, e pertanto un peggioramento a livello di volumi richiesti. La previsione 1000 600 160 550 mm pioggia mm Portata Portata [l/s] per l’anno 2020 è una riduzione della portata, anche in 400 140 500 Portata [l/s] virtù dei dati registrati nel primo trimestre dell’anno pioggia mm 500 200 120 corrente. -

Arpinoand Surroundings
THE QUINTESSENCE OF ITALY ARPINO and surroundings through the eyes of ALFANO REAL ESTATE FOR MORE INFO ABOUT ITALIAN PROPERTIES CLICK ON WWW.GATE-AWAY.COM DID YOU KNOW ARPINO? Probably you have never heard of Arpino, but many overseas house-hunters already have… and some of them already own their piece of la dolce vita there. The interest of international would-be buyers in Italy is now always more focused on off-the-beaten-track destinations like Arpino in Ciociaria area of Lazio region − which mainly coincides with Frosinone province − and not only on the most famous locations like Florence, Venice and Rome just to name a few. It’s a must if… 1 YOU ARE LOOKING FOR AMAZING AFFORDABLE PROPERTIES You can find beautiful housing solutions at very affordable prices. Here are indicative average prices: House to be restored – from € 350 to € 550 / m² House ready to be lived in – from € 700 to € 1,100 / m² Brand new house – from € 1,200 to € 1,500 / m² But oh yes, if you are searching for a luxury home you’ll be literally spoiled for choice, especially if you like the idea of living in an elegant historic palazzo. 2 YOU WANT TO BE CLOSE TO A MAJOR AIRPORT Usually they have a higher number of routes as well as low-cost airlines. Arpino it's just 1.5 from either Naples or Rome airports. YOU LOVE THE BEACH BUT WANT TO LIVE FAR FROM 3 THE HUSTLE AND BUSTLE OF SEA RESORTS ... and because properties in coastal towns are more expensive than those situated inland. -

Un Ciociaro Al Giro D'italia
Sabato 15 Maggio 2004 SPORT 41 Il Giro d’Italia e la provincia di Frosinone nella storia La curiosità A CASTROCIELO Quel giorno di Coppi IL TRAGUARDO Nel 1985 l’ultimo arrivo in via Aldo Moro DEL SORRISO Quest’anno Frosinone n occasione del passaggio della raccoglierà da Itappa del Giro d’Italia Frosinone- Valmontone il testimone Montevergine l’Associazione per rilanciare il Giro Castrocielo Sport Emi radunerà d’Italia nella sua prima tutti i suoi ottanta tesserati a frazione impegnativa. Castrocielo sulla via Casilina pres- Frequentazione molto so il Bar Lanterna Blu, abituale più assidua ha avuto la ritrovo del sodalizio, per festeggia- Tirreno-Adriatico che nei re il passaggio della carovana rosa. suoi 38 anni di vita vi ha Verrà allestitito un colorato addob- fissato ben 28 sedi di bo per applaudire i partecipanti al tappa e Fiuggi per 11 Giro fra cui figurano molti prota- volte ha accolto la tappa gonisti della ‘Due Giorni Ciclistica di apertura. Frosinone di Pasqua’ come Figueras, a Ciociaria ha con il ha ospitato la Tirreno- D’Amore, Podgornik, Illiano, Lciclismo vincoli sal- Adriatico in 5 occasioni Strazzer, Marzoli. Al primo che dissimi. E’ una provincia (vittoria di Bettini nel- transiterà sotto lo striscione della che ha particolare voca- l’ultima); Cassino in 3; Il passaggio del Giro d’Italia nel 1947 in piazzale Vittorio Veneto. In testa Fausto Coppi Castrocielo Sport Emi, il premio zione per le ‘due ruote’. Alatri, Arpino ed Isola simbolico del sorriso dei tanti Il Giro d’Italia vi ha fatto del Liri in 2; Sora, ragazzi che vestono la casacca di tappa per la prima volta Ferentino e Santa Serena trionfò Nino De Filippis. -

Rally Di Roma Capitale 2020 Itinerary
RALLY DI ROMA CAPITALE 2020 Free Practice / Qualifying Friday 24 July 2020 Liaison Target First car TC LOCATION SS dist. Total dist. AVS dist. time due RZ Fiuggi - Refuel + QS Fumone - Start of Free Practice 07:00 FREE PRACTICE CLOSES AT 09:00 TCQS Fumone 09:27 QS Fumone - QUALIFYING STAGE 4,02 00:03 09:30 TCPF Fiuggi - Parc Fermé IN 13,25 17,27 00:30 34,54 10:00 Sunrise: Fiuggi 05:53 vers bull.1 - 18.06.2020 Totals 4,02 13,25 17,27 Sunset: Fiuggi 20:55 Shakedown Friday 24 July 2020 Liaison Target First car TC LOCATION SS dist. Total dist. AVS dist. time due RZ Fiuggi - Refuel (0,85) + (14,85) SD Shakedown Start 10:30 SD Fumone - SHAKEDOWN 4,02 SHAKEDOWN CLOSES AT 12:30 Sunrise: Roma 05:53 vers bull 1. - 18.06.2020 Sunset: Fiuggi 20:55 RALLY DI ROMA CAPITALE 2020 Start (Section 1) Friday 24 July 2020 Liaison Target First car TC LOCATION SS dist. Total dist. AVS dist. time due Roma Castel Sant'Angelo - Ceremonial Start and Roma Parade 17:15 Sunrise: Roma 05:53 vers bull 1. - 18.06.2020 Sunset: Fiuggi 20:55 RALLY DI ROMA CAPITALE 2020 Start (Sections 1 & 2) Saturday 25 July 2020 Liaison Target First car TC LOCATION SS dist. Total dist. AVS dist. time due Section 0 Fiuggi Service Out 07:40 RZ Ceprano - Refuel 1 Distance to next refuel (48,50) (77,17) (125,67) 1 Pico 71,35 71,35 01:30 46,53 09:10 SS 1 Pico-Greci 1 13,40 00:03 09:13 2 Caprile 20,69 34,09 00:46 46,33 09:59 SS 2 Roccasecca-Colle San Magno 1 13,93 00:03 10:02 3 Fraioli 22,21 36,14 00:47 46,14 10:49 1 Section SS 3 Santopadre-Arpino 1 21,17 00:03 10:52 RZ Ceprano - Refuel 2 Distance -
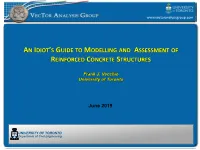
An Idiot's Guide to Modelling and Assessment Of
www.vectoranalysisgroup.com AN IDIOT’S GUIDE TO MODELLING AND ASSESSMENT OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES Frank J. Vecchio University of Toronto June 2019 www.vectoranalysisgroup.com Ancient Romans: Masters of Concrete Structures www.vectoranalysisgroup.com Lake Fucino Source of Malaria; often flooded nearby arable land. Potential source of new land. In 40 A.D., Emperor Claudius attempted to drain the lake, requiring 30 000 workers and 11 years to level a hill and tunnel 5.6 km through Monte Salviano. This remained the longest tunnel in the world until the mid-19th century. The high hydraulic pressure combined with the small tunnel diameter caused the water to rush out in a torrent. Claudius almost drowned during the opening ceremony, and much of the nearby valley was flooded. If D is small and h is large, Tunnel was plugged. then V is very large! WE DON’T ALWAYS GET OUR ANALYSES RIGHT! Suetonius, The Twelve Caesars, 121 A.D. www.vectoranalysisgroup.com Colle San Magno, Frosinone, Italy Lake Fucino Colle San Magno www.vectoranalysisgroup.com Colle San Magno, Frosinone, Italy www.vectoranalysisgroup.com Arpino, Frosinone, Italy Arpino C Arpino Colle San Magno Colle San Magno www.vectoranalysisgroup.com Cicero Marcus Tullius Cicero was a Roman philosopher, politician, lawyer, orator, political theorist, consul, and constitutionalist. Born: January 3, 107 BC, Arpinum, Rome Assassinated: December 7, 43 BC, Formia, Italy “Any man can make mistakes, but only an idiot persists in his error.” www.vectoranalysisgroup.com An Idiot’s Guide to Modelling -

The Medieval Castle of Arpino
Polygonal walls and fortified landscape: the medieval castle of Arpino Polygonal walls and fortified land- scape: the medieval castle of Arpino Sabrina Pietrobono THE CASTLE STUDIES GROUP JOURNALTHE CASTLE NO 29:292 2015-16 STUDIES GROUP JOURNAL NO 30: 2016-17 Polygonal walls and fortified landscape: the medieval castle of Arpino Fig. 1: Arpino (Frosinone, Italy). Satellite image showing the two medieval fortifications standing at the opposite corners of the settlement. Flash-earth, 1:5000. Polygonal walls and fortified landscape: the The settlement in its whole extent was once a medieval castle of Arpino Volscian and Roman oppidum. Still partially Sabrina Pietrobono enclosed by polygonal walls and medieval for- tifications, it reveals itself as a complex archi- Nowadays the ancient town of Arpino [Fig. 1], tectural and archaeological palimpsest from known primarily for having been the birthplace antiquity to the present day, which has attracted of the Roman orator Cicero (e.g. in Dench a long lasting antiquarian interest developed 2013, 122-137), is a picturesque municipality during the 19th century (e.g. Candidi Dionigi on the east of the River Liri, province of Frosi- 1809 [Fig. 02]; Starke 1837, 373-374; Blewitt none, in Southern Lazio (Italy). With more 1853, 49-50; Stieler, Paulus; Kaden 1877, 309). than 7,500 inhabitants, it is located on the slope of two hills, one called Civitavecchia (Civita Arpinum first appears in the documents in 314 Vecchia, meaning “the old town”), and Pesco BC (Leoni 2008, 137), and around that time it Falconario (later referred to as Civita Falco- was presumably already closed by remarkable nara, Falconaria or Falconiera). -

The February 16Th Earthquake Sequence in Central Italy, a Tool for Improving Microzonation Results in the Municipality of Arpino D
GNGTS 2013 SEssIONE 2.3 THE FEBRUARY 16TH EARTHQUAKE SEQUEncE in CENTRAL ITALY, A TOOL FOR impROving micROZONATION RESULTS in THE MUnicipAliTY OF ARpinO D. Famiani1-3, M. Manuel2, G. Milana3 1 DISTAV – Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita, Università degli Studi di Genova, Italy 2 Geotecnica e geognostica SRL, Frosinone, Italy 3 Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV, Rome, Italy Introduction. Microzonation studies, (hereinafter MS) are widely recognized as a useful tool to investigate the variation of earthquake-induced ground shacking as a function of the geological and geotechnical characteristics of the shallow soil layers. Moreover the results of MS can be used as an instrument for urban planning. Even though already performed after seismic events in Italy both at local scale as for the 1976 Friuli event and a regional scale, as for the Umbria-Marche event of September 1997, MS studies become a standard procedure in Italy following the L’Aquila (Mw 6.3) event of April 2009 and now they are required in the areas most prone to high level of seismicity. The MS is regulated by the guidelines promoted by the Civil Defence Department (DPC) since 2008 (Gruppo di lavoro MS, 2008) and contemplates studies at three different stages of detail the simplest one being indicated as MS of level 1 (hereinafter MS1). In MS the use of recorded seismic events, either strong and weak motion types, is indicated as a useful tool for evaluating the seismic response of a site. Moreover the analysis of the recorded seismicity can be used to verify and confirm the amplification factors found using numerical modelling of seismic response as required by MS guidelines. -

Cultural Tradition and Location-Based Policies
Historical Legacy and Policy Effectiveness: the Long-Term Influence of pre-Unification Borders in Italy Giovanna D’Adda Guido de Blasio April 2014 Abstract This paper investigates the interplay between cultural traditions and policy effectiveness. It explores the differential impact of a large development program (Cassa per il Mezzogiorno), implemented for four decades, starting in the 1950s, to stimulate convergence between Italy’s South and the more developed North, on municipalities with different histories. Namely, we consider a sample of municipalities located on either side of the historical border of the Kingdom of Sicily, whose legacy is considered, from Putnam (1993) onwards, to be a prime-facie cause of Southern Italy’s underdevelopment. Having been part of the Kingdom of Sicily is associated with a negative impact of development policies, but only when the allocation of development funds through the Cassa per il Mezzogiorno suffered from low quality of governance and was driven by political considerations rather than by efficiency ones. Keywords: Economic development, History, Social capital, Italy. JEL Classifications: N4, O2. We are grateful to Diego Gambetta, Guido Tabellini and Tommaso Nannicini for helpful comments. Giovanni Occhiali and Fabrizio Di Girolamo provided excellent research assistance. All errors remain our own. The views expressed herein are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the institutions they are affiliated with. Corresponding author. Department of Economics, University of Birmingham. Email: [email protected]. Bank of Italy. Email: [email protected]. 1 1. Introduction A large literature regards history as one of the main determinants of current economic development. -

Unmasking the 1349 Earthquake Source (Southern Italy): Paleoseismological and Archaeoseismological Indications from the Aquae Iuliae Fault
Journal of Structural Geology 31 (2009) 128–149 Contents lists available at ScienceDirect Journal of Structural Geology journal homepage: www.elsevier.com/locate/jsg Unmasking the 1349 earthquake source (southern Italy): paleoseismological and archaeoseismological indications from the Aquae Iuliae fault Paolo Antonio Costantino Galli a,b,*, Jose´ Alfredo Naso a a Dipartimento della Protezione Civile, Via Vitorchiano 4, 00189 Rome, Italy b CNR – Istituto di Geologia ambientale e Geoingegneria, Via Bolognola 7, 00183 Rome, Italy article info abstract Article history: The 9th September, 1349, earthquake was one of the most catastrophic events experienced along the Received 2 May 2008 Apennines. At least three main shocks struck a vast area of the Molise–Latium–Abruzzi regions, and Received in revised form damage was even sustained by the distant monumental buildings of Rome. The southern-most shock 15 September 2008 (Mw w 6.7) occurred at the border between southern Latium and western Molise, razing to the ground Accepted 30 September 2008 the towns of Isernia, Venafro and Cassino, amongst others, and devastating Montecassino Abbey. As with Available online 1 November 2008 other Medieval catastrophic sequences (e.g., in December 1456, Mw w 6.5–7.0), this earthquake has not yet been associated to any seismogenic source; thus, it still represents a thorn in the flesh of earthquake Keywords: Active tectonics geologists. We have here carried out a reappraisal of the effects of this earthquake, and through an Earthquakes interpretation of aerial photographs and a field survey, we have carried out paleoseismological analyses Paleoseismology across a poorly known, wN130 normal fault that crosses the Molise–Campania border.