Atti Isole.4A
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Cahier Des Charges De L'appellation D'origine Contrôlée Vin De Corse Ou
Publié au BO-AGRI le Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « VIN DE CORSE » ou « CORSE » homologué par le décret n° 2011-1084 du 8 septembre 2011, modifié par arrêté du publié au JORF du CHAPITRE Ier I. - Nom de l’appellation Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Vin de Corse » ou « Corse », initialement reconnue par le décret du 22 décembre 1972, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci- après. II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires 1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la dénomination géographique « Calvi » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges. 2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la dénomination géographique « Coteaux du Cap Corse » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges. 3°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la dénomination géographique « Figari » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges. 4°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la dénomination géographique « Porto- Vecchio » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges. 5°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la dénomination géographique « Sartène » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges. -

Dossier EPCI
N° 11 Octobre 2018 Portrait des 19 intercommunalités de Corse Synthèse Sommaire Synthèse Dans le cadre de la loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la Les 19 intercommunalités de corse République (NOTRe), une nouvelle cartographie des intercommunalités est effective depuis le 1er janvier 2017. Sur l'ensemble du territoire de Corse, cela se traduit par la création de 19 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : Synthèse 3 deux communautés d'agglomération (CA) et 17 communautés de Cap communes (CC). Cette refonte réduit le nombre d'EPCI qui était de Corse 27 auparavant ; huit intercommunalités ont gardé leurs délimitations Communauté d'agglomération du Pays Ajaccien 4 antérieures. Ces modifications sont principalement dues à la taille minimum demandée par la loi : 15 000 habitants, avec une Communauté d'agglomération de Bastia 7 Nebbiu- Bastia dérogation à 5 000 pour les territoires montagneux. La Corse étant Conca d'Oro une « montagne dans la mer », seuls quatre EPCI dépassent les Communauté de communes de Marana-Golo 10 L'Île-Rousse-Balagne 15 000 résidents : les deux CA du Pays Ajaccien et de Bastia ainsi Marana-Golo Communauté de communes du Sud Corse que les CC de Marana-Golo et du Sud Corse. 13 Castagniccia- Communauté de communes de Fium'orbu Castellu Des territoires aux profils différents Calvi Balagne Casinca 16 Pasquale Paoli Communauté de communes de la Castagniccia-Casinca Les intercommunalités de l'île sont plurielles. Avec 917 km², la CC 19 Costa Verde Communauté de communes de la Pieve de l'Ornano Spelunca-Liamone est la plus vaste, 13 fois plus étendue que la plus 22 petite, la CA de Bastia. -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2020
Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 2B HAUTE-CORSE INSEE - décembre 2019 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 2B - HAUTE-CORSE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 2B-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 2B-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 2B-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 2B-3 INSEE - décembre 2019 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires -

Schéma Départemental De Coopération Intercommunale
PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE 2016 Sommaire 1ère Partie : Etat des lieux de l'intercommunalité en Haute-Corse........................................................6 I. ANALYSE TERRITORIALE :............................................................................................6 A - Éléments démographiques de base :..............................................................................................6 B - Les EPCI à fiscalité propre : ........................................................................................................6 1. Population et densité :...............................................................................................................6 2. Dynamique démographique :.....................................................................................................7 C- Les Bassins de vie :........................................................................................................................9 1. Définition :.................................................................................................................................9 2. Le zonage en bassin de vie :......................................................................................................9 D - Les EPCI classés en zone de montagne :.....................................................................................11 II – CADRAGE GÉNÉRAL DE L'INTERCOMMUNALITÉ :.........................................13 A – Couverture spatiale de l'intercommunalité -

Recueil Des Actes Administratifs De La Prefecture De La Haute-Corse
- PREFECTURE DE HAUTE-CORSE SECRETARIAT GENERAL BUREAU DE LA COORDINATION ET DE LA MODERNISATION DE L’ETAT RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE JUIN 2008 N° 6-1 Edité le 30 Juin 2008 Le contenu intégral des textes/ou les documents et plans annexés peuvent être consultés auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée. SOMMAIRE CABINET .................................................................................................................. 8 BUREAU DU CABINET ................................................................................................................................. 9 ARRETE n° 2008-156-14 en date du 5 juin 2008 accordant une récompense pour acte de courage et de dévouement .................................................................................................................................................. 10 ARRETE n° 2008-157-15 en date du 5 juin 2008 conférant l'honorariat des maires. ................................ 11 ARRETE n° 2008-164-6 en date du 13 juin 2008 portant attribution de la Médaille d’honneur régionale, départementale et communale.Promotion du 14 juillet 2008 ...................................................................... 12 ARRETE n° 2008-168-5 en date du 16 juin 2008 portant attribution de la Médaille d’Honneur Agricole Promotion du 14 juillet 2008. ...................................................................................................................... 14 .............................................................................................................................................................. -

Recueil Des Actes Administratifs N°2B-2020-11-003 Publié Le 5
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°2B-2020-11-003 HAUTE-CORSE PUBLIÉ LE 5 NOVEMBRE 2020 1 Sommaire DDCSPP 2B-2020-10-07-002 - Arrêté portant organisation de la campagne de prophylaxie 2020-2021dans le département de la Haute-Corse (9 pages) Page 3 2B-2020-11-03-002 - DDCSPP-2B "arrêté portant modification de l' arrêté N°2B-2020-10-01-007 attribuant un complément de subvention à l’association Le foyer de Furiani destinée au financement des surcoûts liés au Covid, durant la crise sanitaire. (3 pages) Page 13 2B-2020-11-03-001 - DDCSPP-2B "arrêté portant modification de l’arrêté N° 2B-2020-09-001-009 en date du 2 septembre 2020 attribuant un complément de subvention à l’association A Fratellanza relative aux dépenses liées aux surcoûts du COVID. (3 pages) Page 17 2B-2020-10-14-002 - SPAV arrêté portant levée de la surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Monsieur SANTONI Philippe – EDE 20083007 (2 pages) Page 21 2B-2020-10-01-014 - SPAV arrêté portant mise sous surveillance d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de M. Carry Alexandre – EDE 20143022 (4 pages) Page 24 2B-2020-10-14-003 - SPAV arrêté portant mise sous surveillance d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation SCEA SANTA MARIA – EDE 20261004 (4 pages) Page 29 PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE 2B-2020-10-30-001 - AP CDCI 2020 - prenant acte de la répartition des délégués (4 pages) Page 34 2B-2020-10-30-002 - AP CDCI 2020 portant composition de la CDCI (3 pages) Page 39 2B-2020-11-04-001 - AP établissant la liste électorale des maires et EPCI de moins de 20 000 habitants (7 pages) Page 43 2B-2020-11-02-002 - ARRETE portant composition de la commission d'élus DETR (3 pages) Page 51 2B-2020-11-03-003 - Arrêté portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de la SARL POMPES FUNEBRES CORSES, sise à BASTIA (20200) - 1 Rue César Vezzani, gérée par M. -

Viva Xpress Logistics (Uk)
VIVA XPRESS LOGISTICS (UK) Tel : +44 1753 210 700 World Xpress Centre, Galleymead Road Fax : +44 1753 210 709 SL3 0EN Colnbrook, Berkshire E-mail : [email protected] UNITED KINGDOM Web : www.vxlnet.co.uk Selection ZONE FULL REPORT Filter : Sort : Group : Code Zone Description ZIP CODES From To Agent FR FRAOD01 FR-Corsica Island AJACCIO 20000 - 20000 BILIA 20100 - 20100 FOCE 20100 - 20100 GIUNCHETO 20100 - 20100 GRANACE 20100 - 20100 GROSSA 20100 - 20100 SARTENE 20100 - 20100 TIVOLAGGIO 20100 - 20100 ARBELLARA 20110 - 20110 BELVEDERE CAMPO MORO 20110 - 20110 PROPRIANO 20110 - 20110 VIGGIANELLO 20110 - 20110 AMBIEGNA 20111 - 20111 ARRO 20111 - 20111 CALCATOGGIO 20111 - 20111 CASAGLIONE 20111 - 20111 ALTAGENE 20112 - 20112 MELA 20112 - 20112 OLMICCIA 20112 - 20112 SANTA LUCIA DI TALLA 20112 - 20112 ZOZA 20112 - 20112 OLMETO 20113 - 20113 FIGARI 20114 - 20114 PIANA 20115 - 20115 AULLENE 20116 - 20116 ZERUBIA 20116 - 20116 CAURO 20117 - 20117 ECCICA SUARELLA 20117 - 20117 OCANA 20117 - 20117 TOLLA 20117 - 20117 SAGONE 20118 - 20118 BASTELICA 20119 - 20119 AZZANA 20121 - 20121 PASTRICCIOLA 20121 - 20121 REZZA 20121 - 20121 ROSAZIA 20121 - 20121 SALICE 20121 - 20121 QUENZA 20122 - 20122 COGNOCOLI MONTICCHI 20123 - 20123 PILA CANALE 20123 - 20123 ZONZA 20124 - 20124 POGGIOLO 20125 - 20125 SOCCIA 20125 - 20125 ORTO 20125 - 20125 CRISTINACCE 20126 - 20126 EVISA 20126 - 20126 SERRA DI SCOPAMENE 20127 - 20127 ALBITRECCIA 20128 - 20128 GROSSETO PRUGNA 20128 - 20128 GUARGUALE 20128 - 20128 URBALACONE 20128 - 20128 BASTELICACCIA 20129 - 20129 Orbitrax.Win -
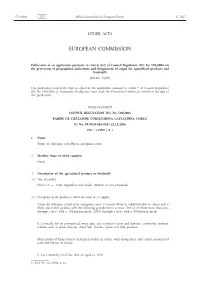
Of Council Regulation (EC)
27.3.2010 EN Official Journal of the European Union C 78/7 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of an application pursuant to Article 6(2) of Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs (2010/C 78/07) This publication confers the right to object to the application pursuant to Article 7 of Council Regulation (EC) No 510/2006 ( 1 ). Statements of objection must reach the Commission within six months of the date of this publication. SINGLE DOCUMENT COUNCIL REGULATION (EC) No 510/2006 ‘FARINE DE CHÂTAIGNE CORSE/FARINA CASTAGNINA CORSA’ EC No: FR-PDO-005-0581-22.12.2006 PGI ( ) PDO ( X ) 1. Name: ‘Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa’ 2. Member State or third country: France 3. Description of the agricultural product or foodstuff: 3.1. Type of product: Class 1.6 — Fruit, vegetables and cereals, whether or not processed 3.2. Description of the product to which the name in (1) applies: ‘Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa’ is creamy white to reddish-brown in colour and is finely and evenly ground, with the following granulometry: at least 70 % of the flour mass must pass through a sieve with a 106-micron mesh, 100 % through a sieve with a 450-micron mesh. It is notable for its pronounced sweet taste and complex scents and flavours, combining aromatic families such as dried chestnut, dried fruit, biscuits, spices and milk products. Flour produced from roasted chestnuts is darker in colour, with strong hues, and a more pronounced taste and flavour of biscuit. -

Archives De Corse. Les Documents Du Terrier Général De L'île
Archives de Corse. Les documents du Terrier général de l’île de Corse, étude et histoire du fonds. Ajaccio 2018. Pierre Portet To cite this version: Pierre Portet. Archives de Corse. Les documents du Terrier général de l’île de Corse, étude et histoire du fonds. Ajaccio 2018.. 2018. halshs-02521985 HAL Id: halshs-02521985 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02521985 Submitted on 27 Mar 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Archives de Corse Les documents du Terrier général de l'île de Corse, étude et histoire du fonds Pierre Portet 2018 1 Table des matières Introduction ............................................................................................ 4 I - La production des bureaux du Terrier général................................ 5 II - Cheminements documentaires. ....................................................... 6 A - Les documents remis à Testevuide. ............................................................... 6 B - Les documents transportés en Angleterre. ..................................................... 9 C - Les "envois à la Cour" : trajets parisiens. ..................................................... 10 Annexe n°1 : Pièces produites par le Terrier général de la Corse et présentes à Bastia en 1796. ........................................................................................................................... 12 Annexe n°2 : Procès-verbal de la remise du Terrier aux deux gouvernements Français et Britannique en conséquence du traité passé le 26 Décembre 1794. Bastia, 1796, 25 février. -

Discussion Paper Is/Has Been Under Review for the Journal Natural Hazards and Earth Evaluation of Forest System Sciences (NHESS)
Discussion Paper | Discussion Paper | Discussion Paper | Discussion Paper | Open Access Nat. Hazards Earth Syst. Sci. Discuss., 2, 3219–3249, 2014 Natural Hazards www.nat-hazards-earth-syst-sci-discuss.net/2/3219/2014/ and Earth System doi:10.5194/nhessd-2-3219-2014 NHESSD © Author(s) 2014. CC Attribution 3.0 License. Sciences Discussions 2, 3219–3249, 2014 This discussion paper is/has been under review for the journal Natural Hazards and Earth Evaluation of forest System Sciences (NHESS). Please refer to the corresponding final paper in NHESS if available. fire models on a large observation database Evaluation of forest fire models on a large J.-B. Filippi et al. observation database Title Page J.-B. Filippi1, V. Mallet2,3, and B. Nader1 Abstract Introduction 1CNRS SPE, Università di Corsica, BP 52, 20250 Corte, France 2 INRIA, BP 105, 78 153 Le Chesnay cedex, France Conclusions References 3CEREA (joint laboratory École des Ponts ParisTech & EDF R&D, université Paris Est), Marne-la-Vallée, France Tables Figures Received: 16 April 2014 – Accepted: 17 April 2014 – Published: 8 May 2014 J I Correspondence to: J.-B. Filippi (fi[email protected]) Published by Copernicus Publications on behalf of the European Geosciences Union. J I Back Close Full Screen / Esc Printer-friendly Version Interactive Discussion 3219 Discussion Paper | Discussion Paper | Discussion Paper | Discussion Paper | Abstract NHESSD This paper presents the evaluation of several fire propagation models using a large set of observed fires. The observation base is composed of 80 Mediterranean fire cases 2, 3219–3249, 2014 of different sizes, which come with the limited information available in an operational 5 context (burned surface and approximative ignition point). -
ZRR - Zone De Revitalisation Rurale : Exonération De Cotisations Sociales
ZRR - Zone de Revitalisation Rurale : exonération de cotisations sociales URSSAF Présentation du dispositif Les entreprises en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale) peuvent être exonérée des charges patronales lors de l'embauche d'un salarié, sous certaines conditions. Ces conditions sont notamment liées à son effectif, au type de contrat et à son activité. Conditions d'attribution A qui s’adresse le dispositif ? Entreprises éligibles Toute entreprise peut bénéficier d'une exonération de cotisations sociales si elle respecte les conditions suivantes : elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, elle a au moins 1 établissement situé en zone de revitalisation rurale (ZRR), elle a 50 salariés maximum. Critères d’éligibilité L'entreprise doit être à jour de ses obligations vis-à-vis de l'Urssaf. L'employeur ne doit pas avoir effectué de licenciement économique durant les 12 mois précédant l'embauche. Pour quel projet ? Dépenses concernées L'exonération de charges patronales porte sur le salarié, à temps plein ou à temps partiel : en CDI, ou en CDD de 12 mois minimum. L'exonération porte sur les assurances sociales : maladie-maternité, invalidité, décès, assurance vieillesse, allocations familiales. URSSAF ZRR - Zone de Revitalisation Rurale : exonération de cotisations sociales Page 1 sur 5 Quelles sont les particularités ? Entreprises inéligibles L'exonération ne concerne pas les particuliers employeurs. Dépenses inéligibles L'exonération de charges ne concerne pas les contrats suivants : CDD qui remplace un salarié absent (ou dont le contrat de travail est suspendu), renouvellement d'un CDD, apprentissage ou contrat de professionnalisation, gérant ou PDG d'une société, employé de maison. -
EPRI De Corse
L’évaluation préliminaire des risques d’inondation 2011 Bassin corse pollution connaissance torrent patrimoine inondation réseaux remontée de nappe préliminaire ruissellement potentielle phénomènes population nationale historique côtier directive ouvrages débordements gouvernance agriculture analyse inondable risque bassin densité impacts extrême vulnérabilité gestion acteurs rupture submersion marine tsunami synthèse crue emplois environnement évaluation indicateurs enjeux conséquences diagnostic économie méthode enveloppe Europe établissements changement climatique Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement www.developpement-durable.gouv.fr 11030_EPRI_corse_couv.indd 1 08/03/2012 14:52:45 Sommaire Introduction..........................................................................................................................3 De la politique de gestion actuelle des inondations vers la mise en œuvre de la directive inondation ..........................................................................................................5 Les grandes étapes de mise en œuvre de la directive inondation............................................ 6 Les grands principes de mise en oeuvre de la directive inondation : concept de « choix partagé » et organisation de la gouvernance............................................................................ 7 Présentation et contenu de l'EPRI....................................................................................8 Présentation de l’'EPRI : un premier