Statuti Di Raveo, 1734
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Direzione Dei Servizi Sociosanitari PROPOSTA DEL COMUNE DI
Direzione dei Servizi Sociosanitari Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Carnia PROPOSTA DEL COMUNE DI RAVEO DI MESSA A DISPOSIZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE PER ATTIVITA’ SOCIO EDUCATIVE A FAVORE DEI BAMBINI/RAGAZZI DELLA CARNIA Il comune di Raveo propone di mettere a disposizione del Servizio Sociale dei Comuni della Carnia ed in particolare dell’area minori e di sviluppo di comunità la vecchia scuola di Raveo, quale centro nel quale svolgere attività educativa, a favore di bambini e ragazzi seguiti e/o di progetti comunque promossi e gestiti dal servizio sociale. La ex scuola è dotata di spazi interni (3 aule ed un ampio corridoio) e di una area esterna con dei campetti sportivi polivalenti (basket, pallavolo, tennis, calcetto) e permetterebbe attività sia indoor che outdoor anche per la realizzazione di centri estivi, come già sperimentato. Per rendere fruibili gli spazi interni è necessario reperire degli arredi e sistemare i bagni; a tal fine è necessario reperire dei fondi (regionali, bandi..) IL COMUNE DI RAVEO, con finanziamento già disponibile, si impegna ad eseguire i lavori di efficientamento energetico dell'immobile, con la sostituzione dell'impianto di riscaldamento e delle superfici finestrate Per quanto riguarda le spese di gestione: riscaldamento a metano, ipotizzando un utilizzo € 3.000,00 del riscaldamento per 5 mesi all'anno, 5 giorni a settimana per 5 ore al giorno, si stima un consumo di metano di ca. 4.000 mc per una spesa sui energia elettrica € 1.000,00 spese varie per manutenzione ordinaria euro € 1.000,00 TOTALE: € 5.000,00 Direzione dei Servizi Sociosanitari Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Carnia ANALISI DI FATTIBILITA’ BISOGNO Il SSC gestisce, realizza e promuove attività di carattere socio educativo con bambini e ragazzi del territorio carnico sia come presa in carico di situazioni note e segnalate dall’autorità giudiziaria, che come prevenzione del disagio e promozione del benessere. -

Cheste Liste Di Toponims E Je Il Risultât Dal Lavôr Di Une Comission Li Che Si
I TOPONIMS DAL FRIÛL Jentrade Cheste liste di toponims e je il risultât dal lavôr di une comission li che si son dâts dongje: Francesco Micelli e Donato Toffoli pal OLF, Enos Costantini e Franco Finco nomenâts de Societât Filologjiche Furlane, Sergio Fantini e Paolo Roseano nomenâts de Clape di Culture "Patrie dal Friûl". La finalitât e je chê di proferî une liste di toponims in grafie uficiâl, sedi tal furlan standard che te varietât locâl, par ducj chei che a àn la dibisugne di scriviju. Tal câs des tabelis stradâls a valin lis indicazions dal OLF: duncje, se si presentin formis compagnis tal talian e tal furlan (es.: Nimis), si consee di scrivi, neri su blanc, dome une forme. Stant che l'OLF al è l'organisim regjonâl previodût de L.R. 15/1996, la liste e fâs riferiment al teritori delimitât dai Decrets dal President de Zonte Regjonâl n.0412/Pres. dal 13.11.1996 e n.0160/Pres. dal 20.5.1999. O savìn che a esistin altris localitâts li che si fevele par furlan, o li che al è atestât che si fevelave furlan fin a une ete no tant lontane, ma jessint cheste une publicazion uficiâl o vin decidût chest criteri, salacor lassant a altris publicazions la integrazion dai toponims che a mancjin, che a cjapin dentri ancje la microtoponomastiche. La comission e à decidût di tignîsi il plui pussibil dongje ae forme locâl ancje tal proferî la forme standard (es.: Alture = Ulturis e no Alturis), ancje parcè che in cierts câs si rive a sclarî formis che par talian si puedin confondi (es.: Gradisca e ven scrite in standard Gardiscje = Gradisca d'Isonzo, Grediscje = Gradisca di Sedegliano, Gradiscje = Gradisca di Spilimbergo). -

Elenco Posti Nelle Riserve Di Caccia Del Friuli Venezia Giulia
Elenco posti nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia Provincia di Gorizia 26 agosto 2020 Riserve interessate da cacciatori Riserve di caccia posti disponibili posti liberi eccedenti parco regionale o presenti riserve naturali BOSCHINI - PETEANO 12 14 0 2 BRAZZANO 11 11 0 0 CAPRIVA DEL FRIULI 9 9 0 0 CORMONS 39 37 2 0 CORONA 7 7 0 0 DOBERDO' DEL LAGO 14 14 0 0 * DOLEGNA DEL COLLIO 13 12 1 0 FARRA D'ISONZO 23 19 4 0 FOGLIANO 10 8 2 0 GABRIA 8 9 0 1 GIASBANA 8 8 0 0 GRADISCA D'ISONZO 10 7 3 0 GRADO 80 76 4 0 * JAMIANO 13 12 1 0 * LUCINICO 22 22 0 0 MARIANO DEL FRIULI 13 11 2 0 MEDEA 15 15 0 0 MERNICO 10 10 0 0 MONFALCONE 13 10 3 0 * MORARO 8 8 0 0 MOSSA 11 13 0 2 PIEDIMONTE 9 9 0 0 PIERIS - BEGLIANO - ISOLA MOROSINI 19 13 6 0 * PIUMA 11 11 0 0 PLESSIVA 10 10 0 0 ROMANS 1° 13 13 0 0 RONCHI DEI LEGIONARI 16 13 3 0 * RUTTARS 11 10 1 0 SAGRADO - SAN MARTINO 14 13 1 0 SAN CANZIAN D'ISONZO 14 7 7 0 * SAN FLORIANO DEL COLLIO 14 16 0 2 SAN LORENZO ISONTINO 9 9 0 0 SAN MAURO - SALCANO 8 9 0 1 SAN MICHELE DEL CARSO 10 9 1 0 Riserve interessate da cacciatori Riserve di caccia posti disponibili posti liberi eccedenti parco regionale o presenti riserve naturali SAN PIER D'ISONZO 14 11 3 0 SAVOGNA - RUBBIA 13 12 1 0 SPESSA 8 8 0 0 STARANZANO 14 12 2 0 * TURRIACO 7 7 0 0 * VALLONE 16 14 2 0 * VERSA 9 10 0 1 VILLESSE 19 19 0 0 607 567 49 9 Riserve interessate da cacciatori posti disponibili posti liberi eccedenti parco regionale o Provincia di Pordenone presenti riserve naturali ANDREIS 11 12 0 1 * ARBA 40 37 3 0 ARZENE 15 17 0 2 AVIANO 176 170 -

Second Report Submitted by Italy Pursuant to Article 25, Paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities
Strasbourg, 14 May 2004 ACFC/SR/II(2004)006 SECOND REPORT SUBMITTED BY ITALY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES (received on 14 May 2004) MINISTRY OF THE INTERIOR DEPARTMENT FOR CIVIL LIBERTIES AND IMMIGRATION CENTRAL DIRECTORATE FOR CIVIL RIGHTS, CITIZENSHIP AND MINORITIES HISTORICAL AND NEW MINORITIES UNIT FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES II IMPLEMENTATION REPORT - Rome, February 2004 – 2 Table of contents Foreword p.4 Introduction – Part I p.6 Sections referring to the specific requests p.8 - Part II p.9 - Questionnaire - Part III p.10 Projects originating from Law No. 482/99 p.12 Monitoring p.14 Appropriately identified territorial areas p.16 List of conferences and seminars p.18 The communities of Roma, Sinti and Travellers p.20 Publications and promotional activities p.28 European Charter for Regional or Minority Languages p.30 Regional laws p.32 Initiatives in the education sector p.34 Law No. 38/2001 on the Slovenian minority p.40 Judicial procedures and minorities p.42 Database p.44 Appendix I p.49 - Appropriately identified territorial areas p.49 3 FOREWORD 4 Foreword Data and information set out in this second Report testify to the considerable effort made by Italy as regards the protection of minorities. The text is supplemented with fuller and greater details in the Appendix. The Report has been prepared by the Ministry of the Interior – Department for Civil Liberties and Immigration - Central Directorate for Civil Rights, Citizenship and Minorities – Historical and new minorities Unit When the Report was drawn up it was also considered appropriate to seek the opinion of CONFEMILI (National Federative Committee of Linguistic Minorities in Italy). -

Brochure at Carnia INGLESE
The lands of Carnia 1 Houses in stone and wood, ancient carnival rituals, a cuisine imbued with flavours lost elsewhere, and above all the people, who in Forni di Sopra, Ovaro, Raveo, Sauris and Sutrio help you rediscover the slow rhythm of times gone by. Authentic architecture olidaying in one of the “borghi village food festival, H autentici” (authentic villages) in celebrates the Friuli Venezia Giulia, in Forni di flavours of a cuisine Sopra, Raveo, Sauris, Sutrio and Ovaro, imbued with the culture means being hosted by a rare quality of and the history of these people, people who love welcoming others places. In Sauris, a marvellous into their community and helping them village of German origin, you will be rediscover the slow rhythms of times gone welcomed into mountain-style dwellings by. People, places, flavours and traditions built in stone and wood. The influence all speak of a magically preserved of the German culture can be seen in the authenticity. Forni di Sopra, dominated village’s countless traditions and folk by the majestic peaks of the Dolomites, festivals, including the Carnival, one of welcomes you into its spacious the oldest across the Alps. Finally, a stroll courtyards and narrow lanes through the lanes in Sutrio, a beautiful featuring rural houses in mountain village, will lead you to a host stone and wood, with wide of workshops of skilled artisans who, upstair landings where hay during the Magia del Legno festival each was once dried. Raveo, September, demonstrate their great nestled in a sunny dell creativity and skill in the courtyards of the at the foot of Col Gentile, houses: the same courtyards where the exudes the charm of nativity scenes made by the marangons, an authentic village. -

Carnia 1944 – Un'estate Di Liberta'
Domenica 9 aprile 2017 CARNIA 1944 – UN’ESTATE DI LIBERTA’ Traversata da Ampezzo (559 m) a Raveo (503 m) passando per la Forca di Pani (1139 m), i Pani di Raveo, gli Stavoli Valdie (807 m) e il Convento della Madonna di Raveo. Direttore d’escursione: ONC Riccardo Ravalli TABELLA DEI TEMPI Ore 6.30 partenza da piazza Oberdan, breve sosta durante il viaggio “ 9.00 arrivo ad Ampezzo (559m), eventuale visita al Palazzo Comunale “ 9.30 in cammino verso Voltois (660m) “ 11.30 alla Forcella di Pani (1139m) “ 12.30 sosta per il pranzo al sacco “ 14.00 ripresa del cammino verso il casolare Fleris e gli stavoli di Valdie (807m) “ 17.00 al Convento della Madonna di Raveo “ 17.30 Raveo, zona artigianale “ 18.00 partenza per Trieste “ 20.00 circa, arrivo a Trieste Premessa storica Molte delle nostre montagne, pur luogo di piacevoli escursioni, conservano memoria di tra- gici eventi storici. Ciò riguarda in particolare l’itinerario proposto che si snoda nell’ampia zona ove i partigiani della formazione “Garibaldi" e della Brigata “Osoppo” diedero vita alla “Libera Repubblica della Carnia” con capitale Ampezzo che, dall’agosto all’ottobre del 1944, resistette agli attacchi di tedeschi e cosacchi e che vide la formazione di un governo civile, fondato sui principi che ritroviamo sanciti nella vigente Costituzione. Descrizione dell’itinerario e dell’ambiente naturale L’escursione prende avvio da Ampezzo (559 m) dove si incontrerà Giulio Magrini, figlio di uno dei principali protagonisti di questa vicenda e, attualmente, Presidente delle Sezioni Carni- che del CAI, che accompagnerà gli escursionisti a visitare, se possibile, il Palazzo comunale dove sono conservati cimeli relativi a questa epopea. -

Densità Della Viabilità Forestale Nelle Foreste Pianificate
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE DENSITÀ DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI NELLE SUPERFICI FORESTALI PIANIFICATE (DICEMBRE 2020) Obiettivo per le strade camionabili principali: ottimale 40 m/ha - accordo interregionale di Verona 2016: 25 m/ha Strade forestali di primo livello Strade forestali di secondo livello Superficie camionabili (camionabili e trattorabili) Proprietà (*) Forestale m/ha (**) km (**) m/ha (**) km (**) ha (**) Foresta regionale di Pramosio (Paluzza) 20 3 19 3 169 Foresta regionale di Fusine (Tarvisio) 12 19 12 19 1.562 Comune di Clauzetto 11 2 6 1 173 Foresta regionale del Cansiglio orientale (Budoia, Caneva, Polcenigo) 11 14 5 6 1.295 Comune di Comeglians 10 2 16 3 196 Comune di Raveo 9 1 13 1 60 Givigliana (Rigolato) 9 1 20 3 154 Del Missier Luca (S.F. Clauzetto) 6 0 116 1 6 Comune di Verzegnis 5 7 26 33 1.234 Comune di Paluzza 4 4 29 27 927 Foresta regionale del Monte Rest (Socchieve) 4 2 10 5 472 Eberhard s.s. Società Agricola (S.F. Treppo Ligosullo) 3 0 51 3 50 Comune di Enemonzo 3 2 10 7 732 Azienda Agricola Villa Dante s.a.s. (S.F. Ampezzo) 3 0 19 3 154 Comune di Pontebba 3 4 13 18 1.412 Foresta regionale della Val Alba (Moggio Udinese) 2 3 0 1 1.531 Foresta regionale del Prescudin (Barcis) 2 1 22 8 378 Comune di San Dorligo della Valle 2 0 19 2 102 Amministrazione beni fraz. di Ovasta (Ovaro) 1 0 29 6 195 Comune di Ravascletto 1 1 24 19 816 Comune di Caneva 1 0 23 9 392 Foresta regionale dei Lotti (Tarvisio) 1 1 7 6 921 * S.F.: scheda forestale; ove -
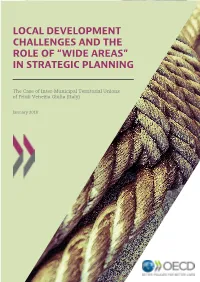
Local Development Challenges and the Role of “Wide Areas” in Strategic Planning
LOCAL DEVELOPMENT CHALLENGES AND THE ROLE OF “WIDE AREAS” IN STRATEGIC PLANNING The Case of Inter-Municipal Territorial Unions of Friuli Venezia Giulia (Italy) January 2018 2 │ OECD Working Papers should not be reported as representing the official views of the OECD or of its member countries. The opinions expressed and arguments employed are those of the authors. Working Papers describe preliminary results or research in progress by the author(s) and are published to stimulate discussion on a broad range of issues on which the OECD works. Comments on Working Papers are welcomed, and may be sent to CFE Directorate, OECD, 2 rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France This document and any map included herein are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area. Cover image: Designed by welcomia / Freepik © OECD 2018 You can copy, download or print OECD content for your own use, and you can include excerpts from OECD publications, databases and multimedia products in your own documents, presentations, blogs, websites and teaching materials, provided that suitable acknowledgment of OECD as source and copyright owner is given. All requests for public or commercial use and translation rights should be submitted to [email protected]. Requests for permission to photocopy portions of this material for public or commercial use shall be addressed directly to the Copyright Clearance Center (CCC) at [email protected] or the Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) [email protected]. -

Ufficio Del Territorio Di UDINE
Ufficio del territorio di UDINE Data: 14/03/2017 Ora: 10.55.18 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2017 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.2 del 20/01/2017 n.- del - REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 1 2 Comuni di: AMPEZZO, COMEGLIANS, ENEMONZO, FORNI AVOLTRI, Comuni di: AMARO, ARTA TERME, CAVAZZO CARNICO, FORNI DI SOPRA, FORNI DI SOTTO, LAUCO, OVARO, PRATO CERCIVENTO, LIGOSULLO, PALUZZA, PAULARO, SUTRIO, CARNICO, PREONE, RAVASCLETTO, RAVEO, RIGOLATO, SAURIS, TOLMEZZO, TREPPO CARNICO, VERZEGNIS, ZUGLIO SOCCHIEVE, VILLA SANTINA COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) ALPE 260,00 260,00 BOSCHI 6000,00 6000,00 BOSCO CEDUO 4000,00 4000,00 BOSCO D`ALTO FUSTO 9500,00 9500,00 FRUTTETO 33500,00 33500,00 GOLENALE IN. 1500,00 1500,00 INCOLTO PRODUTTIVO 6000,00 6000,00 ORTO 32000,00 32000,00 ORTO VIVAIO FLOREALE 43000,00 PASCOLO 1200,00 1200,00 PASCOLO CESPUGLIATO 500,00 500,00 PRATO 10500,00 10500,00 PRATO ARBORATO 10500,00 10500,00 Pagina: 1 di 10 Ufficio del territorio di UDINE Data: 14/03/2017 Ora: 10.55.18 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2017 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.2 del 20/01/2017 n.- del - REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 1 2 Comuni di: AMPEZZO, COMEGLIANS, ENEMONZO, FORNI AVOLTRI, Comuni di: AMARO, ARTA TERME, CAVAZZO CARNICO, FORNI DI SOPRA, FORNI DI SOTTO, LAUCO, OVARO, PRATO CERCIVENTO, LIGOSULLO, PALUZZA, PAULARO, SUTRIO, CARNICO, PREONE, RAVASCLETTO, RAVEO, RIGOLATO, SAURIS, TOLMEZZO, TREPPO CARNICO, VERZEGNIS, ZUGLIO SOCCHIEVE, VILLA SANTINA COLTURA Valore Sup. -

Scarica Benemeriti Congresso Udine
•• fine - dono benemeriti 2018.qxp_DONO 2013 benemeriti 14/08/18 09:38 Pagina 1 BENEMERITI AL 60° CONGRESSO AFDS DI UDINE SUPPLEMENTO AL N.4 SETTEMBRE 2018 DE “IL DONO” - DIRETTORE RESPONSABILE ROBERTO TIRELLI LA COMMISSIONE CONSILIARE PER IL DONO HA DECISO, IN VIA SPERIMENTALE, DI SEPARARE L’ELENCO DEI BENEMERITI DAL CORPO DEL PERIODICO AL FINE SIA PIÙ AGEVOLE CONSERVARE IL RICORDO E VENGA MESSA IN EVIDENZA LA LORO GENEROSITÀ CRITERI PER LA CONSEGNA DELLE BENEMERENZE UOMINI DONNE UOMINI DONNE Diplomi di Benemerenza 10 8 Targhe d’Argento Distintivi di Bronzo 20 15 con Pellicano d’Oro 75 60 Distintivi d’Argento 35 25 Gocce d’Oro 100 80 Distintivi d’Oro 50 40 MASCHI FEMMINE TOTALE DIPLOMI DI BENEMERENZA 516 323 839 DISTINTIVI DI BRONZO 407 191 598 DISTINTIVI D'ARGENTO 271 123 394 DISTINTIVI D'ORO 185 68 253 TARGA D'ARGENTO CON PELLICANO D'ORO 109 23 132 GOCCIA D'ORO 55 11 66 TOTALE 1543 739 2282 •• fine - dono benemeriti 2018.qxp_DONO 2013 benemeriti 14/08/18 09:38 Pagina 2 BENEMERITI - GOCCIA D’ORO GOCCIA D’ORO Loretta Malagnini Lorenzo Pertoldi Candoni LuiginoErmanno Zanier Daniele Pitta Amaro Ancona Udine Arta Terme Arta Terme Bagnaria Arsa Patrizia Dorigo Adriano Del Giudice Fabrizio Panigutti Massimiliano Mario Gloazzo Claudio Pohar Susi Morettin Baldasseria Basiliano Camino al Taglia- Cardone Castions di Strada Cave del Predil Cervignano mento Campoformido Giuseppe Barbiani Angelo Diplotti Vittorino De Clara Claudio Tonassi Paolo Zamuner Enrica Carera Marco Masotti Cividale del Friuli Cividale del Friuli Comunale Codroipo Comunale -

Carnia in Bici Da Corsa
1 » ANELLO DI PASSO LANZA 1 » LANZA PASS ROUTE 2 » LA STENTARIA 3 » CASERA RAZZO E VAL PESARINA 3 » CASERA RAZZO AND VAL PESARINA AN OVERVIEW OF THE ROUTE » A tough climb in a wonderful setting almost devoid of traffic. AN OVERVIEW OF THE ROUTE » Incredible but true: this climb is harder than the Zoncolan. CARNIA IN The descent is steep and narrow. The descent is steep and narrow. PANORAMICA SUL GIRO » PLACE OF DEPARTURE » TOLMEZZO PANORAMICA SUL GIRO » PANORAMICA SUL GIRO » PLACE OF DEPARTURE » SOCCHIEVE Si affronta una salita impegnativa in un contesto Incredibile ma vero: Incredibile ma vero: meraviglioso e quasi privo di traffico. [DESCRIPTION OF THE ROUTE] After the Caneva bridge, you turn right and with nice ups and downs get to Zuglio, questa salita è più dura dello Zoncolan. questa salita è più dura dello Zoncolan. [DESCRIPTION OF THE ROUTE] Going up the old road "della cleva", you reach State Road 52 and go up towards BICI DA CORSA La discesa e ripida e stretta. where you cross the bridge and turning right follow the 52bis road for a short distance. On the left, you follow the old Ampezzo through Mediis. In the village centre, you turn right and on a magnificent road you reach lake Sauris, with road that climbs towards Paularo. An easy climb with alternating flat stretches leading to Salino, where the route joins PUNTO DI PARTENZA VILLA SANTINA PUNTO DI PARTENZA SOCCHIEVE three basalt paved tunnels at the end. From the Maina hamlet, the route climbs to Sauris di Sotto with a short but steep the main road and descends towards the village of Paularo. -

Danni Di Guerra - Partigiani
Ministero per i Beni e le Attività Culturali Archivio di Stato di Udine SCHEDA FONDO 3.1.2 Denominazione o titolo Danni di guerra - partigiani 3.1.3 Data/e 1945-1978 3.1.4 Livello di descrizione fondo 3.1.5 Consistenza e supporto 25 bb. dell'unità archivistica 3.2.1 Denominazione del soggetto Intendenza di Finanza di Udine. produttore 3.2.2 Storia Le Intendenze sono organi periferici dell'amministrazione finanziaria dello Stato. Già istituzionale/amministrativa del esistenti in epoca preunitaria, sono riconfermate con il RD n. 5286/1869 per soggetto produttore esercitare competenze in materia di imposte dirette ed indirette, catasto, dogane, tesoro, sulla circoscrizione provinciale di pertinenza, e per amministrare i beni dello stato. In Friuli, per i territori delle province di Udine e Pordenone, ha operato la sola Intendenza di Finanza di Udine da cui dipendevano uffici periferici quali agenzie delle imposte dirette, uffici del registro, conservatorie delle ipoteche etc. Tra il 1923 ed il 1926 vengono compresi nella sua giurisdizione alcuni comuni della Venezia Giulia aggregati alla Provincia del Friuli. La ristrutturazione del Ministero delle Finanze, attuata a partire dalla L. 358/1991, ha portato alla soppressione dell'ufficio. Recentemente le funzioni sono state attribuite all'Agenzia delle Entrate istituita con il D. Leg.vo 300/1999. 3.2.4 Modalità di acquisizione o Versato dalla Direzione Generale delle Entrate di Udine nel 1998. versamento 3.3.1 Ambiti e contenuto Raccoglie la documentazione relativa ai rimborsi a privati per danni subiti in seguito alle requisizioni effettuate dalle brigate partigiane (D.L. 19.04.1948 n.