Actas Vol. 3.Indb
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Abruzzo: Europe’S 2 Greenest Region
en_ambiente&natura:Layout 1 3-09-2008 12:33 Pagina 1 Abruzzo: Europe’s 2 greenest region Gran Sasso e Monti della Laga 6 National Park 12 Majella National Park Abruzzo, Lazio e Molise 20 National Park Sirente-Velino 26 Regional Park Regional Reserves and 30 Oases en_ambiente&natura:Layout 1 3-09-2008 12:33 Pagina 2 ABRUZZO In Abruzzo nature is a protected resource. With a third of its territory set aside as Park, the region not only holds a cultural and civil record for protection of the environment, but also stands as the biggest nature area in Europe: the real green heart of the Mediterranean. en_ambiente&natura:Layout 1 3-09-2008 12:33 Pagina 3 ABRUZZO ITALY 3 Europe’s greenest region In Abruzzo, a third of the territory is set aside in protected areas: three National Parks, a Regional Park and more than 30 Nature Reserves. A visionary and tough decision by those who have made the environment their resource and will project Abruzzo into a major and leading role in “green tourism”. Overall most of this legacy – but not all – is to be found in the mountains, where the landscapes and ecosystems change according to altitude, shifting from typically Mediterranean milieus to outright alpine scenarios, with mugo pine groves and high-altitude steppe. Of all the Apennine regions, Abruzzo is distinctive for its prevalently mountainous nature, with two thirds of its territory found at over 750 metres in altitude.This is due to the unique way that the Apennine develops in its central section, where it continues to proceed along the peninsula’s -
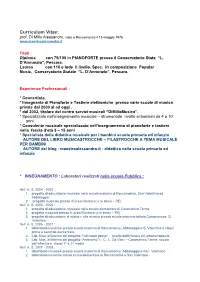
Curriculum Vitae: Prof
Curriculum Vitae: prof. Di Millo Alessandro, nato a Roccamorice il 15 maggio 1976 www.maestroalessandro.it Titoli : Diploma con 75/100 in PIANOFORTE presso il Conservatorio Stata “L. D’Annunzio”, Pescara. Laurea con 110 e lode II livello. Spec. In composizione Popular Music, Conservatorio Statale “L. D’Annunzio”, Pescara. Esperienze Professionali : * Concertista. * Insegnante di Pianoforte e Tastiere elettroniche presso varie scuole di musica private dal 2000 al ad oggi . * dal 2002, titolare del centro servizi musicali “DiMilloMusica”. * Specializzato nell’insegnamento musicale – strumentale rivolto ai bambini da 4 a 10 anni. * Consulente musicale specializzato nell’insegnamento di pianoforte e tastiere nella fascia d’età 3 – 15 anni * Specialista della didattica musicale per i bambini scuola primaria ed infanzia AUTORE DEL LIBRO MUSICASTROCCHE – FILASTROCCHE A TEMA MUSICALE PER BAMBINI AUTORE del blog : maestroalessandro.it - didattica nella scuola primaria ed infanzia * INSEGNAMENTO : Laboratori realizzati nella scuola Pubblica : Nell’ A. S. 2004 - 2005_: 1. progetto di educazione musicale nella scuola materna di Roccamorice, San Valentino ed Abbateggio. 2. progetto musicale presso il Liceo Ravasco (v.le bovio – PE) Nell’ A. S. 2005 - 2006 : 1. progetto di educazione musicale nella scuola elementare di Caramanico Terme 2. progetto musicale presso il Liceo Ravasco (v.le bovio – PE) 3. progetto di educazione al suono e alla musica presso scuola materna Istituto Comprensivo S. Valentino - Nell’ A. S. 2006 - 2007 : 1. laboratorio musicale presso scuola materna di Roccamorice, Abbateggio e S. Valentino e classi prima e seconda elementare. 2. Lab. Mus. all’interno del progetto “Col corpo posso” - scuola dell’infanzia di Lettomanoppello - 3. Lab. Mus. all’interno del progetto “Animiamo” I . -

Civita Dell'abbadia Antonio Alberto Longo, I Consulenti Di Civita Dell'abbadia Stefania Di Primio, Annalisa Massimi E Camillo Chiarieri
Associazione Culturale CIVITA dell’ABBADIA Cultura – Ambiente - Territorio Storia in comune: 22 comuni dell’entroterra pescarese in mostra alla Fondazione Pescarabruzzo Mercoledì 16 maggio, alle ore 17:00 presso il palazzo sede della Fondazione Pescarabruzzo, nel cuore di Pescara, verrà presentato al pubblico un nuovo tassello del grande progetto Terra Autentica che coinvolge ben 22 Comuni della provincia di Pescara. Si tratta della mostra storico documentaria e della pubblicazione del relativo catalogo “Storia in Comune. Viaggio alla scoperta dei Comuni dell’entroterra pescare se”, promossa dall’Associazione Culturale Civita dell’Abbadia con il coordinamento della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Abruzzo e del Molise, e finanziata dalla Fondazione Pescarabruzzo. Il progetto ha visto inoltre la partecipazione dei Comuni di Brittoli, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Civitaquana, Civitella Casanova, Corvara, Cugnoli, Farindola, Montebello di Bertona, Nocciano, Penne, Pietranico, Rosciano, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Scafa, Serramonaces ca, Tocco da Casauria, Torre de’ Passeri, Turrivalignani Villa Celiera e Vicoli, le Pro Loco di Carpineto della Nora, Catignano, Civitaquana, Civitella Casanova, Montebello di Bertona, Villa Celiera, l’Associazione Culturale Villa Badessa e con la collabor azione dell’Archivio di Stato di Pescara, del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, del Parco Nazionale della Majella, dell’Associazione Cu lturale Tutti Pazzi per Corvara e della Cooperativa Archivi e Cultura . L’obiettivo è quello di promuove re la conoscenza del patrimonio archivistico comunale, meno noto rispetto a quello museale e monumentale, ma fondamentale per ricostruire la storia dei luoghi e ristabilire il primato dei documenti nella memoria collettiva. Il materiale esposto e quello ri prodotto sul catalogo, sono solo un assaggio della ricchezza nascosta negli archivi. -

BOLLETTINO INTEGRALE In
Anno XXXIX REPUBBLICA ITALIANA N. 16 Ordinario BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE ABRUZZO L’AQUILA, 14 MARZO 2008 Pag. 2 Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XXXIX - N. 16 (14.03.2008) BOLLETTINO UFFICIALE INFORMAZIONI Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione. Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto. Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti: I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini. II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione. III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati). Nei Supplementi vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali. ABBONAMENTO E PASSWORD E' possibile sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno. Il costo annuale è di € 77,47 da versare sul c.c.p. n° 12101671 specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. -

TUA 'Avviso Al Pubblico'
D.G. 148/2021 AVVISO SERVIZIO DELLE LINEE “PESCARA-L’AQUILA” “CARAMANICO TERME-PESCARA” “CARAMANICO-SULMONA” “CARAMANICO-CHIETI” “CIVITELLA CASANOVA-PESCARA” “CIVITELLA CASANOVA-PENNE” -“PESCHIOLE-PENNE”- “S. EUFEMIA-SCAFA - PESCARA” “SERRAMONACESCA-PESCARA” “PIETRANICO-PESCARA” “NOCCIANO-CEPAGATTI” “FARINDOLA-PENNE-PESCARA” “VILLA CELIERA-PESCARA” Si informa la gentile clientela che, dal 11 GIUGNO 2021 , le CORSE FERIALI dei servizi in oggetto saranno effettuate come di seguito riportato: LINEA “PESCARA-L’AQUILA” PARTENZE DA PESCARA: 5:55 - 6.25(*) – 6:35 - 8:00 – 8:30 – 10:30 – 13:10 – 14:10 – 16:05 – 17:15 – 18:00 - 19:45 PARTENZE DA L’AQUILA: 6:00 – 6:25(*) – 8:15 - 10:00 – 13:00 – 14:10(*) - 15:15 – 16:10 - 17.15 – 18:00(*) - 18:45 - 20:15 (*) NO STOP LINEA “CARAMANICO TERME-PESCARA” PARTENZE DA CARAMANICO: 6:15(*) – 15:30 PARTENZE DA PESCARA: 14:05 – 19:15 (*) parte da S. Eufemia LINEA “CIVITELLA CASANOVA-PESCARA” PARTENZA DA CIVITELLA CASANOVA: 5:35 - 6:15 – 8:30 – 13:15 – 17:10(*) – 18:15 PARTENZA DA PESCARA: 7:00 – 13:00 - 14:10 – 16:00(*) – 18:35 – 20:30 (*) Corse in partenza/arrivo a Civitaquana LINEA “CIVITELLA CASANOVA-PENNE” PARTENZA DA CIVITELLA CASANOVA: 06:15 – 12:00 PARTENZA DA PENNE: 10:15 - 14:40 LINEA “PESCHIOLE-PENNE” PARTENZA DA PESCHIOLE: 6:00 PARTENZA DA PENNE: 14:10 LINEA “S. EUFEMIA-SCAFA-PESCARA” PARTENZA DA SCAFA: 5:50(*) - 8:15(1) – 11:55(1) - 14:10 PARTENZA DA PESCARA: 7:10 - 11:10(1) – 13:05 – 18:00(1) (*) da/per P.D. Castagne, transita Roccamorice, Abbateggio, S. -

Ambito Distrettuale Sociale N.17 “Montagna Pescarese” Azienda ASL Di Pescara
Ambito Distrettuale Sociale n.17 “Montagna Pescarese” Azienda ASL di Pescara Piano Sociale Distrettuale 2017/2018 ENTE AMBITO SOCIALE N. 17 “MONTAGNA PESCARESE” (P.S.R. 2016/2018) Comuni di: Abbateggio, Alanno, Bolognano, Bussi sul Tirino, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Salle, Sant’Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Tocco da Casauria, Torre de Passeri, Turrivalignani Indice pag. Presentazione ...................................................................................................................................... 4 SEZIONE 1. ASSETTI ISTITUZIONALI E FORMAZIONE DEL PIANO DISTRETTUALE .............................................................................................................................. 5 1.1. Gli assetti istituzionali dell’Ambito distrettuale ............................................................................ 5 1.2. L’Ufficio di Piano .......................................................................................................................... 5 1.3. Il processo di formazione del Piano sociale distrettuale ................................................................ 6 1.4. Il Gruppo di Piano ......................................................................................................................... 8 1.5. La Conferenza locale socio-sanitaria e gli assetti di integrazione ................................................ -

Edited by Giovanni Lattanzi -.:: Camera Di Commercio Di Chieti
edited by Giovanni Lattanzi index introduction 5 craft in Abruzzo, a long history 6 craftmen, instructions for use 12 province of Chieti, capitals of craft Guardiagrele 16 Lanciano 22 Chieti 28 Vasto 36 province of Chieti, routes for the craft workshops the stone masters 42 the goldsmith’s masters 48 the glass masters 56 the ceramics masters 60 the iron and copper masters 68 the paper and decorations masters 74 the leather, textiles and embroidery masters 80 the wood masters 86 introduction his work, that I have the pleasure of presenting, moves out of the normal schemes that distinguish it from guides on Tartistic craft to offer the keen traveler a cross-section of the territory of our province indicating some tourist itineraries that include, apart from the artistic and environment beauties, what this province can offer, also an index of craft workshops representing various sectors. The guide to the itineraries to artistic craft wishes to tell of the magic spell of our villages and of people’s passion that animate these places through their work with the awareness that it is possible to hand down the memory only by drawing visitors close to this priceless heritage. The Chieti province, with its peculiarity of environment and traditions, is the ideal place to satisfy the curiosity of the attentive tourist. The four chosen itineraries are just a small part of what this territory has to offer. This guide is testimony to the interest the Chamber of Commerce of Chieti nurtures for this sector, so important because it is evidence of a civilization that proposes itself in such an evident way. -

Aristocratic Society in Abruzzo, C.950-1140
Aristocratic society in Abruzzo, c.950-1140 Felim McGrath A dissertation for the degree of Doctor of Philosophy University of Dublin 2014 Declaration I declare that this thesis has not been submitted as an exercise for a degree at this or any other university and it is entirely my own work. I agree to deposit this thesis in the University’s open access institutional repository or allow the Library to do so on my behalf, subject to Irish Copyright Legislation and Trinity College Library conditions of use and acknowledgement. ____________________________ Felim McGrath iii Summary This thesis is an examination of aristocratic society in the Italian province of Abruzzo from the mid-tenth century to the incorporation of the region into the kingdom of Sicily in 1140. To rectify the historiographical deficit that exists concerning this topic, this thesis analyses the aristocracy of Abruzzo from the tenth to the twelfth centuries. It elucidates the political fragmentation apparent in the region before the Norman invasion, the establishment and administration of the Abruzzese Norman lordships and their network of political connections and the divergent political strategies employed by the local aristocracy in response to the Norman conquest. As the traditional narrative sources for the history of medieval southern Italy provide little information concerning Abruzzo, critical analysis of the idiosyncratic Abruzzese narrative and documentary sources is fundamental to the understanding this subject and this thesis provides a detailed examination of the intent, ideological context and utility of these sources to facilitate this investigation. Chapter 1 of this thesis examines the historical and ideological context of the most important medieval Abruzzese source – the chronicle-cartulary of San Clemente a Casauria. -

Europe's Greenest Region Gran Sasso E Monti Della Laga National Park Majella National Park Abruzzo, Lazio E Molise Na
en_ambiente&natura:Layout 1 3-09-2008 12:33 Pagina 1 Abruzzo: Europe’s 2 greenest region Gran Sasso e Monti della Laga 6 National Park 12 Majella National Park Abruzzo, Lazio e Molise 20 National Park Sirente-Velino 26 Regional Park Regional Reserves and 30 Oases Abruzzo Promozione Turismo - Corso V. Emanuele II, 301 - 65122 Pescara - Email [email protected] en_ambiente&natura:Layout 1 3-09-2008 12:33 Pagina 2 ABRUZZO In Abruzzo nature is a protected resource. With a third of its territory set aside as Park, the region not only holds a cultural and civil record for protection of the environment, but also stands as the biggest nature area in Europe: the real green heart of the Mediterranean. Abruzzo Promozione Turismo - Corso V. Emanuele II, 301 - 65122 Pescara - Email [email protected] en_ambiente&natura:Layout 1 3-09-2008 12:33 Pagina 3 ABRUZZO ITALY 3 Europe’s greenest region In Abruzzo, a third of the territory is set aside in protected areas: three National Parks, a Regional Park and more than 30 Nature Reserves. A visionary and tough decision by those who have made the environment their resource and will project Abruzzo into a major and leading role in “green tourism”. Overall most of this legacy – but not all – is to be found in the mountains, where the landscapes and ecosystems change according to altitude, shifting from typically Mediterranean milieus to outright alpine scenarios, with mugo pine groves and high-altitude steppe. Of all the Apennine regions, Abruzzo is distinctive for its prevalently mountainous nature, -

Presentazione Aziendale New
ELECTROINDUSTRIAL INSTALLATIONS FOR OVER 40 YEARS I C E E L S. r. l. ELECTRICAL AND ELECTRONIC CONSTRUCTION COMPANY HQ: Via Boezio 4/C – 00913 ROME (ITALY) P.IVA 01491490692 tel. 0039 0873 301014 - fax 0039 0873 301016 O: Via San Leonardo 7F – 66054 Vasto (CH) (ITALY) C.F. 00691220636 www.iceel.it - mail: [email protected] ELECTROINDUSTRIAL INSTALLATIONS FOR OVER 40 YEARS VALUES FLEXIBILITY The ICEEL Srl has been operating successfully in the field of electroindustrial installations for nearly 40 years. Thanks to the flexibility that is not common, it has managed to diversify industry-specific interventions and the construction of plants, electrical and electronic equipment for industrial applications. The ability to measure all work with the investment plans of the customer, allows ICEEL to create tailor- made solutions which has realized important relationships and earned important consideration and credit. CULTURE AND INNOVATION The experience of ICEEL Srl, gained over the years, also for the work of highly qualified management and staff, has been the engine to acquire a real "culture" system able to ensure the optimization of execution. This was the starting point to tend to continuous improvement and to ensure technological innovation in the choices of installations, maintenance and management to ensure the overall quality of its interventions. SAFETY Aware of the fact that life is a precious, unique and indispensable ICEEL prefigured and pursued a path of "safety objective" for years, that lead her through a challenging policy in the field, to reach advanced results in this capital area. The planning refresher courses combined with specific awareness of staff and collaborators to continued compliance with the rules of hygiene and safety and the use of specific devices adapted to various types of risk, allows ICEEL to prevent the possible cause of injury and ponder wisely the residual risks present in each intervention. -

Vademecum Del Terremoto
Informazione Toccolana Periodico di informazione e cultura edito dal Comune di Tocco da Casauria n. 1 anno 2009 (26) Giugno - Diffusione gratuita Le lettere al Sindaco vanno inviate all’indirizzo IL DETTO: A pajare viecchie n’ce manche li surge [email protected] IL PAESE EDITORIALE Riflettori su tutte le ordinanze ministeriali Altezza s.l.m.m. 356 m. • ABITANTI 2831 • MASCHI 1402 Guardare Vademecum del terremoto • FEMMINE 1429 Tocco TELEFONI UTILI Le valutazioni dei danni anche da tecnici di fiducia • Municipio 085.880533-4 di RIZIERO ZACCAGNINI di ERIBERTO DI LORETO • Carabinieri 085.880502 Sindaco Consigliere comunale • Polizia Municipale na tesi di laurea sulla ge- l Presidente del Consiglio Finanziato il consolidamento del castello 085.8809245 Ustione dei rifiuti a Tocco dei Ministri ha emanato • Corpo Forestale (mentre il Governo nasconde dueI ordinanze la n. 3778 e lavori per seicentomila euro dalla Regione 085.880165 quelli di Napoli e promuove gli la n. 3779 che consentono • Farmacia 085.880506 inceneritori), una sull’utilizzo di ottenere i contributi per dell’energia eolica, una sui consumi e sulle azioni volte la cd. “ricostruzione leggera” al risparmio energetico (men- degli edifici danneggiati. Si GRAZie tre in barba alla democrazia tratta di quell’insieme dei e a uno storico referendum si interventi necessari alla ripa- CARABinieRI riaprono in Italia le porte al razione degli edifici che nelle nucleare). verifiche tecniche di agibilità La comunità toccolana ri- Ancora: riconoscimenti a livello risultano di tipo A, B oppure volge un ringraziamento nazionale, inchieste, indagini C. Ci sono infatti, diversi alla locale stazione dei Ca- sul rapporto tra partecipazione livelli di classificazione dei rabinieri, per l’aumentato e pianificazione del territorio danni provocati dal sisma grado di sicurezza che si che hanno come oggetto di è raggiunto in paese negli studio il nostro paese. -

Formato Europeo Per Il Curriculum Vitae
CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome e Cognome ZAIRA LAZZARI Nazionalità Italiana Domicilio Stato Civile Data di nascita Patente o patenti SOFT SKILLS Flessibilità, problem solving, spirito d’iniziativa, capacità di pianificare ed organizzare, conseguire obiettivi, apprendimento e miglioramento continuo OCCUPAZIONE Psicologa DESIDERATA ISTRUZIONE E FORMAZIONE DIPLOMA • Data 2011 • Nome e tipo di istituto di Liceo Scientifico “F. Capece” – Maglie (LE) istruzione o formazione • Qualifica conseguita Maturità Scientifica LAUREA • Data 2016 • Nome e tipo di istituto di Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti – Pescara istruzione o formazione Facoltà di Psicologia • Qualifica Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute (LM-51) conseguita con votazione 108/110 ALBO PROFESSIONALE • Data 2018 • Qualifica conseguita Iscrizione all’Albo A degli Psicologi - Regione Puglia, n. 5791 CORSI DIFORMAZIONE 5-6/10/2019 Seminario – Formazione in presenza Punti e Linee, tamburi sottili, tuboing, voce e body percussion intorno all’Orff-Schulwerk Italiano , tenuto dal prof.Conrado A. Da 07/2019 in corso Corso Quadriennale di Musicoterapia Scuola di Assisi II anno 07/2019 Corso di formazione Tecnico operatore ABA “Autismo e socializzazione” A cura del Direttore della Fondazione Lovaas Da 01/2018 3’ anno in corso Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Istituto Associazione di Psicologia Cognitiva sede di Lecce (APC-SPC, Francesco Mancini) 2018 Eccellenze in digitale Camera di Commercio di Chieti-Pescara, UnionCamere, Google