— Le Rime Di Bernardo Cappello Edizione Critica
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Camillo Camilli's Imprese for the Academies
Journal of Literature and Art Studies, April 2018, Vol. 8, No. 4, 589-613 doi: 10.17265/2159-5836/2018.04.009 D DAVID PUBLISHING Camillo Camilli’s Imprese for the Academies Liana De Girolami Cheney Independent Scholar, Boston, MA, USA This study examines the humanistic influence of ancient and Renaissance art in Camillo Camilli’s Imprese of 1586. Camillo Camilli (ca. 1560-1615—his exact birth date is unknown) was an Italian poet of the sixteenth-century. His family came from Monte San Savino, Siena, and records mention that he died on July 13, 1615, in Ragusa. While personal documentation on Camilli’s life is scarce there are substantial sources about his literary career as a translator, compiler and poet. Camilli wrote extensively. There are the five canti on Erminia e Tancredi which were collated with Tarquo Tasso’s (1544-1595) unfinished poems, and his commentaries for Ludovico Ariosto’s Orlando Furioso in 1584 and for Tasso’s Gerusalemme Liberata in 1585. Under the influence of Tasso’s writings and his involvement in the commentary of Gerusalemme Liberata (1585), Camilli started formulating his concetto (conceit) of what an impresa is (badge, device or insignia). The focus of this essay is on Camilli’s Imprese for the Academies. The whole collection of the Imprese consists of three volumes. The frontispiece to each volume depicts three different stage settings filled with classical ornamentation and bearing in the center of the lintel the impresa or insignia of Francesco Ziletti’s printing company—a starfish surrounded by stars and bound by a ribbon. -

Scansia O Poeti D'ogni Genere
Scanzia O [O 4] Bembo Pietro. Rime unitavi la vita scritta dal Porcacchi. Bergamo 1745. Pietro Lancelotto. Poeti di ogni genere O.2. Poeti serj a tutto il 1500 BEMBO, Pietro Rime di m. Pietro Bembo corrette, illustrate, ed accresciute come dalla prefazione si puo vedere. [O 1] S'aggiungono le poesie latine, e la vita dell'autore Ariosto Lodovico. L'Orlando furioso con le descritta da Tommaso Porcacchi di varie annotazioni annotazioni del Ruscelli. Venezia 1603. Felice novellamente illustrata. Valgrisi. O.1. In Bergamo: appresso Pietro Lancellotti, 1745. ATL M.IV.16 ARIOSTO, Ludovico Orlando furioso di m. Lodouico Ariosto, tutto ricorretto, & di nuoue figure adornato, con le annotationi, gli [O 5] auuertimenti, & le dichiarationi di Ieronimo Ruscelli. Bolognetti Franc.o. Il Constante poema. La vita dell'autore descritta dal signor Giouanbattista Venezia 1565. Dom. Mirolini. O.1 sotto. Pigna. Gli scontri de' luoghi mutati dall'autore dopo la prima impressione. La dichiaratione di tutte le istorie, BOLOGNETTI, Francesco & fauole toccate nel presente libro, fatte da m. Nicolo Il Constante di m. Francesco Bolognetti. Eugenico. Di nuouo aggiuntoui li Cinque canti del In Venetia: per Domenico Nicolino, 1565. medesimo autore. Et una tauola de' principij di tutte le ATL M.I.12 stanze. Con altre cose vtili, & necessarie. In Venetia: appresso Felice Valgrisi, 1603. Nota di possesso: «Gaia» ATL M.VI.3 [O 6] [O 2] a Corbellini. Rime. Torino 1603. Dom. Tarino. Item. Opere; esistono solo i tomi III e IV . O.1 sotto. Bassano 1780. Remondini. O.7. Posti a nell'armadietto CORBELLINI, Aurelio Rime di F. -

Philip Sidney's Book-Buying at Venice and Padua, Giovanni Varisco's Venetian Editions of Jacopo Sannazaro's Arcadia
This is a repository copy of Philip Sidney's Book-Buying at Venice and Padua, Giovanni Varisco's Venetian editions of Jacopo Sannazaro's Arcadia (1571 and 1578) and Edmund Spenser's The Shepheardes Calender (1579). White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/136570/ Version: Accepted Version Article: Brennan, MG orcid.org/0000-0001-6310-9722 (2018) Philip Sidney's Book-Buying at Venice and Padua, Giovanni Varisco's Venetian editions of Jacopo Sannazaro's Arcadia (1571 and 1578) and Edmund Spenser's The Shepheardes Calender (1579). Sidney Journal, 36 (1). pp. 19-40. ISSN 1480-0926 Reuse Items deposited in White Rose Research Online are protected by copyright, with all rights reserved unless indicated otherwise. They may be downloaded and/or printed for private study, or other acts as permitted by national copyright laws. The publisher or other rights holders may allow further reproduction and re-use of the full text version. This is indicated by the licence information on the White Rose Research Online record for the item. Takedown If you consider content in White Rose Research Online to be in breach of UK law, please notify us by emailing [email protected] including the URL of the record and the reason for the withdrawal request. [email protected] https://eprints.whiterose.ac.uk/ 1 Philip Sidney’s Book-Buying at Venice and Padua, Giovanni Varisco’s Venetian editions of Jacopo Sannazaro’s Arcadia (1571 and 1578) and Edmund Spenser’s The Shepheardes Calender (1579)1 [Abstract] This essay traces Philip Sidney’s involvements with the book trade at Venice and Padua during his residence there from November 1573 until August 1574. -

Childe Harold's Pilgrimage Canto Iv
CHILDE HAROLD’S PILGRIMAGE CANTO IV Look at the end for Appendix 1: Hobhouse’s four stanzas “in the Childe’s style” and Appendix 2: Gibbon, Chapter 71. Background Byron arrived in Venice on November 10th 1816, and stayed while Hobhouse travelled with members his family to Naples. Unwillingly – for he was most attached to his Venetian mistress, Mariana Segati – Byron went south on April 17th 1817. He paid a short visit to Florence on April 22nd, and then proceeded to Rome, where, with Hobhouse, he stayed between April 29th and May 20th. 1 He returned to Venice on May 28th. He started Childe Harold IV on June 26th, and had finished the first draft by July 29th. He worked on the poem throughout the autumn, stopping only to rough-out Beppo , a poem so diametrically opposed to Childe Harold in matter and idiom that it might have come from another pen. Hobhouse left Venice on January 7th 1818, and Byron wrote to Murray My dear Mr Murray, You’re in damned hurry To set up this ultimate Canto, But (if they don’t rob us) You’ll see M r Hobhouse Will bring it safe in his portmanteau. 2 – The poem was published on April 28th 1818. Influence The fourth and last canto of Byron’s poem shows his holiday with Shelley (palpable for much of Canto III) to be over, and the baleful influence of Hobhouse to have returned. Claire Claremont wrote to her ex-lover on January 12th 1818, after the poem had been dispatched, with Hobhouse, to London. -

Torquato Tasso and the Problem of Vernacular Epic in 16Th-Century Italy
THE TRUMPET AND THE LYRE: TORQUATO TASSO AND THE PROBLEM OF VERNACULAR EPIC IN 16TH-CENTURY ITALY by Christopher Geekie A dissertation submitted to Johns Hopkins University in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Baltimore, Maryland July 19th, 2017 © Christopher Geekie 2017 All rights reserved ABSTRACT In this dissertation, I analyze conceptions of epic poetry in sixteenth century Italy, specif- ically the debates surrounding vernacular poetic language, which ultimately produce the first successful Italian epic, Torquato Tasso’s Gerusalemme liberata. While scholars have mainly focused on early interpretations of Aristotle’s Poetics and questions of narrative structure, I argue for a shift towards analyzing discourses of language and style, which provide a more concrete framework for understanding Tasso’s poetic innovation. Examin- ing linguistic and literary texts from the 1530s to 1560s, I focus on issues of establishing a stable vernacular poetic language capable of equalling classical forms, specifically that of epic, at a time when the epic genre is defined by an exacting set of aesthetic expec- tations seemingly at odds with a predominantly lyric tradition grounded in Petrarchan love poetry. I argue that an unstable critical moment emerges by the mid sixteenth cen- tury concerning the ability of poets to translate the ideal form of classical epic into the mellifluous Italian language. This tension leads to experimentation with various formal elements that concern sound, notably meter and rhyme. I conclude that Tasso addresses this issue of sound with a radical theory of epic style based on the unconventional aes- thetic qualities of harshness, dissonance, and sonority. -

Verkauf Eines Hauses in Der Toskana
Rif. 0103 Lionard s.r.l. - via dei Banchi, 6 - ang. Piazza S. Maria Novella 50123 Firenze Italia - Tel. +39 055 0548100| Fax. +39 055 0548150 C.F. e P.IVA: 01660450477 - REA PT 173842 - Cap. Soc € 30.000 i. v. www.lionard.com - [email protected] Lionard Luxury Real Estate Via dei Banchi, 6 - ang. Piazza S. Maria Novella 50123 Florence Italy Tel. +39 055 0548100 Fax. +39 055 0548150 FLORENZ VERKAUF EINES HAUSES IN DER TOSKANA Beschreibung TOSKANA – Luxus-Landhaus zum Verkauf in Florenz. Zwei perfekt gepflegte Luxus-Villen von insgesamt 900 m2 , mit 3 ha Olivenhainen und zwei Swimmingpools. Die Luxusvilla liegt eingebettet in die herrliche Landschaft des malerische Dorfes Montaione und besteht aus zehn geräumige Apartments: Acht dieser Wohnungen wurden im Inneren des 630 m2 gro?em, typisch toskanischen Landhauses aus dem 17. Jhdt , unter Beibehaltung der architektonischen Linien und Bögen, Gewölbe und Deckenbalken , errichtet. Zwei weitere Wohnungen wurden in der 160m2 gro?en Scheune realisiert. Das renommierte zum Verkauf angeboten Landhaus war einst im Besitz von Vincenzo da Filicaja, ein Dichter der mit dem Santa Croce Orden ausgezeichnet wurde und von dem die heutigen Besitzer abstammen. Er erhielt diese Prestige-Immobilie als Geschenk von der Familie Medici.Die Wohnungen haben den renommierten Luxus-Villa haben männliche und weibliche Namen, welche auf die Namen der alten Besitzer zurückgehen. Die beiden Luxus-Häuser sind von 3 Ha Land mit Olivenbäumen umgeben, welche der Gegend das typische Aussehen der toskanischen grünen Hügeln, mit ihren ordentlichen Reihen von grünen Lionard s.r.l. - via dei Banchi, 6 - ang. Piazza S. -

On the Threshold of Poems: a Paratextual Approach to the Narrative/Lyric Opposition in Italian Renaissance Poetry
This is a repository copy of On the Threshold of Poems: a Paratextual Approach to the Narrative/Lyric Opposition in Italian Renaissance Poetry. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/119858/ Version: Accepted Version Book Section: Pich, F (2019) On the Threshold of Poems: a Paratextual Approach to the Narrative/Lyric Opposition in Italian Renaissance Poetry. In: Venturi, F, (ed.) Self-Commentary in Early Modern European Literature, 1400-1700. Intersections, 62 . Brill , pp. 99-134. ISBN 9789004346864 https://doi.org/10.1163/9789004396593_006 © Koninklijke Brill NV, Leiden, 2019. This is an author produced version of a paper published in Self-Commentary in Early Modern European Literature, 1400-1700 (Intersections). Uploaded in accordance with the publisher's self-archiving policy. Reuse Items deposited in White Rose Research Online are protected by copyright, with all rights reserved unless indicated otherwise. They may be downloaded and/or printed for private study, or other acts as permitted by national copyright laws. The publisher or other rights holders may allow further reproduction and re-use of the full text version. This is indicated by the licence information on the White Rose Research Online record for the item. Takedown If you consider content in White Rose Research Online to be in breach of UK law, please notify us by emailing [email protected] including the URL of the record and the reason for the withdrawal request. [email protected] https://eprints.whiterose.ac.uk/ 1 On the Threshold of Poems: a Paratextual Approach to the Narrative/Lyric Opposition in Italian Renaissance Poetry Federica Pich Summary This contribution focuses on the presence and function of prose rubrics in fifteenth- and sixteenth-century lyric collections. -

“A MUCH MILDER MEDIUM”: ENGLISH and GERMAN WOMEN WRITERS in ITALY 1840-1880 by Federica Belluccini Submitted in Partial Fulf
“A MUCH MILDER MEDIUM”: ENGLISH AND GERMAN WOMEN WRITERS IN ITALY 1840-1880 by Federica Belluccini Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at Dalhousie University Halifax, Nova Scotia December 2011 © Copyright by Federica Belluccini, 2011 DALHOUSIE UNIVERSITY INTERDISCIPLINARY PHD PROGRAM The undersigned hereby certify that they have read and recommend to the Faculty of Graduate Studies for acceptance a thesis entitled ““A MUCH MILDER MEDIUM”: ENGLISH AND GERMAN WOMEN WRITERS IN ITALY 1840-1880” by Federica Belluccini in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Dated: December 2, 2011 External Examiner: _________________________________ Research Supervisor: _________________________________ Examining Committee: _________________________________ _________________________________ Departmental Representative: _________________________________ ii DALHOUSIE UNIVERSITY DATE: December 2, 2011 AUTHOR: Federica Belluccini TITLE: “A MUCH MILDER MEDIUM”: ENGLISH AND GERMAN WOMEN WRITERS IN ITALY 1840-1880 DEPARTMENT OR SCHOOL: Interdisciplinary PhD Program DEGREE: PhD CONVOCATION: May YEAR: 2012 Permission is herewith granted to Dalhousie University to circulate and to have copied for non-commercial purposes, at its discretion, the above title upon the request of individuals or institutions. I understand that my thesis will be electronically available to the public. The author reserves other publication rights, and neither the thesis nor extensive extracts from it may be printed or otherwise reproduced without the author’s written permission. The author attests that permission has been obtained for the use of any copyrighted material appearing in the thesis (other than the brief excerpts requiring only proper acknowledgement in scholarly writing), and that all such use is clearly acknowledged. _______________________________ Signature of Author iii In Memory of Dr. -

Idées Et Formes Du Tragique Dans La Société Et La Culture Italiennes De L’Humanisme À La Fin De L’Époque Moderne
Cahiers d’études italiennes Filigrana 19 | 2014 Idées et formes du tragique dans la société et la culture italiennes De l’Humanisme à la fin de l’époque moderne Patrizia De Capitani (dir.) Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/cei/2048 DOI : 10.4000/cei.2048 ISSN : 2260-779X Éditeur UGA Éditions/Université Grenoble Alpes Édition imprimée Date de publication : 1 novembre 2014 ISBN : 978-2-84310-285-1 ISSN : 1770-9571 Référence électronique Patrizia De Capitani (dir.), Cahiers d’études italiennes, 19 | 2014, « Idées et formes du tragique dans la société et la culture italiennes » [En ligne], mis en ligne le 01 mai 2016, consulté le 26 mars 2021. URL : http://journals.openedition.org/cei/2048 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cei.2048 © ELLUG Cahiers d’études italiennes Filigrana No 19 / 2014 Idées et formes du tragique dans la société et la culture italiennes De l’Humanisme à la fin de l’époque moderne Études réunies par Patrizia De Capitani Gerci Groupe d’études et de recherches sur la culture italienne Université Grenoble Alpes Directeur de la publication Enzo Neppi (Novecento… e dintorni) Serge Stolf (Filigrana) Comité de rédaction Filigrana Serge Stolf (Université Stendhal - Grenoble 3) Patrizia De Capitani (Université Stendhal - Grenoble 3) Filippo Fonio (Université Stendhal - Grenoble 3) Cécile Terreaux-Scotto (Université Stendhal - Grenoble 3) Novecento… e dintorni Enzo Neppi (Université Stendhal - Grenoble 3) Leonardo Casalino (Université Stendhal - Grenoble 3) Lisa El-Ghaoui (Université Stendhal - Grenoble 3) -
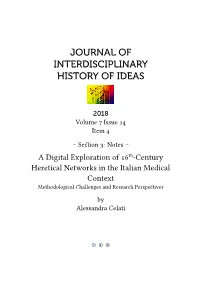
A Digital Exploration of 16Th-Century Heretical Networks in the Italian Medical Context Methodological Challenges and Research Perspectives *
JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY HISTORY OF IDEAS 2018 Volume 7 Issue 14 Item 4 – Section 3: Notes – A Digital Exploration of 16ᵗʰ-Century Heretical Networks in the Italian Medical Context Methodological Challenges and Research Perspectives by Alessandra Celati c b a JIHI 2018 Volume 7 Issue 14 Section 1: Editorials 1. Editorial (JIHI) Section 2: Articles 2. L’Antiquité tardive à l’épreuve du genre (S. Kerneis) 3. Condorcet, Kelsen et la règle de majorité (P. Pasquino) Section 3: Notes 4. A Digital Exploration of 16tʰ-Century Heretical Networks in the Italian Medical Context: Method- ological Challenges and Research Perspectives (A. Celati) Section 4: Reviews 5. Book Reviews (R. Soliani, L. Randone, E. Pasini) . A Digital Exploration of 16th-Century Heretical Networks in the Italian Medical Context Methodological Challenges and Research Perspectives * Alessandra Celati ** After the Reformation began in 1517, Protestant ideas soon crossed theAlpsand spread out of Italian cities, fascinating (especially, but not exclusively) the human- ists and scholars who were part of the late-Renaissance intellectual environment. In particular, between the 1530s and the 1590s a great number of Italian physicians absorbed, promoted, and re-elaborated, often in radical terms, the reformed and heretical discourse. In this article I am presenting some research perspectives and methodological challenges concerning the application of social network research and digital humanities tools to the history of 16tʰ-century religious dissent. In par- ticular, I will discuss and examine the reconstruction, out of a sample of 200 cases, of a network of dissident physicians who faced religious repression and opposed dogmatic confessional boundaries in Italy, and in their European diaspora, as a part of my own ongoing interdisciplinary research. -

Charlotte Smith and the Sonnet
1 Charlotte Smith and the Sonnet Thesis submitted in accordance with the requirements of the University of Liverpool for the degree of Doctor in Philosophy by Bethan Lloyd Roberts August 2014 2 For George Condliffe (1925-2014) i Acknowledgements Thank you, very much, to Paul Baines for supervising this thesis, and for all that has involved. Thank you to Kelvin Everest for reading and commenting on the draft. I would also like to thank the staff and postgraduate community in the School of English at the University of Liverpool – as well as in the university more widely – for their support and encouragement. For financial help, I am grateful to the University of Liverpool; Funds for Women Graduates; BARS, for a Stephen Copley Postgraduate Research Award; and am especially grateful to Barbara Statham and for the help I have received from the Price Memorial Scholarship Fund. Thank you to my family and friends for their support, especially my parents Jill and Lloyd; and to Huw, Emma and Simon. Special thanks to my Grandpa George: I would like to dedicate this thesis to him. Parts of chapters two and three have appeared as ‘From River to Sea: Literary Past and Present in Charlotte Smith’s Elegiac Sonnets’ in SEL Studies in English Literature, 54.3 (2014). ii Contents Acknowledgements i List of Illustrations iii Abstract iv Introduction 1 Thesis Structure 16 Chapter One: The Eighteenth-Century Sonnet 18 Elegiac Sonnets 46 Chapter Two: Tradition 52 Woodlands 52 Streams 65 River Arun 73 Other Poetic Landscapes 96 Chapter Three: Innovation 102 The Sea 102 ‘All the charms of novelty’ 106 Breaking ‘the silent Sabbath of the grave’: Sonnet XLIV 114 Between Sea and Churchyard 130 Giddy Brinks and Lucid Lines 140 Chapter Four: Wider Prospect of the Sonnet Revival 149 Illegitimate Sonnet 155 ‘Other Song’: 1789 and Beyond 161 Hotwells and Penshurst 170 Chapter Five: Botany to Beachy Head 185 The Goddess of Botany 188 Economies of Vegetation 194 Gossamer 201 Coda: Beachy Head 206 Bibliography 217 iii List of Illustrations 1. -

Autografi Manoscritti
AUTOGRAFI E MANOSCRITTI STORIA, FILOSOFIA E SCIENZE Pag. 3 LETTERATURA E TEATRO « 49 ARTE « 93 2 56. Farinacci, Ciano, Bruno Mussolini e Vittorio Mussolini STORIA, FILOSOFIA E SCIENZE 1. (Antropologia) Abissinia Manoscritto autografo intitolato “ Notizie circa i Bogos ”, costituito da 20 pagine in-4 rilegate in fascicolo. La memoria è strutturata in diversi paragrafi (circa trenta) riportanti argomenti, temi o domande che si intendono sviluppare relative ai Bogos , una popolazione indigena del nord dell’Abissinia (queste parti di testo sono vergate a penna nera e in italiano) ciascuno dei quali è seguito da una risposta - di altra mano - che è stata compilata sull’argomento specifico (testo a penna blu, in francese). Alcuni passi a titolo esemplificativo. “ Come [è] punito il furto - i ferimenti - l’omicidio - l’adulterio -la calunnia - la falsa testimonianza - il rifiuto d’obbedienza al Capo tribù - Debitori e creditori: ‘Le vol n’a autre punition que la restitution de l’objét volé au de l’équivalent (…) l’homicide pour la lois du talion. L’adultère du Mari reste impunée (…) Il Capo ha diritto di vita e di morte?: ‘Non, à ma conaissance, il n’ a pas ce droit pour sa qualité de chef (…) I figli - loro relazioni coi genitori - quando liberi - reati fra parenti - figli legittimi - figli illegittimi - figli di più mogli: come trattati. ‘Les enfants sont considérés comme le bien, la propriété du père… ”. Interessanti pagine di antropologia culturale, dense di correzioni e rifacimenti. La Società Geografica Italiana promosse una spedizione nel paese dei Bogos, compiuta dagli esploratori Orazio Antinori, Odoardo Beccari ed Arturo Issel nel 1870.