Allegato 5 Stratigrafie Dei Sondaggi
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Functions of Mountain Settiembnts in Relation to Their Physical Environment
THE FUNCTIONS OF MOUNTAIN SETTIEMBNTS IN RELATION TO THEIR PHYSICAL ENVIRONMENT RUTH HANNAM ProQuest Number: 10107214 All rights reserved INF0RMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed a note will indicate the deletion. uest. ProQuest 10107214 Published by ProQuest LLC(2016). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.Q. Box 1346 Ann Arbor, MI 48106-1346 ABSTRACT OF DISSERTATION THE FUNCTIONS OF MOUNTAIN SETTLEMENTS IN RELATION TO THEIR PHYSICAL ENVIROmŒNT A settlement is an expression of man’s activity, therefore they can be classed according to the predom ant activity in a particular place. The effect of mo conditions on the choice of site and the mode of livi in different types of settlements is discussed, I* Agricultural and Pastoral Settlements, These are the most numerous; the effects of altitu exposure, degree of slope, the nature of soils and la: forms, water supply and type of farming are discussed Examples(personal knowledge),Reichenbach(Kander Valle; and Devoluy in the Alps, Pyrenean Navarre and the Pic< de Europe in Spain, Others,The Val d*Anniviers; the Hunza Valley in the Karakoram; the Altiplano of Bolivia, II, Mining and Other Industrial Settlement, Mining in relation to geology and structure; artif: character of mining towns; areas where they are most important. -

Comunicato Funghi 2017
FUNGHI 2017 Con il subentro dal 1° gennaio 2016 della Unione Montana valle Susa al posto della precedente Comunità Montana, cambiano i riferimenti per il versamento degli importi per la raccolta funghi anno 2017. Il pagamento può avvenire: 1. mediante bonifico bancario; i dati identificativi sono: Unione Montana Valle Susa Via Carlo Trattenero 15 1053 Bussoleno (TO) Servizio di Cassa e Tesoreria: conto n. 46024 IBAN: IT30J 03069 30180 1000000 46024 Causale: raccolta funghi anno 2017 2. mediante versamento sul conto corrente postale n. IT-93-L-07601-01000-00 1037819503 Intestato a: Unione Montana Valle Susa Servizio Tesoreria Causale: raccolta funghi anno 2017 Gli importi sono i seguenti: € 30,00 per il titolo di raccolta con validità annuale € 60,00 per il titolo di raccolta con validità biennale € 90,00 per il titolo di raccolta con validità triennale Il titolo di raccolta ha validità su tutto il territorio regionale Per i residenti nei Comuni dell’Unione (Almese, Avigliana, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, San Didero, San Giorio di Susa, Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo) sono stati deliberati il 31 marzo 2016 dal Consiglio i seguenti importi ridotti: euro 20,00 per il rilascio del titolo di raccolta per la raccolta funghi annuale, euro 40,00 per il rilascio del titolo di raccolta per la raccolta funghi biennale euro 60,00 per il rilascio del titolo di raccolta per la raccolta funghi triennale Il titolo di raccolta ha validità solo sul territorio dei Comuni sopra elencati TRA TUTTI COLORO CHE EFFETTUARANNO UN VERSAMENTO RACCOLTA FUNGHI 2017 VERRANNO SORTEGGIATI, A FINE OTTOBRE 2017, TRE NOMINATIVI CUI SARA’ OFFERTA IN OMAGGIO UNA COPIA DEL VOLUME “TUTTO FUNGHI, CONOSCERLI, RACCOGLIERLI, CUCINARLI” . -

Modelling Last Glacial Cycle Ice Dynamics in the Alps
The Cryosphere Discuss., https://doi.org/10.5194/tc-2018-8 Manuscript under review for journal The Cryosphere Discussion started: 16 February 2018 c Author(s) 2018. CC BY 4.0 License. Modelling last glacial cycle ice dynamics in the Alps Julien Seguinot1, Guillaume Jouvet1, Matthias Huss1, Martin Funk1, Susan Ivy-Ochs2, and Frank Preusser3 1Laboratory of Hydraulics, Hydrology and Glaciology, ETH Zürich, Switzerland 2Laboratory of Ion Beam Physics, ETH Zürich, Switzerland 3Institute of Earth and Environmental Sciences, University of Freiburg, Germany Correspondence to: J. Seguinot ([email protected]) Abstract. The European Alps, cradle of pioneer glacial studies, are one of the regions where geological markers of past glaciations are most abundant and well-studied. Such conditions make the region ideal for testing numerical glacier models based on simplified ice flow physics against field-based reconstructions, and vice-versa. 5 Here, we use the Parallel Ice Sheet Model (PISM) to model the entire last glacial cycle (120–0 ka) in the Alps, using horizontal resolutions of 2 and 1 km and up to 576 processors. Climate forcing is derived using present-day climate data from WorldClim and the ERA-Interim reanalysis, and time-dependent temperature offsets from multiple palaeo-climate proxies, among which only the EPICA ice core record yields glaciation during marine oxygen isotope stages 4 (69–62 ka) and 2 (34– 18 ka) spatially and temporally consistent with the geological reconstructions, while the other records used result in excessive 10 early glacial cycle ice cover and a late Last Glacial Maximum. Despite the low variability of this Antarctic-based climate forcing, our simulation depicts a highly dynamic ice sheet, showing that Alpine glaciers may have advanced many times over the foreland during the last glacial cycle. -

TOPONOMASTICA Nome Ufficiale Del Comune Usseglio Nome L.M
TOPONOMASTICA Nome ufficiale del comune Usseglio Nome L.M. (escolo dou pò) Nome L.M. (normalizzata) Useui Microtoponimo Nome ufficiale Non documentato Nome tradiz. L.M. (escolo dou pò) Nome tradiz. L.M. (normalizzata) la Bòiri Coordinate UTM GPS ED1950 32 T 359277 5011294 Quota in m CTR 1:10000 1620 Eventuale significato Cavità naturale o artificiale sfruttata dall’uomo Descrizione geografica Il microtoponimo indica una cavità mineralizzata, del tutto o in parte artificiale, che si apre nel versante destro del basso vallone di Servin (‘d Servìn) entro una fascia di calcescisti. La mineralizzazione consiste in una concentrazione di solfuri massivi di ferro-rame-zinco legata a processi esalativo- sedimentari, formatasi in contesto geologico di tipo ofiolitico; essa può essere stata sfruttata, in età per ora imprecisabile, per il rame o per la produzione di acido solforico (a partire dalla pirite). Poco più in alto (1626 m) è presente una seconda cavità più piccola, interamente artificiale (fori di barramina). Parte turistico - storico - Bòira, nelle sue diverse varianti (bòiri, bora, boùira, boùire, etnografica bouìri, bourì, bura), è termine ampiamente diffuso non solo in area francoprovenzale (valli di Susa, Cenischia, Ala, Orco e Soana, alta Dora Baltea), ma anche occitana (sino ai Pirenei catalani), con significato di ‘grotta, cavità anche artificiale, buca profonda su terreno piano o fra grossi blocchi rocciosi’. A Usseglio B. Terracini registra “boiri botro” senza precisare se intenda botro nel senso letterario di ‘fossato, valloncello scosceso soggetto a forte erosione’ o in quello archeologico di ‘pozzo per rifiuti, libagioni od offerte’. In val Soana boijra/boijro compare in atti notarili del 1679-1749 con significato di ‘taglio del terreno dovuto a cause naturali (frane del terreno morenico, affossamenti talora con piccolo lago) o artificiali (gallerie e scarichi di miniere)’. -

Bumble Bees of the Susa Valley (Hymenoptera Apidae)
Bulletin of Insectology 63 (1): 137-152, 2010 ISSN 1721-8861 Bumble bees of the Susa Valley (Hymenoptera Apidae) Aulo MANINO, Augusto PATETTA, Giulia BOGLIETTI, Marco PORPORATO Di.Va.P.R.A. - Entomologia e Zoologia applicate all’Ambiente “Carlo Vidano”, Università di Torino, Grugliasco, Italy Abstract A survey of bumble bees (Bombus Latreille) of the Susa Valley was conducted at 124 locations between 340 and 3,130 m a.s.l. representative of the whole territory, which lies within the Cottian Central Alps, the Northern Cottian Alps, and the South-eastern Graian Alps. Altogether 1,102 specimens were collected and determined (180 queens, 227 males, and 695 workers) belonging to 30 species - two of which are represented by two subspecies - which account for 70% of those known in Italy, demonstrating the particular value of the area examined with regard to environmental quality and biodiversity. Bombus soroeensis (F.), Bombus me- somelas Gerstaecker, Bombus ruderarius (Mueller), Bombus monticola Smith, Bombus pratorum (L.), Bombus lucorum (L.), Bombus terrestris (L.), and Bombus lapidarius (L.) can be considered predominant, each one representing more than 5% of the collected specimens, 12 species are rather common (1-5% of specimens) and the remaining nine rare (less than 1%). A list of col- lected specimens with collection localities and dates is provided. To illustrate more clearly the altitudinal distribution of the dif- ferent species, the capture locations were grouped by altitude. 83.5% of the samples is also provided with data on the plant on which they were collected, comprising a total of 52 plant genera within 20 plant families. -

TESTO COORDINATO DELL'allegato a ALLA DCR N. 563-13414 Del 29.10.99 “INDIRIZZI GENERALI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANIST
TESTO COORDINATO DELL’ALLEGATO A ALLA DCR n. 563-13414 del 29.10.99 “INDIRIZZI GENERALI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER L’INSEDIAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS 31.3.1998 114/98” COME MODIFICATO DALLA DCR n. 347-42514 del 23.12.2003 E DALLA DCR n. 59-10831 del 24.03.2006 ELENCO COMUNI MINORI PROVINCIA DI TORINO: AGLIE', ALA DI STURA, ALBIANO D'IVREA, ALICE SUPERIORE, ALPETTE, ANDEZENO, ANDRATE, ANGROGNA, ARIGNANO, AZEGLIO, BAIRO, BALDISSERO CANAVESE, BALME, BARBANIA, BARONE CANAVESE, BIBIANA, BOBBIO PELLICE, BOLLENGO, BORGIALLO, BORGOMASINO, BORGONE SUSA, BOSCONERO, BROSSO, BROZOLO, BRUSASCO, BRUZOLO, BURIASCO, BUROLO, BUSANO, CAMPIGLIONE FENILE, CANDIA CANAVESE, CANISCHIO, CANTALUPA, CANTOIRA, CAPRIE, CARAVINO, CAREMA, CASALBORGONE, CASCINETTE D'IVREA, CASELETTE, CASTAGNETO PO, CASTAGNOLE PIEMONTE, CASTELNUOVO NIGRA, CAVAGNOLO, CERCENASCO, CERES, CERESOLE REALE, CESANA TORINESE, CHIALAMBERTO, CHIANOCCO, CHIAVERANO, CHIESANUOVA, CHIOMONTE, CHIUSA DI SAN MICHELE, CICONIO, CINTANO, CINZANO, CLAVIERE, COASSOLO TORINESE, COAZZE, COLLERETTO CASTELNUOVO, COLLERETTO GIACOSA, COSSANO CANAVESE, CUCEGLIO, EXILLES, FELETTO, FENESTRELLE, FIANO, FIORANO CANAVESE, FOGLIZZO, FRASSINETTO, FRONT, FROSSASCO, GARZIGLIANA, GERMAGNANO, GIAGLIONE, GIVOLETTO, GRAVERE, GROSCAVALLO, GROSSO, INGRIA, INVERSO PINASCA, ISOLABELLA, ISSIGLIO, LA CASSA, LAURIANO, LEMIE, LESSOLO, LEVONE, LOCANA, LOMBARDORE, LOMBRIASCO, LORANZE', LUGNACCO, LUSERNETTA, LUSIGLIE', MACELLO, MAGLIONE, MARENTINO, MASSELLO, MATTIE, MEANA DI -

Susa Gorge: a Demodulation Reservoir for Pont Ventoux Hydro Power Plant1
SUSA GORGE: A DEMODULATION RESERVOIR FOR PONT VENTOUX HYDRO POWER PLANT1 Ezio Baldovin Dr. Eng. Geotecna Progetti – Consulting Engineers – Milano Nicola Brizzo Dr. Eng. Iride Energia – Torino ITALY 1. INTRODUCTION Iride Energia S.p.A. (once A.E.M. of Turin S.p.A.) has completed the construction of the new Pont Ventoux-Susa Hydro Power and Pump Plant, now in phase of final acceptance. Located in High Susa Valley, it will substitute two old flowing plants built in 1910 and 1923, doubling the production of electric energy with diurnal operation of the turbines and night repumping of the water. The installed power is 150 MW and the foreseen production is bigger than 400 GWh/year. 1 Gorge de Susa: un réservoir de démodulation pour l’Aménagement hydroélectrique de Pont Ventoux 2. THE HYDRO POWER PLANT The water is diverted at Pont Ventoux from Dora Riparia River, tributary of Po River, with a maximum flow discharge of 34 m3/s and, after an average geodetic jump of about 515 m, it is returned to the same river about 1 km upstream of Susa Town (Fig. 1). Fig. 1 Pont Ventoux – Susa Hydro Power Plant lay-out Plan général de l’Aménagement Hydroélectrique de Pont Ventoux – Susa A Dora Riparia River A Fleuve Dora Riparia B Clarea River B Fleuve Clarea 1 Pont Ventoux gate-structure Dam 1 Traverse de Pont Ventoux 2 Conveyance tunnel 2 Tunnel de dérivation 3 Clarea Basin 3 Bassin de Clarea 4 Pressure tunnel 4 Tunnel en pression 5 Penstock in shaft 5 Conduite forcée en puits 6 Underground power station 6 Usine hydroélectrique souterraine 7 Susa Dam 7 Barrage -

It1110039 – Rocciamelone
NUOVA LINEA TORINO LIONE PARTE COMUNE ITALO FRANCESE - TRATTA IN TERRITORIO ITALIANO CUP C11J05000030001 PROGETTO PRELIMINARE IN VARIANTE CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI VEGETAZIONE FLORA FAUNA ECOSISTEMI CENSIMENTO ED INDIVIDUAZIONE SORGENTI - NOTA TECNICA (Commissione VIA – Richiesta N. 15a) Indice Date / Data Modifications / Modifiche Etabli par / Concepito da Vérifié par / Controllato da Autorisé par / Autorizzato da BERNARDI GARAVOGLIA CHANTRON 0 15/12/2010 PRIMA EMISSIONE (TECNIMONT) OGNIBENE MANCARELLA N° P P 2 C 3 0 T S 3 1 1 5 1 0 P A N O T Doc Phase / Fase Sigle étude / Sigla Émetteur / Emittente Numero Indice Statut / Stato Type / Tipo ADRESSE GED / C3C // // 55 01 15 10 01 INDIRIZZO GED ECHELLE / SCALA - LTF sas - 1091 Avenue de la Boisse BP 80631 F-73006 CHAMBERY CEDEX (France) Tél.: +33 (0) 4.79.68.56.50 - Fax: +33 (0) 4.79.68.56.59 RCS Chambéry 439 556 952 – TVA FR 03439556952 Propriété LTF Tous droits réservés - Proprietà LTF Tutti i diritti riservati Bureau d’études TSE3 – Gruppo di progetto TSE3 BG-AMBERG–LOMBARDI-ARCADIS-TECNIMONT-STUDIO QUARANTA-SEA CONSULTING-ITALFERR-INEXIA-SYSTRA SOMMAIRE – INDICE 1 PREMESSA 3 2 METODOLOGIA E RISULTATI DELL’INDAGINE SVOLTA 3 SIC IT1110039 – ROCCIAMELONE 8 SIC IT1110030 – OASI XEROTERMICHE DELLA VAL DI SUSA - ORRIDO DI CHIANOCCO 10 SIC/ZPS IT1110006 – ORSIERA ROCCIAVRÈ 12 SIC IT1110027 – BOSCAGLIE DI TASSO DI GIAGLIONE 13 SIC IT1110055 – ARNODERA - COLLE MONTABONE 14 3 CONCLUSIONI 15 4 ALLEGATI 16 ALLEGATO 1 - SCHEDE DI MONITORAGGIO DELLE SORGENTI RICADENTI NEI SIC. 16 C30_1151-55-01-15-10-01_0_Flora -

Zona Naturale Di Salvaguardia Della Dora Riparia
Zona Naturale di Salvaguardia della Dora Riparia CONVENZIONE DI GESTIONE Rev 7 del 10/10/18 Art. 1 – Convenzione per la gestione associata della Zona naturale di Salvaguardia della Dora Riparia Ai sensi dell’art. 30, Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000), i Comuni di Almese, Alpignano, Avigliana, Buttigliera Alta, Caselette, Collegno, Pianezza, Rivoli e Rosta si convenzionano per la gestione associata della Zona naturale di Salvaguardia della Dora Riparia. E’ identificata quale Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia il territorio indicato con la sigla “z4” all’art. 52bis e perimetrato nelle Tavole nn. 75-78, alla scala 1:25.000 allegate al testo coordinato della Legge Regionale n. 19/2009, Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità. Art. 2 - Finalità e funzioni La Convenzione ha per scopo l’organizzazione della gestione amministrativa, tecnica, di pianificazione, promozione e valorizzazione della Zona naturale di salvaguardia individuata all’art. 1. In particolare, tramite la presente Convenzione, i Comuni sottoscrittori si propongono di organizzare la gestione associata della Zona naturale di salvaguardia. Scopi e finalità della gestione associata sono: Per seguire e garantire le finalità che hanno portato all’istituzione della Zona naturale di salvaguardia, così come indicate all’ art. 52ter della Legge Regionale n. 19/2009, Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità: a) tutelare gli ecosistemi agro-forestali esistenti; b) promuovere iniziative di recupero naturalistico -
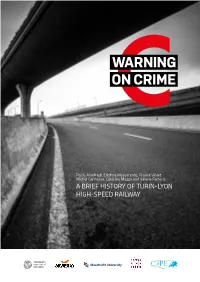
A Brief History of Turin-Lyon High-Speed Railway 2
1 Paola Manfredi, Cristina Massarente, Franck Violet, Michel Cannarsa, Caterina Mazza and Valeria Ferraris A BRIEF HISTORY OF TURIN-LYON HIGH-SPEED RAILWAY 2 Paola Manfredi, Cristina Massarente, Franck Violet, Michel Cannarsa, Caterina Mazza and Valeria Ferraris1 A brief history of Turin-Lyon high-speed railway Table of Content 1. Introduction 2. The origin of the project and the stakeholders involved 3. The history of the project 4. Criminal infiltration and high-speed railway in the media 5. References 1. Introduction The history of the project of the New Railway Line Turin-Lyon, shortened as NLTL and currently known as high-speed train Turin- Lyon (named TAV Turin-Lyon), saw a lot of stakeholders that interacted, exchanged, conflicted and overlapped. The first part of this paper aims at understanding the evolution/origin of the project in order to clarify the role of the Italian and French stakeholders involved. Then, the paper continues with the description of the main steps of the history of TAV project. In these steps will be underlined the moments in which some stakeholders have been involved in incidents of lawlessness and corruption. 2. The origin of the project and stakeholders involved 2.1 The Italian stakeholders The project for the TAV Turin-Lyon involved many Italian stakeholders, institutional and not. First of all in 1989 the Associazione Tecnocity2 presented in a public meeting at the Fondazione Agnelli the project of a high-speed railway line for passengers between France and Italy. The project foresees the construction of a transalpine tunnel 50 km long as a part of the future railway line between East and West Europe (Number Five Corridor3). -

The 4Dilan Project (4Th Dimension in Landscape and Artifacts Analyses)
POLITECNICO DI TORINO Repository ISTITUZIONALE THE 4DILAN PROJECT (4TH DIMENSION IN LANDSCAPE AND ARTIFACTS ANALYSES) Original THE 4DILAN PROJECT (4TH DIMENSION IN LANDSCAPE AND ARTIFACTS ANALYSES) / Chiabrando, Filiberto; Naretto, Monica; Sammartano, Giulia; Sambuelli, Luigi; Spano', Antonia Teresa; TEPPATI LOSE', Lorenzo. - In: INTERNATIONAL ARCHIVES OF THE PHOTOGRAMMETRY, REMOTE SENSING AND SPATIAL INFORMATION SCIENCES. - ISSN 2194-9034. - STAMPA. - XLII-5/W1(2017), pp. 227-234. Availability: This version is available at: 11583/2675389 since: 2017-06-30T00:53:09Z Publisher: Tucci G., Bonora V. Published DOI:10.5194/isprs-archives-XLII-5-W1-227-2017 Terms of use: openAccess This article is made available under terms and conditions as specified in the corresponding bibliographic description in the repository Publisher copyright (Article begins on next page) 08 December 2018 The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-5/W1, 2017 GEOMATICS & RESTORATION – Conservation of Cultural Heritage in the Digital Era, 22–24 May 2017, Florence, Italy THE 4DILAN PROJECT (4TH DIMENSION IN LANDSCAPE AND ARTIFACTS ANALYSES) F. Chiabrandoa, M. Narettoa, G. Sammartanoa, L. Sambuellib. A. Spanòa,*, L. Teppati Losèa a Politecnico di Torino, DAD, 10129, Torino, Italy - (filiberto.chiabrando, monica.naretto, giulia.sammartano, antonia.spano, lorenzo teppati)@polito.it b Politecnico di Torino, DIATI, 10129, Torino, Italy - (luigi [email protected]) WG V/1, WG V/2, WG II/8 WG IV/2 KEY WORDS: 3D modelling, UAV photogrammetry, GPR (Ground Penetrating Radar), TLS (Terrestrial laser scanning), archive documents, knowledge for conservation project ABSTRACT: The project is part of the wider application and subsequent spread of innovative digital technologies involving robotic systems. -

PRESS RELEASE from No TAV Valleys, 27Th of November, 2009 - - -
PRESS RELEASE from No TAV Valleys, 27th of November, 2009 www.notav.info - www.notav-valsangone.eu - www.notavtorino.org - www.notav.eu - www.ambientevalsusa.it The Committee on Petitions of the European Parliament resumed contacts with the No TAV movement No TAV committees preparing for the hearing in Brussels The Committee on Petitions of the European Parliament sent in recent days the European Commission's response to the Members for the four petitions submitted between 2003 and 2007 by citizens who are involved in the No TAV Committees. Despite the serious delay in the answer, No TAV committees have reaffirmed their confidence in the instrument Petition to the European Parliament –to which in the past have delivered 32,000 signatures- that allow them to present the arguments that have supported the twenty years of opposition to the New Railway Line between Lyon and Turin (NRLLT). It has already been claimed -as required by the Rules of petitions- an urgent hearing in Brussels that will allow MEPs to assess the reasons of popular opposition in the concrete and to provide Parliament and the European Commission to evaluate the items and then to alter decisions on financing the base tunnel and related works of NRLLT. Many MEPs Italians and foreigners have in recent days expressed solidarity with the No TAV Committees and opposition to geognostic coring, and a delegation will travel to Brussels soon to meet and strategy in the European Parliament against the Commission. No TAV Committees has declared that has to be assessed carefully the