Consumatori Fuori Pasto
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
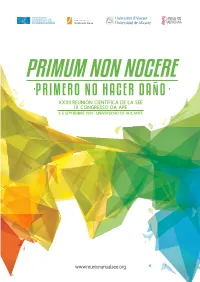
Descargar Programa
AGÈNCIA VALENCIANA DE SALUT PRIMUM NON NOCERE PRIMERO NO HACER DAÑO XXXII REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SEE IX CONGRESSO DA APE 3-5 SEPTIEMBRE 2014 · UNIVERSIDAD DE ALICANTE www.reunionanualsee.org CRONOGRAMA MIÉRCOLES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014 SALA ED/0-02 ED/0-03 ED/0-04 ED/0-09 ED/0-10 ED/0-11 ED/0-12 ED/0-13 ED/TALLER1 ED/TALLER2 Salón de Grados 08:00 - 09:00 Acreditación y entrega de documentación Primum non nocere Determinantes y Actividades de Sesión especial Nutrición, Epidemiología del Desigualdades de Vigilancia en salud 09:00 - 11:00 Gripe en la actividad estado de salud de la prevención y candidatas premio alimentación y Cáncer I género en salud pública clínica I población inmigrante promoción I “Emilio Perea” ejercicio físico 11:00 - 11:30 Pausa-Café 11:30 - 12:00 Inauguración 12:00 - 13:30 Conferencia Inaugural Tapas y Gurús Tapas y Gurús 13:30 - 15:00 Comida I (sala ED/1-19) II (sala ED/1-18) 15:00 - 17:00 Comunicaciones pre- seleccionadas a premios SEE-CIBERESP 17:00 - 17:30 Pausa Actividades de Beneficios y efectos Protección y Mesa Alianza Nutrición y Problemas Legionelosis y Brotes de origen Vigilancia Enfermedades 17:30 - 19:30 prevención y Vacunas adversos del cribado actividades Sociedades alimentación específicos de salud registros alimentario epidemiológica I raras promoción II de cáncer colorrectal preventivas Iberoamericanas 19:30 - 21:30 Sesión APE Asamblea SEE 21:30 Recepción de Bienvenida y exposición sobre la Historia de la SEE PLENARIA MESA ESPONTÁNEA COMUNICACIONES ORALES ACTOS SOCIALES SESIONES ESPECIALES JUEVES -

Anziani E Alcol: Perché E Come Prendersi Cura
Anziani e alcol: perché e come prendersi cura Sabato 16 settembre 2017 ore 8.30 – 13.45 UNA Hotel Scandinavia Via Fauchè 15 – Milano Evento 1834 204571 Crediti 5 Il nostro Ordine è particolarmente impegnato nell’ambito della formazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti. Questo evento che rappresenta una tappa del percorso e dell’impegno profuso da parte degli organizzatori merita il nostro ringraziamento e plauso. Numerosi sono gli altri corsi in programma a testimonianza della vitalità e dell’impegno dei nostri iscritti per far crescere e rendere sempre più vicina la nostra professione ai bisogni dei nostri ammalati. Non sfugge ad una attenta riflessione che tali eventi rappresentano non solo opportunità di aggiornamento scientifico ma vitali strumenti per una crescita professionale ed etica. Questo obiettivo verrà perseguito con particolare determinazione e il nostro Ordine sarà sempre pronto ad accogliere suggerimenti e proposte per poter migliorare la professione medica. Il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Dott. Roberto Carlo Rossi Anziani e alcol: perché e come prendersi cura Sabato 16 settembre 2017 – ore 8.30 – 13.45 UNA Hotel Scandinavia Via Fauchè 15 – Milano Coordinatori Luciana Bovone Consigliere Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri – Milano Antonio Sarassi Dirigente Medico – Nucleo Operativo Alcologia (NOA) di Via Perini – Milano ASST Fatebenefratelli Sacco PROGRAMMA 8.30 - 9.00 Registrazione Partecipanti 9.00 - 9.15 Saluto del Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri -

CG36(2019)12Final 3 April 2019
36th SESSION Report CG36(2019)12final 3 April 2019 Social rights of young people: the role of local and regional authorities Current Affairs Committee Co-rapporteurs:1 Liisa ANSALA, Finland (L, ILDG) and Piero FASSINO, Italy (L, SOC) Resolution 442 (2019) ................................................................................................................... 2 Recommendation 433 (2019) ........................................................................................................ 5 Explanatory memorandum ............................................................................................................ 7 Summary Following a series of debates, resolutions and other instruments to strengthen the integration, participation and engagement of young people at the local and regional level, this report focuses on the social rights of young people guaranteed by the European Social Charter. It underlines the essential role that local and regional authorities play by virtue of their competences in the social field, in facilitating the access and effective exercise of social rights by young people, as well as the implementation of the Social Charter and its jurisprudence as being a source of inspiration for local and regional authorities to take action in this field. The report calls on local and regional authorities to encourage their national authorities to sign and ratify the revised European Social Charter, and to accept the collective complaints procedure. It also invites them to disseminate the text of the Charter through their own communication channels and social networks, and raise awareness of the social rights of young people through various initiatives. It further recommends the governments of member States to develop and co-ordinate actions with other levels of governance to raise awareness of young people’s social rights, and invites governments of the States’ Parties to the Charter to involve local and regional authorities throughout the implementation of this legal instrument. -

A SUMMER on MALLORCA ©Matteo Vieille Arenal, Tourists in a Club
SPAIN A SUMMER ON MALLORCA ©Matteo Vieille Arenal, tourists in a club. Mallorca is the largest of the Balearic islands Every summer thousands of young people flock to places such as El Arenal and Magaluf Germans, English, Scandinavians, Spanish, Italians: on the hunt for cheap holidays in the name of uninhibited fun The party gets going towards evening - on the beach, on boats, in pubs, or in the countless clubs - and is driven by cheap alcohol The criticism? Too much tolerance on the part of the authorities as regards the excess, alcoholic comas, and balconing: diving into the pool from your hotel room Arenal, a group of tourists stops traffic, rowing an imaginary boat. A full rubbish bin after just one day, on Arenal beach. Tourists having a shower on the beach. It’s not at all uncommon to find people wearing bizarre costumes on Arenal’s beachfront. Alcohol on sale at a market in Magaluf. Bad ideas make the best memories Every summer tens of thousands of young people arrive on Mallorca for an unforgettable holiday. The most popular spots are El Arenal and Magaluf, two immense tourist meccas on the outskirts of Palma de Mallorca made up of hotels, clubs, and restaurants. Often the young people have no interest whatsoever in seeing the rest of the island: they stay here the entire time, at the centre of the party where fun is custom-made just for them. Excessive, open, and cheap entertainment has turned Mallorca into one of the most popular destinations for young Europeans. What drives their holidays is a party at all costs as they explore their own physical limits or forget their worries in a constant and unfettered search for fun. -

Rivista Quadrimestrale
RIVISTA QUADRIMESTRALE Pubblicata con il patrocinio della Società Italiana di Alcologia e di Eurocare Italia FIRENZE CB 1 ANDREA GHISELLI, Consumo consapevole o, meglio, astensione consapevole? y INA MARIA HINNENTHAL, CHRISTA EBNER ASAM, SEBASTIANO GALLO, GIAMPIETRO comma SPOLAOR, MAURO CIBIN, Trauma: aspetti terapeutici nelle dipendenze da alcol e 1, cocaina y ROSANNA MARCHETTI, MARILENA RICCI, Il percorso di cambiamento in art. ) persone con dipendenza da alcol nei gruppi di Auto‐Aiuto y IOANNIS ANIFANTAKIS, ILARIA LONDI, MARCELLA CAPOZZA, ELENA RUVIGLIONI, SANDRA TEMPESTINI, Ricerca e intervento sui comportamenti compulsivi nei preadolescenti di Prato y CATERINA 27/02/2004 CARTA, I servizi di alcologia in Sardegna tra passato e presente y EMANUELE SCAFATO, L. In Alcol: la nuova addiction y SARAH SANTINI, L’intervento breve applicato durante la nv. p seduta di igiene orale professionale tramite l’utilizzo dell’Audit co ( 353/2003 D.L. – ostale p abbonamento in edizione p S – .A. p S. Italiane NUOVA SERIE * N.10 * LUGLIO 2011 Poste Alcologia Rivista quadrimestrale della Fondazione Istituto Andrea Devoto pubblicata con il patrocinio della Società Italiana di Alcologia e di Eurocare Italia Iscritto presso l’elenco della stampa periodica del Tribunale di Firenze n. 5548 del 22 gennaio 2007 ISSN 0394-9826 Abbonamento annuale (3 numeri) €50 Un fascicolo € 18 Fascicolo arretrato € 23 C/c postale n. 85621886 IBAN IT-82-J-07601-02800-000085621886 Spogli ed indici presenti su: www.alcolonline.it L’Editore non può essere ritenuto responsabile per errori o qualunque azione derivante dall’uso di informazioni contenute nella rivista: le opinioni espresse non riflettono necessariamente quelle dell’Editore. -

Osservatorio Nazionale
ALCOHOL AGE LIMITS The Italian experience E. Scafato Director National Observatory on Alcohol (ONA) Director Population Health and Health determinants National Centre for Epidemiology, Surveillance and Health Promotion (CNESPS) Director WHO Collaborating Centre for Health Promotion and Research on Alcohol and Alcohol-related problems Istituto Superiore di Sanità (ISS) Luxembourg 21 MAY 2012 CNAPA meeting Osservatorio Nazionale Alcol - World Health Organization Collaborating Centre for RESEARCH and HEALTH PROMOTION on ALCOHOL and ALCOHOL- RELATED HEALTH PROBLEMS European Charter on Alcohol Paris, december 1994 Alcohol? Less is better ! Osservatorio Nazionale Alcol - World Health Organization Collaborating Centre for RESEARCH and HEALTH PROMOTION on ALCOHOL and ALCOHOL- RELATED HEALTH PROBLEMS Osservatorio Nazionale Alcol - World Health Organization Collaborating Centre for RESEARCH and HEALTH PROMOTION on ALCOHOL and ALCOHOL- RELATED HEALTH PROBLEMS Istituto Superiore di Sanita’ From alcopops to Alcohol Policy: reacting to threats to health of young people in Europe. Emanuele SCAFATO MD Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica ENLAPRE, OPORTO 22/ 11/ 1999 Istituto Superiore ALCOHOL and YOUNG PEOPLE di Sanità ALCOPOPS Flavoured mixed alcoholic drinks with a suggestive style of packaging particularly appealing youth culture and taste YOUNG PEOPLE & ALCOHOL European recalls PARIGI Dic. 1995 LUSSEMBURGO Giu. 2001 STOCCOLMA Febb. 2001 Tutti i bambini e gli • Incrementare il grado di consapevolezza Entro l'anno 2006: dei giovani nei confronti -

On Health and Safety in Nightlife
MEDIA INFLUENCE ON HEALTH AND SAFETY IN NIGHTLIFE liteRatuRe RevieW The project is supported by the European Commission under the Health Programme 2008-2013. Other supporters of the project are: Ministry of Health JOHAN JONGBLOET PEER VAN DER KREEFT TINA VAN HAVERE Criminalité (Luxembourg) and the City of London (United Kingdom). The project is supported by the European Commission under the Health Programme 2008-2013. Other supporters of the project are: Ministry of Health Criminalité (Luxembourg) and the City of London (United Kingdom). contact: Johan Jongbloet university college ghent faculty of education, health and Social work voskenslaan 362 9000 ghent belgium [email protected] copyRight: Johan Jongbloet, peer van der kreeft, tina van havere university college ghent faculty of education, health and Social Work voskenslaan 362 9000 ghent belgium index executive Summary.................................................................................4 introduction.............................................................................................. 11 Media.influence.theory........................................................................... 13 Youth.and.media.use.today................................................................... 16 Nightlife.in.Europe................................................................................... 19 Media and nightlife behaviour............................................................23 Health.and.harms.in.Nightlife................................................................24 -
Psychiatria Danubina PSYCHIATRIC
cyan magenta yellow black C MYK MY CY CM 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 DANUBIAN ASSOCIATION psychiatria psychiatria danubina PSYCHIATRIC FACULTAS MEDICA UNIVERSITATIS danubina STUDIORUM 2018 supplement 7 volume 30 ZAGRABIENSIS UDC 616.89 ISSN 0353 - 5053 www.hdbp.org/psychiatria_danubina International Twined Congress Psychiatry beyond DSM-5 Vol. 30/Suppl. 7 pp 393-652 (2018 Vol. ) November 15-17, 2018 Iseo, Italy ISSN 0353 - 5053 Excerpta Medica (EMBASE), Psychological Abstracts/ PsycINFO, Chemical Abstracts, MEDLINE/PubMed, EBSCO, Cambridge Scientific Abstracts/Social Services Abstracts, Science Citation Index Expanded (SciSearch), Social Sciences Citation Index , Social SciSearch, Journal Citation Reports/ Social Sciences Edition, Journal Citation Reports/ Science Edition, SCOPUS, HRCAK, MEDICINSKA NAKLADA ZAGREB, CROATIA BioMedWorld.com, Research Alert, Google Scholar, Current Contents 9 770353 505002 - Social and Behavioral Sciences,, Web of Science (WoS), CiteFactor. PRO MENTE d.o.o. ZAGREB, CROATIA PSYCHIAT DANUB, 30(suppl. 7): S393-652 November 2018 korice DANUBINA_2018-Suppl-7 cyan magenta yelloww black C MYK MY CY CM 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 PSYCHIATRIA DANUBINA An Official Journal of Danubian Psychiatric Association Vol. 30, Suppl. 7 November, 2018 Acknowledgement to genuine initiative for founding Psychiatria Danubina Nenad Bohaþek Gustav Hofmann Honorary Editors - Ehrenredakteure Norman Sartorius, Association for the Improvement of Mental Health Programs 14 Chemin Colladon, CH-1209 Geneve, Switzerland Editors in Chief - Hauptredakteure Miro Jakovljeviü, Department of Psychiatry Werner Schöny University Hospital Centre Zagreb OÖ Landes - Nervenklinik Wagner Jauregg Kišpatiüeva 12, 10000 Zagreb, Croatia Wagner-Jauregg-Weg 15, 4020 Linz, Austria International Editorial Board – Internationale Redaktion Agius M. -
Drogas Emerxentes E Sumisión Química: ¿Mito Ou Realidade?
Drogas emerxentes e sumisión química: ¿mito ou realidade? Prof. Dr. Manuel Isorna Folgar Dr. Manuel Isorna Folgar Febreiro 2019 OBJETIVOS • Dar a conocer nuevas drogas emergentes “NPS” • Sumisión química-Drogas Facilitadoras del AsaltoSexual Dr. Manuel Isorna Folgar ¿QUÉ TIENEN LOS JÓVENES EN LA CABEZA? Dr. Manuel Isorna Folgar DROGAS Y CEREBRO ADOLESCENTE Dr. Manuel Isorna Folgar Dr. Manuel Isorna Folgar Dr. Manuel Isorna Folgar Dr. Manuel Isorna Folgar Dr. Manuel Isorna Folgar CANNABIS Y PSICOSIS Dr. Manuel Isorna Folgar Fuente: Di Forti et al. Biol Psychiatry, 2012. CANNABIS Y PSICOSIS Dr. Manuel Isorna Folgar Caspi et al. Biol Psychiatry. 2005. Dr. Manuel Isorna Folgar Dr. Manuel Isorna Folgar Tabaco Dr. Manuel Isorna Folgar Dr. Manuel Isorna Folgar IQOS Dr. Manuel Isorna Folgar Dr. Manuel Isorna Folgar Dr. Manuel Isorna Folgar FUMAR EN CACHIMBA Dr. Manuel Isorna Folgar CACHIMBAS O PIPAS DE AGUA MITOS Y CREENCIAS: 1. Que es menos nocivo que los pitillos 2. Que el agua que forma parte de su mecanismo filtra las sustancias nocivas, 3. Que es menos irritante para la garganta y el tracto respiratorio 4. El tabaco está hecho de frutas —normalmente están aromatizados con esencias frutales- y por ello es una opción sana. REALIDAD: • Inhalar entre 30 y 50 bocanadas de cachimba en una hora, aproximadamente, equivaldría a fumar DOS PAQUETES DE CIGARROS. • Tampoco conviene olvidar que la tasa de MONÓXIDO DE CARBONO INHALADO POR LA Dr. Manuel Isorna Folgar CACHIMBA ES SIETE VECES CONSECUENCIAS - CÁNCER DE PULMÓN, - DISMINUCIÓN DE LA FUNCIÓN RESPIRATORIA, - DEPENDENCIA, - BAJO PESO EN RECIÉN NACIDOS DE MADRES CONSUMIDORAS, - INFERTILIDAD… ES UNA PRÁCTICA EMINENTEMENTE SOCIAL (varias personas compartan la pipa): - Todos/as aspiran a través de LA MISMA BOQUILLA QUE PASA DE BOCA EN BOCA, lo que supone una fuente de transmisión de enfermedades infecciosas como la Hepatitis C o el Herpes Simplex. -
Revealing the Attractiveness of Outrageous Beer Tourism
View metadata, citation and similarbrought COREpapers to youat core.ac.ukby provided by OpenArchive@CBS REVEALING THE ATTRACTIVENESS OF OUTRAGEOUS BEER TOURISM Ana María Munar ([email protected]) November 2012 CLCS Working Paper Series Copenhagen Business School Center for Leisure & Culture Services Department of International Economics and Management © 2012 INTRODUCTION Tourism is often linked to ideas of escapism and release from everyday duties and obligations. Modern societies are characterized by highly complex systems of social and cultural control, and citizens of these societies find forms of liberation in travel (Jafari 1987). Tourism destinations act as magnetic spaces of leisure and relaxation that can be visualized as the realm of ‘touristhood’– a theatrical arena in which individuals adopt different masks and conduct themselves according to expectations and norms that differ from those that rule their everyday lives. The consumption and enjoyment of alcoholic drinks constitutes a relevant element of the scenery of touristhood. In touristic spaces the beer product is socially transformed and constructed; tourists enact beer tourism through drinking practices and rituals performed at the destination. Alcohol, and in this case beer consumption, is constitutive of socio-cultural traditions in many national cultures (such as those in Northern Europe). National and local beer cultures are however being transformed and re-shaped in tourism destinations. This study examines the interrelation of beer cultures, more specifically German beer culture, and tourism. It examines how beer culture, combined with touristhood, produces extreme and novel forms of consumption transforming both tourism practices and the world of beer. Tourists get attracted to places due to a sense of anticipation of intense pleasures (Urry 2002). -

Revealing the Attractiveness of Outrageous Beer Tourism
Revealing the Attractiveness of Outrageous Beer Tourism Munar, Ana Maria Document Version Final published version Publication date: 2012 License CC BY-NC-ND Citation for published version (APA): Munar, A. M. (2012). Revealing the Attractiveness of Outrageous Beer Tourism. Department of International Economics and Management, Copenhagen Business School. CLCS Working Paper Series Link to publication in CBS Research Portal General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us ([email protected]) providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 30. Sep. 2021 REVEALING THE ATTRACTIVENESS OF OUTRAGEOUS BEER TOURISM Ana María Munar ([email protected]) November 2012 CLCS Working Paper Series Copenhagen Business School Center for Leisure & Culture Services Department of International Economics and Management © 2012 INTRODUCTION Tourism is often linked to ideas of escapism and release from everyday duties and obligations. Modern societies are characterized by highly complex systems of social and cultural control, and citizens of these societies find forms of liberation in travel (Jafari 1987). Tourism destinations act as magnetic spaces of leisure and relaxation that can be visualized as the realm of ‘touristhood’– a theatrical arena in which individuals adopt different masks and conduct themselves according to expectations and norms that differ from those that rule their everyday lives. -

Travel Insurance
Travel Insurance Your Cleveland Police Group Insurance Benefit Scheme Policy Wording Period of Cover:1st April 2021 - 31st March 2022 Scheme number: FI8910AHA210 Table of content Contact Details 2 Summary of Cover 3 360 Assistance Service 4 Stranded Passenger 4 Important Information 4 Who is covered 4 What is covered 5 This Is Not A Health Insurance Policy 5 Limits of cover and excesses 5 When cover starts and ends 5 Working abroad 5 Disclosing facts 6 Health Declaration 6 Pregnancy and Childbirth 6 Definitions 7 Section 1 Cancellation 9 Section 2 Curtailment 9 Section 3 Personal Accident 10 Section 4 Emergency Medical Expenses 10 Section 5 Baggage & Personal Belongings 12 Section 6 Money 13 Section 7 Loss of Passport/Driving Licence 13 Section 8 Travel Disruption 13 Section 9 Missed Departure 14 Section 10 Personal Liability 15 Section 11 Hijack 15 Section 12 Sports and Activities 16 Section 13 Winter Sports 23 Section 14 Catastrophe 24 Section 15 Legal Expenses 24 Section 16 Collision Damage Waiver Excess 25 General Conditions 26 General Exclusions 26 Complaints Procedure 27 Claims Procedures 28 Data Protection 29 Governing Law 29 Details about our Regulator 29 Financial Services Compensation Scheme 29 Contact details Telephone For cover queries - Gallagher 0191 479 7600 (Office hours Monday –Friday, 9am –5pm) Claims and Assistance Service +44 (0) 330 660 0785 Other useful contacts Telephone Email Foreign, Commonwealth and Development Office +44 (0)20 7008 5000 www.gov.uk/fcdo Global Health Insurance Card (GHIC) +44 (0)300 330 1350 www.ghic.org.uk Department of Health – Advice for Travellers +44 (0)20 7210 4850 www.dh.gov.uk/travellers Medicare Australia +61 132 011 www.medicareaustralia.gov.au 2 Summary of cover (£) The following table is only a summary of the main cover limits.