Ricerche. Scienze Politiche E Sociali
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fundamental Shifts in Anti-Belarusian Disinformation and Propaganda: Analysis of Quantitative and Qualitative Changes*
FUNDAMENTAL SHIFTS IN ANTI-BELARUSIAN DISINFORMATION AND PROPAGANDA: ANALYSIS OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHANGES* ______________________________________________________________________________ 1 ANDREI YELISEYEU** 1* This is a shortened version of the report. Full version in Russian can be found at this link. ** Andrei Yeliseyeu is Research Director at EAST Center. He is part of the iSANS expert network and the Younger Generation Leaders Network on Euro-Atlantic Security. Previously, he completed fellowships at GMF, GLOBSEC Policy Institute, and the Finnish Institute of International Affairs. He also worked as researcher at the Belarusian Institute for Strategic Studies. Email: [email protected] ______________________________________________________________________________ Executive Summary Monitoring of anti-Belarusian disinformation and propaganda in the Russian online media, conducted in August-November 2016, 2 primarily focused on publications by the Regnum and EADAily media outlets containing hate speech. Many materials questioned the sovereignty, independence, and territorial integrity of Belarus, contained derogatory statements about the Belarusian people, language, and culture. The study indicated that the Belarusian authorities used the most radical and inexpensive method of combating the anti-Belarusian propaganda campaign by arresting three authors of such materials. The monitoring concluded the following: "Whether the anti-Belarus campaign fades away or, on the contrary, takes a new impetus, -

Anton Shekhovtsov
RUSSIAN CONNECTIONS TO THE FAR RIGHT IN EUROPE Anton Shekhovtsov Contents Executive summary Nothing New under the Sun Post-Soviet period and early Putin era European far-right politicians and pro-Kremlin fake election observation Russian media and the European far right Political cooperation between Russian stakeholders and the European far right – Austria – France – Germany – Italy Moscow’s objectives of engaging with the European far right Policy recommendations Executive summary • Today’s relations between the European far right and various Russian pro-Kremlin actors reflect a historical reality: Soviet state actors were prepared to cooperate with European right-wing extremists to entrench the international position of the Soviet Union and to inflict damage to the capitalist West, while some European right-wing extremists sought to cooperate with the Soviet Union as an ally in their struggle against Western capitalism and imperialism. • After the Second World War, Soviet authorities provided financial support to West German and Austrian right-wing extremists as a way to influence politics and political debates in those countries; in particular, Soviet funding was used to cover publishing costs of far-right newspapers and information bulletins. • After the collapse of the Soviet Union, European far-right activists and politicians revived their interest in cooperating with Russian actors, but they could only reach out to Russian ultranationalists who opposed the democratising Russian authorities that aspired to become part of the liberal-democratic West, not undermine it. • The first area of institutionalised cooperation between the European far right and Russian pro-Kremlin actors was politically biased (fake) international election observation, a form of political activity performed by international actors and aimed at advancing interests of politicians and political forces by imitating credible election monitoring during electoral processes. -

POLITICALLY BIASED ELECTION OBSERVATION – a Threat to the Integrity of International Institutions
Politically biased electionPolitically observation POLITICALLY BIASED ELECTION OBSERVATION – a threat to the integrity of international institutions – a threat to the integrity the to – a threat of international institutions POLITICALLY BIASED ELECTION OBSERVATION – a threat to the integrity of international institutions 2 Imprint Edition: European Platform for Democratic Elections www.epde.org Responsible for the content: Europaischer Austausch gGmbH Erkelenzdamm 59 10999 Berlin, Germany Represented through: Stefanie Schiffer EPDE is financially supported by the European Union and the Federal Foreign Office of Germany. The here expressed opinion does not necessarily reflect the opinion of the donors. 3 Content Introduction 4 Detection and Prevention of politically Biased election observation (“fake observation”) in the OSCE region 7 Foreign Observation of the Illegitimate Presidential Election in Crimea in March 2018 13 Politically biased foreign electoral observation at the Russian 2018 presidential election 33 Politically Biased International Election Observation at the 2018 Regional Elections in Russia 63 The Globalisation of Pro-Kremlin Networks of Politically Biased Election Observation: The Cases of Cambodia and Zimbabwe 75 Foreign Observation of the Illegitimate “General Elections” in the Donetsk People’s Republic and Lugansk People’s Republic in November 2018 101 4 Introduction In recent years, we have witnessed the increasing phenomenon of “bi- ased observation”—a form of more politically-motivated election observation whose chief objective is to mislead the public regarding the regularity of some political process or the legitimacy of an election result. Striking examples were the “referendum” on Crimea in March 2014, the “elections” in Eastern Ukraine in November 2014, the Presidential and Parliamentary elections in Azerbaijan since 2013, and the Presidential elections in the Russian Federation in March 2018. -
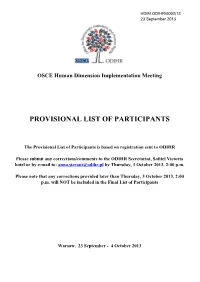
Provisional List of Participants
OSCE Human Dimension Implementation Meeting PROVISIONAL LIST OF PARTICIPANTS The Provisional List of Participants is based on registration sent to ODIHR Please submit any corrections/comments to the ODIHR Secretariat, Sofitel Victoria hotel or by e-mail to: [email protected] by Thursday, 3 October 2013, 2:00 p.m. Please note that any corrections provided later than Thursday, 3 October 2013, 2:00 p.m. will NOT be included in the Final List of Participants Warsaw, 23 September - 4 October 2013 OSCE Delegations / Partners for Co-operation Albania Amb. Spiro KOCI Permanent Mission of Albania to the International Organizations in Head of Delegation; Permanent Representative of the Republic of Albania to Vienna the OSCE Reisenerstrasse 27/6a; 1030 Vienna; Austria E-Mail: [email protected] Tel:+43-1-328 87 10 Website: http://www.mfa.gov.al Amb. Florent CELIKU Albanian Embassy to Poland E-Mail: [email protected] ul. Altowa 1; 02-386 Warsaw; Poland Tel:+48-22-824 14 27 Fax:+48-22-824 14 26 Ms. Selma XHOXHAJ Permanent Mission of Albania to the International Organizations in First Secretary Vienna E-Mail: [email protected] Reisenerstrasse 27/6a; 1030 Vienna; Austria Tel:+43-660-350 38 12 Website: http://www.mfa.gov.al Germany Amb. Rudiger LUDEKING Permanent Mission of the Federal Republic of Germany to the OSCE Head of Delegation Metternichgasse 3; 1030 Vienna; Austria E-Mail: [email protected] Tel:+43-1-711 54 171 Fax:+43-1-711 54 268 Website: http://www.osze.diplo.de Mrs. -

Politically Biased Foreign Electoral Observation at the Russian 2018 Presidential Election Report by Anton Shekhovtsov
Politically Biased Foreign Electoral Observation at the Russian 2018 Presidential Election Report by Anton Shekhovtsov International observers in the Kuban region: (left to right) Hans-Wilhelm Dünn (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V.), Mylène Troszczynski (National Front), head of the Kuban election commission, Aleksey Chernenko, Alexander Von Bismarck and Jaromír Kohlíček, Communist Party of Bohemia and Moravia). Source: http://ikkk.ru/news/mezhdunarodnye-nablyudateli-ot-evropejskogo- parlamenta-i-mezhdunarodnyh-obshhestvennyh-obedinenij-posetili-krasnodarskij-kraj/. Executive summary 1513 foreign electoral observers monitored the Russian 2018 presidential election which constitutes the largest foreign electoral monitoring mission in Russia’s history. 598 of these observers were deployed by the Parliamentary Assembly of the Organisation for Security and Co- operation in Europe (OSCE) and the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR); 363 observers were sent by other international organisations; 65 monitors represented observers from national election committees from 26 countries and 2 disputed territories; and 482 monitors were invited by the lower (State Duma) and upper (Federation Council) houses of the Federal Assembly of the Russian Federation. Several Russian organisations formally not affiliated with the Russian authorities, in particular, CIS-EMO, the Civic Control Association and the National Social Monitoring, actively participated in recruiting and coordinating foreign observers who were officially invited by the Federal Assembly. Chairman of the State Duma Committee on International Affairs Leonid Slutsky and his deputy Aleksey Chepa mediated between those formally non-state organisations and the Federal Assembly, although Slutsky invited several observers himself through his personal networks. While Russia’s Central Election Commission (CEC) published a list of foreign observers present at the presidential elections, it refused to publicise the names of the foreign observers invited by the Federal Assembly. -

Belarus Disinformation Campaign in 2019
The Stalemate of Deepened Integration: Analysis of the Russian Anti- Belarus Disinformation Campaign in 2019 By Vasil Navumau, Anastasiya Ilyina and Katsiaryna Shmatsina Dr Vasil Navumau is a visiting fellow at the Center for Advanced Internet Studies. He completed his PhD at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences. His research interests lie at the intersection of such areas as comparative analysis of contemporary protest trends in the Eastern European countries, challenges to the local societies and cultures under the influence of globalization and information-communicative technologies (e.g. orchestrated disinformation campaigns, proliferation of populist messages and establishment of post-truth society), analysis of social media and digital communities. Dr Anastasiya Ilyina is a graduate of the Faculty of History at Brest State University, a graduate of Eastern Studies at the University of Warsaw, a PhD in humanities in the field of sociology at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences. The title of her PhD thesis is “The Escape From Identity: Belarusian Reality”. She studied Human Rights at Columbia University in New York. In 2010–2019, she was an editor of the “European Radio for Belarus”. She cooperates with the Belarusian television “Belsat”. She writes about migration movements, protection of the rights of national minorities and identity issues. Katsiaryna Shmatsina is a political analyst at the Belarusian Institute for Strategic Studies where she focuses on the Belarusian foreign policy and regional security. Katsiaryna's portfolio includes non-residential fellowship at the German Marshall Fund (2020) and Think Visegrad Fellowship (2019). -
Final List of Participants
OSCE Human Dimension Seminar on The Role of Political Parties in the Political Process FINAL LIST OF PARTICIPANTS Warsaw, 18 - 20 May 2011 OSCE Delegations / Partners for Co-operation Albania Amb. Florent CELIKU Albanian Embassy to Poland Head of Delegation ul. Altowa 1; 02-386 Warsaw; Poland E-Mail: [email protected] Tel:+48-22-824 14 27 Fax:+48-22-824 14 26 Germany Mr. Thomas LENK Permanent Mission of the Federal Republic of Germany to the OSCE Counsellor Metternichgasse 3; 1030 Vienna; Austria E-Mail: [email protected] Tel:+43-1-711 54 0 Website: http://www.osze.diplo.de United States of America Mr. Timothy FINGARSON United States Mission to the OSCE Political Officer Obersteinergasse 11/1; 1190 Vienna; Austria E-Mail: [email protected] Tel:+43-1-313 39 32 11 Fax:+43-1-313 39 32 55 Website: http://osce.usmission.gov Ms. Dana BEEGUN USAID/Bosnia-Herzegovina Director, Democracy Office Ulica Roberta C. Frasurea I; 71000 Sarajevo; Bosnia and Herzegovina E-Mail: [email protected] Tel:+387-33-70 42 30 Fax:+387-33-65 97 22 Website: http://www.usaid.gov/ba Mrs. Kateryna RYABIKO U.S. Agency for International Development; Kyiv Office Elections and Political Processes Advisor 19 Nyzhny Val St.; Kyiv; Ukraine E-Mail: [email protected] Tel:+380-504-41 69 28 Website: http://ukraine.usaid.gov Armenia Mr. Armen MARTIROSYAN National Assembly of the Republic of Armenia Member of the Parliament Baghramyan 19; Yerevan; Armenia E-Mail: [email protected] Tel:+374-93-52 03 70 Website: http://www.parliament.am Austria Ms. -

List of Foreign Citizens Illegally Visited Occupied Territories of the Republic
Updated: 18.01.2021 LIST OF FOREIGN CITIZENS ILLEGALY VISITED OCCUPIED TERRITORIES OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN Date and purpose № Name and surname Citizenship Position of the visit Participated at so called Scientist and journalist 1. Abel Riu Kingdom of Spain “referendum” as an observer on (Catalonia) February 20, 2017 2. Abedi Maryam Gholamreza Islamic Republic of Iran - 2018 Participated at the event held in 3. Abugail Sin Si Ern Republic of Singapore Musician July, 2011 4. Adqur Dzidzariya Georgia/Russian Federation - - Adarya Gushtin 5. Republic of Belarus Journalist May 25, 2016 (Адарья Гуштын) 6. Adam Bennet Schiff United States of America Member of US Congress October, 2019 7. Adrien Buchard French Republic - November, 2019 Member, California State 8. Adrin Nazarian United States of America October 4-9, 2017 Assembly 1 Date and purpose № Name and surname Citizenship Position of the visit 9. Avigdor Eskin State of Israel Journalist April, 2016 Columnist, “Posttimees”; 10. Ahto Lobjakas Republic of Estonia expert, Estonian Foreign - Policy Institute, NGO 11. Agostinho Leitao Portugal - July, 2018 Chairman, “Neptune” 12. Agop Srents Republic of Bulgaria Summer, 2016 Diving Club Director, Kaunas Chamber 13. Egidijus Tamasiunas Republic of Lithuania October, 2012 Theatre 14. Akram Khalief Algeria Blogger February 9-13, 2018 Former adviser to the 15. Alan Yelbakiyev Georgia/Russian Federation “President of South - Ossetia” Alan Robertovich Khugaev 16. (Алан Хугаев Georgia/Russian Federation June 01-09, 2019 Робертович) 17. Ali Bayramoğlu Republic of Turkey Political commentator September 22, 2017 2 Date and purpose № Name and surname Citizenship Position of the visit 18. Ali Sait Çetinoğlu Republic of Turkey Scholar September 22, 2017 Federal Republic of Member of Bundestag, 19. -

Neonazis & Euromaidan
Stanislav Byshok Alexey Kochetkov NEONAZIS & EUROMAIDAN From democracy to dictatorship [Third edition] 2014 Stanislav Byshok, Alexey Kochetkov NEONAZIS & EUROMAIDAN. From democracy to dictator- ship. [Third edi on]. “Whoever is not jumping is a Moskal” is a chant that women and men of diff erent ages who took to Kiev Independence Square in win- ter 2013-2014 repeated trying to get warm. They kept jumping and laughing, for nobody in the ‘brave new world’ of the Ukrainian revo- lu on under Stepan Bandera’s banner fancied gaining the character of a staunch enemy of Ukrainian statehood. Mass demonstra ons of “angry ci zens” in Ukraine had objec ve reasons. This was a protest against ineff ec ve and corrupt govern- ment, against police and bureaucra c abuse of power, against unclear and dead-end policies of the President and the Government. All na onal libera on movements use the popular ideas and po- li cal sen ments that dominate the society as their posi ve mani- festo. Thus, exclusively le -wing ideologies were mainstream in the Russian Empire in 1917, radical Islamism was most popular in Arab countries during the Arab spring of 2012, whereas na onalism, also radical, turned mainstream in the Ukraine of 2013-2014. The book describes the development of Ukraine’s na onal- ist groups since 1991 un l present day. It focuses on the history of the parliamentary right-wing radical Svoboda party and the non- parliamentary Right Sector movement. The authors study the ideol- ogy, psychology and methods of poli cal struggle of these structures. -

At the Local Elections in Ukraine in 2015 61 “Political Initiative” Evaluates Elections in Dnipropetrovsk and Mariupol 66 Conclusion 69 Executive Summary 71
1 2 3 The Right of IDPs to Vote International Practice, Options for Ukraine and Recommendations ELENE NIZHARADZE / 2015 3 Content Introduction 5 International Standards 6 International Practice 9 Georgia 10 Bosnia and Herzegovina 17 Possible Options for IDPs to Vote 21 Conclusion and Recommendations 25 Executive Summary 27 4 5 Introduction As a result of annexation of Crimea by the Russian Federation followed by the armed conflict in eastern Ukraine between the Ukrainian military forces and pro-Russian separatists there are over 1 million IDPs who fled their ha- bitual places of residence and settled in other parts of the country. Usually, IDPs face various problems. Among these problems is the right to vote and to participate in political life which is often paid less attention compared to social and economic rights, but in fact it is very important for the integration of IDPs in local communities and for democratic devel- opment of the country. In Ukraine internally displaced persons also face restriction in terms of exercising their political right to vote. Article 38 of the Constitution of Ukraine states that: “citizens have the right to participate in the administration of state affairs, in All-Ukrainian and local referendums, to freely elect and to be elected to bodies of state power and bodies of local self-government”. Despite this constitutional provision, IDPs were still not permitted to take part in the local elections held on 25th of October according to their current places of residence. Civil society organizations prepared a draft law envisaging amendments to different legal acts in or- der to ensure the right of IDPs to participate in elections. -

VO “Svoboda” Party Phenomenon in Ukraine
VO “Svoboda” party phenomenon in Ukraine Nika Palaguta DEPARTMENT OF EUROPEAN INTERDISCIPLINARY STUDIES Natolin Best Master Thesis 03 / 2014 VO “Svoboda” party phenomenon in Ukraine Nika Palaguta Supervisor: Prof. Georges Mink Thesis presented by Nika Palaguta for the Degree of Master of Arts in European Interdisciplinary Studies Academic year 2013 / 2014 DEPARTMENT OF EUROPEAN INTERDISCIPLINARY STUDIES Natolin Best Master Thesis 03 / 2014 COLLEGE OF EUROPE NATOLIN CAMPUS SCIENTIFIC COMMITTEE Hannes Adomeit, Kerry Longhurst, Georges Mink Views expressed in the College of Europe publications are solely those of the author and do not neccesarily reflect positions of the College of Europe Published by the College of Europe Natolin Campus © Nika Palaguta. All rights reserved. FUNDacJA KOLEGIUM EUROpeJSKIE ul. Nowoursynowska 84 · PL-02-792 Warszawa · Poland/Pologne e-mail: [email protected] First edition: 2014 Printed in Poland Graphic design and layout: Wojciech Sobolewski ISBN 978-83-63128-20-3 STATUTORY DeclaRATION I hereby declare that this thesis has been written by myself without any external unauthorised help, that it has been neither submitted to any institution for evaluation nor previously published in its entirety or in parts. Any parts, words or ideas, of the thesis, however limited, and including tables, graphs, maps etc., which are quoted from or based on other sources, have been acknowledged as such without exception. Moreover, I have also taken note and accepted the College rules with regard to plagiarism (Section 4.2 of the College study regulations). DÉclaRATION SUR L’HONNEUR Je déclare sur l’honneur que ce mémoire a été écrit de ma main, sans aide extérieure non autorisée, qu’il n’a été déposé auparavant dans aucune autre institution pour évaluation, et qu’il n’a jamais été publié, dans sa totalité ou en partie. -

Russia and the European Far Right
University College London Russia and the European Far Right by Anton Shekhovtsov A thesis submitted to University College London for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) School of Slavonic and East European Studies University College London 2018 1 Declaration of Authorship I, Anton Shekhovtsov, confirm that the work presented in this thesis is my own. Where information has been derived from other sources, I confirm that this has been indicated in the thesis. 2 Abstract This thesis explores contemporary relations between various Russian actors and European far right ideologues, movements, organisations and parties. The thesis demonstrates that each side of this relationship is driven by evolving and, at times, circumstantial political and pragmatic considerations that involve, on the one hand, the need to attain or restore declining or deficient domestic or international legitimacy and, on the other hand, the ambition to reshape the apparently hostile domestic or international environments in accordance with one’s own interests. Introduction discusses the research background of the thesis, and outlines its conceptual framework, methodology and structure. Chapter 1 discusses pro-Russian elements of the European far right milieu before the Second World War. Chapter 2 looks at the active cooperation between Russian and Western far right politicians after the fall of the Soviet Union. Chapter 3 examines the right-wing authoritarian evolution of Vladimir Putin’s regime – an evolution that facilitated the deepening of the relations between Russian pro-Kremlin actors and the European far right. Chapters 4 and 5 consider two areas of dynamic cooperation between various Russian actors and European far right politicians and organisations aimed at supporting and consolidating alternative institutions that aim at challenging and undermining liberal- democratic practices and traditions: electoral monitoring and the media.