Terza Serie (2006)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Vatican. Archives De La Sacree Congregation De La Propagande
National Archives Archives nationales 1+1 of Canada du Canada Manuscript Division des Division manuscrits Vatican. Archives de la Sacree Congregation de la Propagande 1904-1914 Instrument de recherche no 1186 I Finding Aid No. 1186 Prepare en 1993 pour la Division des manuscrits des Prepared in 1993 for the Manuscript Division of the Archives nationales du Canada, Ie Centre de National Archives of Canada, the Research Centre in recherche en histoire religieuses du Canada de Religious History of Canada of the Saint-Paul l'Universite Saint-Paul et Ie Centre academique University and the Canadian Academic Centre in canadian en Italie Italy. I. GIOVANNI PIZZORUSSO INVENTAIRE DES DOCUMENTS D~INTERET CANADIEN DANS LES ARCHIVES DE LA CONGREGATION "DE PROPAGANDA FIDE", 1904-1914 Rome Ottawa Centre Academique canadien en Italie 'Archives Nationales du Canada 1993 - \ TABLE DE MATXERES I Introduction XVI Liste des Abr~viations XIX La Curie romaine (1904-1914) XXIII Dioceses et ~v~ques du Canada (1904-1914) XXXVIII Representants du Saint-Siege en Amerique du Nord (1904-1914) 1 Serie ACT~ (1904-1914) 29 Serie NUOVA SERlE (1904-1914) 31 Annee 1904 147 Ann~e 1905 267 Annee 1906 403 Annee 1907 563 Annee 1908 761 Annee 1909 791 Annee 1910 827 Annee 1911 865 Annee 1912 885 Annee 1913 899 Annee 1914 913 Index INTRODUCTION 1. La periode du pontificat de Pie X (Giuseppe Sarto, 4 aOut 1903 - 20 aOut 1914) est un tournant tres important dans Ies rapports entre Ia Congregation "de Propaganda Fide" et Ie Canada. En 1908, Ies dioceses du pays cessent d'etre soumis la juridiction de la Congregation, regime qui datait depuis sa fondation en 1622 et qui s'est poursuivi pendant toutes les phases de l'histoire canadienne. -

Cardinal Willem V an Rossum, C.Ss.R
SHCSRSS (2007) 347-400 JOOP VERNOOIJ, C.SS.R. CARDINAL WILLEM VAN ROSSUM, C.SS.R. «The Great Cardinal of the Small Netherlands» (1854-1932) lNmooucnoN; 1. -The Historical Context of Cardinal van Rosswn; 1.1. So cial and Political Context in the Netherlands; 1.2. The Roman Catholic Context in the Netherlands; 1.3. The Cultural Context in the Netherlands; 1.4. The Papal Con text of van Rosswn; 1.5. The Redemptorist Context in the Netherlands; 1.6. The Context of Missionary Outreach in the Netherlands; 2 - The Family of Cardinal van Rossum; 3. -Van Rossum at the Minor Seminary of Culemborg (Kuilen burg); 4. - Van Rossum's Early Life with the Redemptorists; 5. - Serving the Re demptorists and the Vatican, 1895-1909; 6. -Consultor to the Redemptorist Su perior General. 1909-1911; 7.-Van Rosswn, Cardinal of the Catholic Church, 1911; 8. -Van Rossum in the Role of Grand Penitentiary, 1915-1918; 9. -In 1918, an Ap pointment as Prefect of Propaganda Fide; 10. - The 1924 International Euchari stic Congress in Amsterdam; 11.- Other Events as a Cardinal; 12.- The Death of Cardinal van Rossum, 1932; 13.- Evaluation of Cardinal Willem van Rossum; CONCLUSION. IN1RODUCTION When visitors come to the Redemptorist residence in Wit tern, a small town in the Limburg Province of the Netherlands, they cannot help but notice the pride taken in the memory of the Redemptorist Cardinal Willem van Rossum. Looming large in the church is van Rossum's memorial statue, in exquisite white Carrara marble. They are told that the statue was carved in 1939 by the official sculptor of the Vatican, Enrico Quattrini, and that the cardinal's remains lie just behind the memorial, inside a spe cial vault within the church wall. -

Pío Xi Y Álvaro Obregón. Relaciones a Través De La Delegación Apostólica En México (1921-1923)
Pío XI y Álvaro Obregón. Relaciones a través de la Delegación Apostólica en México (1921-1923) Carmen José ALEJOS Facultad de Teología, Universidad de Navarra (España) [email protected] Este artículo forma parte de un proyecto de investigación sobre la libertad religiosa en México durante los años 20 y 30 del siglo XX. Años convulsos sobre los que hay abundantes estudios y publicaciones. El objeto del presente trabajo es ofrecer docu- mentación inédita sobre las relaciones Iglesia-Estado, en concreto entre el delegado apostólico Filippi con el Presidente Álvaro Obregón durante los catorce meses de estancia de aquél en México. Es lógico que se note la ausencia de bibliografía más detallada, explicaciones más completas, pero no es el objetivo de esta publicación. Además, al ser un estudio parcial no es posible sacar conclusiones generales, pero sí permite descubrir algunos aspectos poco o nada conocidos hasta ahora. I. BREVE HISTORIA DE LA DELEGACIÓN APOSTÓLICA Las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede desde la Independen- cia en 1821 fueron difíciles. En efecto, después de la guerra, y durante los primeros treinta años la Santa Sede no envió un nuncio o delegado; en parte por las buenas relaciones que ésta mantenía con la corona española, y en parte por la inestabilidad de los gobiernos mexicanos que hacía un poco complicado establecer un entendi- miento. De hecho, el primer delegado apostólico de México y América Central fue el obispo Luigi Clementi, que llegó a México en 1851 y fue expulsado en 1861. El segundo delegado, Pier Francesco Meglia, estuvo en México del 26 septiembre 1864 al 1 junio 1865, durante el gobierno de Maximiliano. -

Sons of Don Bosco Successors of The
SONS OF DON BOSCO SUCCESSORS OF THE APOSTLES SALESIAN BISHOPS 1884 to 2001 by Charles N. Bransom, Jr. INTRODUCTION he study of apostolic succession and episcopal lineages has long fascinated students of church history. It was not until the middle T of the twentieth century, however, that a systematic attempt was made to trace and catalogue the consecrations of bishops on a world-wide basis. A small group of researchers has catalogued the consecrations of tens of thou sands of bishops dating back many centuries. The fruits of their labors--labors that are on going-have resulted in a database, which can trace the episcopal lineage of any living bishop and the vast majority of deceased bishops. In 1984, I began a project on the episcopal ordinations of bishops of re ligious orders and congregations. One fruit of that work was a study of the ordi nations of Salesian bishops, Les Eveques Salesiens. The present work updates, corrects and expands the 1984 study. In 1984, the episcopal ordinations of 130 bishops were presented. This study contains the details of 196 bishops. The text has been expanded to include the episcopal lineages of the bishops. Of the 196 bishops in this study, 183 trace their orders to Scipione Re biba, who was appointed Auxiliary Bishop ofChieti in 1541. The Rebiban suc cession is the major episcopal line in the contemporary Catholic episcopate. More than 91 % of the more than 4,500 bishops alive today trace their orders 54 Journal of Salesian Studies back to Rebiba Why so many bishops should trace their lineages to this one bishop can be explained, in great part, by the intense sacramental activity of Pope Benedict XIII, who consecrated 139 bishops during his pontificate, many of them cardinals, nuncios and bishops of important sees who in tum conse crated many other bishops. -
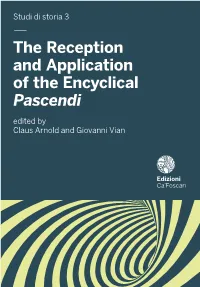
— the Reception and Application of the Encyclical Pascendi Edited by Claus Arnold and Giovanni Vian
Studi di storia 3 — The Reception and Application of the Encyclical Pascendi edited by Claus Arnold and Giovanni Vian Edizioni Ca’Foscari The Reception and Application of the Encyclical Pascendi Studi di storia Collana coordinata da Laura Cerasi Mario Infelise Anna Rapetti 3 Studi di storia Coordinatori Laura Cerasi (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Mario Infelise (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Anna Rapetti (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Comitato scientifico Claus Arnold (Johannes Gutenberg-Universität, Mainz, Deutschland) Marina Caffiero (Università di Roma «La Sapienza», Italia) Giovanni Filoramo (Università degli Studi, Torino, Italia) Marco Fincardi (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Stefano Gasparri (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Vincenzo Lavenia (Università degli Studi, Macerata, Italia) Simon Levis Sullam (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Adelisa Malena (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Alberto Masoero (Università degli Studi di Genova, Italia) Rolf Petri (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Giorgio Politi (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Silvio Pons (Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», Italia) Antonella Salomoni (Università della Calabria, Cosenza, Italia) Enzo Traverso (Cornell University, Ithaca, New York, United States) Giovanni Vian (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Chris Wickham (All Souls College, University of Oxford, United Kingdom) Direzione e redazione Università Ca’ Foscari Venezia Dipartimento di Studi Umanistici Palazzo Malcanton -

St. Louis, Mo., Will Baltimore
National Circulation, 4481)38; Denver Catholic Register, 21J08 WASHINGTON, D.C., MADE SEAT OF ARCHDIOCESE Contents Copyrighted by the Catholic Press Society, Inc., 1939— Permission to Reproduce, Excepting 3-Day Observance to Mark Little Sisters’ on Articles Otherwise Marked, Given After 12 M. Friday Following Issue Archbishop Curley Centenary; Bishop Will Sing Mass Of Raltimore Will A three-day celebration of their Very Rev. Wm. Coyne, president Vincent’s home will give plays and DENVER CATHOLIC order’s centenary will be held by of St. Thomas’, will preach and a other entertainment. the Little Sisters of the Poor in choir from St. Francis de Sales’ Came to Denver in 1916 Denver Oct. 26, 27, and 28. A pari.sh, under the direction of Ar The Little Sisters of the Poor Rule New District Solemn Pontifical Mass to be cele thur Alcorn, will sing. A .special came to Denver in 1916 at the re brated by Bishop Urban J. Vehr invitation to attend the services quest of the Most Rev. Nicholas in the chapel of the J. K. Mullen this day is extended to all bene C. Matz, second Bishop of Denver. home for the aged conducted by factors and friends of the home The modern home for the nuns and Same Curia Will Serve Both Sees, Which Are the nuns will open the observance. and to the general public. Bene their 170 charges at W. 30th ave REGISTER The Very Rev. Wm. Higgins of St. diction will be held at 4 p. m. nue and Newton street was erected The National Catholic Welfare Conference News Service Supplies The Denver Catholic Register. -

The Kirby Collection Catalogue Irish College Rome
Archival list The Kirby Collection Catalogue Irish College Rome ARCHIVES PONTIFICAL IRISH COLLEGE, ROME Code Date Description and Extent KIR / 1886/ 560 February Holograph letter from Enrico Gualdi, Rome, to Kirby: 1886 Communicates reply of S. Congregation of Indulgences regarding the request of the Irish Dominican Sisters of Lisbon. [Italian] 4pp 1 1 January Holograph letter from Rector of [Seminario Pio], Rome, to 1887 Kirby: Writer requests Kirby's presence at a meeting of the rectors of Colleges and seminaries to be held on Thursday, 13 January, regarding the forthcoming Jubilee of Leo XIII. 1p 2 3 January Holograph letter from Mother Abbess, Skiddaway, 1887 Savannah, to Kirby: A long letter in detail regarding troubles of the Poor Clares Collettines and telling what happened at a meeting with, recently appointed, Bishop Becker who wishes to close the convent. Asks Kirby's help and advice. 8pp 3 3 January Holograph letter from +John Leahy, Newry, to Kirby: Asks 1887 for renewal of special faculties of Formula Sexta. 1p 4 3 January Holograph letter from Sr. M. Antonio, Dominican Convent, 1887 Dublin, to Kirby: Letter of thanks for beautiful prize sent by Pope. 4pp 5 5 January Holograph letter from +T. Power, St. John's, 1887 Newfoundland, to Kirby: Letter of salutation etc. - writer hopes that his student, John O'Reilly, is doing well. 4pp 6 5 January Holograph letter from Pauline Ch. Hehl, London, to Kirby: 1887 Writer begs Kirby to do something to stop Fr. Porter being sent to Bombay. He feels the heat badly, is getting old and is needed in England, while in India 'the heathens do not require such first rate theologians and preachers'. -

Apostolicae Sedis
APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE ANNUS VIII - VOLUMEN VIII ROMAE TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS MCMXVI i t \ i Si ; t i f 5 '. îï ' ' f 1 f; .il r i Ir li il k il I Î Annus VIII - Vol. VIII Die 18 Ianuarii 1916 Num. 1 ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE ACTA BENEDICTI PP. XV EPISTOLA AD CAROLUM HAMEL ET HENRICUM SAINT-OLIVE, COETUS MODERANDO OPERI « A PROPAGATIONE FIDEI » ALTERUM PARISIIS ALTERUM LUGDUNI PRAESIDES, GRATULANDI HORTANDIQUE CAUSA. Dilecti Filii, salutem et apostolicam benedictionem. — Ad christiani apostolatus apicem divina miseratione evectis, nihil sane optatius Nobis, dilecti Filii, quam vos alioqui praesentes et consilia vobiscum commu nicare. Catholicorum enim universitatem quoties animo intuemur, toties monemur alias esse oves, quae non sunt ex Ecclesiae ovili, easque Nos ad illud adducere oportere : et ex hac cogitatione sponte sua ad vos et ad pium Opus, cui praepositi estis, cupida mens pro voi at, in studiis ac coeptis vestris rerum in dies meliorum anquirens auspicia. Vera, ut fatea mur, non exiguos sollertiae diligentiaeque vestrae respondisse, Dei bene ficio, fructus testantur corrogatae piorum stipes multiplicataeque, earum ope, evangelicorum virorum expeditiones. Sed, proh dolor! quo potis simum tempore effusiorem, eamdem in rem, catholicorum caritatem desiderabamus, ea incidisse vidimus rerum adiuncta, quae iure admodum pietas vestra eam etiam ob caussam deplorat, quod Ecclesiae Missio nibus sacrorum administrorum copiam, et necessaria subsidia sub trahant. At vero spectata virtus vestra vix àdmonitos vos vult ne ad surgentes ingravescentesque difficultates animum despondeatis. Opus enim Fidei Propagandae adeo, ut nostis, cohaeret cum hominum aeterna salute, cui studet impense, ut Is, qui vult omnes homines salvos fieri 6 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale et pro omnibus mortuus est, et semen seminanti praestiturus sit et incrementa aucturus frugum, quos evangelici eduxerint operarii. -
Smrt Pape Pija X. I Izbor Benedikta XV. U Ozračju Početka Prvoga Svjetskoga Rata
Studia lexicographica, GOD. 8 (2014) BR. 1(14), STR. 77–97 Ivan Armanda: Smrt pape Pija X. i izbor Benedikta XV. u ozračju početka Prvoga svjetskoga rata Pregledni rad Primljeno: 14. I. 2015. Prihvaćeno: 25. II. 2015. 272-722Pius X, Benedictus XV tj. pape-Pio X i Benedikt XV 94(100)"1939/1945":272 tj. prvi svjetski rat:Katolička crkva Smrt pape Pija X. i izbor Benedikta XV. u ozračju početka Prvoga svjetskoga rata Ivan Armanda Leksikografski zavod Miroslav Krleža SAŽETAK: U članku se govori o smrti pape Pija X. i o konklavi iz 1914. u kojoj je izabran nje- gov nasljednik Benedikt XV., pri čemu se ti događaji stavljaju u kontekst početka Prvoga svjetskoga rata. Iznose se činjenice koje svjedoče da je Pio X. predviđao ratni sukob u Europi, a potom se opisuju njegove reakcije i stajališta u predvečerje i neposredno nakon početka Prvoga svjetskoga rata. Osobito se nagla- šava kako je početak rata porazno djelovao na Pija X., koji je preminuo ni mjesec dana nakon početka rata. Nakon kratkoga prikaza novih pravila za održavanje konklava, što ih je propisao upravo Pio X., iznose se podatci o održavanju općih kongregacija kardinala prije početka konklave i podatci o trima najizglednijim kandidatima za novoga papu, pri čemu se posebno naglašavaju čimbenici koji su utjecali na raspoloženje i stajališta kardinala. Nakon sažetih podataka o sudionicima konklave, iznosi se njezin tijek s detaljnim podatcima o glasovanju u svim izbornim krugovima, o sukobima među kardinalima i o izboru novoga pape, koji je uzeo ime Benedikt XV. Na kraju se iznose prve geste i prve mirovne poru- ke novoga pape. -

WILL LIVE OVER PIONEER DAYS. PRIEST WRITES On
WILL LIVE OVER PIONEER DAYS. PRIEST WRITES PLANS FOR BIG Contents Copyrighted— PemissioH to Reproduce Given After 12 M. Friday Following Issue FR. HOWLETT COMMUNITY CHEST NEEDS YOUR HELP RALLY BY MEN IS UNABLE TO The annual financial ealnpaicn ef the Community Chest opens DENVERCATHOUC Monday, Oct. 21. We bespeak the whole-hearted co-operation of the ATTEND JUBILEE Catholics of the city in this com A N N O U N CED munity enterprise. The Catholic Charities must ask for an increase for the coming yeer^ e» increase Great Demonstration by Holy Name Union Church Indebted to Oldest Living Former that may not be possible unless all of us are willing to do our share To Be Held in Conjunction With REGISTER Rector of Cathedral for His in making the campaign a success, j The National Catholic Welfare Conference News Service Supplies The Denver Catholic Register. We Have tory of Diocese Alfred E. Smith, former goT*| Cathedral Jubilee Also the International News Service (Wire and Mail), a Large Special Service, and Seven Smaller Services. ernor of New York, declared at the National Conference of Catholic Plans have been completed for what is expected to be VOL. XXXI. No. 9. DENVER, COLO., THURSDAY, OCT. 17, 1935. $2 PER YEAR Though because of his advanced age and physical con Charities, held a few weeks ago in the most magnificent demonstration of faith in the Rocky dition he will be unable to come to Denver for the diamond Peoria, IIl.^ that gorernment relief jubilee celebration of the Cathedral parish, the Rev. Wil is “ cold” abd "costly;” that public Mountain region, when the annual rally of the Holy Name Oldest Living Former Rector charity is “ impractical and inade societies of Denver will be held on the ffe^st of Christ the liam J. -

Apostolicae Sedis
ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE ANNUS XXXVII - SERIES II - VOL. XII TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS M • DCCCC • XLV An. et vol. XXXVII 28 Ianuarii 1945 (Ser.n,v.Xn)-Num.l ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE ACTA PII PP, xn SERMO QUEM SSMUS D. N. PIUS PP. XII HABUIT DIE XXIV MENSIS DECEMBRIS A. MCMXLIV, IN PERVIGILIO NATIVITATIS D. N. IESU CHRISTI, ADSTANTIBUS EMIS PP. DD. CARDINALIBUS ET EXCMIS DD. EPISCOPIS AC ROMANAE CURIAE PRAELATIS. Gratitudine paterna In questa vigilia del Santo Natale e all'approssimarsi del nuovo anno, il nobile impulso dei vostri cuori, più ancora che una usanza tradizionale, vi ha condotti, Venerabili Fratelli e diletti Figli, alla casa del Padre comune dei fedeli. Voi che, durante Panno che volge al tramonto, Ci avete assistiti coi vostri saggi consigli e con la vo stra assidua collaborazione, avete voluto ora offrirci il dono delle vo stre fervorose preghiere e dei vostri auguri, espressi con tanta defe rente bontà, con tanta freschezza e con così chiaro accento, dal vo stro eminente interprete, il venerando Signor Cardinale Decano del Sacro Collegio: avete voluto far sentire a chi porta sulle sue deboli spalle, in tempi così difficili, il peso del Supremo Ministero Aposto lico, che nell'adempimento di un ufficio ognor più vasto e gravoso egli può sempre contare sul concorso di tutte le vostre forze consacrate al servigio di una così augusta causa. A tanta vostra devozione e fedeltà, a tanto zelo operoso, esercitato da voi negli uffici che vi sono assegnati nella milizia di Cristo, -

Of the Most Holy Rosary a Very Efficacious Devotion to Obtain All Kinds of Graces H-- the FIFTEEN SATURDAYS
CQ v . - of the Most Holy Rosary A Very Efficacious Devotion to Obtain All Kinds of Graces h-- THE FIFTEEN SATURDAYS OF THE MOST HOLY ROSARY A VERY EFFICACIOUS DEVOTION TO ORTAIN ALL KINDS OF GRACES UOMMANDER BARTOLO LONGO, Li. D. —— ————— THE FIFTEEN SATURDAYS OF THE MOST HOLY BOSARY A VERY EFFICACIOUS DEVGTION TO OBTAIN ALL KINDS OF GRACES Translated from the eleventh italian edition BY LUIGI CATURELLI Inc. Sinners Publishing, by Refuge of copyright 6 2015 ndiana. Pekin, of Refuge of Sinners the property in of this book i5 in whole, or The typography noto t be r€ roduced, Inc. àn d may the publisher. publishing, permission from part, without written of America. in the United States Printed and bound Published by In: Refuge of Sinners Publishing, IN. 471€ 5271 E Mann Rd - Pekin, www.JoyfulCatholic.com 1-800-451-3993 A PROTESTATION MarchComplyingA5 end wi 5b june W a& ell as wit $d as well as with the Decrees of the Sac (Jlune 1631, lemaly declare thmP et Congregations of Kites, wes So- and Doctrines exeep- led which the noll he Dogmas : t conceras mirac) ¥ Cathotie See delined, to all u €8, apparitions and Suinl; nul. vel (ll: nonized, w W6 meg ; only human ^i 10 give and require i cred M. n t : THE BOOK OF THE FIFTEEN SATURDAYS The origin of this book. On the eighth of May 1876 we laid the corner stone of the Sanctuary of Pompei. Among the Neapolitan ladies who contri- buted by their offerings to the building of this Temple of the Rosary, there was the pious Marchioness Filiasi di Somma.