Le Due Chiese Di San Carlo a Paludea
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Disponibilità Supplenze I Grado
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Ufficio VI - Ambito territoriale per la Provincia di Pordenone Disponibilità per assunzioni a tempo determinato Scuole second. I grado a.s. 2014-15 A043 – ITAL.STORIA.ED.CIVICA GRADUATORIA ESAURITA Cattedre Ist. Scol. 1/C S.M.BRUGNERA 14/Co S.M. CHIONS + 4 S.M. PRAVISDOMINI 1/C S.M.PRAVISDOMINI 12/Co S.M. CORDOVADO + 6 S.M. SESTO 10/Co S.M.FIUME VENETO 8 S.M. ZOPPOLA 1/C S.M.MANIAGO A 1/C S.M.MANIAGO 12/Co S.M. MONTEREALE + 6 S.M. VIVARO A 1/C S.M. CLAUT A 12/Co S.M. PN RORAI + 6 PN CENTRO 14/Co S.M. ROVEREDO + 4 S.M. CORDENONS 1/C S.M. SACILE 1/C S.M. S. VITO AL TAGL. 1/C S.M. TRAVESIO 1/C S.M. ZOPPOLA ORE RESIDUE 9 ore S.M. AVIANO 17 ore S.M. AZZANO 9 ore S.M. MORSANO 7 ore S.M. FONTANAFREDDA 9 ore S.M. MEDUNO 12 ore S.M. PASIANO 11 ore S.M.PN SUD 9 ore S.M. PRATA 8 ore S.M. SACILE 9 ore S.M. VALVASONE 15 ore S.M. ZOPPOLA A059 –MATEM. E SCIENZE GRADUATORIA ESAURITA 1/C S.M. AVIANO A 1/C S.M. AVIANO A 1/C S.M. AZZANO A 1/C S.M. BRUGNERA A 1/C S.M. BRUGNERA A 1/C S.M. CANEVA A 1/C S.M. CANEVA A 12/Co S.M. POLCENIGO + 6 S.M. -

Legenda 245 392 242
2350000 2351000 2352000 2353000 2354000 2355000 2356000 2357000 2358000 2359000 Cavasso Nuovo Travesio Castelnovo del Friuli ¡ Fanna ! Pinzano al Tagliamento Sequals Arba Meduno Maniago 5117000 5117000 Spilimbergo Vivaro S. R. 552 240 Castelnovo del Friuli Travesio Legenda 245 392 242 300 Cavasso Nuovo Confini amministrativi Confine comunale Sequals Solimbergo 300 Altri limiti comunali 241 361 200 247 COL PALOTTA 230 5116000 5116000 Individuazione delle aziende agricole S. P. 33 276 Iõ Aziende agricole 241 C.Paludo Classe acustica aggregata delle unità territoriali 239 319 194 192 304 Classe I Castello Canale Classe II Classe III COL PALIS 187 S.Antonio Classe IV 300 Collettore 192 Classe V Azienda Agricola 377 200 192 Casarotto Zona di interesse militare (non classificabile) 5115000 5115000 173 S. P. 22 190 Sequals 208 Molino Vecchio 205 Ancona da Fasce di decadimento acustico Vies 186 Pinzano al Tagliamento Bonifica 186 256 Fascia di decadimento acustico di classe II Sequals IL COLLE 195 S.Zenone Lestans Ancona Cantando Infrastrutture di trasporto 209 Stalla della Costa 349 186 Strada Regionale 204 208 Strada Provinciale Font.na della Povra C.Picchiutto 188 217 S. Matteo 192 Altre strade V.la Odorico S. P. 34 182 206 178 182 5114000 5114000 S.Giuseppe 214 S.Antonio 217 176 185 Il Capitel Mad.a della Maseres Ten.ta Emonia 197 199 177 S. R. 464 Azienda Agr.la Ancona di 175 211 170 170 la Madonnina Gamberel S.Urbano 190 173 Ancona di Giai 201 173 172 5113000 180 5113000 Fattoria 191 169 203 Progresso Arba 200 187 200 Azienda Agr.la Lis Gravis Sistema di riferimento: Gauss-Boaga fuso est - Base cartografica: Carta Tecnica Regionale al 1:25.000 193 193 REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI PORDENONE COMUNE DI SEQUALS 185 5112000 5112000 195 192 Azienda Agr.la 183 la Ghiaia 183 S. -

Percorso Tra Archeologia E Storia Nell'ecomuseo Delle Dolomiti
Ecomuseo Il tempo nei luoghi Lis Aganis Percorso tra Archeologia e Storia nell’Ecomuseo delle Dolomiti Friulane Presentazione Il tempo nei luoghi Percorso tra Archeologia e Storia nell’Ecomuseo delle Dolomiti “L’Archeologia è una delle tematiche scelte dall’Ecomuseo L’Ecomuseo Lis Aganis ringrazia i Soci per raccontare e far conoscere il proprio territorio, che hanno partecipato attivamente alla ideazione attraverso le cellule, i percorsi, attività e manifestazioni. e realizzazione del progetto Archeologia 2 L’Archeologia è uno strumento per documentare, narrare, ”Il tempo nei luoghi. Percorso tra Archeologia le storie dei luoghi e le tracce lasciate dagli uomini, e storia nell’Ecomuseo delle Dolomiti Friulane”: dai tempi più antichi fino ai giorni nostri, è il fascino e l’utilità della conoscenza dell’oggi e del domani, • Comune di Budoia attraverso il passato” • Comune di Clauzetto • Comune di Montereale Valcellina Ezio Cesaratto • Comune di Polcenigo Presidente Ecomuseo Lis Aganis • Comune di Travesio • Comune di Tramonti di Sotto • Ass. “Amici della Centrale” Malnisio di Montereale Valcellina • Circolo culturale Menocchio Montereale Valcellina • Gruppo Archeologico Archeo 2000 Lestans di Sequals • Gruppo Archeologico Cellina Meduna Grafica: Medeia Tesis di Vivaro Stampa: Grafiche Risma • Pro Loco Tramonti di Sotto • Pro Loco Valtramontina Le foto di reperti proprietà dello Stato sono pubblicate su concessione del Ministero per i Beni e le Attività culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia; ne è vietata -

Circ. N. 4 Travesio, 07 Settembre 2021 a Tutto Il Personale Docente Ed ATA
Circ. n. 4 Travesio, 07 settembre 2021 A tutto il personale docente ed ATA Ai Genitori degli alunni Alle Amministrazioni Comunali di Arba, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Clauzetto, Fanna, Meduno, Pinzano al T.to, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d’Asio Loro Sedi OGGETTO: CALENDARIO SCOLASTICO 2021-2022 Si comunica il calendario scolastico deliberato dal Consiglio d’Istituto del 30/06/2021 DATA DI INIZIO E DI TERMINE DELLE LEZIONI NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO Lunedì 13 settembre 2021: data inizio per la Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado Venerdì 10 giugno 2022: data termine per le Scuole Primarie, Secondarie di Primo Grado Giovedì 30 giugno 2022: data termine per le Scuole dell’Infanzia LE ATTIVITÀ DIDATTICHE SARANNO SOSPESE PER LE SEGUENTI FESTIVITÀ NAZIONALI tutte le domeniche Festa di tutti i Santi: lunedì 1 novembre 2021; Festa dell’Immacolata: mercoledì 8 dicembre 2021; Natale: sabato 25 dicembre 2021 Santo Stefano: domenica 26 dicembre 2021 Capodanno: sabato 1 gennaio 2022 Epifania: giovedì 6 gennaio 2022 Lunedì dell’Angelo: lunedì 18 aprile 2022 Anniversario della Liberazione: lunedì 25 aprile 2022 Festa del Lavoro: domenica 1 maggio 2022 Festa della Repubblica: giovedì 2 giugno 2022 SOSPENSIONI DELLE LEZIONI E DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE • Vacanze natalizie: da giovedì 23 dicembre 2021 a venerdì 07 gennaio 2022 • Carnevale e mercoledì delle Ceneri: da lunedì 28 febbraio a mercoledì 2 marzo 2022 • Vacanze pasquali: da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 • Deliberata dal -

Movimenti Provinciali.Pdf
********************************************************************************** * SI-13-SM-PDO2B * * * * SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE * * * * * * SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO * * * * * * UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI * * * * * * UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : PORDENONE * * * * * * ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO * * * * * * ANNO SCOLASTICO 2015/2016 * * * * * * ATTENZIONE: PER EFFETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY QUESTA STAMPA NON * * CONTIENE ALCUNI DATI PERSONALI E SENSIBILI CHE CONCORRONO ALLA * * COSTITUZIONE DELLA STESSA. AGLI STESSI DATI GLI INTERESSATI O I * * CONTROINTERESSATI POTRANNO EVENTUALMENTE ACCEDERE SECONDO LE MODALITA' * * PREVISTE DALLA LEGGE SULLA TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. * * * * * ********************************************************************************** POSTI DI SOSTEGNO PER MINORATI PSICO-FISICI ***** TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL COMUNE 1. BOSCHIAN MARA . 24/11/60 (EE) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) DA : PNMM83101R - GIUSEPPE LOZER ( PORDENONE ) A : PNMM83201L - SMS CENTRO STORICO ( PORDENONE ) PRECEDENZA: TRASFERIMENTO D'UFFICIO NEL COMUNE PUNTI 237 2. LUCA' SILVIA . 12/12/66 (PN) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) DA : PNMM83101R - GIUSEPPE LOZER ( PORDENONE ) A : PNMM830011 - EX TERZO DRUSIN ( PORDENONE ) SOPRANNUMERARIO TRASFERITO A DOMANDA CONDIZIONATA PUNTI 108 ***** TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA 1. BIANCO FIORE MARCO . 15/ 8/81 (PN) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) -

Anduins Di Vito D'asio (Pn)
CURRICULUM VITAE La sottoscritta De Nardo Eleonora ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità DICHIARA INFORMAZIONI PERSONALI Nome/Cognome ELEONORA DE NARDO Indirizzo Via Pelesan, 14 - 33090 - Anduins di Vito d’Asio (Pn) - Italy Cellulare 339.6162153 E-mail [email protected] Pec [email protected] Codice Fiscale DNR LNR 65S70 Z133V Partita I.V.A. 00250238888 (libera professionista dal 2003) Data e Luogo di Nascita 30 novembre 1965 - Ginevra (Svizzera) Nazionalità Italiana Madrelingua Italiana Curriculum Vitae aggiornato al 10 giugno 2016 Eleonora De Nardo - Cell.: 339.6162153 - E-mail: [email protected] Pagina 1 ISTRUZIONE E FORMAZIONE Titolo di Studio Diploma di Ragioniera conseguito presso l’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI "VINCENZO MANZINI" di San Daniele del Friuli (UD) con il punteggio di 43 sessantesimi nell’a.s. 1983/84. o 1984 Iscritta e frequentato il corso di laurea in Conservazione Dei Beni Culturali, indirizzo BENI MOBILI e ARTISTICI; Università degli Studi di Udine; Facoltà di Lettere e Filosofia. Esami mancanti: Letteratura Italiana e Storia dell’Arte Contemporanea. Pubblicato un sunto del lavoro di ricerca per la tesi in Numismatica e Medaglistica in Fabio PIUZZI 1998, Frammenti di luce. Storia, archeologia e misteri di una pieve -

Supermercati Per Colletta Alimentare Del 27/11/2010
Supermercati per Colletta Alimentare del 30/11/2019 mattino pomeriggio chiusura Note AVIANO 5 Bottegon srl V.le S.Giorgio, 36/b Aviano Aviano Aviano Conad. Via De Zan Aviano Aviano Aviano Coop. Casarsa loc.Marsure Aviano Aviano Aviano Eurospin Via Nervesa Discount Dpiù Via Pordenone AZZANO X° 8 Maxì loc. Tiezzo Conad Via Ilaria Alpi Eurospar Via dei Frassini Azzano Azzano Dalle 15.30 Despar Via XXV Aprile,41 Azzano Azzano Lidl Via I° Maggio, 17 Azzano Azzano Eurospin Azzano Azzano IN's Via Rimembranze Azzano Azzano Crai P.za Garibaldi loc. Tiezzo BRUGNERA 3 Super A&O Via Ungaresca Brugnera Brugnera Brugnera Super A&O loc.Tamai Brugnera Brugnera Brugnera Crai Via Santarossa loc. Maron Brugnera Brugnera Brugnera BUDOIA 1 Visotto Budoia Budoia Budoia CANEVA 4 Crai Via G Mazzini loc. Sarone Caneva Caneva Caneva Vem Piazza Martiri Garibaldini Caneva Caneva Caneva Alimentari Del Col loc. Stevenà Caneva Chiude a mezzogiorno Maxì Via Roma Caneva Chiude a mezzogiorno CHIONS 2 Visotto loc. Villotta Pravisdomini Pravisdomini Pravisdomini CLAUT 2 Portano a Montereale che consegna a Maniago Sisa Cooperativa S.O.M.S. Panificio De Giusti CORDENONS 6 C.C. Discount Via Maestra Vecchia Lidl Via Goetta, 5 A&O P.zza Vittoria Eurospar Via della Filanda Penny Market Via Sclavons, 8 Visotto (Dip. Interno neg.) CORDOVADO 1 Coop. Casarsa Via Roma, 26 Cordovado Cordovado Cordovado Supermercati per Colletta Alimentare del 30/11/2019 mattino pomeriggio chiusura Note FIUME VENETO 4 Crai di Sist Via Giovanni XXIII , 11 Fiume V. Fiume V. Fiume V. Coop. Casarsa V.le Trento, 58 Fiume V. -
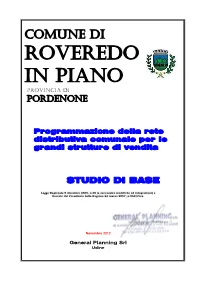
Studio Di Base
COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO PROVINCIA DI PORDENONE Programmazione della rete distributiva comunale per le grandi strutture di vendita STUDIO DI BASE Legge Regionale 5 dicembre 2005, n.29 (e successive modifiche ed integrazioni) e Decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2007, n.069/Pres. Novembre 2012 General Planning Srl Udine Comune di Roveredo in Piano Indice PREMESSA ....................................................................................................................... 3 1. LA RETE COMMERCIALE COMUNALE – SUA STRUTTURAZIONE ED EVOLUZIONE DAL 2006 AD OGGI ........................................................................... 6 1.1. Note metodologiche ........................................................................................... 6 1.2. La rete distributiva comunale attuale e la sua evoluzione .................................. 6 2. DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI DI VENDITA DA ATTRIBUIRE ALLA GRANDE DISTRIBUZIONE A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE NORME COMUNITARIE E STATALI .............................. 13 2.1. Considerazioni generali ................................................................................... 13 2.2. Valutazione dei traffico commerciale oggi presente e possibile ....................... 15 2.2.1. Valutazione degli attuali livelli di traffico ....................................................... 15 2.2.2. Valutazione dei livelli di traffico possibili alla riapertura di attività oggi sospese e al completamento delle previsioni del vigente Piano di settore ..... -

Piano Unione Definitivo
Andreis Arba Barcis Castelnovo Cimolais Claut Clauzetto Erto e Casso Frisanco Maniago del Friuli PIANO DELL’UNIONE Art. 17 - L.R. 26/2014 e ss.mm.ii Approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. __ del XX/XX/2017 Meduno Montereale Pinzano al Sequals Tramonti di Tramonti di Travesio Vajont Vivaro Vito Valcellina Tagliamento Sopra Sotto d’Asio 1 Sommario 1. PREMESSA 4 2. IL CONTESTO DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 5 2.1 Il quadro delle condizioni esterne 5 2.2 Il territorio e gli Enti interessati 9 2.2.1 Analisi del contesto territoriale 14 2.2.1.1 Demografia 14 2.2.1.2 Economia locale e lavoro 28 2.2.1.3 Ambiente e territorio 43 2.3 Analisi dei servizi erogati dalle Amministrazioni comunali 52 2.3.1 Informatica 52 2.3.2 Statistica 54 2.3.3 Catasto 55 2.3.4 Elaborazione progetti europei 55 2.3.5 Polizia Locale 55 2.3.6 Attività produttive compreso lo SUAP 55 2.3.7 Gestione dei tributi 56 2.3.8 Gestione del personale 57 2.3.9 Pianificazione di protezione civile 57 2.3.10 Gestione dei servizi contabili, finanziari e controllo di gestione 58 2.3.11 Servizi socio assistenziali 58 2.3.12 Fabbisogni della CUC 59 2.3.13 Procedure autorizzatorie in materia di energie 59 2.4 Analisi SWOT 60 2.4.1 Sviluppo artigianale e industriale 61 2.4.2 Sviluppo turistico, agroalimentare e ambientale 62 2.4.3 Sviluppo energetico e infrastrutturale 64 2.4.4 Sviluppo delle politiche sociali e welfare 65 2.4.5 Sviluppo delle competenze, cultura e socializzazione 66 2.5 I fabbisogni e le sfide del territorio dell’UTI 67 3. -

Regione Friuli - Venezia Giulia
2356000 2357000 2358000 2359000 2360000 2361000 2362000 2363000 2364000 Clauzetto 0 0 Vito d'Asio 0 Clauzetto 0 Osoppo 0 0 Forgaria nel Friuli 0 0 2 2 1 1 5 5 Meduno Vito d'Asio Travesio Castelnovo del Friuli ¡ Majano Ragogna Pinzano al Tagliamento Sequals San Daniele del Friuli Arba Spilimbergo Rive d'Arcano ZONS MANAZ Forgaria nel Friuli ZIS AGRA COL M RIO LEGENDA BIANCO Sintesi del P.R.G.C. 0 0 0 0 0 P 0 Zona A di interesse storico ambientale 9 R 9 1 1 1 A 1 5 D 5 A Zona B di completamento L D P Zona C di espansione CES TTU O FRA NTE Zona D3 industriale e artigianale FO N E S T A N T Zona E2 agricola e forestale ricadente negli ambiti boschivi N T O A Zona E3 agricola e forestale ricadente negli ambiti silvo-zootecnici I N. 1 Zona E4 agricola e forestale ricadente negli ambiti di interesse agricolo-paesaggistico S.P. B LA Zona E4.4 golena del Tagliamento S DEL E A M Zona RV di rispetto visuale I VAL L ARZINO Zona O degli insediamenti residenziali misti O D' RZINO COLLE A O M RI IMES Zona S delle attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico MOL TOIO A SERBA MIC Zona V di verde privato - qualificazione ambientale FOR LA DEL TE K.56 Allevamento ittico FON Demanio ferroviario ALI Castelnovo del Friuli COL VI 0 0 Infrastrutture di trasporto 0 . N. 1 0 0 S.P 0 8 8 1 1 1 LLA 1 Ferrovia 5 DE 5 ES OLIM TE M VAL Ferrovia (tratti in galleria) MON AIBA Strade Provinciali PONT Strade Provinciali (tratti in galleria) BA PONTAI Strade Comunali I) RONCH (RUDER CHIA Strade Comunali (tratti in galleria) R EMONA TAMA G RTI O O - RRENTE Confine comunale PINZAN TO EIS - CAMP SACILE BA PONTAI RROVIA LA VILE FE R I K.55 V Travesio E R A V A T I O D'ARZIN 0 P 0 0 0 0 VAL 0 7 7 1 A 1 1 N. -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2017
Ufficio del territorio di PORDENONE Data: 24/10/2017 Ora: 11.57.49 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2017 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.485 del 24/02/2017 n.- del - REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 3 N. 5A MONTAGNA INTERNA: ALTE VALLI DEL CELLINA E DEL N. 10 PIANURA: PIANURA TRA CELLINA E LIVENZA MEDUNA Comuni di: ANDREIS, BARCIS, CIMOLAIS, CLAUT, CLAUZETTO, ERTO Comuni di: AZZANO DECIMO, BRUGNERA, CHIONS, CORDENONS, E CASSO, FRISANCO, TRAMONTI DI SOPRA, TRAMONTI DI SOTTO, FIUME VENETO, FONTANAFREDDA, PASIANO DI PORDENONE, VITO D`ASIO PORCIA, PORDENONE, PRATA DI PORDENONE, PRAVISDOMINI, ROVEREDO IN PIANO, SACILE, SAN QUIRINO, ZOPPOLA COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO 12600,00 SI 17600,00 SI BOSCO D`ALTO FUSTO 12600,00 SI 17600,00 BOSCO MISTO 12600,00 SI 17600,00 SI FRUTTETO 77000,00 SI FRUTTETO STRUTTURATO 92000,00 SI INCOLTO PRODUTTIVO 6600,00 SI 17600,00 SI ORTO 33100,00 60500,00 PASCOLO 1370,00 SI PIOPPETO - BOSCO DI IMPIANTO 48500,00 SI PRATO 12600,00 SI 35200,00 SI PRATO ARBORATO 12600,00 SI SEMINATIVO 21000,00 SI 55000,00 SI SEMINATIVO ARBORATO 21000,00 SI 55000,00 SI Pagina: 1 di 6 Ufficio del territorio di PORDENONE Data: 24/10/2017 Ora: 11.57.49 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2017 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.485 del 24/02/2017 n.- del - REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 3 N. -

TRAVESIO Piano Anticorruzione 2016
COMUNE DI TRAVESIO (Provincia di Pordenone) Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 del Comune di Travesio (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, articolo 1, commi 8 e 9 della legge n. 190/2012) Approvato con delibera della Giunta Comunale n.4 del 27/01/2016 0 PARTE I INTRODUZIONE GENERALE 1 1. Introduzione Sulla Gazzetta Ufficiale numero 265 del 13 novembre 2012 è stata pubblicata la legge 6 novembre 2012 numero 190, entrata in vigore il 28 novembre 2012. La legge 190/2012, anche nota come “ legge anticorruzione ” o “ legge Severino ”, reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione . Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia. Si segnala, in particolare, la Convenzione dell’Organizzazione della Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4, sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2013 e ratificata il 3 agosto 2009 con la legge numero 116. La Convenzione O.N.U. del 2003 prevede all’articolo 5 che ogni Stato: elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate; si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione; verifichi periodicamente l’adeguatezza di tali misure; collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione. La Convenzione O.N.U.