I BERBERI Elementi Di Storia, Lingua E Letteratura
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Cambridge Companion to Age of Constantine.Pdf
The Cambridge Companion to THE AGE OF CONSTANTINE S The Cambridge Companion to the Age of Constantine offers students a com- prehensive one-volume introduction to this pivotal emperor and his times. Richly illustrated and designed as a readable survey accessible to all audiences, it also achieves a level of scholarly sophistication and a freshness of interpretation that will be welcomed by the experts. The volume is divided into five sections that examine political history, reli- gion, social and economic history, art, and foreign relations during the reign of Constantine, a ruler who gains in importance because he steered the Roman Empire on a course parallel with his own personal develop- ment. Each chapter examines the intimate interplay between emperor and empire and between a powerful personality and his world. Collec- tively, the chapters show how both were mutually affected in ways that shaped the world of late antiquity and even affect our own world today. Noel Lenski is Associate Professor of Classics at the University of Colorado, Boulder. A specialist in the history of late antiquity, he is the author of numerous articles on military, political, cultural, and social history and the monograph Failure of Empire: Valens and the Roman State in the Fourth Century ad. Cambridge Collections Online © Cambridge University Press, 2007 Cambridge Collections Online © Cambridge University Press, 2007 The Cambridge Companion to THE AGE OF CONSTANTINE S Edited by Noel Lenski University of Colorado Cambridge Collections Online © Cambridge University Press, 2007 cambridge university press Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao˜ Paulo Cambridge University Press 40 West 20th Street, New York, ny 10011-4211, usa www.cambridge.org Information on this title: www.cambridge.org/9780521818384 c Cambridge University Press 2006 This publication is in copyright. -

La Maison Kabyle Art Et Organisation Spatiale Et Conception (Cas Village AIT EL KAID)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴸ ⵓⵏⵏⵉⴴ ⴴ ⵓⵏⴰⴸⵉ ⵓⵙⵏⴰⵏ ⵝⴰⵙⴸⴰⵡⵉⵝ ⵏ ⵍⵎⵓⵍⵓⴸ ⴰⵝ ⵎⵄⴻⵎⵎⴻⵕ ⵏ ⵝⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ ⵝⴰⵣⴻⴷⴷⴰⵢⵝ ⵏ ⵜⵙⴻⴿⵍⵉⵡⵉⵏ ⴸ ⵝⵓⵝⵍⴰⵢⵉⵏ جامعة مولود معمري - تيزي وزو UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI DE TIZI OUZOU كلية اﻵداب واللغات FACULTE DES LETTRES ET DES LANGUES DEPARTEMENT LANGUE ET CULTURE AMAZIGHES N° d’Ordre : N° de série : Mémoire en vue de l’obtention Du diplôme de master II DOMAINE : Langue et culture amazighe FILIERE : Langue et culture amazighe SPECIALITE : Art et littérature amazighe « imaginaire » La maison kabyle art et organisation spatiale et conception (cas village AIT EL KAID) Présenté par : Encadré par : MEZIANI Fatma MESSAOUDI Zahwa Mme ACHILI Fadila Jury de soutenance : Président : Mme DAHMANI Samia Encadreur : Mme ACHILI Fadila Co-Encadreur : Mme HACID Farida Promotion : Octobre 2016 Laboratoire d’aménagement et d’enseignement de la langue amazighe Remerciements A l’issue de ce travail, nous voulons remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la concrétisation de ce travail de recherche. En premier lieu, nous tenons à adresser nos remerciements à notre promotrice de ce mémoire, Madame ACHILI Fadila, pour son encadrement, sa rigueur, sa minutie et ses connaissances professionnelles polyvalentes dont on a tiré le plus grand profit. Nous adressons également nos remerciements à Madame DAHMANI Samia pour avoir accepté de présider le jury de cette soutenance et à Madame HACIDE Farida qui a bien voulu accepter d’examiner ce travail de recherche. Nous n’oublierons pas non plus de remercier Madame HAMADOUCHE Ourdia Présidente de l’association Trésor Touristique algérienne, qui nous fait déplacé au village Ait El Kaid et nous beaucoup encouragé. -

01- Cristina Kormikiari
GRUPOS INDÍGENAS BERBERES NA ANTIGÜIDADE: A DOCUMENTAÇÃO TEXTUAL E EPIGRÁFICA Maria Cristina N. Kormikiari Doutora em Arqueologia-MAE/USP Resumo A pesquisa desenvolvida neste artigo foi realizada durante um traba- lho de organização da documentação epigráfica e textual referente aos grupos berberes norte-africanos na Antigüidade. Oportunamente, dis- cutimos as especificidades da documentação à disposição do pesqui- sador desta área: arqueológica, epigráfica e textual e apresentamos nossa contribuição para a definição do conceito teórico tribo, normal- mente utilizado de maneira vaga e pouco fundamentada. Abstract The research developed in this article was carried out during the organizing of textual and epigraphic document refering to the North- African Berbers of Antiquity. Opportunely, we discussed the proper uses of the documentation available for the researcher working in this field: archaeological, epigraphic and textual, and we also present here our contribution for defining the theoretical concept of tribe, usually applied vaguely and with little depth. Palavras-Chave Berbere – Norte da África – Antigüidade – Roma – Grupos Indígenas Keywords Berber – North Africa – Antiquity – Rome – Indigenous Groups Maria Cristina N. Kormikiari / Revista de História 145 (2001), 09-60 1 Introdução O Norte da África, enquanto laboratório de transformações culturais impostas por mudanças históricas, constitui um campo de análise extremamente rico para o cientista humano. Esta região pode ser considerada, geograficamente, uma “ilha”, 2 pois encontra-se separada da Europa pelo mar e do resto da África pelo deserto . De fato, sua ligação física mais direta é com o Oriente, esse mesmo Oriente com o qual grande parte de sua História se mescla. No entanto, apesar das barreiras físicas, a Península Ibérica em especial, mas igualmente a região mediterrânica central, desde tempos os mais remotos, estabeleceram uma série de contatos e intercâmbios hu- 3 manos, culturais e econômicos com a região norte-africana . -

A History of Rome to 565 A. D. by Arthur Edward Romilly Boak
The Project Gutenberg EBook of A History of Rome to 565 A. D. by Arthur Edward Romilly Boak This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at http://www.gutenberg.org/license Title: A History of Rome to 565 A. D. Author: Arthur Edward Romilly Boak Release Date: May 31, 2010 [Ebook 32624] Language: English ***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK A HISTORY OF ROME TO 565 A. D.*** A HISTORY OF ROME TO 565 A. D. BY ARTHUR E. R. BOAK, Ph. D., Professor of Ancient History in the University of Michigan v New York THE MACMILLAN COMPANY 1921 All rights reserved COPYRIGHT, 1921. By THE MACMILLAN COMPANY. Set up and electrotyped. Published December, 1921. vii PRINTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA [v] PREFACE This sketch of the History of Rome to 565 A. D. is primarily intended to meet the needs of introductory college courses in Roman History. However, it is hoped that it may also prove of service as a handbook for students of Roman life and literature in general. It is with the latter in mind that I have added the bibliographical note. Naturally, within the brief limits of such a text, it was impossible to defend the point of view adopted on disputed points or to take notice of divergent opinions. Therefore, to show the great debt which I owe to the work of others, and to provide those interested in particular problems with some guide to more detailed study, I have given a list of selected references, which express, I believe, the prevailing views of modern scholarship upon the various phases of Roman History. -

La Coda Del Pavone Elementi Di Storia, Lingue E Letterature Del Nordafrica
Vermondo Brugnatelli La coda del pavone Elementi di Storia, Lingue e Letterature del Nordafrica Appunti per la parte generale del corso di Lingue e Letterature del Nordafrica 2011-2012 Università degli Studi di Milano-Bicocca Le cartine e le immagini che illustrano la presente dispensa sono reperibili on-line alla pagina: http://www.brugnatelli.net/vermondo/didattica/bicocca/immagini © Vermondo Brugnatelli 2012 Foto in copertina: Un pavone raffigurato in un mosaico di Qasr Libya (Cirenaica) di epoca bizantina. Prologo Si venne a parlare del Maghreb alla presenza del Principe dei Credenti, Ibn ʿAbd al-ʿAzīz al ʿUbaydī. Uno degli astanti prese la parola e disse: “Ci è stato tramandato che il mondo assomiglia ad un uccello: il Levante è il suo capo, lo Yemen è un’ala e la Siria un’altra ala, l’Iraq è il suo petto e il Maghreb è la sua coda.” Un magrebino che era tra i presenti gli disse: “È proprio vero: e l’uccello è un pavone!”. Il Sultano scoppiò in una risata, ben sapendo che la coda è ciò che vi è di meglio in un pavone. (Yaʿlâ 1996: 126, in Elmedlaoui 2008: 36) White Athena, ovvero: il vuoto epistemologico del Nordafrica. 1. African = Black? Black Athena, “Atena nera” è il titolo che nel 1987 Martin Bernal diede ad un libro, destinato a suscitare accesi dibattiti, in cui si proponeva di denunciare il mito eurocentrico della civiltà classica, facendo presente il grande debito che la civiltà occidentale ha nei confronti delle più antiche civiltà del Vicino Oriente antico, in particolare quelle dell'Egitto e della Mesopotamia. -

Thesis Submitted in Fulfilment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy
JASON BLOCKLEY THE COLONATE IN AFRICA A LEGAL & ECONOMIC HISTORY OF COLONI IN LATE ANTIQUE AFRICA FACULTY OF ARTS AND SOCIAL SCIENCES THE UNIVERSITY OF SYDNEY 2021 A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy The Colonate in Africa iii Acknowledgements I express my deepest and sincerest appreciation for the innumerable people who helped make this thesis a reality. Firstly, I must thank Mr John Whitehouse, whose inestimable generosity and confidence made this project possible. Earning a doctorate in ancient history became a personal ambition soon after beginning my undergraduate studies, and I cannot properly express how grateful I am that I was entrusted with this opportunity. John not only provided the means for me to pursue this project; his personal insights, advice, and his own scholarship were vital in establishing, growing, and ultimately completing this study. John offered a scholarship in the hopes of perpetuating his love of ancient North Africa and the scholarship thereof, and I am pleased to say he has succeeded. Secondly, I must express my sincere gratitude to Mr Jeffrey Hilton and Ms Suzanne Coleman, whose remarkable generosity and enduring love of ancient Rome afforded me the opportunity to live and study at the British School at Rome for six months. It was at the British School that this study matured, and I cannot imagine how this project would have turned out without my sojourn in Rome. Thirdly, I am incredibly thankful to Prof Richard Miles, and to Dr Jelle Stoop, my supervisors without whom this project would not be possible. -

Encyclopédie Berbère, 9 | 1991 Bavares 2
Encyclopédie berbère 9 | 1991 9 | Baal – Ben Yasla Bavares (Babares – Baveres) G. Camps Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/2552 DOI : 10.4000/encyclopedieberbere.2552 ISSN : 2262-7197 Éditeur Peeters Publishers Édition imprimée Date de publication : 1 avril 1991 Pagination : 1394-1399 ISBN : 2-85744-509-1 ISSN : 1015-7344 Référence électronique G. Camps, « Bavares », Encyclopédie berbère [En ligne], 9 | 1991, document B48, mis en ligne le 01 mars 2013, consulté le 24 septembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/2552 ; DOI : https://doi.org/10.4000/encyclopedieberbere.2552 Ce document a été généré automatiquement le 24 septembre 2020. © Tous droits réservés Bavares 1 Bavares (Babares – Baveres) G. Camps 1 Peuples de Maurétanie Césarienne qui nous sont connus par une série de textes et d’inscriptions des IIIe, IVe et Ve siècles et qui furent présentés par les uns comme des nomades, et par d’autres comme des montagnards sédentaires. 2 Les Bavares sont mentionnés pour la première fois dans une dédicace de Volubilis relatant une conférence entre un prolégat (Furius Celsus ?) et un « princeps gentis Bavarum et Baquatum ». Cette inscription date du règne d’Alexandre Sévère (222-235). Les Baquates* étant localisés dans l’est de la Maurétanie Tingitane, vraisemblablement dans la trouée de Taza et le Rif oriental, les Bavares sont leurs voisins de Maurétanie Césarienne. Julius Honorius (Riese, Geographi latini min., A, p. 53) précise que le fleuve Malva (Moulouya) coule entre Bacuates (= Baquates) et Barbares (= Bavares). Dans un autre passage (A, p. 54) le même auteur cite les Barbares (= Bavares), dans le Dahra, et les Salamaggenites dans lesquels il faut retrouver les Macénites du Moyen Atlas dont le nom fut associé, à la suite d’une lecture erronée de la carte, à celui du fleuve Sala. -

Il Nordafrica E I Nordafricani Elementi Di Storia, Lingue E Letterature
Vermondo Brugnatelli Il Nordafrica e i Nordafricani Elementi di Storia, Lingue e Letterature Appunti per la parte generale del corso di Lingue e Letterature del Nordafrica 2009-2010 Università degli Studi di Milano-Bicocca Le immagini che illustrano la presente dispensa sono reperibili on- line alla pagina: http://www.brugnatelli.net/vermondo/didattica/bicocca/immagini © Vermondo Brugnatelli 2010 Foto in copertina: Un tipico disegno ornamentale tradizionale del Nordafrica (dettaglio da un antico portone ligneo - Marocco) PROLUSIONE White Athena, ovvero: il vuoto epistemologico del Nordafrica. 1. African = Black? Black Athena, “Atena nera" è il titolo che nel 1987 Martin Bernal diede a un libro, destinato a suscitare accesi dibattiti, in cui si proponeva di denunciare il mito eurocentrico della civiltà classica, facendo presente il grande debito che la civiltà occidentale ha nei confronti delle più antiche civiltà del Vicino Oriente antico, in particolare quelle dell'Egitto e della Mesopotamia. Il titolo-shock deriva dalla consapevolezza (diffusa già presso gli antichi) di una identificazione della dea greca Atena con la dea Neith egiziana. Non intendo qui soffermarmi sulla validità delle tesi di Bernal. Quello che mi preme sottolineare è la disinvoltura con cui questo autore (e con lui più o meno tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito sul libro, sia favorevoli sia contrari alle sue posizioni) considera "nero" come sinonimo di "africano". Né gli antichi egizi né i popoli mesopotamici dell'antichità erano di pelle "nera". E neppure tutti i popoli del Nordafrica dall'Egitto fino all'Atlantico. Al massimo saranno stati bruni di capelli e con la carnagione facile all'abbronzatura, come tutti i popoli intorno al Mediterraneo. -
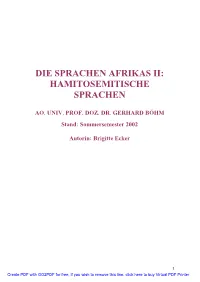
Die Sprachen Afrikas Ii: Hamitosemitische Sprachen
DIE SPRACHEN AFRIKAS II: HAMITOSEMITISCHE SPRACHEN AO. UNIV. PROF. DOZ. DR. GERHARD BÖHM Stand: Sommersemester 2002 Autorin: Brigitte Ecker 1 Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer Vorlesung 8.3. Hamitosemitische Sprachen sind eine genealogische Einheit von Sprachen den indogermanischen entsprechend Eine Gruppe von Sprachen, von der man annehmen darf, dass sie eine gemeinsame Grundsprache hatten Verwandtschaft der Sprachen zu verfolgen, Grundsprache hypothetisch zu rekonstruieren FORSCHUNGSGESCHICHTE Beschäftigung mit semitischen Sprachen ist älter als die Sprachwissenschaft in engerem Sinn Beginn in der Zeit der Reformation Anfang 16. Jh. mit dem Studium des Hebräischen (Bibelwissenschaft AT-Text) Bahnbrechend: Hebräisch im Bildungsgut Latein: bereits Griechisch: seit Humanismus Besonders Johannes Reuchlin, deutscher Humanist aus dem alemannischen Südwestdeutschland, ohne Beziehung zur Reformation, es ging ihm einfach um die Sprache, intensive Studien und Kontakt zu jüdischen Gelehrten, dadurch Grundlagen des biblischen Hebräisch kennen gelernt und ausführlich dargelegt, fasziniert vom Aufbau der Sprache, der anders war als der des Lateinischen und Griechischen Spätere Studien durch lutherische und calvinistische Bibelwissenschaftler, Anschluss an die jüdische vergleichende Methode Jüdische Gelehrte griffen bereits auf das Arabische und Aramäische zurück, vom Bekannten wurde auf das Unbekannte geschlossen, dies führte zu mehrsprachigen Wörterverzeichnissen Latein – Hebräisch – Arabisch – Aramäisch – Äthiopisch Anfang des 16. Jahrhunderts Gesandtschaft äthiopischer Mönche nach Rom, damals wurde Äthiopien von der islamischen Macht Adal (Zentrum Harar) und den Oromo (Kriegszüge im gesamten Gebiet), daher wurde Verbindung zum christlichen Portugal gesucht. Mitte des 15. Jahrhunderts Konzil von Florenz: Wiederherstellung der Union lateinische – griechische Kirche, da der Kaiser von Konstantinopel auf westliche Unterstützung hoffte, die Union wurde nie realisiert. -

The Grand Strategy of the Roman Empire from the First Century CE to the Third
The Grand Strategy of the Roman Empire From the First Century CE to the Third REVISED AND UPDATED EDITION Edward N. Luttwak |( >1111 ! I • 'i >( II! I imriMlx I ’less © 1976. ' 979i 2016 Johns Hopkins University Press All rights reserved. Published 2016 Printed in the United States of America on acid-free paper 98765432 1 Johns Hopkins University Press 2715 North Charles Street Baltimore, Maryland 21218-4363 www.press, jhu.edu Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Luttwak, Edward, author. Title: The grand strategy of the Roman Empire : from the first century CE to the third / Edward N. Luttwak. Description: Revised and updated edition. I Baltimore .- Johns' Hopkins University Press, 2016. I Includes bibliographical references and index. Identifiers: LCCN 2015030270I ISBN 9781421419442 (hardback) I ISBN 9781421419459 (paperback) I ISBN 9781421419466 (electronic) Subjects: LCSII: Rome—Army. I Strategy. I Military history, Ancient. I BISAC: HISTORY / Ancient / General. I HISTORY / Military / Strategy. Classification: LCC U35 .L8 2016 I DDC 355/033537—dc23 LC record available at http://lccn.l0c.g0v/2015030270 A catalog record for this book is available from the British Library. Special discounts are available for bulk purchases of this book. For more information, please contact Special Sales at pio-pi6-6p^6 or speaalsales®press .jhu.edu. Johns Hopkins University Press uses environmentally friendly book materials, including recycled text paper that is composed of at least 30 percent post-consumer waste, whenever possible. -

The Roman Army, 31 BC–AD 337
The Roman Army, 31 BC–AD 337 The Roman imperial army was unrivalled until recent times in its professional structure, efficient training, detailed organization, and ordnance support. It was remarkable in an age of poor communications and limited technological advance. The army sustained a great empire militarily and politically. First, its skill and success ensured Rome’s domination, and second the loyalty of the troops ensured the political survival of the emperors, who sought to preserve the fabric of government and make it work. The army was therefore a vital element in the subsequent development of Western Civilization. The large number of soldiers and their associated dependants meant that they had significant impact socially, economically, and culturally on the settlements that grew up round the camps and on some of the communitites where they settled after discharge. The privileges of the soldiers set them apart from other men of their social class, and the enhanced position of veterans established them as a very important group in their own right, an integral part of the whole phenomenon of Roman ‘government’. The study of the Roman army therefore embraces not only military but also political, social and economic history. This source book collects literary and epigraphic material, and papyri and coins which illustrate the varied aspects of army life both at war and at peace, and it takes account of evidence made available by recent archaeological investigations in many parts of the empire. Subjects covered include training, officers, the role of the emperor, fighting, community life, politics, and veterans. The introductions to each section and the linking passages provide a narrative structure and explain difficulties of the source material. -

Africa and Africans Brent D. Shaw
Princeton/Stanford Working Papers in Classics Who Are You? Africa and Africans Version 1.3 September 2011 Brent D. Shaw Princeton University Abstract: This is the third revised version of a chapter that is being prepared for the Wiley-Blackwell Companion to Ethnicity in the Ancient Mediterranean. © Brent D. [email protected] 2 Who Are You? Africa and Africans Brent D. Shaw In a letter written to his former teacher from the city of Madauros, the Christian bishop Augustine of Hippo addressed the rhetor Maximus by saying, ‘well now, as one African writing to another African, and since we are both from Africa...’ (Aug. Ep. 17.2 = CCL 31: 41; 390 CE). His deliberate seeking of common ground in being ‘African’ was, it should be confessed, a rhetorical gambit. It was a powerful ploy because the identity to which appeal was made was a strong one of real substance. Not only among Christians like Augustine, but also among non-Christian interlocutors of the time like Maximus, being African had become an identity that they shared in common. How this came to be was the result of a long process of changes and responses. As late as the first century CE, no persons of Punic background, or any indigenous inhabitants of the land, or any Italian, Etruscan, or Greek settlers living in the region that we today call North Africa ever thought of themselves as ‘African,’ even if the matrix for this new identity was beginning to be formed all around them. The process of creating the new identity followed a path that ethnic labelling had often travelled in the past.