Guarda Dentro
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Liechtensteiner Volkblatt Vom 6. Mai 2021
DONNERSTAG 6. MAI 2021 | Inland|11 Rechtstipp Auch medizinische Die Zweithöchsten haben es in sich Gutachten sind Einblicke Der Extremberg- anfechtbar steiger Hans Kammerlander bezwang die höchsten Berge der Welt. Im TAK berichtete der Südtiroler über sein Pro- jekt Seven «Second Summits». uch er ist älter geworden. In jungen Jahren gerade- In seinem Vor- REINHARD PITSCHMANN zu klettersüchtig, seien al- trag nahm der lein die hohen Berge sein Berg steiger Beat RECHTSANWALT, A Ziel gewesen, sagte Kammerlander. Kammerlander LIECHTENSTEIN / ÖSTERREICH Heute gelte seine Aufmerksamkeit am Dienstag die vermehrt auch den Kulturen der Besucher mit auf er Oberste Gerichtshof hat in Länder, den Menschen und ihrer eine malerische und einer Entscheidung klarge- Lebensweise, der Natur, den faszi- spannende Reise stellt, dass ärztliche Unterla- nierenden Landschaften, die er für rund um die Erde. Dgen/Gutachten zwingend ei- seine Touren bereiste. (Foto: Paul Trummer) ne zuverlässige Beurteilung des streiti- gen Rechtsanspruches gestatten müs- Weniger «Bergsteiger-Rummel» den zweithöchsten Bergen auch we- Ojos del Salado (6893 m) in der ar- werden, was den Bergsteiger nicht sen, in dem für die Rechtsanwender Vor Jahren entschloss er sich, nach- niger «Bergsteiger-Rummel». Die gentinischen Atacamawüste, am von weiteren Anläufen in den Folge- nachvollziehbar und schlüssig der Ver- dem er zusammen mit Reinhold höchsten Gipfel aller sieben Konti- Mount Logan (5956 m) in Nordame- jahren abzuhalten vermochte. Den lauf des Gesundheitszustandes der Messner 7 der 14 Achttausender be- nente seien zur «Katalogware» ver- rika, am Gora Dyckh Tau (5202 m) in Mount Logan in Nordamerika be- versicherten Person dargestellt wird. stiegen hatte, die jeweils zweithöchs- kommen, so Kammerlander. -

Auf Allen Gipfeln
Szene Sport FUSSBALL „Schlechtere Werte“ 320 Michael Fuchs, 41, Torwart - D P Bergsteiger A trainer der deutschen Frauen- D / Z T Nationalmannschaft, über R E P erklommen P die Leistungen der Torhüte - I N K rinnen bei der WM bereits die „Seven Summits“; die „Seven Second SPIEGEL: Der englischen Torfrau Karen Summits“ hat noch Bardsley und der Japanerin Ayumi keiner geschafft. Kaihori unterliefen bei der WM schwe - re Fehler, die zu Gegentreffern führ - ten. Trügt der Eindruck, oder fehlt vie - len Torhüterinnen im Vergleich zu den Feldspielerinnen das Niveau? Fuchs: Frauenfußball ist ein junger Sport, der Ausbildung der Torhüterin - nen wird noch zu wenig Beachtung ge - R E schenkt. 2007 wurde ich der erste D N A hauptamtliche Torwarttrainer der Na - L R E tionalmannschaft. Andere Teams, die M M A K Kammerlander auf dem Mount Logan in Kanada erst auf dem Sprung in die Weltspitze O R Ü sind, vernachlässi - B gen die Schulung der Torhüterinnen bis - BERGSTEIGEN her völlig. SPIEGEL: Welchen Einfluss haben ge - Auf allen Gipfeln schlechtsspezifische Unterschiede? er Südtiroler Hans Kammerlander will noch in diesem Jahr als erster Mensch Fuchs: Torfrauen sind die „Seven Second Summits“ bezwingen, die zweithöchsten Gipfel jedes G D I N kleiner als ihre Erdteils. Im April bestieg Kammerlander den 4730 Meter hohen Puncak Trikora Ö K D männlichen Kolle - in Indonesien, nun fehlt ihm nur noch der Mount Tyree (4852 Meter), der Berg N R E B gen und haben bei liegt in der Antarktis. Weil Kammerlander, 54, kaum Informationen über den Bardsley der Schnellkraft und Berg hat, will er ihn vor dem Aufstieg mehrmals mit dem Flugzeug umrunden, der Sprungkraft et - um die beste Route zu finden. -

The American Antarctic Mountaineering Expedition Are Vinson Massif (1), Mount Shinn (2), Mount Tyree (3), and Mount Gardner (4)
.' S S \ Ilk 'fr 5 5 1• -Wqx•x"]1Z1"Uavy"fx{"]1Z1"Nnxuxprlau"Zu{vny. Oblique aerial photographic view of part of the Sentinel Range. Four of the mountains climbed by the American Antarctic Mountaineering Expedition are Vinson Massif (1), Mount Shinn (2), Mount Tyree (3), and Mount Gardner (4). Mount Os- tenso and Long Gables, also climbed, are among the peaks farther north. tica. Although tentative plans were made to answer The American Antarctic the challenge, it was not until 1966 that those plans began to materialize. In November of that Mountaineering Expedition year, the National Geographic Society agreed to provide major financial support for the undertaking, and the Office of Antarctic Programs of the Na- SAMUEL C. SILVERSTEIN* tional Science Foundation, in view of the proven Rockefeller University capability, national representation, and scientific New York, N.Y. aims of the group, arranged with the Department of Defense for the U.S. Naval Support Force, A Navy LC-130 Hercules circled over the lower Antarctica, to provide the logistics required. On slopes of the Sentinel Range, then descended, touched December 3, the climbing party, called the Ameri- its skis to the snow, and glided to a stop near 10 can Antarctic Mountaineering Expedition, assem- waiting mountaineers and their equipment. Twenty- bled in Los Angeles to prepare for the unprece- five miles to the east, the 16,860-foot-high summit dented undertaking. of Vinson Massif, highest mountain in Antarctica, glistened above a wreath of gray cloud. Nearby The Members were Mount Tyree, 16,250 feet, second highest The expedition consisted of 10 members selected mountain on the Continent; Mount Shinn, about 16,- by the American Alpine Club. -

Spring Outfitter 2012 FYI Mechanical - 'Clean', Without Phototags
The original expediTion ouTfiTTer Spring Outfitter 2012 FYI Mechanical - 'clean', without phototags 01/13/12_11:01AM FREE SHIPPING Catalog in-home 2/6/20 12 On yOur purchase Of $75 Or mOre. See inSide for detailS. 2012 OuTfITTEr BOOK: volume 2, no. 1 CD12_1_048A_001.pdf ThE OuTfITTEr BOOK + EXPEDITION TravEl: JOrDaN uPrIsINg + ThE ThIrD DIscIPlINE Of guIDINg sPrINg + KayaK BrazIl: amazONIaN WaTErfalls + JaKE NOrTON TaKEs ON challENgE 21 NO CHANGES CAN BE MADE AT THIS TIME. fEaTurED INTErvIEWs: + caroline george + dave HaHn + melissa arnot + ben stookesberry For changes to the distribution list, please call Mary Ward-Smith at extension 6472. Color is not accurate and is to be used as a guide only. The pages can be viewed by clicking on the page number desired in the Bookmark column. Womens 6 - 19, 24/25, 28/29, 36/37, 42/43, 44, 48 Field & Gear 14/15, 20 - 25, 30/31, 34 - 37, 40 - 43 Mens 6 - 21, 28 - 31, 34/35, 40/41, 45, 48 Kids 46/47 Marketing Components At the end PRSRT STD Prices expire 4/29/12 U.S. POSTAGE PO Box 7001, Groveport, OH 43125 PAID EDDIE BAUER Printed in USA Caring for the environment is one of our core values. The paper in this catalog is certified to contain fiber from responsibly managed sources. Please pass this catalog on or recycle it. THE MICROTHERM™ DOWN VEST NEW CORE FOCUS FROM OUR LIGHTEST, WARMEST LAYER EVER. 800 DOWN FILL MICROTHERM DOWN VEST “THE LIGHTEST, WARMEST THINGS ON EARTH.”® Incredibly thin and lightweight, but with all the insulating warmth of 800 fill Premium European Goose Down in a streamlined, non-puffy silhouette. -

Seven Second Summits
Hans Kammerlander Seven Second Summits Hans Kammerlander mit Walther Lücker Über Berge um die Welt Mit 77 farbigen Abbildungen und einer Karte MALIK Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.malik.de Von Hans Kammerlander liegen bei Malik und Piper außerdem vor: Bergsüchtig Abstieg zum Erfolg Unten und oben – Berggeschichten Am seidenen Faden – K2 und andere Grenzerfahrungen Zurück nach Morgen – Augenblicke an den 14 Achttausendern ISBN 978-3-89029-427-8 © Piper Verlag GmbH, München 2012 2. Auflage 2013 Fotos: Hans Kammerlander Karte: Eckehard Radehose, Schliersee Satz: Kösel, Krugzell Druck und Bindung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm Printed in Germany Inhalt Prolog Das Abenteuer beginnt zwei Meter abseits der ausgetrampelten Pfade 7 Asien – K2 Ein Bilderbuchberg Auf dem Gipfel mischte sich Wehmut in die Freude, und ein neues Ziel nahm Gestalt an 23 Südamerika – Ojos del Salado Wüstensand und ein Kraterloch In der Atacama erklärte mir ein Freund, dass man Bilder nicht unbedingt in einem Album aufbewahren muss 52 Afrika – Mount Kenia Ein kleines Wetterfenster genügte Winterliche Besteigung unter Afrikas Schneehimmel 76 Nordamerika – Mount Logan Über Nacht öffnete sich der Gletscher Im Grenzgebiet zwischen Alaska und Kanada ist der Beruf des Piloten eine Kunst 100 Europa – Dychtau Ein schier endlos langer Tag an einem großen Berg Im Kaukasus lernt man Härte, Leidensfähigkeit und wuchtige Berge kennen 134 Australien-Ozeanien – Puncak Trikora Dauerhaft nass und jede Menge Spaß Ein Berg, ein Koch, zerschlissene Gummistiefel, eine Erst- und eine Zweitbegehung 167 Antarktis – Mount Tyree Spannung in vielerlei Hinsicht In der Antarktis zwischen Daunentouristen, großer Abgeschiedenheit und einer Menge Zwist 199 Epilog Über Berge um die Welt Gefangen zwischen Schlagzeilen – die Besteigung des Mount Logan 238 Prolog Das Abenteuer beginnt zwei Meter abseits der ausgetrampelten Pfade Vor rund sechzig Millionen Jahren zerfiel unsere Erdkruste. -

„Die Geschichte Der Grossen Alpinisten“ | “La Saga Dei Grandi Alpinisti” Filmische Kurzporträts | Rassegna Cinematografica S I L a S
Swiss Mountain Film Festival 4. INTERNATIONALES BERGFILMFESTIVAL Kongress- und Kulturzentrum RONDO - PONTRESINA - ENGADIN | 10.-16. AUGUST 2015 | 20.45 Uhr Reinhold Messner Kurt Diemberger Karl Unterkircher Hans Kammerlander Walter Bonatti Simone Moro „Die Geschichte der grossen Alpinisten“ | “La saga dei grandi alpinisti” filmische Kurzporträts | rassegna cinematografica s i l a S o n a m o R y b o t o h P - ” t h g i n y b a n i s e r t n o P “ Con il patrocinio di www.eda.admin.ch/milano www.ccsi.it www.myswitzerland.com www.alpinesmuseum.ch www.pontresina.ch/museumalpin www.regione.lombardia.it Sac sektion Bernina www.bergsteiger-pontresina.ch www.mountainwilderness.it www.hotel-rosatsch.ch www.engadinerpost.ch www.suedostschweiz.ch www.affaritaliani.it www.sac-bernina.ch 2I saluti al Festival | Die Grussbotschaften IL SALUTO DI ROBERTO GUALDI IL SALUTO DI JAN STEINER Presidente del Festival/Festivalpr äsident Direzione operativa Pontresina Turismo/Geschäftsführer Pontresina Tourismus Grussbotschaft von Roberto Gualdi Grussbotschaft von JAN STEINER Siamo pronti a presentare la quarta edizione del Festival Internazionale del Pontresina Turismo porge un cordiale benvenuto allo Swiss Mountain Cinema di Montagna, “Swiss Mountain Film Festival”, un Festival che Film Festival. promuove le montagne del mondo partendo dalla splendida cittadina di Pon - Pontresina, patria delle vette più alte nelle Alpi orientali, si rallegra di tresina, in Engadina. ospitare il Festival del film. Saranno sette serate di cinema con i film dedicati ai grandi nomi dell’alpinismo La stupenda posizione fa di Pontresina la cornice perfetta per accogliere mondiale abbinati alle opere del concorso ufficiale. -
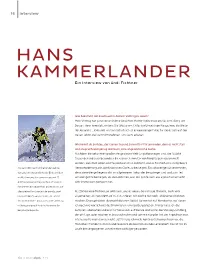
HANS KAMMERLANDER Ein Interview Von Andi Fichtner
16 interview HANS KAMMERLANDER Ein Interview von Andi Fichtner Was bekommt der Zuschauer in deinem Vortrag zu sehen? Mein Vortrag hat ganz verschiedene Gesichter. Harter Alpinismus am K2, dem »Berg der Berge«, dann komplett anders: Die Wüste von Chile, der Urwald von Neuguinea, die Weite der Antarktis … Kulturell und landschaftlich ist es eine riesige Fülle, für die es sich auf den Reisen lohnt, viel Zeit mitzunehmen, um sie zu erleben. Wie kamst du zur Idee, der »Seven Second Summits«? Für jemanden, dem es nicht steil und anspruchsvoll genug sein kann, eine ungewöhnliche Sache. Nachdem die bekannten großen Berge dieser Welt längst bestiegen sind, die 14 Acht- tausender und auch besonders die »Seven Summits« von Bergsteigern gesammelt werden, dass fast schon ein Massentourismus entsteht, war es für mich eine viel größere Als der Südtiroler Kammerlander den K2, Herausforderung, die zweithöchsten Gipfel zu besteigen. Ein schwieriges Unternehmen, den zweithöchsten Gipfel der Erde und den denn diese Berge liegen nicht im allgemeinen Fokus der Bergsteiger und sind zum Teil wohl schwierigsten seiner insgesamt 13 schwieriger zu besteigen, als die Höchsten, was das ganze auch aus alpinistischer Sicht Achttausender bestieg, reifte dort oben in sehr interessant gemacht hat. ihm bereits ein neuer Plan. Er beschloss, auf allen sieben Kontinenten die jeweils zweit- Als 2008 meine Tochter zur Welt kam, war es genau der richtige Moment, mich vom höchsten Gipfel zu besteigen, die „Seven allgemeinen alpinen Wettlauf zu distanzieren. Ich wollte nur noch schöne Geschichten Second Summits“. Anlässlich seines Vortrags machen. Dazu gehörten die zweithöchsten Gipfel. So kam ich auf Kontinente, auf denen in Stuttgart sprach Andi Fichtner mit der ich noch nie war. -

Customer Magazine INSIDE 01/2014
HIGHLIGHTS OF THIS ISSUE ELEGANT AND SOPHISTICATED. THE NEW NET-BOX. INSIDE 01/2014 Recognising the needs of our customers and developing the right solutions is the basis of our success. 2|3 INSIDE 01/2014 „WE KNOW WHERE YOUR ELECTRONICS ARE IN THE BEST HANDS IN FUTURE.” EDITORIAL DEAR READERS, I am very pleased to be able to present the latest edition of enclosures. This is the ideal solution for equipment with the OKW customer magazine INSIDE, with plenty of interesting reduced displays that can be interconnected quickly information from our company. and easily via a network. I am sure you will agree: successful development requires We hope you enjoy reading our magazine. foresight and commitment. For this reason, we are constantly in search of innovative developments and technical progress to ensure that your finished product is ideally tuned to the applications of your customers. While we are on the subject of applications: the main focus (from page 6 to 19) in this edition is on the area of „Building services systems“ and the relevant products by OKW Gehäusesysteme, in particular the new NET-BOX range of Dipl.-Ing. Christoph Schneider, Managing Director 4|5 INSIDE 01/2014 „OKW ENCLOSURES ARE AT HOME ALL OVER THE WORLD.” In OKW cases, your products become attractive eye-catchers in the direct environment of the living and working world. INDEX 2 EDITORIAL 18 YOU CAN FIND US HERE Exhibition Light + Building, Hall 9.0, Booth B64 MAIN FOCUS „BUILDING SERVICES SYSTEMS” 20 EXCELLENT DESIGN iF design award for enclosure series BLOB 8 IDEAL FOR MODERN BUILDING SERVICES SYSTEMS 22 NEW PRODUCTS/ENHANCEMENTS Nowadays, building automation systems are planned and designed in such a way that they meet the indi- 24 2PCS PERSONAL PROTECTION SYSTEM vidual requirements of users. -

Foreign Rights List Spring 2018
Foreign Rights List Spring 2018 FICTION Novels ▪ 2 Crime/Thriller ▪ 9 Fantasy/ Sci-Fi ▪ 15 NON-FICTION ▪ 19 Exclusive Agents ▪ 35 Foreign Rights Contacts: Ms. Elisabeth Wiedemann ([email protected]) ▪ Mr. Sven Diedrich (sven.diedrich@ piper.de) Piper Verlag GmbH ▪ Georgenstr. 4 ▪ 80799 München, Germany ▪ Tel.: +49 (0)89 38 18 01-735 ▪ www.piper.de FICTION ▪ NOVEL 2 Gunnar Kaiser Beneath the Skin The breathtaking story of a book-loving killer About the Book ▪ New York during the final sum- mer of the nineteen sixties: literature student Jona- than Rosen has just met book-loving dandy Josef Eisenstein. Through the mysterious older man, the inexperienced boy discovers not only the world of art and the intellect, but also the power of seduction, and it is during those bright summer days that he comes of age. As time passes, Jonathan gradually begins to sus- pect that his mentor is hiding a dark secret, but this suspicion is only confirmed decades later, when he is tracked down in Israel by former FBI agent Sally Goldman – for years, she has been hunting the “Skinner”, a legendary serial killer ... ▪ “Beneath the Skin is a declaration of love to literature and sensibility (but who can really tell them apart?). Just as Patrick Süßkind proved that you can smell the world through words, Beneath the Specifications Skin proves that you can feel it through words, too.“ ▪ Berlin Verlag Hardcover Eléonore Delair, Editorial director Fayard ▪ March 2018 ▪ 528 pages ▪ “Beneath the Skin is the kind of novel you’d ▪ English review available love to move into: magical, beautifully written and ▪ Rights sold to: Italy (Rizzoli) and France uniquely evocative. -

Manuskript Höhenbergsteigen-Traum Oder Albtraum
COPYRIGHT Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt. Es darf ohne Genehmigung nicht verwertet werden. Insbesondere darf es nicht ganz oder teilweise oder in Auszügen abgeschrieben oder in sonstiger Weise vervielfältigt werden. Für Rundfunkzwecke darf das Manuskript nur mit Genehmigung von Deutschlandradio Kultur benutzt werden. Nachspiel am 26.12.2008 Höhenbergsteigen – Traum oder Albtraum? Hintergründe zur Unfallserie an herausragenden Gipfeln Von Ernst Vogt und Andrea Zinnecker 1. Zuspielung: Collage über Musik/Atmo Zitat: „Wir haben unseren Traum erfüllt und alles andere dafür hergegeben.“ O-Ton Kurt Diemberger: O-Ton Reinhold Messner: Es gab viele Leute, Tausende von Leuten, die vor allem auf den Everest wollten, die gesagt haben: Ich zahle alles, wenn ich nur auf den Everest kann. O-Ton Hanspeter Eisendle: Ich will nichtpauschal sagen, dass alles Unfähige sind, aber selbst die Fähigen sind dann in einer kritischen Situation, wenn zu viele am gleichen Ort sind. O-Ton Helga Söll (Nanga-Parbat-Bezwingerin) Kein Berg ist ein Leben wert. Auch einem Fremden hilft man, wenn der in Not ist. Das ist auch den Gipfelerfolg von mir nicht wert, man geht an so einem Menschen nicht vorbei. Musik hoch und aus 2 E: Wie viel Unglück ist selbstverschuldet und wie viel ist dem Restrisiko zuzuschreiben, das beim extremeren Bergsteigen häufig eine Rolle spielt? A: Nicht immer ist der Fall so klar, wie beim Lawinenunglück am Montblanc, das am 24. August eine Gruppe von acht Bergsteigern in den Tod gerissen hat. Karl Gabl, der Präsident des österreichischen Kuratoriums für alpine Sicherheit: 2. Zusp. Karl Gabl „Auslöser für diese Lawine war ein riesiger Serac, also ein Eisturm, mehrer Türme, die zusammengebrochen sind; und der hat dann in Folge ein Schneebrett ausgelöst.“ E: Die acht Alpinisten hatten keine Chance: Sie waren zur falschen Zeit am falschen Ort. -

2008 July Vol 132 No 3
d i TA TAU DELTA INTE RATERNI 1$ .1.. ^ - ONE BROTHER'S DREAM3ECOMES ' i A BREWHOUSe'rEALITY 1 PAGE 74" 1 50 Years is a Long Time to Keep a Promise... 38 generations of college students have. ."Remembered those who followed." You can create a legacy with Delta Tau Delta that will endure through time. we complete our $18 million campaign for Delta Tau Delia W- ^iring the 150th Celebration ofour founding, we want every jl^T^ ^elt to be able to make a legacy building gift. NO HASSLE AND EASY TO ACCESS 1, Just go io www.dcUrouiidatioii.org 2, Click Oil "Planned Giving - Remembering Those Who Follow" 3. Design the gilt that is right for yon ALL YOU NEED TO KNOW Our Website is complete and updated monthly � LEARN how different gifts can provide benefits to you today or in the future for yourself and your loved ones Be a part of one of the � CALCULATE benefits with our online calculator your gift largest Campaigns in the � DETERMINE the right gift and how current tax laws make certain gifts World better for you and your beneficiaries. Fraternity YOU CAN CREATE A BENEVOLENT LEGACYTHAT ENDURES Discover the Benefits We are to with additional information. Feel free lo happy provide you of Giving�and Create contact Ken File at 888-383-1858 or ken.file@dclts,net with any questions� a specific or general�about gift options that best fit your philanthropic and Legacy! financial goals. DELTA TAU DELTA EDUCATIONAL FOUNDATION 10000 Allisonville Road. Fishers. IN 46038 88S-.183-I858 kcn.flkra delts.net vvww,deltfoundation.oro INTERNATIONAL OFFICERS FROM THE Dr.KenneUl U"Rocli" Clinton. -

Binomial Theorem Lecture Notes Pdf
Binomial theorem lecture notes pdf Continue Click on the arrows to change the time. Use arrows to change time. Scale up to see live images! Click to add a point. Click twice to complete. Click to add a point. Click twice to complete. The Zoom Of Earth shows live weather satellite images updated in real time, and the best high-resolution aerial views of Earth in a fast, scalable map. Explore the latest images of storms, wildfires, property and more. Formerly known as Flash Earth. Direct weather images are updated every 10 minutes with NOAA GOES and JMA Himawari-8 satellites, as well as every 15 minutes via EUMETSAT Meteosat satellites. Daily images are provided by NASA's GIBS, part of EOSDIS. NASA-NOAA Suo my NPP satellite as well as MODIS Aqua and Terra provide continuous am images at the local 10:30 a.m. and PM at the local 13:30. Historical images from both Microsoft and Esri. Storm tracks and forecast maps are based on the latest NHC, JTWC and IBTrACS data. Fire hotspots show the sources of high temperature per day using FIRMS data via GIBS. Follow us on Twitter. © 2020 Neave Interactive (en) Disclaimer Privacy Policy Press CTRL and D to bookmark this page zoom in and then click on the map to get StreetView Panorama. Afghanistan Albania Aldin Andorra Angola Antigua and Barbuda Argentina Armenia Australia Australia Azerbaijan Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belgium Belize Benin Bhutan Bolivia Botswana Botswana Brazil Brunei Bulgaria Burkina Faso Cape Verde Cambodia Cameroon Canada Canada Chad Chile China Colombia Comor