Terza Serie (1998)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bl. Mose Tovini Catholic.Net
Bl. Mose Tovini Catholic.net Roman martyrology: In Brescia, Italy, Blessed Mosè Tovini, priest of the diocese of that city (1930). Beatification date: September 17, 2006 by Pope Benedict XVI SHORT BIOGRAPHY Born December 27, 1877 in Cividate Camuno, Brescia, Italy. Eldest of eight children, the son of Eugenio, an accountant, and Domenica Malaguzzi, a teacher. Nephew and god-son of Blessed Giuseppe Tovini. Attended elementary school in Breno, Italy, and was a good student. Moved in with Blessed Giuseppe in Brescia, Italy at age nine to continue his studies. He made his First Communion on November 14, 1886. Went to school in Romano Lombardia, Italy in 1889. Mose began to feel a call to the priesthood, but his father opposed it, and he put off the training. Attended high school in Celana, Bergamo, Italy, but had trouble with city life, and was abused by his fellow students. He returned home, and this time his father agreed with Mose's call to the priesthood. The boy moved back in with his uncle Giuseppe, and studied at the seminary in Brescia. Upon finishing the minor seminary, during which his uncle had died, Mose took off from school and joined the army. His personal piety even impressed his fellow soldiers. He reached the rank of sergeant, was discharged on October 31, 1898, returned home, and resumed his studies for the priesthood. Ordained in Brescia on June 9, 1900 at age 22. Assigned as chaplain of Astrio, Italy. He was soon sent to Rome, Italy to continue his studies, and by 1904 had degrees in mathematics, philosophy, and theology. -

ECHO of MARY Queen of Peace 142
ECHO ECHO OF MARY Queen of peace 142 November-December 1998 - Info Our Lady's message of 25 Sept. 1998: Dear Children, I invite you today to become my witnesses by living the faith of your fathers. My Children, you seek signs and messages and do not see that God, with the rising of the sun each morning, calls you to convert and to return to the path of truth and salvation. You talk much, my Children, but you work little for your conversion. Therefore, convert and begin to live my messages; not with words, but with your lives. Then my Children, you will have the strength to decide for true conversion of the heart. Thank you for responding to my call. Be my Witnesses, and work at Conversion of Heart Our Lady once again speaks of living the faith, and of conversion of heart. Her plea to live the messages is mixed with a reproach for the way we talk too much of and live too little our faith. The message contains an unusual call to become Her witnesses of the faith. The way to do this is to live the faith of our fathers. Faith is accepting with all one's heart and life those promises of the invisible God Who revealed Himself in the person of Jesus Christ. Mary lived in the faith of the fathers, making it Her own. Let us look at Abraham's faith. He had no doubts when he offered in sacrifice his son of the promise, thinking that God is able to raise man even from the dead (cf. -
![2020 Consolidated Non-Financial Statement Pages [I] Link to Websites](https://docslib.b-cdn.net/cover/8136/2020-consolidated-non-financial-statement-pages-i-link-to-websites-1828136.webp)
2020 Consolidated Non-Financial Statement Pages [I] Link to Websites
2020 Consolidated Non-financial Statement in accordance with Legislative Decree No. 254 of 2016 Boards, Management, Auditors BOARD OF DIRECTORS Chairman Gian Maria GROS-PIETRO Deputy Chairperson Paolo Andrea COLOMBO Managing Director and Chief Executive Officer Carlo MESSINA (a) Board Members Franco CERUTI Rossella LOCATELLI Luciano NEBBIA Bruno PICCA Livia POMODORO Maria Alessandra STEFANELLI Guglielmo WEBER Daniele ZAMBONI Maria MAZZARELLA Anna GATTI Andrea SIRONI (1) Fabrizio MOSCA (*) Milena Teresa MOTTA (*) Maria Cristina ZOPPO (*) Alberto Maria PISANI (*) (**) Roberto FRANCHINI (*) (2) MANAGER RESPONSIBLE FOR PREPARING THE COMPANY'S FINANCIAL REPORT Fabrizio DABBENE INDIPENDENT AUDITORS KPMG S.p.A. (a) General Manager (*) Member of the Management Control Committee (**) Chairman of the Management Control Committee (1) Appointed by the Shareholders’ Meeting on 27 April 2020 after co-option by the Board of Directors on 2 December 2019 (2) Appointed by the Shareholders’ Meeting on 27 April 2020 in substitution of resigning Director Corrado Gatti 3 Contents LETTER TO STAKEHOLDERS 6 Combating money laundering 79 Compliance with tax regulations 80 METHODOLOGY 9 Protection of free competition 83 Privacy protection 84 EXECUTIVE SUMMARY 11 Compliance with labour laws 85 Main performance indicators 12 Audits 85 Main actions taken to face the Disputes and fines 86 COVID-19 emergency 23 Sustainability indices, rankings SOCIETY 87 and awards 24 Quality of service and customer satisfaction 92 IDENTITY AND PROFILE 26 Service quality 92 Group Presentation -

TESE Silvana Sobreira De Matos.Pdf
UNIVERDIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SILVANA SOBREIRA DE MATOS A BEATA CHIARA LUCE E AS TRANSFORMAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES NA SANTIDADE CATÓLICA RECIFE 2014 SILVANA SOBREIRA DE MATOS A BEATA CHIARA LUCE E AS TRANSFORMAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES NA SANTIDADE CATÓLICA Tese apresentada ao Curso de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para obtenção do título de Doutora em Antropologia. Orientadora: Profª. Drª. Roberta Bivar Carneiro Campos RECIFE 2014 Catalogação na fonte Bibliotecária Maria Janeide Pereira da Silva, CRB4-1262 M433b Matos, Silvana Sobreira de. A beata Chiara Luce e as transformações e/ou atualizações na santidade católica / Silvana Sobreira de Matos. – 2014. 243 f. : il. ; 30 cm. Orientador: Profª. Drª. Roberta Bivar Carneiro Campos. Tese (doutorado) - Universidade Federal de Pernambuco, CFCH. Programa de Pós-graduação em Antropologia, 2014. Inclui referências e anexos. 1. Antropologia. 2. Catolicismo. 3. Santidade. 4. Juventude. I. Campos, Roberta Bivar Carneiro (Orientadora). II Título. 301 CDD (22. ed.) UFPE (BCFCH2017-201) SILVANA SOBREIRA DE MATOS A BEATA CHIARA LUCE E AS TRANSFORMAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES NA SANTIDADE CATÓLICA Tese apresentada ao Curso de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para obtenção do título de Doutora em Antropologia. Aprovada em 25 / 02 / 2015 Banca Examinadora _____________________________________________ Dra. Roberta Bivar Carneiro Campos Orientadora Universidade Federal de Pernambuco ______________________________________________ Dra. Misia Lins Reesink Universidade Federal de Pernambuco Examinador Interno ______________________________________________ Dr. Bartolomeu Tito Figuerôa de Medeiros Universidade Federal de Pernambuco Examinador Interno _____________________________________________ Dra. -
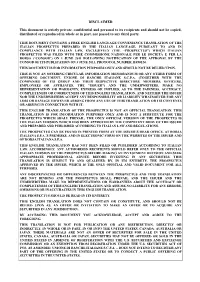
DISCLAIMER This Document Is Strictly Private, Confidential
DISCLAIMER This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. THIS DOCUMENT CONTAINS A FREE ENGLISH LANGUAGE CONVENIENCE TRANSLATION OF THE ITALIAN PROSPECTUS PREPARED IN THE ITALIAN LANGUAGE, PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH ITALIAN LAW, EXCLUSIVELY (THE “PROSPECTUS”) WHICH ITALIAN PROSPECTUS WAS FILED WITH THE COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E PER LA BORSA (“CONSOB”) ON 1 JUNE 2011 FOLLOWING NOTIFICATION OF THE APPROVAL BY THE CONSOB OF ITS PUBLICATION ON 3 JUNE 2011, PROTOCOL NUMBER 11050124. THIS DOCUMENT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND SHOULD NOT BE RELIED UPON. THIS IS NOT AN OFFERING CIRCULAR, INFORMATION MEMORANDUM OR ANY OTHER FORM OF OFFERING DOCUMENT. UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. (TOGETHER WITH THE COMPANIES OF ITS GROUP AND THEIR RESPECTIVE DIRECTORS, MEMBERS, OFFICERS, EMPLOYEES OR AFFILIATES, THE “ISSUER”) AND THE UNDERWRITERS, MAKE NO REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE FAIRNESS, ACCURACY, COMPLETENESS OR CORRECTNESS OF THIS ENGLISH TRANSLATION, AND NEITHER THE ISSUER NOR THE UNDERWRITERS ACCEPT ANY RESPONSIBILITY OR LIABILITY WHATSOEVER FOR ANY LOSS OR DAMAGE HOWEVER ARISING FROM ANY USE OF THIS TRANSLATION OR ITS CONTENTS OR ARISING IN CONNECTION WITH IT. THIS ENGLISH TRANSLATION OF THE PROSPECTUS IS NOT AN OFFICIAL TRANSLATION. THIS TRANSLATION IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A SUBSTITUTE FOR THE PROSPECTUS WHICH SHALL PREVAIL. THE ONLY OFFICIAL VERSION OF THE PROSPECTUS IS THE ITALIAN VERSION WHICH HAS BEEN APPROVED BY THE COMPETENT BODY OF THE ISSUER AND PREPARED AND PUBLISHED ACCORDING TO ITALIAN LAW AND REGULATIONS. -

The Holy See
The Holy See PASTORAL VISIT OF HIS HOLINESS JOHN PAUL II TO CHIAVARI AND BRESCIA (ITALY) (SEPTEMBER 18-20, 1998) ADDRESS OF POPE JOHN PAUL II TO MEMBERS OF THE FAMILY AND SCHOOL APOSTOLATES IN THE CATHEDRAL Sunday, 20 September 1998 Dear Brothers and Sisters, Directors and Leaders of the Family and School Apostolates, 1. During my brief visit to your Church, my meeting with you is particularly significant and gives me great joy today as Brescia commemorates the centenary year of Paul VI's birth and rejoices in the beatification of Giuseppe Tovini, both distinguished sons of your land. They both offer a message precisely about the matters in which you are particularly involved, promotion of the family and education of the young. The new blessed speaks to us by the example of his life. Indeed, he was an exemplary husband, the father of 10 children, who was able to make his family a true “domestic church”, rich in prayer and communion. Then, in his civil role, he distinguished himself as a tireless leader of educational initatives to imbue schools with Christian truth. 2. In a different role, Paul VI also deserves praise for these two noble causes. In his magisterium, both as Archbishop of Milan and as Pastor of the universal Church, he devoted a special place to the family. His concern for this matter was rooted in his own experience of a family marked by great sensitivity to relationships and deep spirituality. The Church in Brescia could not but be influenced by these two figures. Therefore, she does well today to recall them with legitimate pride and to let them infuse new zeal into her pastoral activity, especially in the areas of school and the family. -

Should There Be a Place for Spirituality in Business? Reflections on Spirituality of a Business Leader
MELITA THEOLOGICA David Cortis1 Journal of the Faculty of Theology University of Malta 67/2 (2017): 191-216 Should there be a Place for Spirituality in Business? Reflections on Spirituality of a Business Leader owadays, in the Western world, many people are realising that there is more Nto profits in the economy. In a post-Enron world,2 people have become aware of the importance of ethics in business and the values that are being exercised in the day-to-day leadership. At the same time, spirituality in business and the workplace has increased. In the introduction to their book, Managing as if faith mattered, Alford and Naughton, pointed out that: Ten years ago [in 1991], questions of faith and spirituality seemed, confined to the private realm, discussed publicly only in churches or during retreats. Now, conferences, seminars, and workshops reveal an awakening to the importance of the religious and spiritual dimensions in all realms of life.3 Furthermore, a proliferation of books on this subject; some of which I have read, have and are still being published at a steady pace. These include:The Seven Habits of Highly Effective People; Jesus CEO; Working from the Heart; The Soul of Business; Spirit at Work; Leading with Soul; Redefining the Corporate Soul; 1 David Cortis is an assistant lecturer in moral theology, especially in business ethics, at the Faculty of Theology at the University of Malta. He pursued his studies in commerce, accountancy, and later in theology at the University of Malta and the Pontifical University of Comillas, Madrid. 2 A scandal, revealed in October 2001, eventually led to the largest bankruptcy reorganisation in American history at that time of the Enron Corporation, an American energy company. -

Il Segreto Diabolico En
Franco Adessa The Diabolical Secret of the “Crucifix of Cevo” PAULPAUL VIVI BEATIFIED?BEATIFIED? By Dr. Franco Adessa May 13, 1992 In late summer, Fr. Villa contact- ed the postulator of the cause of Freemasonry wanted her man, beatification of Paul VI and this, Paul VI, on the altars, and thus, a was followed up with an exchange part of the plan was to put the two of letters. Popes – John XXIII and Paul VI Fr. Villa was aware of the fact that – on the altars, so that that the Card. Pietro Palazzini had sent “supernatural” [quality] of Vati- a letter to the Postulator in can II would become apparent. which he named three of the last On May 13, 1992, Card. Ruini, homosexual lovers of Paul VI. President of the CEI and the Card. Palazzini was an authori- Pope’s vicar for Rome, issued an ty in this field, since he possessed edict in which, among other two binders full of documents things, one reads: «We invite all that showed, unequivocally, the individual believers to communi- impure and unnatural vice of cate directly or send to the Paul VI. Diocesan Tribunal of the Vicari- In his last letter, he wrote that the ate of Rome any “news” from Procurator would proceed with the which we can, in some way, ar- cause of beatification. gue against the reputation of Fr. Villa replied that he, then, felt sanctity of the said “Servant of compelled to write a book about God.”» Paul VI. Paul VI. Msgr. Nicolino Sarale, however, It was a demanding job, feverish, sent word to Fr. -

Padre Agostino Gemelli and the Crusade to Rechristianize Italy, 1878–1959: Part One
University of Pennsylvania ScholarlyCommons Publicly Accessible Penn Dissertations 2010 Padre Agostino Gemelli and the crusade to rechristianize Italy, 1878–1959: Part one J. Casey Hammond Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/edissertations Part of the European History Commons, and the History of Religion Commons Recommended Citation Hammond, J. Casey, "Padre Agostino Gemelli and the crusade to rechristianize Italy, 1878–1959: Part one" (2010). Publicly Accessible Penn Dissertations. 3684. https://repository.upenn.edu/edissertations/3684 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/edissertations/3684 For more information, please contact [email protected]. Padre Agostino Gemelli and the crusade to rechristianize Italy, 1878–1959: Part one Abstract Padre Agostino Gemelli (1878-1959) was an outstanding figure in Catholic culture and a shrewd operator on many levels in Italy, especially during the Fascist period. Yet he remains little examined or understood. Scholars tend to judge him solely in light of the Fascist regime and mark him as the archetypical clerical fascist. Gemelli founded the Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan in 1921, the year before Mussolini came to power, in order to form a new leadership class for a future Catholic state. This religiously motivated political goal was intended to supersede the anticlerical Liberal state established by the unifiers of modern Italy in 1860. After Mussolini signed the Lateran Pacts with the Vatican in 1929, Catholicism became the officialeligion r of Italy and Gemelli’s university, under the patronage of Pope Pius XI (1922-1939), became a laboratory for Catholic social policies by means of which the church might bring the Fascist state in line with canon law and papal teachings. -
CQ-TL-Book-HS-Ser2-Book-1-Hot-Dogs-For-The-Homeless-TB.Pdf
INSIDE COVER BLANK TABLE OF CONTENTS Book Theme: WHAT SHOULD I UNDERSTAND IN DEPTH ABOUT MY CATHOLIC FAITH? How to Use the Guidebook 2 PROJECT OVERVIEW 8 WEEKLY ACTIVITIES Week 1 >>> WHAT DOES THE HOLY SPIRIT DO? WHY IS CONFIRMATION IMPORTANT? 12 WHY DOES GOD WANT US TO BE PART OF THE CHURCH? HOW DOES THAT Week 2 >>> 22 WORK? Week 3 >>> HOW SHOULD A CATHOLIC LIVE?HOW DO I KNOW WHAT IS RIGHT FROM WRONG? 36 Week 4 >>> WHAT DO THE FIRST THREE COMMANDMENTS HAVE TO DO WITH MY LIFE? 50 Week 5 >>> WHAT DO THE REST OF THE TEN COMMANDMENTS HAVE TO DO WITH MY LIFE? 60 Week 6 >>> SERVICE PROJECT : HOT DOGS FOR THE HOMELESS 70 Online RESOURCE RECAP 72 This book is meant to be a guide to help you lead your team’s weekly meeting & activities. There is one service project and 6 weeks of activities per book. The final week is meant to be a hands on apostolic service project with your team. Use your team leader guidebook as a workbook where you write in it and plan and prepare your team activities. You will find other helpful things for the activities on your Team Leader online resource center. Each weekly meeting is an opportunity to help your team members discover something new about God, themselves and the world around them. We all have questions in our hearts and Conquest gives you a unique way to work together to discover the answers to those questions. In Conquest, we have a special way to help the boys discover the answers to their questions: EXPERIENCE CONNECT DECIDE 1 HOW to USE this GUIDEBOOK This guidebook is intended for your personal use, the Conquest “teen” team leader, (ideally 2-3 years older than the boys you are leading). -

The Advocate - April 16, 1964 Catholic Church
Seton Hall University eRepository @ Seton Hall The aC tholic Advocate Archives and Special Collections 4-16-1964 The Advocate - April 16, 1964 Catholic Church Follow this and additional works at: https://scholarship.shu.edu/catholic-advocate Part of the Catholic Studies Commons, and the Missions and World Christianity Commons Trend to Evil in The Advocate Films Official Publication of the Archdiocese of Newark, N. J., and Diocese of I’atcrson Vol. 13, No. 17 TIIURSDAY, APRIL Hi, 11161 PRICE: 10 CENTS Cited by U.S. Bishops NEW YORK Good and evil two subjects often treated lightly in the movies got a o thorough going over fro committee of U.S. Bishops in a lengthy review of the movies issued on the 30th anniversary of the Na- tional Legion of Decency. The Bishops found a little of both in modern films, warned against growing ten- dency toward evil, and wound Text, Pages 4. 5 up with a hopeful word on the future of the industry. In its wide-ranging, 6,500- word review published April 15, the U.S. Bishops Committee for Motion Pictures, Radio and Television praised the work of the legion and gave a modest nod to the work of some film makers. AT TIIE SAME time they CARDINAL'S Cardinal AUDIENCE - Franziskus Koenig of rabbis at St. Peter's warned of the efforts College April 9. At left is Rev. of Vienna addresses an audience of ministers Very JUST LIKE CANDY - the thousands priests, and Edward F. S.J. of Among of North Jerseyans who took their second "powerful factions in Holly- Clark, president the university. -

Married Couples
INSPIRING STORIES OF CATHOLIC SAINTS FOR MARRIED COUPLES AGAPÈ BOOK 1 SAINTS FOR CatholicMinistries FAMILIES TODAY BOOKS SERIES DEDICATED TO BUILDING STRONG CHRIST CENTERED FAMILIES After 15 years of teaching Catholic Marriage Preparation courses to engaged couples and offering married enrichment programs, I can say with certainty that as Catholic married couples, we need saintly role models. To see the witness of how other couples have lived their vocation to marriage with holiness and true faith in God, inspires us to do the same. This short book is the first in a series which presents the stories of saints who can inspire us to follow Christ more closely on our path and vocation in life. Some saints did not share the same faith with their spouses and other saints not only shared the faith, but lived it to the fullest. Some were martyrs and others lived the daily martyrdom of ordinary life. Some of the saints had many children and other had none. Each of these couples or married saints comes with a specific God given gift, or virtue, to share with all of us. We hope these stories lift your spirits, inspire you to love God more and have a happier and holier marriages. Christian and Christine Founders of Catholic Marriage Prep www.catholicmarriageprep.com “THE LIFE OF HOLINESS WHICH IS RESPLENDENT IN SO MANY MEMBERS OF THE PEOPLE OF GOD, HUMBLE AND OFTEN UNSEEN, CONSTITUTES THE SIMPLEST AND MOST ATTRACTIVE WAY TO PERCEIVE AT ONCE THE BEAUTY OF TRUTH, THE LIBERATING FORCE OF GOD’S LOVE, AND THE VALUE OF UNCONDITIONAL FIDELITY TO ALL THE DEMANDS OF THE LORD’S LAW, EVEN IN THE MOST DIFFICULT SITUATIONS.” ST JOHN PAUL II Copyright Agape Catholic Ministries.