I Castelli Di Ocre, Ariscola E San Vittorino (L'aquila)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Long-Term Influence of Pre-Unification Borders in Italy
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics de Blasio, Guido; D'Adda, Giovanna Conference Paper Historical Legacy and Policy Effectiveness: the Long- Term Influence of pre-Unification Borders in Italy 54th Congress of the European Regional Science Association: "Regional development & globalisation: Best practices", 26-29 August 2014, St. Petersburg, Russia Provided in Cooperation with: European Regional Science Association (ERSA) Suggested Citation: de Blasio, Guido; D'Adda, Giovanna (2014) : Historical Legacy and Policy Effectiveness: the Long-Term Influence of pre-Unification Borders in Italy, 54th Congress of the European Regional Science Association: "Regional development & globalisation: Best practices", 26-29 August 2014, St. Petersburg, Russia, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/124400 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. -

Protezione Civile Regione Abruzzo
Protezione civile - Regione Abruzzo Sede Operativa Protezione Civile Abruzzo scuola di formazione c/o Reiss Romoli, Via G.Falcone, n.25, L'Aquila. - Centralino : Numeri telefonici: 0862.336579 - 0862.336600 Numero verde: 800860146 - 800861016 - Per la ricerca e l’offerta di alloggi : Sala Operativa Regione Abruzzo Numeri telefonici: 0862318603 - 0862314311 - 0862317085 - 0862312725 E-mail: [email protected] - Per informazioni sul rilevamento dei danni degli immobili : Direzione generale Economato Numero telefonico: 0862412470 - Per informazioni sulla valutazione e il censimento dei danni agli immobili: Numero telefonico: 800 324171 Elenco COM Comuni Telefoni e Fax 1. L'Aquila L'Aquila Tel.: Scuola Materna 085 2950155 Indirizzo: Via Scarfoglio Fax: 0852 950143 E-mail: com1aquila@ protezionecivile.it 085 2950112 0852 950143 2. San Demetrio Acciano Tel.: Scuola Elementare Barisciano 0862 810071 Fagnano Alto 0862 810826 Fontecchio Fossa Fax: Poggio Picenze 0862 810897 Prata D'Ansidonia S. Eusanio Forconese E-mail: San Demetrio ne Vestini com2sandemetrio@ San Pio Delle Camere protezionecivile.it Tione degli Abruzzi Villa S. Angelo 3. Pizzoli Barete Tel: Scuola Elementare Cagnano Amiterno 0862 976629 Campotosto 0862 977015 Capitignano 0862 976143 L'Aquila 0862 976122 Lucoli Montereale E-mail: Pizzoli com3pizzoli@ Scoppito protezionecivile.it Tornimparte 4. Pianola Celano Tel.: Centro sportivo L'Aquila 0862 751535 Ocre 0862 751506 Ovindoli Rocca di Cambio Fax: Rocca di Mezzo 0862 751860 E-mail: com4pianola@ protezionecivile.it 5. Paganica L'Aquila Tel: Campo Sportivo 0862 689420 Fax: 0862 68764 E-mail: com5paganica@ protezionecivile.it 6. Navelli Bussi sul Tirino Tel: Istituto Calascio 0862 959142 Comprensivo Capestrano Scolastico Caporciano Fax: Carapelle 0862 959429 Castel Del Monte Castelvecchio Calvisio E-mail: Collepietro com6navelli@ L'Aquila protezionecivile.it Navelli Ofena San Benedetto in Perillis Santo Stefano di Sessanio Villa S.Lucia Degli Abruzzi 7. -

Supplementary Material of the Earthquake Lights (EQL) of the April 6, 2009 Aquila Earthquake, in Central Italy
Manuscript prepared for Nat. Hazards Earth Syst. Sci. with version 1.3 of the LATEX class copernicus.cls. Date: 22 April 2010 Supplementary material of the earthquake lights (EQL) of the April 6, 2009 Aquila earthquake, in Central Italy. Cristiano Fidani1 1Dipartimento di Fisica, Universita´ di Perugia, Via A. Pascoli, Perugia ITALY What did they remind you of? Questionnaire and Testimonials 9) Did you see sparks or phosphorescence on metal rods on top of buildings or masts? The questionnaire was based on several observations re- 10) Were there electric shocks? If so, please describe: ported in the past. It was used in face-to-face interviews Were they near voltage pylons? without being shown to the witnesses. The questions were Were they near other electrical lines? asked in the same order used here. The questionnaire and a Near the railways? summary of collected testimonials on EQL are reported be- What color were they? low. Were surrounding objects lit up? Phenomena observed before, during and or after the Were there thunderstorms? earthquake. 11) Did they have characteristics of flames or fires? If so, Name: please describe: Date: Were there gas cylinders nearby? Place: Were there pipelines nearby? Did you smell gas? Were there flashes of light and/or brightness of any defi- Were surrounding objects lit up? nite or indefinite form? If yes: 12) Did they have characteristics of phosphorescence or 1) When and where were they spotted? of an aurora? If so, please describe: Were they in motion? At what time and in what direction? 2) How long -

Cities Call for a More Sustainable and Equitable European Future
Cities call for a more sustainable and equitable European future An open letter to the European Council and its Member States Tuesday 30th April 2019, President of the European Council, Heads of States and Governments of the European Union Member States, We, the undersigned mayors and heads of local governments have come together to urge the Heads of States and Governments of the Member States to commit the European Union (EU) and all European institutions to a long-term climate strategy with the objective of reaching net-zero emissions by 2050 – when they meet at the Future of Europe conference in Sibiu, Romania on 9 May, 2019. The urgency of the climate crisis requires immediate action, stepping up our climate ambition and pursuing every effort to keep global temperature rise below 1.5C by mid-century, as evidenced by the Intergovernmental Panel on Climate Change Special Report on Global Warming of 1.5C. Current energy and climate policies in place globally, set the planet on a global warming pathway of 3°C. We are reminded of the inadequacy of our response to climate change, by the thousands of young people demonstrating each week on the streets of European cities - and around the world. We cannot let the status quo jeopardise their future and those of millions of European citizens. We owe it to the next generation to make more ambitious commitments to address climate change at all levels of government and in every aspect of European policy-making. We acknowledge and support the positions of the European Parliament and of the Commission to pursue net-zero emissions as the only viable option for the future of Europe and the world. -

Mappe Interattive Per Promuovere Gli Antichi Castelli Dell’Aquilano
| 1 MAPPE INTERATTIVE PER PROMUOVERE GLI ANTICHI CASTELLI DELL’AQUILANO L’AQUILA – Con la cerimonia di consegna dei pannelli con qrcode per la promozione turistica del territorio dei comuni di Lucoli, Ocre, Pizzoli e San Pio delle Camere coinvolti nel progetto “L’Aquila dei 99 – Castelli narranti”, si è conclusa l’attività che ha visto protagonisti gli studenti dell’Indirizzo Turismo dell’’Istituto “Amedeo d’Aosta”, vincitore del Bando Restart “L’Aquila. Città della memoria e della conoscenza” del Comune dell’Aquila. I pannelli dotati di qrcode, che saranno installati nei comuni che hanno partecipato www.virtuquotidiane.it | 2 all’iniziativa, consentiranno al turista che li visiterà di accedere a una mappa interattiva che segnala luoghi di interesse storico, artistico e architettonico del territorio al quale sono associate immagini e tracce audio realizzate dagli studenti, sotto la guida degli archeologi Alessio Cordisco e Francesca Savini. Si potrà pertanto passeggiare in questi splendidi borghi accompagnati da informazioni sul territorio, la sua storia e i suoi monumenti principali, utilizzando uno smartphone o un tablet. Tutti i contenuti, accessibili attraverso il qrcode, rimandano ad un sito web che fornisce un itinerario turistico che ha per meta ciascuno dei quattro borghi, accomunati dall’aver partecipato alla fondazione della città-territorio di L’Aquila, in un ideale percorso dal contado alla città e dalla città al contado. Sui pannelli è presente inoltre un qrcode che attiva le audio narrazioni realizzate dagli studenti con l’aiuto dei professionisti del museo Maxxi di Roma, Federico Borzelli, Giulia Masini e il regista radiofonico Marco Stefanelli e con il contributo della Camera di Commercio dell’Aquila che ha voluto fornire il proprio apporto alla felice riuscita dell’iniziativa. -

Genio Civile Dell'aquila
GENIO CIVILE DELL’AQUILA Divisione territoriale dei Comuni L’Ufficio Sismica L’Aquila è competente in materia sismica per i seguenti Comuni Acciano Castel del Monte Ocre Sant’Eusanio Forconese Barete Castelvecchio Calvisio Ofena Santo Stefano di Sessanio Barisciano Fagnano Alto Pizzoli Scoppito Cagnano Amiterno Fontecchio Poggio Picenze Tione degli Abruzzi Campotosto Fossa Prata d’Ansidonia Tornimparte Capestrano L’Aquila Rocca di Cambio Villa Santa Lucia Capitignano Lucoli Rocca di Mezzo Villa Sant’Angelo Caporciano Montereale San Demetrio ne’ Vestini Carapelle Calvisio Navelli San Pio delle Camere L’Ufficio Tecnico e Sismica Avezzano è competente in materia sismica e quale Autorità Idraulica per i seguenti Comuni Aielli Cerchio Massa d’Albe Rocca di Botte Avezzano Civita d’Antino Morino San Benedetto dei Marsi Balsorano Civitella Roveto Opi San Vincenzo Valle Roveto Bisegna Cocullo Oricola Sante Marie Canistro Collarmele Ortona dei Marsi Scurcola Marsicana Capistrello Collelongo Ortucchio Tagliacozzo Cappadocia Gioia dei Marsi Ovindoli Trasacco Carsoli Lecce dei Marsi Pereto Villavallelonga Castellafiume Luco dei Marsi Pescasseroli Celano Magliano dei Marsi Pescina L’Ufficio Tecnico e Sismica L’Aquila-Sulmona è competente in materia sismica per i seguenti Comuni Alfedena Castel di Sangro Pacentro Roccaraso Anversa degli Abruzzi Castelvecchio Subequo Pescocostanzo Scanno Ateleta Civitella Alfedena Pettorano sul Gizio Scontrone Barrea Collepietro Pratola Peligna Secinaro Bugnara Corfinio Prezza Sulmona Campo di Giove Gagliano Aterno Raiano -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2011
Ufficio del territorio di L`AQUILA Data: 09/04/2013 Ora: 12.13.48 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2011 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 ALTO ATERNO E BACINO DI CAMPOTOSTO MONTAGNA DI LAQUILA Comuni di: CAMPOTOSTO, CAPITIGNANO, MONTEREALE Comuni di: L`AQUILA, BARETE, CAGNANO AMITERNO, FOSSA, LUCOLI, OCRE, PIZZOLI, S DEMETRIO NE` VESTINI, SANT`EUSANIO FORCONESE, SCOPPITO, TORNIMPARTE, VILLA SANT`ANGELO COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO 1850,00 1380,00 BOSCO D`ALTO FUSTO 5910,00 3460,00 CASTAGNETO DA FRUTTO 3380,00 4680,00 FRUTTETO 13890,00 INCOLTO PRODUTTIVO 530,00 610,00 MANDORLETO 1320,00 NOCETO 4580,00 ORTO IRRIGUO 47190,00 PASCOLO 680,00 930,00 PASCOLO ARBORATO 1010,00 1160,00 PASCOLO CESPUGLIATO 440,00 660,00 PRATO 3440,00 SI SI 6350,00 PRATO ARBORATO 4440,00 9100,00 PRATO IRRIGUO 7580,00 13230,00 Pagina: 1 di 13 Ufficio del territorio di L`AQUILA Data: 09/04/2013 Ora: 12.13.48 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2011 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 ALTO ATERNO E BACINO DI CAMPOTOSTO MONTAGNA DI LAQUILA Comuni di: CAMPOTOSTO, CAPITIGNANO, MONTEREALE Comuni di: L`AQUILA, BARETE, CAGNANO AMITERNO, FOSSA, LUCOLI, OCRE, PIZZOLI, S DEMETRIO NE` VESTINI, SANT`EUSANIO FORCONESE, SCOPPITO, TORNIMPARTE, VILLA SANT`ANGELO COLTURA Valore Sup. -

Biological Anomalies Around the 2009 L'aquila Earthquake
Animals 2013, 3, 693-721; doi:10.3390/ani3030693 OPEN ACCESS animals ISSN 2076-2615 www.mdpi.com/journal/animals Article Biological Anomalies around the 2009 L’Aquila Earthquake Cristiano Fidani Central Italy Electromagnetic Network, 63847 San Procolo, Fermo, Italy; E-Mail: [email protected]; Tel.: +39-0753-4060; Fax: +39-0753-4036 Received: 4 February 2013; in revised form: 30 July 2013 / Accepted: 31 July 2013 / Published: 6 August 2013 Simple Summary: Earthquakes have been seldom associated with reported non-seismic phenomena observed weeks before and after shocks. Non-seismic phenomena are characterized by radio disturbances and light emissions as well as degassing of vast areas near the epicenter with chemical alterations of shallow geospheres (aquifers, soils) and the troposphere. Many animals are sensitive to even the weakest changes in the environment, typically responding with behavioral and physiological changes. A specific questionnaire was developed to collect data on these changes around the time of the 2009 L’Aquila earthquake. Abstract: The April 6, 2009 L’Aquila earthquake was the strongest seismic event to occur in Italy over the last thirty years with a magnitude of M = 6.3. Around the time of the seismic swarm many instruments were operating in Central Italy, even if not dedicated to biological effects associated with the stress field variations, including seismicity. Testimonies were collected using a specific questionnaire immediately after the main shock, including data on earthquake lights, gas leaks, human diseases, and irregular animal behavior. The questionnaire was made up of a sequence of arguments, based upon past historical earthquake observations and compiled over seven months after the main shock. -

Civitella Roveto Aq 45,35 15 3229 4,6 0,33
A.R.T.A. - Agenzia Regionale per la Tutela dellÕAmbiente CIVITELLA ROVETO AQ 45,35 15 3229 4,6 0,33 COCULLO AQ 31,72 28 228 122,8 0,88 COLLELONGO AQ 57,17 5 1540 3,2 0,09 FAGNANO ALTO AQ 24,48 11 454 24,2 0,45 GORIANO SICOLI AQ 21,77 15 622 24,1 0,69 LÕAQUILA AQ 466,96 71 70005 1,0 0,15 LECCE NEI MARSI AQ 65,98 7 1796 3,9 0,11 LUCOLI AQ 109,74 10 956 10,5 0,09 MONTEREALE AQ 104,39 19 2971 6,4 0,18 ORICOLA AQ 18,4 16 948 16,9 0,87 ORTONA DEI MARSI AQ 52,66 4 778 5,1 0,08 OVINDOLI AQ 58,84 16 1234 13,0 0,27 PERETO AQ 41,11 4 711 5,6 0,10 PESCASSEROLI AQ 92,54 11 2267 4,9 0,12 PESCINA AQ 37,51 7 4713 1,5 0,19 PRATOLA PELIGNA AQ 28,27 3 8011 0,4 0,11 PREZZA AQ 19,71 27 1110 24,3 1,37 RAIANO AQ 29,1 3 2972 1,0 0,10 RIVISONDOLI AQ 31,65 1 718 1,4 0,03 ROCCA DI CAMBIO AQ 27,62 11 495 22,2 0,40 ROCCA PIA AQ 44,8 9 210 42,9 0,20 ROCCARASO AQ 49,95 18 1608 11,2 0,36 S. BEN. IN PERIL. AQ 19,01 6 175 34,3 0,32 S. EUSANIO FORCONESE AQ 7,97 3 446 6,7 0,38 SCANNO AQ 134,04 18 2154 8,4 0,13 SCOPPITO AQ 53,04 3 2748 1,1 0,06 SULMONA AQ 58,33 14 25301 0,6 0,24 TIONE ABRUZZI AQ 40,24 6 413 14,5 0,15 TORNIMPARTE AQ 65,87 3 2994 1,0 0,05 TRASACCO AQ 51,41 1 6011 0,2 0,02 VILLALAGO AQ 35,29 3 631 4,8 0,09 ARCHI CH 28,18 10 2362 4,2 0,35 BOMBA CH 18,13 31 978 31,7 1,71 BUCCHIANICO CH 38,05 3 4913 0,6 0,08 CASACANDITELLA CH 12,41 3 1462 2,1 0,24 CHIETI CH 58,63 7 56615 0,1 0,12 FARA S. -

Speciale N. 120 Del 23 Settembre 2016
AnnoAnno XLVI – XLVIN. 120 Speciale (23.09.2016) Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 1 Speciale N. 120 del 23 Settembre 2016 DECRETI DI ESPROPRIO COMUNI DI BARISCIANO - CIVITELLA CASANOVA – FONTECCHIO – OCRE – PRATA D’ANSIDONIA UFFICIO BURA Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it L'AQUILA e-mail: [email protected] Via Leonardo Da Vinci n° 6 Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 Pag. 2 Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XLVI - N. 120 Speciale (23.09.2016) Anno XLVI Anno XLVI – N. 120 Speciale (23.09.2016) Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 3 PARTE II Avvisi, Concorsi, Inserzioni USRA-USRC Decreto di Esproprio n. 40 del 16.08.2016 – Comune di Barisciano ..........................................................................4 Decreto di Esproprio n. 1 del 25.08.2016 – Comune di Civitella Casanova ............................................................10 Decreto di Esproprio n. 1 del 08.08.2016 – Comune di Fontecchio .........................................................................14 Decreto di Esproprio n. 2 del 08.08.2016 – Comune di Fontecchio .........................................................................20 Decreto di Esproprio n. 3 del 08.08.2016 – Comune di Fontecchio .........................................................................27 Decreto di esproprio n. 94 del 09.08.2016 – Comune di Ocre ..................................................................................32 -
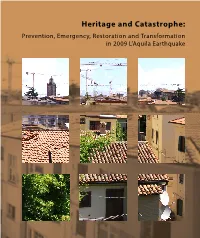
Heritage and Catastrophe: Prevention, Emergency, Restoration and Transformation in 2009 L’Aquila Earthquake This Page Intentionally Left Blank
Heritage and Catastrophe: Prevention, Emergency, Restoration and Transformation in 2009 L’Aquila Earthquake This page intentionally left blank Editors Renato D’Alençon Castrillón, TU Berlin Federico Rota, Reclaiming Heritage e.V. Authors Proofreading Panagiotis Achamnos Mary Stewart Ana Laura Alcántara Castillo Riza Avriansyah Kori Layout Aydeen Azarnezhad Carsten Dittus Pedro Becerra Rodríguez Florencia Carvajal S. Print Rohit Chandragiri ZeitDruck GmbH, Berlin Maged Elgendy Uli Fadilah Siregar Edition Gissu Firoozmand Berlin, February 2015 Pratiksha Gogoi Felipe González González Arief Gunawan Lukas Terrence Hoye Muntari Illyasu Carolina Lunetta Shaimaa Mobasher Marina Moscoso Teixeira Mendonça Adrianto Oktavianus Aditi Poudel Dhakal Daniela Roque Montes Jesús Salcedo Villanueva Aline Simões Ollertz Silva Yi-ting Tsai Siqi Wang ISBN 978-3-98127-695-4 Heritage and Catastrophe: Prevention, Emergency, Restoration and Transformation in 2009 L’Aquila Earthquake Report on the results of a case study research project, 2014 Technische Universität Berlin Urban Management Program Cover View of the Reconstruction in L’Aquila Photo: Riza Avriansyah Kori (Background picture and details) Preface Preface At 3:32 on April 6th, 2009, after a four-month swarm, suburbs and we have started the restoration of the a massive earthquake struck a part of Abruzzo great historical and architectural heritage of historic and the entire city of L’Aquila. A city of over 72,000 centers. inhabitants, the fourth university city of Italy and the second city of Italy for the number of historic The new town of L’Aquila was, however, thought buildings. The earthquake, considering the people of as an important “smart” dimension that will around the basin and students from other cities, have a key role in the national scene. -

ALFONSO FORGIONE Pubblicazioni Scientifiche
ALFONSO FORGIONE pubblicazioni scientifiche Monografie 1) Scudi di frontiera. Dinamiche di conquista e di controllo normanno dell’Abruzzo aquilano. Firenze, All'Insegna del Giglio, 2018 [ISBN: 9788878148550]. Edizione di scavi archeologici 2) Populonia, da San Cerbone ai d’Appiano. Archeologia di una “città debole” della Maremma toscana, a cura di REDI F., FORGIONE, A., Firenze, All'Insegna del Giglio, 2018 [ISBN: 9788878148925]. 3) La chiesa di S. Paolo di Barete. Dallo scavo al restauro; venti secoli di storia riscoperti, a cura di REDI F., FORGIONE A., Firenze, All'Insegna del Giglio, 2014 [ISBN: 9788878146020]. Curatele 4) Stratigrafia degli elevati e nuove tecnologie diagnostiche. Archeologia dell'edilizia storica in situazioni di emergenza, a cura di REDI F., FORGIONE A. ARMILLOTTA F., L’Aquila, Ed. One Group, 2016 [ISBN: 9788889568620]. 5) “Tra Normanni e Plantageneti: al bivio di una cultura complessa”, a cura di L. CORE, A. FORGIONE, L. SPETIA, Atti del II Seminario internazionale di studio (L’Aquila, 2-3 dicembre 2015), Roma, Spolia 2016 [ISSN: 1824-727X]. 6) VI Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, a cura di REDI F., FORGIONE A., (L’Aquila – Sala Carispaq, 12 - 15 settembre 2012), Firenze, All'Insegna del Giglio, 2012 [ISBN: 9788878145436]. Articoli in rivista internazionale di fascia A 7) Il contesto stratigrafico e i sigilli plumbei dell’Area 6 di Campo S. Maria (AQ), in F. REDI, A. FORGIONE, M. PANTALEO, Due sigilli plumbei di papa Gregorio IX dagli scavi di “Campo S. Maria” ad Amiternum (AQ) in «Archeologia Medievale» XLVI, 2019, pp. 357-368 (a firma dell’autore pp. 360-365) [ISSN: 0390-0592; ISBN: 9788878149267].