Anantaratnaprabhava
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

ED132833.Pdf
DOCUMENT RESUME ED 132 833 FL 008 225 AUTHOR Johnson, Dora E.; And Others TITLE Languages of South Asia. A Survey of Materials for the Study of the Uncommonly Taught Languages. INSTITUTION Center for Applied Linguistics, Arlington, Va. SPONS AGENCY Office of Education (DHEW), Washington, D.C. PUB DATE 76 CONTRACT 300-75-0201 NOTE 52p. AVAILABLE FROMCenter for Applied Linguistics, 1611 North Kent Street, Arlington, Virginia 22209 ($3.95 each fascicle: complete set of 8, $26.50) BDRS PRICE MF-$0.83 HC-$3.50 Plus Postage. DESCRIPTORS Adult Education; Afro Asiatic Languages; *Annotated Bibliographies; Bengali; Dialect Studies; Dictionaries; *Dravidian Languages; Gujarati; Hindi; Ind° European Languages; Instructional Materials; Kannada; Kashmiri; Language Instruction; Language Variation; Malayalam; Marathi; Nepali; Panjabi; Reading Materials; Singhalese; Sino Tibetan Languages; Tamil; Telugu; *Uncommonly Taught Languages; Urdu IDENTIFIERS Angami Naga; Ao Naga; Apatani; Assamese; Bangru; Bhili; Bhojpuri; Boro; Brahui; Chakesang Naga; Chepang; Chhatisgarhi; Dafla; Galiong; Garo; Gondi; Gorum; Gurung; Hindustani; *Indo Aryan Languages; Jirel; Juang; Kabui Naga; Kanauri; Khaling; Kham; Kharia; Kolami; Konda; Korku; Kui; Kumauni; Kurukh; Ruwi; Lahnda; Maithili; Mundari Ho; Oraon; Oriya; Parenga; Parji; Pashai; Pengo; Remo; Santali; Shina; Sindhi; Sora; *Tibet° Burman Languages; Tulu ABSTRACT This is an annotated bibliography of basic tools of access for the study_of the uncommonly taught languages of South Asia. It is one of eight fascicles which constitute a revision of "A Provisional Survey of Materials for the Study of the Neglected Languages" (CAI 1969). The emphasis is on materials for the adult learner whose native language is English. Languages are grouped according to the following classifications: Indo-Aryan; Dravidian; Munda; Tibeto-Burman; Mon-Khmer; Burushaski. -
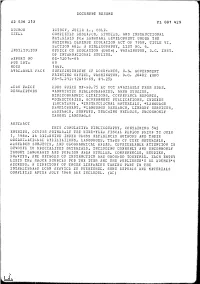
Completed Research, Studies, and Instructional Materials for Language Development Under the National Defense Education Act of 1958, Title VI, Section 602. a Bibliography, List No. 6
DOCUMENT RESUME ED 036 213 FL 001 429 AUTHOR PETROV, JULIA A., COLE. ITTLE COMPLETED BESEAiCH, STUDIES, AND INSTRUCTIONAL MATLEIALS BC R LANGUAGE DEVELOPMENT UNDER THE NATIONAL DEFENSE EDUCATION ACT OF 1958, TITLE VI, SECTION 602.A BIBLIOGRAPHY, LIST NO. 6. INSTITUTION OFFICE CF EDUCATION (DhEW), WASHINGTON, D.C. INST. OF INTERNATIONAL STULIES. REPORT NO 0E-12016-69 PUB LATE 69 NOTE 144P. AVAILABLE FRU. SUPERINTENDENT CF DOCUFENTS, U.S. GOVERNMENT PRINTING OIFICL, WASHINGTON, D.C. 20402 (GPO FS-5.212:12016-69, $1.25) EDRS PRICE EDES PRICE MF-4,0.75 EC NOT AVAILABLE FROM EDRS. DESCRIPTORS *ANNOTATED BIBLIOGRAPHIES, AREA STUDIES, BIBLIOGRAPHIC CITATIONS, CONFERENCE REPORTS, *DIRECTORIES, GOVERNMENT PUELICATIONS, INDEXES (LOCATERS) , *INSTRUCTIONAL MATERIALS, *LANGUAGE DEVELOPMENT, *LANGUAGE RESEARCH, LIBRARY SERVICES, RESEARCH, SURVEYS, TEACdING METHODS, UNCOMMONLY TAUGHT LANGUAGES AESIRACT THIS CUMULATIVE BIBLIOGRAPHY, CONTAINING 542 ENTRIES, CCVIES PRIMAR_LIY THE NINE-YEAR FISCAL PERIOD PRIOR TC JULY 1, 1968. AlEXTENSIVE INDEX ChCSS REFERENCES AUTHORS AND THEIR ORGINILATICNthi AFFILIATIONS, LANGUAGES, TYeES CF TEXT MATERIALS, RESEAECH SUBJECTS, AND GEOGRAPHICAL AREAS. COPSIDELABLE ATTENTION IS DEVOTED TO SPECIALIZED MATERIALS, INCLUDING COMMONLY AND UNCOMMONLY TAUGHT LANGUAGES AND FOREIGN AREA STULlES. CONFERENCES, STUDIES, SURVEYS, AND METHODS CF INSTRUCTION ARE GROUPED TOGETHER. EACH ENTRY LISTS THE MAJCR SOURCES FCR THE ITEM AND THE PUBLISHER'S OR AUTHGE'S ADDRESS.A DIRECTORY OF THOSE LIBRARIES TAKING PART IN THE INTEEIIBRARY LCAN SERVICE IS FURNISHED. SOME REPOEIS AND MATERIALS COMPLETED AMER JULY 1968 ARE INCLUDED. (AT) U.S. DEPARTMENT Of HEALTH,EDUCATION & WELFARE OFFICE OF EDUCATION rwmi 0E-12016-69 REPRODUCED EXACTLY AS RECEIVEDFROM THE THIS DOCUMENT HAS BEEN N POINTS OF VIEW OR OPINIONS PERSON OR ORGANIZATIONORIGINATING IT, O REPRESENT OFFICIAL OFFICE OfEDUCATION STATED DO NOT NECESSARILY r'r\ POSITION OR POLICY. -
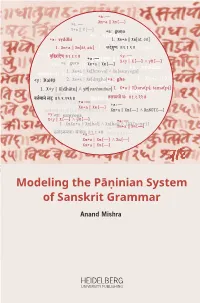
Modeling the Pāṇinian System of Sanskrit Grammar
i i i “more-formulas” — 2019/4/12 — 15:15 — page 1 — #1 i i i i i “more-formulas” — 2019/4/12 — 15:15 — page 1 — #1 i i “more-formulas”i — 2019/4/12 — 15:15 — page 1 — #1 i i i 1 i “rule111” — 2019/4/10 — 15:48 — page 1 — #1 i i +a:— i i i X+a X[ ] ∥ — i i “rule1410” —1 2019/4/10“structure01” — 16:02 — 2019/4/10 — page 1 — — 15:54 #1 — page 1 — #1 i i 1 i i 2 +a: vṛddhi +a:— Xm+ai Xm X+a X[“more-formulas”—] — 2019/4/12 — 15:15 — page 1 — #1 i +a:+a: guṇa1. ∥ [āt, aic] ∥ — i i X+a व1.X[�����ृ Xm+a—चै ]॥१.१.१॥् Xm[at,eṅ] ∥i +a:∥ +a: i +a: vṛddhiguru — अद�े णःु i ॥१.१.२॥ i Xm+a2 Xm[ ] “structure03” — 2019/4/10 — 16:12 — page 1 — #1 i i Xm+a Xm ∥ Xn — 1. Xm+a1. Xm[ā∥t, aic[hrasva]] ∧ [saṃyoga] i ∥ “more-formulas”+a: — 2019/4/12 — 15:15 — page 1 — #1 i Xm+a Xm —+a: guṇa 2 ् 2. ∥ [dīrgha]Xm+a Xm[ ] व�����ृ चै ॥१.१.१॥ 1∥ — i3 1. Xm+a“rule111”Xm[at,eṅ] — 2019/2/8 — 14:44 — page 1 — #1 i +a: vṛddhi��ं लघु ॥१.४.१०॥ सयोगं+a:े ग—�ु ॥१.४.११॥ ��घ∥ � च ॥१.४.१२॥ Xm+a+a:Xm[— ] +a:+a:guṇa+a:Xm+aguruXm अद�े णःु — ॥१.१.२॥ ghai1. -

Introduction*
INTRODUCTION | 1 Introduction* Radhavallabh Tripathi IT is almost an impossible task for a single person to present a comprehensive view on the status and trends of Sanskrit studies in a vast country like India. What is being done here would just appear to be a sketchy account, containing snippets of information, that is to be further corroborated, properly analysed and explored. India is divided into 28 states, 7 union territories and 644 districts. There is hardly any district or region where Sanskrit is not studied in some form or the other. Sanskrit is mentioned in the list of 22 major languages, officially accepted in the Constitution of India, and it is also one of the three languages there, that have an all India character. Teaching, Education and Research In India there are 282 universities as per the records with the AIU, at least 112 of which have postgraduate and research departments of Sanskrit. The number of colleges teaching Sanskrit is around 10,000. “Modern methods” are adopted in these institutions for teaching programmes in Sanskrit. Apart from these universities and colleges, there are 16 Sanskrit universities and a number of Sanskrit pÀÇhaœÀlÀs or Sanskrit * This is an enlarged and revised version of my paper “Sanskrit Studies in India” published in the Bulletin of IASS, 2012. 2 | SIXTY YEARS OF SANSKRIT STUDIES: VOL. 1 colleges where traditional method also known as pÀÇhaœÀlÀ paddhati is practised. As per a recent state-wise survey conducted by the Rashtriya Sanskrit Sansthan (RSkS) the number of Sanskrit pÀÇhaœÀlÀs in Madhya Pradesh is 644, in Chhattisgarh 32, in Uttar Pradesh 1347, Uttarakhand 115, in Karnataka it is 290, in Orissa 433, Punjab 8, Rajasthan 1698, Sikkim 36, Tamil Nadu 55, and in Himachal Pradesh 129, Andhra Pradesh 509, Assam 83, Bihar 717, Goa 4, Gujarat 63, Haryana 74, Jammu & Kashmir 43, Jharkhand 3, Kerala 31, Maharashtra 63, Manipur 8. -

Modeling the Pāṇinian System of Sanskrit Grammar
i i i “script” — 2019/7/11 — 15:06 — page 145 — #155 i Bibliography Sanskrit Texts Aṣṭādhyāyī - Rama Nath Sharma (6 vols.) 1987, 1990, 1995, 1999, 2001 and 2003. - Sumitra M. Katre 1989. - S. D. Joshi and J. A. F. Roodbergen (14 vols.) Baudhāyanaśulbasūtra - S. N. Sen and A. K. Bag 1983. Kāśikāvṛtti - Jaya Shankar Lal Tripathi (5 vols.) 1986a, 1986b, 1986c, 1987, 1988. Mahābhāṣya - Franz Kielhorn (3 vols.) 1885. - S. D. Joshi and J. A. F. Roodbergen 1975. Nirukta - Laksman Sarup (2 vols.) 1962, 1967. Paribhāṣenduśekhara - Charudev Shastri 1973. Paspaśāhnika - S. D. Joshi and J. A. F. Roodbergen 1986. Ṛgveda - Ṛgvedasaṃhitā: Śrīmatsāyanācāryaviracitabhāṣyasametā. (5 vols.) 1933-51, Vaidika Saṃśodhana Maṇḍala, Pune. 145 i i i i i i i “script” — 2019/7/11 — 15:06 — page 146 — #156 i 146 A The Systematic Approach Ṛgvedaprātiśākhya - Virendra Kumar Varma 2007. Siddhāntakaumudī - S. C. Vasu and V. D. Vasu (3 vols.) 1905, 1906, 1907. Vājasaneyiprātiśākhya - Virendra Kumar Varma 1987. Secondary Texts Abhyankar, Kashinath Vasudev (1974). Veda-padapāṭha-carcā. Bhandarkar Oriental Research Institute. Abhyankar, Kashinath Vasudev and Shukla, Jaydev Mohanlal (1977). A dictionary of Sanskrit grammar. Oriental Institute, Baroda. Bharati, Akshar and Chaitanya, Vineet and Sangal, Rajeev (1994). Natural Language Processing: A Paninian Perspective. Prentice-Hall of India, New Delhi. Bare, James Stanton (1980). Phonetics and Phonology in Pāṇini: The System of Features Implicit in the Aṣṭādhyāyī. Department of Linguistics, The Univer- sity of Michigan, Ann Arbor, Michigan. Bhate, Saroja (1987). The meaning-adhikāras in the taddhita section of the Aṣṭādhyāyī: An analysis. In: Indo-Iranian Journal 30 (2), p. 81-92. Brill. -

Both of Thpze Language Areas, Overseas Centers, Summer And
pnrif mIrmT illt cifMI? AL 001 553 ED 023 091 By -Kelley, Gerald B. The Teaching of Hindi-Urdu in the UnitedStates.The State of the Art. Center for Applied Linguistics, Washington,DC.ERIC Clearinghouse forLinguistics. Pub Date Nov 68 Note -24p. EDRS Price MF -5025 HC -SI 30 Language and Area Centers,+Language Instruction,tanguage Descriptors -*Hindi, Instructional Materials, Materials, Programs, Language Role, NationalPrograms, National Surveys,Official Languages, Reference Research Needs, *Urdu, Writing Identifiers -*South Asia The Many Western scholars considerHindi and Urdu as asingle linguistic entity. Muslim author concedes thatin an important sensethisiscorrect." Hindu and inhabitants of the same villagebehave like membersof a single speech community. underscored by However, minor differences inthe phonology, grammar,and lexicon are the differences in the writingsystems, by which prose orpoetry isidentified. Hindi, taught only at the collegelevel in the UnitedStates. which uses Devanagari script, is of this (Exceptions are the Peace Corps programs,no tincluded within the scope Program conducted byBoyd-Bowman from paper, andthe Neglected Languages practices, SUNY. at Buffalo) BecauseHindi has no historyof traditional teaching universities offering coursesin Hindi utilizeoral-aural approaches andemphasize competence in speaking.However, beyond elementarylevel, available materials are very situations applyalso scarce, and notwell suited to studentsof social sciences. These Perso-Arabic script, andfor which there is evenless widely to Urdu, which uses needs of students in available regular instruction.Also discussed in this paper are both of thPze language areas,overseas centers,summerand undergraduate programs, the writingsystems, recommendedteaching materials,research priorities, and the role of these twolanguages in South Asia.(AMM) I CEDUCATIONAL RESOURCESINFORMATION CENTER CLEARINGHOUSE FOR LINGUISTICS WASHINGTON, r". -

Language and Grammar
Language and Grammar It is said that for the great Greek civilization, Geometry was the core science. For the older Indian civilization, Grammar (vyākaraṇa) is the core science. It was the first science to develop because it was needed to maintain and to understand the large body of intellectual texts such as the four knowledge texts, the Vedas, the numerous philosophical Upaniṣads, the prose Brāhmanas, the sociological Dharmaśāstras and the phonetic-linguistic Pratiśākhyas. India has been a knowledge society since the beginning, and for the Indian people jnāna , knowledge, is superior to action ( karma ) and worship ( bhakti ) and is considered as the great purifier. However, another important view is that knowledge and action are equally important. As the Yoga-Vāśiṣṭha notes, for human beings knowledge and action are like the two wings of a bird, both indispensable. As India has always attached the highest value to knowledge and as all knowledge is constituted in language ( jnānam sarvam śabdena bhāsate — Bhartṛhari’s Vākyapadīya ), great value has been attached to the study of language in all its dimensions: sounds, words, sentences, metres, etymology and meaning. As the world’s first text, the Ṛgveda , avers: gaurīrmimāya salilāni takṣaty ... ‘language cuts forms in the ocean of reality ...’ (1.164.41) It is not surprising, given this primacy of language both as object and as means of knowledge, that there is a long-attested tradition of texts and grammarians in India. KTPI Class XII — Language and Grammar 1. Languages of India Indian languages may be grouped into two major language families : Indo-Aryan and Dravidian (s ee the map below) . -

Whatever Happened to Hindustani?
WHATEVER HAPPENED TO HINDUSTANI? LANGUAGE POLITICS IN LATE COLONIAL INDIA A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE DIVISION OF THE UNIVERSITY OF HAWAI‘I AT MĀNOA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN HISTORY DECEMBER 2012 By Richard Forster Thesis Committee: Ned Bertz, Chairperson Peter H. Hoffenberg Miriam Sharma ii Acknowledgements In the course of completing this thesis and other requirements for the MA degree I have become indebted to numerous individuals as well as several institutions for various forms of encouragement and support. Firstly and above all I want to thank Lorinda and Lichen for putting up with me and my often irascible temperament, almost always without complaint, and for supporting me so selflessly that I have been largely free to pursue my studies over the last several years. Without your hard work and many sacrifices it would surely have been impossible for me to spend so much time trying to learn something more about South Asian history and culture, and I am more grateful to both of you than you can know. Similarly, our extended family in both Australia and the USA have been consistently generous, offering both material and moral support without which this study would have so much more challenging. This thesis concerns aspects of the history of certain South Asian languages, in particular Hindi and Urdu, (or Hindustani), but in a way, Sanskrit and Persian as well. Now that I take stock of my attempts to learn each of these languages I realize that I have been assisted in no small way by a rather large cohort of language teachers, for each of whom I hold enormous fonts of respect, affection and gratitude. -

SAIIER Sri Aurobindo International Institute of Educational Research Annual Report 2017-18
SAIIER Sri Aurobindo International Institute of Educational Research Annual Report 2017-18 SAIIER, Administrative Area, Auroville 605101, Tamil Nadu, India 0413-262-2982 | [email protected] Acknowledgments Thank you to all report writers: Aha! Facilitator Team, Aishwarya A., Aloka, Anna, Arun I., Auralice, Bhaga and LOE team, Bogi, Celine, Deoyani, Devi, Egle, Fabrice D., Francesca, Francoise, Gilles G., Grace, Hartmut, Honor, Ing-Marie, Jaya, Jean-Christophe, Jean-Yves, Jill, Jinu, Jyoti and Nandanam Kindergarten team, Kaliananda, Kalou, Kripa, Krishna and Auroville Film Festival team, Laurence, Lisbeth, Manoj, Marie, Marie-Claire, Marion, Martin G., Martin S., Mary and Transition School team, Maya, R. Meenakshi, Miriam, Nathalie, Nele, Nina, Paula C., Philippe and Thierry, Poovizhi, Pratap, Priya, Rabindra and Narendra, Rajesh and Kumar, Rosalba, Ruchi M., RV and Claire, Sabrina, Sangeetha, Sanjeev R., Saranya B., Saraswati, Saravanan, Satyavan B., Selvaraj A., Shraddhavan, Sophie and ACI team, Subash, Sudhir, Sundar, Suriyagandhi, Surya C.R., Swati, Tamar, Thambidurai, Thomas, Varadharajan, Vladimir, Yvelise, Xavier Cover photo by: Olivier N. Report prepared by: Arun, Kristen, Prabha/AVDzines Contents Report from the SAIIER office.....................................................................................1 List of projects supported in 2017-18.........................................................................3 Auroville schools Aha! Kindergarten.................................................................................................7 -

Sanskrit Kāraka Analyzer for Machine Translation Sudhir Kumar Mishra
Sanskrit K āraka Analyzer for Machine Translation Thesis submitted to Jawaharlal Nehru University In partial fulfillment of the requirements For the award of the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY by Sudhir Kumar Mishra Special Centre for Sanskrit Studies Jawaharlal Nehru University New Delhi–110067 INDIA 2007 ÌuÉÍvÉ· xÉÇxM×üiÉ AkrÉrÉlÉ MåülSì SPECIAL CENTRE FOR SANSKRIT STUDIES eÉuÉÉWûUsÉÉsÉ lÉåWûà ÌuɵÉÌuɱÉsÉrÉ JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY lÉD ÌSssÉÏÌSssÉÏ----110067 New Delhi-110067 July 20, 2007 D E C L A R A T I O N I declare that thesis entitled “Sanskrit K āraka Analyzer for Machine Translation” submitted by me for the award of the degree of Doctor of Philosophy is an original research work and has not been previously submitted for any other degree or diploma in any other institution/university. (Sudhir K Mishra) ÌuÉÍvÉ· xÉÇxM×üiÉ AkrÉrÉlÉ MåülSì SPECIAL CENTRE FOR SANSKRIT STUDIES eÉuÉÉWûUsÉÉsÉ lÉåWûà ÌuɵÉÌuɱÉsÉrÉ JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY lÉD ÌSsÌSssÉÏsÉÏsÉÏsÉÏ----110067110067 NEW DELHI-110067 July 20, 2007 C E R T I F I C A T E This thesis entitled “Sanskrit K āraka Analyzer For Machine Translation” submitted by Sudhir K Mishra to Special Centre for Sanskrit Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi-110067 , for the award of the degree of Doctor of Philosophy, is an original work and has not been submitted so far, in part or full, for any other degree or diploma of any University. This may be placed before the examiners for evaluation and for award of the degree of Doctor of Philosophy. Dr. Girish Nath Jha Dr. C. Upender -

Bibliography
251 BIBLIOGRAPHY English Books 1. Cathy N. Davidson. The Oxford Handbook of interdisciplinarity: “Humanities and technology in the Information age”, Oxford UP, 2012. Web. 2. G.D. Singhal. Suśrutasaṃhitā: Ancient Indian Surgery, Delhi, Chaukhamba Sanskrit Pratishthan, 2007. Print. 3. Hartmut Scharfe. Investigations in Kautalya's Manual of Political Science, Germany, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1993. Web. 4. Ian Kaplan and Ingrid Lewis. Promoting Inclusive Teacher Education Methodology, UNESCO Bangkok, 2013. Web. 5. Kapil Kapoor. Dimensions of Pāṇini Grammar: The Indian Grammatical System, New Delhi, D.K. Print World Ltd, 2005. Print. 6. Keshab Chandra dash. Elements of Research Methodology in Sanskrit, Varanasi Chaukamba Sanskrit Sansthan, Varanasi, 1992. Print. 252 7. K.R. Tripathi. Arrangement of the Rules in Pāṇini's Aṣṭādhyāyī, Delhi, Parimal Publications, 1995. Print. 8. K.V.Abhyankar. A Dictionary of Sanskrit Grammar, Baroda, Gaekwad’s Oriental Series, 1961. Print. 9. Prabhat Pandey and Dr. Meenu Mishra Pandey. Research methodology: tools and techniques, Romania Bridge Center, European Union, 2015. Web. 10. Rama Nath Sharma (University of Hawaii). The Aṣṭādhyāyī of Pāṇini, New Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 1995. Print. 11. R.K. Sharma and Bhagavan Dash. Carakasaṃhitā, Varanasi, Cowkhamba Sanskrit Series office, 2012. Print. 12. Robert Penn Warren. Fundamentals of Good Writing, New York, Harcourt, Brace and Company, 1950. Web. 13. S.D Joshi and J.A.F. Roodbergen. The Aṣṭādhyāyī of Pāṇini, Delhi Sahitya Academy, 1991. Print. 253 14. Shripad Krishna Belvalkar. An Account of the Different Existing Systems of Sanskrit Grammar, Self publication with the permission of University of Bombay, Poona, 1915. Print. 15. Svenja Adolphs. -

Repor T Resumes
REPOR TRESUMES ED 020510. 46 AL 001 279 SURVEY OF MATERIALS IN THE NEGLECTED LANGUAGES,PART I (PRELIMINARY EDITION). CENTER FOR APPLIED LINGUISTICS, WASHINGTON, D.C. REPORT NUMBER BR...7...0929 PUB DATE JUN 68 CONTRACT 0EG...1-1...070929-4276 EDRS PRICEMF-S1.73 HC- $19.12 476P. DESCRIPTORS- *BIBLIOGRAPHIES, ANNOTATED BIBLIOGRAPHIES, *UNCOMMONLY TAUGHT LANGUAGES, *INSTRUZTIONAL MATERIALS, TEXTBOOKS, READING MATERIALS, DICTIONARIES, AFRICAN LANGUAGES, AFRO ASIATIC LANGUAGES, AMERICAN INDIAN LANGUAGES, DRAVIDIAN LANGUAGES, FINNO UGRIC LANGUAGES, INDONESIAN LANGUAGES, MALAY() POLYNESIAN LANGUAGES, SEMITIC LANGUAGES, SINO TIBETAN LANGUAGES, SLAVIC LANGUAGES, URALIC AL7AIC LANGUAGES, INDO EUROPEAN LANGUAGES, THIS PRELIMINARY LIST OF STUDY AIDS FOR NEGLECTED LANGUAGES (THOSE NOT COMMONLY TAUGHT IN THE UNITED STATES) GIVES GREATEST EMPHASIS TO MATERIALS INTENDED FOR USE BYTHE ADULT LEARNER WHOSE NATIVE LANGUAGE IS ENGLISH. ITSENTRIES ARE ARRANGED ALPHABETICALLY BY LANGUAGE, ACHINESETO ZULU, AND INCLUDE TEXTS, GRAMMARS, READERS, DICTIONARIES,STUDIES OF WRITING SYSTEMS, AND LINGUISTIC DESCRIPTIONS.ACCOMPANYING TAPES, RECORDS, AND SLIDES ARE LISTED WHEREKNOWN. CREOLES ARE LISTED UNDER ENGLISH, FRENCH, PORTUGUESE, ORSPANISH ACCORDING TO THEIR LEXICAL BASE. BRIEF BUT COMPREHENSIVE ANNOTATIONS ARE SUPPLIED.FOR THE BASIC COURSES EXCEPTIN CASES WHERE THE BOOKS WERE UNAVAILABLE OR NOT AVAILABLE IN TIME FOR INCLUSION. THE FINAL EDITION, COMPLETELYANNOTATED ANDNDEXED, WILL BE PUBLISHED IN THE SPRING OF 1969. FOR FURTHER INFORMATION, WRITE THE FOREIGN LANGUAGES PROGRAM, CENTER FOR APPLIED LINGUISTICS, 1717 MASSACHUSETTSAVENUE, WAHINGTON, D.C. 20036. (DO) 72,07 o 9-27 OEC- . yg L5 SURVEY OF MATERIALS IN TOE NEGLECTED',ANGLIA hit l U.S. DEPARTMENT OFHEALTH, EDUCATION & WELFARE OFFICE OF EDUCATION THIS DOCUMENT HAS BEEN REPRODUCEDEXACTLY AS RECEIVED FROM THE POINTS OF VIEW OR OPINIONS PERSON OR ORGANIZATION ORIGINATINGIT.