Quaderni Coldragonesi 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Comune Di S. Giovanni Incarico PROVINCIA DI FROSINONE
Comune di S. Giovanni Incarico PROVINCIA DI FROSINONE PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLA D.G.R.L. 363/2014 – 415/2015 RELAZIONE TECNICA Data, 30/11/2016 APPROVATO CON D.C.C. N° 27 DEL 02/12/2016 RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI ARCH. ANNA MARIA CAMPAGNA PROFESSIONISTA INCARICATO ING. MASSIMO PATRIZI PREMESSA Il Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile, è stato elaborato con lo scopo di fornire al Comune uno strumento operativo utile a fronteggiare l’emergenza locale, conseguente al verificarsi di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo; ci si riferisce ad eventi che per loro natura ed estensione possono essere contrastati mediante interventi attuabili autonomamente dal Comune, dalla Regione e della Provincia in quanto titolari dei Programmi di previsione e prevenzione. Il presente Piano di Emergenza, obbligatorio a norma di legge, è uno strumento a forte connotazione tecnica, fondato sulla conoscenza delle pericolosità e dei rischi che investono il territorio comunale e, nella prospettiva offerta dalla legislazione, esso trova una chiara collocazione tra gli strumenti che l’Ente ha a disposizione per la gestione dei rischi. Sulla base di scenari di riferimento, individua e disegna le diverse strategie finalizzate alla riduzione del danno ovvero al superamento dell'emergenza ed ha come finalità prioritaria la salvaguardia delle persone, dell’ambiente e dei beni presenti in un'area a rischio. Il Piano include quegli elementi informativi concernenti le condizioni di rischio locale che debbono essere recepite, e in alcuni casi risolte, dalla pianificazione territoriale. Nel caso di grosse calamità il Piano rappresenta lo strumento di primo intervento e di prima gestione dell’emergenza. -
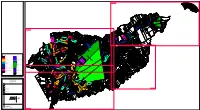
Comune Di Colfelice
Geom. Raffaele DI MURRO DI Raffaele Geom. Arch. Maristella DELLI COLLI DELLI Maristella Arch. COLLABORATORI: Arch. Innocenzo DELLI COLLI DELLI Innocenzo Arch. PROGETTISTA: ZONIZZAZIONE Scala 1:5000 Scala Generale GENERALE DI GENERALE PLANIMETRIA Regolatore Piano TAV. P.01/B TAV. P01 TAVOLA Provincia di Frosinone di Provincia COLFELICE COMUNE DI COMUNE (zone agricole) (zone Zona E Zona commerciali) (zone per insediamenti produttivi - artigianali e artigianali - produttivi insediamenti per (zone Zona D2 Zona (zone per insediamenti produttivi - complessi produttivi) complessi - produttivi insediamenti per (zone Zona D1 Zona contrade rurali) contrade (zone espansione - ristrutturazione e completamento e ristrutturazione - espansione (zone Zona CR Zona (zone di espansione - edilizia economica e popolare) e economica edilizia - espansione di (zone Zona C3 Zona (zone di espansione - obbligo P.P. o P.L.) o P.P. obbligo - espansione di (zone Zona C2 Zona Strade di Progetto di Strade X = +3200 D (zone di espansione - edilizia privata) edilizia - espansione di (zone 366 C1 Zona Y = -13600 STRADA Depuratore Ps 1 completamento) di edificate (zone Zona B2 Zona Palazzetto dello Sport dello Palazzetto C 2 sature) edificate (zone 275 COMUNE DI ROCCAD'ARCE B1 Zona LEGENDA Comune (zone storiche) (zone 3 A Zona (parco ecologico) (parco 201 F6 Zona RIO 12 ACQUA STRADA (verde privato di rispetto) di privato (verde 1032 F5 Zona 276 929 11 COMUNALE 861 COMUNE DI ARCE 17 249 camping) 13 247 16 attrezzati pubblici spazi per (zone TAGLIA 827 1004 1006 COMUNE DI -

4.3.1 DESCRIZIONE: PROGETTISTI STRALCI COMUNALI Ing
1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 1.1 Limiti amministrativi Limite comparto Limite comunale 3. INFRASTRUTTURE 3.1 Rete ferroviaria / funicolare rete ferroviaria esistente rete ferroviaria/ funicolare di progetto Rete Alta Velocità - TAV Metropolitana Cassino - Valle dei Santi - Formia Rete ferroviaria nazionale Funivia per Montecassino 3.2 Rete viaria Rete viaria esistente Rete viaria da potenziare Rete viaria di progetto Autostrada Rete della viabilità Primaria Rete della viabilità Secondaria Rete della viabilità Comunale 3.3 Rete Fluviale Fiumi 1:5.000 0 0,2 Km 3.4 Reti Tecnologiche M E ^ ³ ± Metanodotto ³ ± Elettrodotto ³± Acquedotto Colfelice 4. STRALCI COMUNALI 4.1 Zone Omogenee - Destinazioni Esistente e di P.R.G. Ampliamento PRT INDUSTRIALE (N.T.A. - ART. 16) ARTIGIANALE (N.T.A - ART. 17) COMMERCIALE ED ARTIGIANALE (N.T.A - ART. 18) SERVIZI (N.T.A - ART. 19) RECUPERO STABILIMENTI DISMESSI (N.T.A - ART. 20) VERDE DI RISPETTO (N.T.A - ART. 21) INTERCLUSA (N.T.A - ART. 22) INDUSTRIE INSALUBRI O PERICOLOSE (N.T.A - ART. 24) IMPIANTI TECNOLOGICI (N.T.A - ART. 26) LOGISTICA (N.T.A - ART. 28) RICETTIVA (N.T.A - ART. 32) Roccasecca CENTRO DIREZIONALE (N.T.A - ART. 33) RICERCA E SVILUPPO (N.T.A - ART. 35) AREA VERDE ATTREZZATA (N.T.A - ART. 41) 4.2 Zone di interesse particolare AREA FIERISTICA-ESPOSIZIONE (N.T.A - ART. 34/A) TURISTICO (N.T.A - ART. 40) San Giovanni in Carico AREA FIERISTICA-SERVIZI (N.T.A - ART. 34/B) CAVE (N.T.A - ART. 42) AEREOPORTO (N.T.A - ART. 36) AGRICOLTURA INTENSIVA AREA AGRITURISTICA (N.T.A - ART. -

Documento Programmatico "Antica Terra Di Lavoro"
PROGETTO Rilancio della Competitività del Sistema Territoriale dei 59 Comuni dei Sistemi Locali del Lavoro di: · Cassino · Sora · Atina · Coreno Ausonio Unione di Comuni “Antica Terra di Lavoro” Provincia di Frosinone Linee operative e contenuti dell’intervento Giugno 2014 Premessa Il presente documento riassume i contenuti, le motivazioni e le prime linee operative di un progetto per il rilancio ed il rafforzamento della competitività del tessuto produttivo dell’area SLL di Atina, Cassino, Coreno Ausonio e Sora, nella provincia di Frosinone. Il progetto è stato promosso dall’Unione dei Comuni “Antica Terra di Lavoro” ed all’iniziativa aderisce un ampio partenariato di organismi e soggetti differenti. Il documento riporta le attività svolte tra novembre 2013 e giugno 2014, nella fase preparatoria del progetto 12 e di condivisione, a livello locale, degli obiettivi di intervento. Unione di Comuni “Antica Terra di Lavoro” Provincia di Frosinone Unione di Comuni “Antica Terra di Lavoro” Provincia di Frosinone Indice Premesse e ragioni dell’intervento 01 Motivazioni e caratteristiche dell’intervento 06 Ambiti di intervento 08 Piano di lavoro ed attività svolte 10 Strumento di intervento 13 Il partenariato di progetto 15 Area territoriale sub regionale di rifermento 19 Obiettivi e attività luglio/ottobre 2014 22 Unione di Comuni “Antica Terra di Lavoro” Provincia di Frosinone Unione di Comuni “Antica Terra di Lavoro” Provincia di Frosinone Premesse e ragioni dell’intervento La proposta di un intervento per il recupero di competitività e per il rilancio del versante meridionale della provincia di Frosinone, compreso tra Atina, Cassino, Coreno Ausionio e Sora nasce a novembre 2013 per iniziativa dell’Unione di Comuni “Antica Terra di Lavoro” ed ha trovato, nel giro di pochi mesi, ampio consenso e numerose adesioni da parte di imprese locali, la Camera di Commercio di Frosinone, l’Unione degli Industriali di Frosinone e di soggetti intermedi operanti nella provincia, oltre che del CNR, dell’APRE,di Invitalia e della Regione Lazio. -

Prefettura Di Frosinone Ufficio Territoriale Del
PREFETTURA DI FROSINONE UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO La Prefettura Informa 32 (27 febbraio 2021) 1. I giovani e la scuola Il confronto sul trasporto scolastico degli adolescenti in epoca di Covid-19 è servito a correggere errori, sottovalutazioni e a perfezionare gli orari. Ha avuto anche punte parossistiche. In ogni caso, è stata presente una bassa attenzione al futuro dei giovani, che rischiano di essere un grande spreco di questi tempi. L’educazione e la qualità degli studenti è un grande obbligo delle generazioni adulte e una grande responsabilità per assicurare il patrimonio di crescita del nostro Paese. Il Presidente Draghi ha avvertito: ”Nonostante sia la generazione meglio 1 istruita di sempre, i giovani stanno pagando un prezzo troppo alto per la crisi. Per evitare di creare una “generazione perduta” dobbiamo agire n fretta”. Così si riduce in vari modi la crescita e si determina il decadimento del capitale umano. Ancora il Presidente: “Oltre a ferire l’equità, costituisce un spreco che non possiamo permetterci”. Anche in Ciociaria, dove, purtroppo gli istituti anche di antica tradizione non brillano nelle graduatorie. E’ una questione fondamentale, per tale ragione in coda troverete un articolo di Marco Impagliazzo, docente universitario e presidente della Comunità di Sant’Egidio. Una lettera che può far bene ed aiutare a riflettere. La scuola e, soprattutto, la preparazione non possono perdere l’autobus della vita. 2. Le curve epidemiologiche Per comprendere le difficoltà del momento sui contagi basta guardare i dati storici (ISTAT) sottostanti e comprendere che ormai da settimane la Ciociaria non riesce a contenere la diffusione del virus. -

Quaderni Coldragonesi 4
Quaderni Coldragonesi 4 a cura di Angelo Nicosia In ricordo di ERNESTO GUIDA Regista cinematografico Colfelicese di adozione INDICE Presentazione pag. 7 Prefazione pag. 9 ANGELO NICOSIA, Arule fittili con scena mitologica da Aquino e da Fabrateria Nova (FR) pag. 11 ALESSANDRA TANZILLI, Materiali funerari editi e inediti a Sora, Vicalvi e Casalattico (FR) pag. 17 MARCO SBARDELLA, De vita et miraculis Sancti Benedicti. Il poema religioso del Pellissieri pag. 27 CARLO MOLLE, Graffiti di epoca rinascimentale dalla chiesa di S. Antonio Abate a Castelnuovo Parano pag. 53 FERDINANDO CORRADINI, Viabilità in agro di Castrocielo, Roccasecca, Colfelice, Arce e Fontana Liri pag. 59 COSTANTINO JADECOLA, Una ferrovia lunga 150 anni pag. 69 MARCELLO OTTAVIANI, Il molino Zippo a Fontana Liri pag. 97 SILVANA CASMIRRI, Amministrazione e società nel circondario di Sora in una relazione del sottoprefetto Domenico Tinto (20 giugno 1901) pag. 103 BERNARDO DONFRANCESCO, L’emigrazione da Colfelice: vicende umane e sociali pag. 111 LIANA CORINA TUCU, La latinità nei rapporti italo-romeni: in margine ad un convegno tenutosi a Fondi (LT) pag. 119 VANDA FIORELLI URSINO, I miei ricordi di Colfelice pag. 129 5 UNA FERROVIA LUNGA 150 ANNI Costantino Jadecola Lunedì 25 febbraio 2013 c’era in agenda il era l’estrema periferia. Si trovava, cioè, non certo 150.mo anniversario dell’entrata in funzione della nelle migliori condizioni, non potendo beneficiare ferrovia Roma-Napoli, via Cassino. Ma la ricor- nemmeno di quelle attenzioni, in realtà non molte, renza è stata del tutto trascurata anche perché quel sulle quali potevano più facilmente contare i ter- giorno non si poteva ignorare la conta dei voti ritori più prossimi alle rispettive capitali: Roma e delle elezioni politiche e regionali. -

Elenco Uffici Postali Con Ritiro Apparato Telepass Immediato
ELENCO UFFICI POSTALI CON RITIRO APPARATO TELEPASS IMMEDIATO Pr. Località Denominazione Ufficio Postale Indirizzo Cap Telefono FR ACUTO ACUTO PIAZZA DANTE, 17 03010 0775-56835 FR ALATRI ALATRI CIRCONVALLAZIONE PORTADINI, 3 03011 0775-449920 FR ALVITO ALVITO PIAZZA LIBERTA', SNC 03041 0776-510948 FR AMASENO AMASENO VIA PRATI, 1 03021 0775-658262 FR ANAGNI ANAGNI VIA DELLA PESCHIERA, 4/6 03012 0775-735022 FR ANITRELLA ANITRELLA VIA CAMPO SPORTIVO, 71 03025 0775-868881 FR AQUINO AQUINO VIA FILIPPO DI SOTTO, SNC 03031 0776-728732 FR ARCE ARCE VIA GUGLIELMO MARCONI, SNC 03032 0776-523513 FR ARNARA ARNARA PIAZZA PORTA NUOVA, SNC 03020 0775-231340 FR ARPINO ARPINO PIAZZA MUNICIPIO, 14 03033 0776-848185 FR ATINA ATINA VIA VITTORIO EMANUELE, SNC 03042 0776-609239 FR ATINA INFERIORE ATINA INFERIORE VIA DEI SANNITI, 2 03042 0776-610826 FR AUSONIA AUSONIA VIA DANTE ALIGHIERI, 1 03040 0776-951020 FR BELMONTE CASTELLO BELMONTE CASTELLO VIA POZZI, SNC 03040 0776-692243 FR BOVILLE ERNICA BOVILLE ERNICA PIAZZA SAN NICOLA, SNC 03022 0775-379740 FR BROCCOSTELLA BROCCOSTELLA VIA STELLA, 53 03030 0776-891498 FR CAIRA CAIRA CORSO SAN BASILIO, SNC 03043 0776-337381 FR CAMPOLI APPENNINO CAMPOLI APPENNINO BORGO SAN GIACOMO, SNC 03030 0776-884315 FR CARNELLO CARNELLO PIAZZA MARCO TULLIO CICERONE, SNC 03039 0776-868535 FR CASALATTICO CASALATTICO VICO ASCANIO, 1 03030 0776-692150 FR CASALVIERI CASALVIERI PIAZZA SAN ROCCO, 17/19 03034 0776-639616 FR CASAMARI CASAMARI VIA MARIA, SNC 03029 0775-283458 FR CASSINO CASSINO PIAZZA ALCIDE DE GASPERI, SNC 03043 0776-297226 -

Volume Stampato Con Il Contributo Dell'amministrazione Comunale Di
Volume stampato con il contributo dell’Amministrazione Comunale di Colfelice e della Banca Popolare del Cassinate Stampa Tipografia Arte Stampa, Via Toscana 12, Roccasecca (FR) - www.artestampa.org Copyright Comune di Colfelice 2010 ISBN 978-88-902140-3-5 In copertina Particolare degli affreschi nella Galleria delle carte geografiche al Vaticano. Quaderni Coldragonesi 1 a cura di Angelo Nicosia INDICE Presentazione pag. 7 Prefazione pag. 9 ROSALBA ANTONINI , Novità epigrafiche dalla piana del Liris-Garigliano (FR). Gli apporti della docu - mentazione alle problematiche linguistiche. pag. 11 FRANCESCO AVOLIO , I dialetti dell’area cassinese e dell’odierno basso Lazio: alcune considerazioni pag. 27 ANGELO NICOSIA , Federico II e il territorio di Arce pag. 37 STEFANIA PATRIARCA , Un’antica fontana con iscrizione a Fontana Liri (FR) pag. 43 COSTANTINO JADECOLA , “Hanno a sparire le scarpe!” pag. 49 FERNANDO RICCARDI , Roccasecca e Arce in “guerra” per la Pretura pag. 57 GAETANO DE ANGELIS CURTIS , Terra di Lavoro e le elezioni alla Camera dei deputati nel collegio di Pontecorvo tra Unità d’Italia e primo dopoguerra pag. 71 FERDINANDO CORRADINI , Un contributo sulla malaria nella media valle del Liri da due scritte apparen - temente insignificanti pag. 91 LORETO TERZIGNI , Due interessanti iscrizioni inedite di Sora pag. 101 5 UN CONTRIBUTO SULLA MALARIA NeLLA MedIA vALLe deL LIRI dA dUe SCRITTe APPAReNTeMeNTe INSIGNIFICANTI Ferdinando Corradini Nel territorio del Comune di Colfelice, al km. Sappiamo che in occasione dell’ultimo conflitto 117,450 circa della via Casilina, sulla facciata di una mondiale, e subito dopo di esso, nel territorio che va casa che appare essere poco frequentata, è possibile da Ceprano a Cassino si ebbe una recrudescenza del vedere, scritte con un pennello, utilizzando la vernice fenomeno malarico, che, in modo endemico, era pre - bianca, tre lettere puntate in stampatello maiuscolo: sente nello stesso fin dai tempi antichi. -

Orari E Percorsi Della Linea Bus COTRAL
Orari e mappe della linea bus COTRAL Frosinone | Piazza Pertini →Cassino | Via Visualizza In Una Pagina Web Cerrone La linea bus COTRAL Frosinone | Piazza Pertini →Cassino | Via Cerrone ha una destinazione. Durante la settimana è operativa: (1) Frosinone | Piazza Pertini →Cassino | Via Cerrone: 04:00 - 20:00 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus COTRAL più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus COTRAL Direzione: Frosinone | Piazza Pertini →Cassino | Orari della linea bus COTRAL Via Cerrone Orari di partenza verso Frosinone | Piazza 84 fermate Pertini →Cassino | Via Cerrone: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 04:00 - 20:00 martedì 04:00 - 20:00 Frosinone | Piazza Pertini mercoledì 04:00 - 20:00 Frosinone | Stazione FS Piazzale Alessandro Kambo, Frosinone giovedì 04:00 - 20:00 venerdì 04:00 - 20:00 Frosinone | Via Jacobucci Viale Verdi sabato Non in servizio Frosinone | Via Castagnola Via Saragat domenica Non in servizio Ceccano | Via Frosinone Via Scifelli Ceccano | Cantinella Informazioni sulla linea bus COTRAL Ceccano | Via Frosinone Via Vigne Vecchie Via per Frosinone, Ceccano Direzione: Frosinone | Piazza Pertini →Cassino | Via Cerrone Ceccano | Via Frosinone Via Colle Leo Basso Fermate: 84 Durata del tragitto: 107 min Ceccano | Via Frosinone Via Passo Cardinale La linea in sintesi: Frosinone | Piazza Pertini, Frosinone | Stazione FS, Frosinone | Via Jacobucci Viale Verdi, Frosinone | Via Castagnola Via Saragat, Ceccano | Via Frosinone Via Paolina Ceccano | Via Frosinone Via Scifelli, Ceccano | Cantinella, Ceccano | Via Frosinone Via Vigne Ceccano | Stazione FS Vecchie, Ceccano | Via Frosinone Via Colle Leo Basso, Ceccano | Via Frosinone Via Passo Cardinale, Ceccano | Ospedale Ceccano | Via Frosinone Via Paolina, Ceccano | Stazione FS, Ceccano | Ospedale, Ceccano | Piazza Ceccano | Piazza Berardi Berardi, Ceccano | Via Gaeta (Istituti), Ceccano | Via S. -

Comune Di Ausonia PEC: [email protected]
Investimenti, Ingegneria della Manutenzione, ACEA ATO5 In Partenza Prot. n. 0373401/20 del 23/12/2020 PROTOCOLLOPatrimonio ATO5 e Progettazione ACEA ATO 5 S.p.A. Comune di Ausonia PEC: [email protected] Comune di Castelnuovo Parano PEC: [email protected] Comune di Colle San Magno PEC: [email protected] Comune di Esperia PEC: [email protected] Comune di Ferentino PEC: [email protected] Comune di Fontechiari PEC: [email protected] Comune di Isola del Liri PEC: [email protected] Comune di Piedimonte San Germano PEC: [email protected] Comune di Pignataro Interamna PEC: [email protected] Comune di Pofi PEC: [email protected] Comune di Pontecorvo PEC: [email protected] Comune di Roccasecca PEC: [email protected] Comune di Sant’Ambrogio Sul Garigliano PEC: [email protected] Comune di Sant’Elia Fiume Rapido PEC: [email protected] Acea Ato 5 SpA – Viale Roma, snc, 03100 - Frosinone / T 0775 883 100 Cap.Soc. Euro 10.330.000,00 iv CF, P.IVA 02267050603 CCIAA FR REA 140926 http://www.gruppo.acea.it Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell’art. 2497 bis Acea SpA - CF 05394801004 Investimenti, Ingegneria della Manutenzione, Patrimonio e Progettazione ACEA ATO 5 S.p.A. Comune di Veroli PEC: [email protected] Oggetto: Accordo quadro avente ad oggetto i lavori di bonifica delle reti idriche del servizio idrico integrato Acea Ato5 S.p.A. GARA n. 8800001283/EMA - Lotto 2 CIG 7423624851 Comunicazione avviso ai creditori Luogo di esecuzione: Comune Acquafondata, Acuto, Alatri, Alvito, Anagni, Aquino, Arce, Arnara, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Boville Ernica, Broccostella, Campodimele, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Castelnuovo Parano, Castro dei Volsci, Castrocielo, Ceccano, Ceprano, Cervaro, Colfelice, Colle S. -

San Giovanni Incarico.Pdf
1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 1.1 Limiti amministrativi Limite comparto Limite comunale 3. INFRASTRUTTURE 3.1 Rete ferroviaria / funicolare rete ferroviaria esistente rete ferroviaria/ funicolare di progetto Colfelice Rete Alta Velocità - TAV Metropolitana Cassino - Valle dei Santi - Formia Rete ferroviaria nazionale Funivia per Montecassino 3.2 Rete viaria Rete viaria esistente Rete viaria da potenziare Rete viaria di progetto LAGO Autostrada Rete della viabilità Primaria Rete della viabilità Secondaria Roccasecca Rete della viabilità Comunale 3.3 Rete Fluviale Fiumi 3.4 Reti Tecnologiche M E ^ ³ ± Metanodotto ³ ± Elettrodotto ³± Acquedotto 4. STRALCI COMUNALI 4.1 Zone Omogenee - Destinazioni Esistente e di P.R.G. Ampliamento PRT INDUSTRIALE (N.T.A. - ART. 16) ARTIGIANALE (N.T.A - ART. 17) Colfelice COMMERCIALE ED ARTIGIANALE (N.T.A - ART. 18) SERVIZI (N.T.A - ART. 19) San Giovanni in Carico RECUPERO STABILIMENTI DISMESSI (N.T.A - ART. 20) VERDE DI RISPETTO (N.T.A - ART. 21) INTERCLUSA (N.T.A - ART. 22) INDUSTRIE INSALUBRI O PERICOLOSE (N.T.A - ART. 24) IMPIANTI TECNOLOGICI (N.T.A - ART. 26) LOGISTICA (N.T.A - ART. 28) FIU ME LI RICETTIVA (N.T.A - ART. 32) RI CENTRO DIREZIONALE (N.T.A - ART. 33) Pontecorvo RICERCA E SVILUPPO (N.T.A - ART. 35) AREA VERDE ATTREZZATA (N.T.A - ART. 41) 4.2 Zone di interesse particolare AREA FIERISTICA-ESPOSIZIONE (N.T.A - ART. 34/A) TURISTICO (N.T.A - ART. 40) AREA FIERISTICA-SERVIZI (N.T.A - ART. 34/B) CAVE (N.T.A - ART. 42) AEREOPORTO (N.T.A - ART. 36) AGRICOLTURA INTENSIVA AREA AGRITURISTICA (N.T.A - ART. -

La Storia Di Colfelice È Contrassegnata Anche Dall'emigrazione. La Prima
Emigrazione La storia di Colfelice è contrassegnata anche dall’emigrazione. La prima fase di questo fenomeno si sviluppò alla fine dell’800 e nei primi decenni del ‘900 (nel periodo che per l’Italia tutta fu chiamato della “grande emigrazione“). Furono molti i nostri concittadini a partire per la Francia, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Spesso si trattò di soli uomini che raggiungevano quei Paesi per trovare un lavoro e rimettere il denaro guadagnato ai loro familiari rimasti in Italia. A volte, invece, emigrarono intere famiglie (Fraioli, Lancia, Renzi, Palermo, Frezza, …) che rimasero stabilmente nei luoghi di arrivo. Ne è particolare testimonianza l’emigrazione dei coniugi Nicola e Francesca Lancia che nel 1904 emigrarono da Colfelice a Marsiglia, in Francia, portando con sé i figli Antonia, Giuseppe, Domenica, Rosa e Assunta. In Francia Nicola e Francesca ebbero altri tre figli: Victorine, Louis e Bernardine. Assunta, nata a Colfelice nel 1903, ha festeggiato ad Allauch, in Provenza, i suoi 100 anni di vita. Di questi 8 figli tre (Assunta, Victorine e Bernardine) hanno superato i 100 anni di vita! Particolare non trascurabile, nella regione di Marsiglia sono oggi presenti circa 40 famiglie di cognome Lancia, tutte discendenti da quei coniugi emigrati da Colfelice nel 1904. Fa piacere sottolineare che oggi frequenti e affettuose relazioni con l’Amministrazione comunale di Colfelice sono assicurate da Daniel Lancia, discendente di Louis Lancia. All’epoca dell’emigrazione dai nostri territori trattò la relazione La tratta dei fanciulli di Ugo Cafiero, pubblicata nel 1901 sulla rivista La riforma sociale. L’autore, dopo aver riferito sulle necessità economiche che determinavano da sempre l’emigrazione della nostra gente (“L’ardire di emigrare è antico, è tradizionale in queste contrade”), parlava dell’emigrazione “patologica”, quella che riguardava i bambini strappati all’affetto e al calore della famiglia.