PIANO COLORE Da 1 a 32
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Regione Lazio
REGIONE LAZIO Direzione: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA Area: SUPPORTO AI COMUNI PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DETERMINAZIONE (con firma digitale) N. G13489 del 13/11/2020 Proposta n. 17157 del 06/11/2020 Oggetto: L.R.38/1999-DGR n.855 del 20/12/2018- Bando di concessione contributi ai Comuni, ad esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di opere e lavori pubblici finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici, ex L.R. n. 38/1999. Presa d'atto dei lavori della Commissione. Proponente: Estensore LO GATTO GIULIA _________firma elettronica______ Responsabile del procedimento LO GATTO GIULIA _________firma elettronica______ Responsabile dell' Area F. BISOGNI __________firma digitale________ Direttore Regionale M. MANETTI __________firma digitale________ Firma di Concerto Pagina 1 / 12 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI OGGETTO: L.R.38/1999-DGR n.855 del 20/12/2018- Bando di concessione contributi ai Comuni, ad esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di opere e lavori pubblici finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici, ex L.R. n. 38/1999. Presa d’atto dei lavori della Commissione. IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA Su proposta del Dirigente dell’Area Supporto ai Comuni per la Pianificazione Urbanistica il Recupero dei Centri storici e la Riqualificazione Urbana VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. -

In Lazio, Umbria E Toscana Ci Sono Antichi Borghi Dove Rivivere Culture E Tradizioni Di Un Tempo. Tour Operator
Tour Operator In Lazio, Umbria e Toscana ci sono antichi borghi dove rivivere culture e tradizioni di un tempo. Tour Operator Pensiamo e realizziamo viaggi per vivere le tradizioni ancora custodite in luoghi lontani dal turismo di massa. “Ogni volta che costruisco un tour per un cliente la mia mente vola in quei luoghi. È come se fossi lì a respirare quell’aria... Che bello! È affascinante e straordinariamente coinvolgente. Amo il mio lavoro” Stefano Capoccioni Try Nature www.trynature.it 1 La città scelta dai Papi, nel cuore della Tuscia. viterbo Dal contrasto tra le vecchie e le nuove tendenze artistiche gli umili costruttori viterbesi del dodicesimo secolo seppero trarre, con innato e tradizionale senso dell’arte, gli elementi per abbellire ed in- gentilire le loro case creando un proprio stile che desta sorpresa e ammirazione. Non per la grandiosità degli edifici, sibbene per la originalità dei particolari per la eleganza degli ornati, per l’ardi- tezza delle scale esterne o per lo slancio dei balconi, ogni abitazione, anche la più modesta, si distingue e si nobilita nell’ar- monia dell’insieme. Forse è per questo che tutto il quartiere di San Pellegrino ha conservato pressoché immutato, per tanti secoli, il suo origi- nario aspetto attraverso il quale pare di sentire lo spirito. A.D. 1961 Associazione Amici dei Monumenti 2 3 Questo borgo è stato nei secoli chiamato dai poeti “La città che muore” per via dei lenti franamenti della montagna sulla quale è adagiato; oggi, come uno scrigno, conserva le culture e le tradizioni di un tempo. -
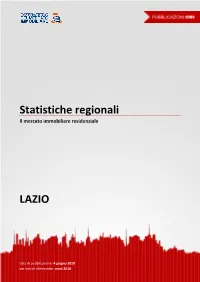
Statistiche Regionali Lazio 2019
Statistiche regionali Il mercato immobiliare residenziale LAZIO data di pubblicazione: 4 giugno 2019 periodo di riferimento: anno 2018 a cura della Direzione Regionale Lazio (Moreno Balestro) in collaborazione con Ufficio Provinciale Territorio di Roma (Emanuela Fantaccione) Direzione provinciale di Frosinone – Ufficio Provinciale Territorio (Giovanni De Vincentis) Direzione provinciale di Latina – Ufficio Provinciale Territorio (Angela Sileo) Direzione provinciale di Rieti – Ufficio Provinciale Territorio (Alessandro Micheli) Direzione provinciale di Viterbo – Ufficio Provinciale Territorio (Laura Mencarini) Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare [email protected] data di pubblicazione: 4 giugno 2019 periodo di riferimento: anno 2018 Le informazioni rese nella presente nota sono di proprietà esclusiva dell’Agenzia delle Entrate. Non è consentito vendere, affittare, trasferire, cedere i dati contenuti in questa pubblicazione, o assumere alcune altre obbligazioni verso terzi. Le informazioni possono essere utilizzate, anche ai fini della loro elaborazione, purché, nel caso di pubblicazione, venga citata la relativa fonte. Indice Il mercato immobiliare residenziale della regione ....................................................................................................................................3 Le compravendite ................................................................................................................................................................................4 -

AAR Magazine
AMERICAN ACADEMY IN ROME MAGAZINE SPRING 2018 SPRING 2018 Welcome to the Spring 2018 issue UP FRONT IN CLOSING of AAR Magazine. 2 33 LETTER FROM THE PRESIDENT DONORS This issue highlights recent work and collabora- tions by our Rome Prize winners and Italian Fellows. 4 36 Because this year was the tenth anniversary of the FAR AFIELD WHEN IN ROME Scharoun Ensemble Berlin in Rome, we reflect on Checking in with past Fellows and Residents Three Fellows share their favorite places in Rome how the concert series began. The spring issue also anticipates a solo show of new work by Yto Barrada, 6 the Roy Lichtenstein Artist in Residence from last INTRODUCING fall, which—along with the Patricia H. Labalme The 2018–2019 Rome Prize winners Friends of the Library Lecture by Mary Roberts in and Italian Fellows March and a conference on Islamic art and architec- ture in May—are the culminating events of East and 10 West, the Academy’s thematic series of events for FROM THE ARCHIVES 2017–18. Ten years of Scharoun Ensemble Berlin Finally, we are excited to announce the 2018–19 Rome Prize winners and Italian Fellows! 11 IN RESIDENCE Vi diamo il benvenuto all’edizione Spotlighting recent Residents primaverile 2018 dell’AAR Magazine. 15 CONVERSATIONS/ CONVERSAZIONI Questo numero dà spazio alle opere e alle collabora- This season’s discussions in Rome and the US zioni recenti dei vincitori del Rome Prize e dei nostri Italian Fellows. Poiché quest’anno ricorre il decimo anniversario dello Scharoun Ensemble Berlin a Roma, ripercorriamo la storia della serie di concerti. -

Best of Rome 2019
©Lonely Planet Publications Pty Ltd Welcome to Rome Even in a country of exquisite cities like Italy, Rome is special. Epic, hot-blooded and achingly beautiful, it’s a heady mix of haunting ruins, awe-inspiring art, iconic monuments and vibrant street life. Rome’s historic cityscape, the result of 3000 years ROME of ad hoc urban development, is an exhilarating spectacle. Ancient icons such as the Colosseum, TOP SIGHTS, AUTHENTIC EXPERIENCES Roman Forum and Pantheon recall its golden age as caput mundi (capital of the world), while barn- storming basilicas testify to its historical role as seat of the Catholic Church. The city’s artistic heritage is also astonishing. Throughout history, Rome has starred in the great upheavals of Western art, drawing the top artists of the day and inspiring them to push the boundaries of creative achievement. The result is a city awash with priceless treasures. Ancient statues adorn world-class museums, Byzantine mosaics and Renaissance frescoes dazzle in art-rich churches, baroque fountains embellish medieval piazzas. Walk around the centre and without even trying you’ll come across masterpieces by the likes of Michelangelo, Caravaggio, Raphael and Bernini. But a trip to Rome is as much about lapping up the dolce vita lifestyle as gorging on art and culture. Whiling away hours at streetside cafes, idling on pretty piazzas, dining in boisterous neighbourhood trattorias – these are all an integral and enjoyable part of the Roman experience. Rome is special...epic, Duncan Garwood, Nicola Williams hot-blooded and achingly beautiful St Peter’s Basilica at dusk MAPICS/SHUTTERSTOCK © £# 0 500 m e# 0 0.25 miles 2 PLAN YOUR TRIP ROME Villa Borghese & Northern Rome # Villa BoEncompassesrghese & the glorious park of Villa Museo e Basilica di NortherBorghesen Rom ande the â# Galleria Santa Maria city’s cultural hub. -

Best of Rome 2019 Preview
Welcome to Rome Even in a country of exquisite cities like Italy, Rome is special. Epic, hot-blooded and achingly beautiful, it’s a heady mix of haunting ruins, awe-inspiring art, iconic monuments and vibrant street life. Rome’s historic cityscape, the result of 3000 years ROME of ad hoc urban development, is an exhilarating spectacle. Ancient icons such as the Colosseum, TOP SIGHTS, AUTHENTIC EXPERIENCES Roman Forum and Pantheon recall its golden age as caput mundi (capital of the world), while barn- storming basilicas testify to its historical role as seat of the Catholic Church. The city’s artistic heritage is also astonishing. Throughout history, Rome has starred in the great upheavals of Western art, drawing the top artists of the day and inspiring them to push the boundaries of creative achievement. The result is a city awash with priceless treasures. Ancient statues adorn world-class museums, Byzantine mosaics and Renaissance frescoes dazzle in art-rich churches, baroque fountains embellish medieval piazzas. Walk around the centre and without even trying you’ll come across masterpieces by the likes of Michelangelo, Caravaggio, Raphael and Bernini. But a trip to Rome is as much about lapping up the dolce vita lifestyle as gorging on art and culture. Whiling away hours at streetside cafes, idling on pretty piazzas, dining in boisterous neighbourhood trattorias – these are all an integral and enjoyable part of the Roman experience. Rome is special...epic, Duncan Garwood, Nicola Williams hot-blooded and achingly beautiful St Peter’s Basilica at dusk MAPICS/SHUTTERSTOCK © 000-title-opener-bo-rom3.indd0-title-opener-bo-rom3.indd 1 223/05/20183/05/2018 115:11:485:11:48 2# 0500m N# 00.25miles 2 PLAN YOUR TRIP ROME Villa Borghese & Northern Rome A Villa BorgheseEncompasses & the glorious park of Villa Museo e Basilica di NorthernBorghese Rome and the A Galleria Santa Maria city’s cultural hub. -

Centro Storico
PDF Rome Centro Storico (PDF Chapter) Edition 9th Edition, Jan 2016 Pages 37 Page Range 70–97, 214–222 COVERAGE INCLUDES: Useful Links • Neighbourhood Top • Sleeping Five Want more guides? Head to our shop • Local Life • Getting There & Trouble with your PDF? Away Trouble shoot here • Sights Need more help? • Eating Head to our FAQs • Drinking & Nightlife Stay in touch • Entertainment Contact us here • Shopping © Lonely Planet Publications Pty Ltd. To make it easier for you to use, access to this PDF chapter is not digitally restricted. In return, we think it’s fair to ask you to use it for personal, non-commercial purposes only. In other words, please don’t upload this chapter to a peer-to-peer site, mass email it to everyone you know, or resell it. See the terms and conditions on our site for a longer way of saying the above – ‘Do the right thing with our content’. ©Lonely Planet Publications Pty Ltd 70 Centro Storico PANTHEON | PIAZZA NAVONA | CAMPO DE’ FIORI | JEWISH GHETTO | ISOLA TIBERINA | PIAZZA COLONNA Neighbourhood Top Five io o rz anz 0000 a Bri a COLON0000NA M a n 0000 e i Vi t f c 1 gt on n Lu 0000 Stepping into the L M i a 0000 i ro ia d tti V 0000 ia c refe del Co 0000 Pantheon (p72) and feeling P V S ei d 0000 a ia l 0000 the same sense of awe that l V 0000 V e ia dell'O rs rso d the ancients must have felt o a i V 2000 years ago. -

Best of Rome 2020 Preview
Welcome to Rome An intoxicating cocktail of haunting ruins, iconic monuments, awe-inspiring art and vibrant street life, Italy’s hot-blooded capital is one of the world’s most charis- matic cities. It’s la dolce vita (the sweet life) at its Italian best. Rome’s historic cityscape, the result of 3000 years of ad hoc urban development, is an exhilarating spectacle. Ancient icons such as the Colosseum, ROME Roman Forum and Pantheon recall its golden age as TOP SIGHTS, AUTHENTIC EXPERIENCES caput mundi (capital of the world), while barn- storming basilicas testify to its historical role as seat of the Catholic Church. The city’s artistic heritage is also astonishing. Throughout history, Rome has starred in the great upheavals of Western art, drawing the top artists of the day and inspiring them to push the boundaries of creative achievement. The result is a city awash with priceless treasures. Ancient statues adorn world-class museums; Byzantine mosaics and Renaissance frescoes dazzle in art-rich churches; and baroque fountains embellish medieval piazzas. Walk around the centre and without even trying you’ll come across masterpieces by the likes of Michelangelo, Caravaggio, Raphael and Bernini. But a trip to Rome is as much about lapping up the local lifestyle as feasting on art and culture. Whiling away hours on a sun-baked cafe terrace, getting lost in backstreet alleys and hidden piazzas, indulging in sunset aperitivi (evening drinks) in on-trend cocktail bars, dining after dark in raucous neighbourhood trattorias – all this, too, is part and parcel of the exquisite Roman experience. -

Deliberazione N. 47 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'assemblea CAPITOLINA
Protocollo RC n. 14590/17 Deliberazione n. 47 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA Anno 2018 VERBALE N. 20 Seduta Pubblica del 17 aprile 2018 Presidenza: DE VITO - STEFÀNO L’anno 2018, il giorno di martedì 17 del mese di aprile, alle ore 15 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI. Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all’appello dei Consiglieri. Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 Consiglieri: Agnello Alessandra, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria. ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri: Angelucci Nello, Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, Di Biase Michela, Di Palma Roberto, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Tranchina Fabio. Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Montella e Tranchina hanno giustificato la propria assenza. -

Il Mercato Degli Immobili Di Pregio Milano E Roma H1- H2 2016
IL MERCATO DEGLI IMMOBILI DI PREGIO MILANO E ROMA SETTORE RESIDENZIALE H1- H2 2016 Con il contributo scientifico di INDICE Introduzione Analisi socio-demografica e dotazione immobiliare delle zone di Milano Analisi socio-demografica e dotazione immobiliare delle zone di Roma Il mercato degli immobili di pregio a Milano e Roma Sintesi delle zone di Milano Sintesi delle zone di Roma Pipeline delle residenze di lusso a Milano e Roma Rapporto sul mercato delle residenze esclusive anno 2016 Nomisma – Santandrea Luxury Houses Gabetti Property Solutions Agency S.p.A – Divisione Santandrea Luxury Houses Via Bernardo Quaranta, 40 20139 Milano www.immobilisantandrea.it Con il contributo scientifico di: Nomisma – Società di Studi Economici S.p.A. Strada Maggiore, 44 40125 Bologna www.nomisma.it Responsabili del progetto Fabio Guglielmi - Direttore Generale, Santandrea Luxury Houses Claudio Casali – RE Private Manager Milano e Torino, Santandrea Luxury Houses Flavio Angeletti – RE Private Manager Roma e Firenze, Santandrea Luxury Houses Francesca Fantuzzi – Responsabile Ufficio Studi Gabetti Gianluigi Chiaro – Nomisma Team di progetto Johnny Marzialetti (Nomisma) Giovanni Salvarani (Nomisma) Federica Coscia (Nomisma) Manuela Massa (Santandrea Luxury Houses Roma) Laila Carro (Santandrea Luxury Houses Roma) Mariagrazia Cascio (Santandrea Luxury Houses Milano) Collaborazione a sezione pipeline cantieri: Nadia Crisafulli (Operations Manager - Patrigest) Mario Paolazzi (Analyst - Patrigest) Premessa e metodologia Il Rapporto “Il Mercato degli Immobili di pregio a Milano e Roma – Settore residenziale H1-H2 2016” Nomisma - Santandrea Luxury Houses nasce dalla trentennale esperienza maturata da Nomisma, nell’attività di analisi e di consulenza immobiliare, e dalla posizione di rilievo di Santandrea Luxury Houses nel mercato dell’intermediazione di immobili di pregio nelle principali città italiane. -

160506 Rome.Pdf
ROME THE WORLD’S CHANGED. Technology now enables us to do so much more, but we can’t forget what it is that inspires us to explore. Whilst celebrating how wonderful technology is, it’s also good to lift your eyes away from the screen and truly get under the skin of a place, seeing it through the eyes of a local. ENCOURAGING CONVERSATIONS, AND DISCOVERING WHERE THEY WILL TAKE YOU. ROME Our fifth installment takes you to the beautiful streets of Rome. Experience our own recommendations, whilst starting the conversation and discovering your own favourite hot spots. Italy FCO Italian EUR +39 Where’s the best place to see the whole city? 1 West of the Tiber, rising above the Trastavere district south of Vatican City, the best panoramic views of the city can be found on Gianicolo (Janiculum) Hill, sweeping across the Roman rooftops from the beautiful Borghese complex to the curving Colosseum. Ask a passing couple where their favourite bar in Trastavere is, and make your way down. Passeggiata del Gianicolo Trastavere Ottoviano Where’s the best place to drink in the views? 2 The luxurious Grand Hotel de la Minerve is home to the Minerva Roof Garden, an exclusive restaurant that also serves up incredible views. Ask your waiter what that beautiful domed building in the distance is (take your pick; there are several) and plan to make your way there tomorrow. Piazza della Minerva 69 Pigna Colosseo Where’s the best place to take a stroll? 3 The Centro Storico can be surprisingly steep, so take this downhill route: start at Piazza del Popolo, checking out the Villa Borghese before making your way down towards the Spanish Steps. -

One Perfect Day Rome
ONE PERFECT DAY RomeAncient monuments and bold new architecture, traditional trattoria and sleek bars, local haunts and tourist traps – all manage to coexist in the colour and chaos of Italy’s Eternal City. WORDS LEE MARSHALL PHOTOGRAPHY NASSIMA ROTHACKER The Colosseum Home to emperors, popes and Italian presidents, the Eternal City is a fascinating historical layer cake, but also a vibrant contemporary capital with a vocation for good food and wine. Quartieri of the moment include boho-chic Monti and the new cultural hub, Flaminio, but don’t write off Centro Storico (old Rome) where cool insider venues sit cheek by jowl with tourist magnets such as Piazza Navona and the Trevi Fountain. Dog-walking contessas and businessmen on their way to work 07:30 stop here for some of Rome’s best The most central of the Roman coffee and house-baked pastries such aristocratic estates that have become as girella (sponge roll) studded with public parks, Villa Borghese is every sultanas and pine nuts. Grab a terrace local jogger’s favourite workout space. table and watch the Roman street In its 80 landscaped hectares, which theatre unfold in the piazza. take in formal gardens and woody glades, the running route combos are endless (fitrunning.it/borghese.htm). Clockwise: retro 10:00 scooter; inside Dive into the church of Santa Maria church of Santa del Popolo, just across the square, Maria del Popolo (9am); L’Asino where Caravaggio’s two dramatically 09:00 d’Oro delight (12pm); Something of a tourist trap from lit canvases in the Cerasi Chapel come fashion at Tina lunchtime on, the elegant 1920s across as frozen cinema – three and Sondergaard (11am) aperitivo spot and literary cafe, Rosati, a half centuries before filmmaker Opposite: Villa in Piazza del Popolo (barrosati.com) Federico Fellini, who lived just Borghese (7.30am); coffee at Rosati is more relaxed in the morning.