Roma Dopo GR
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Influence of International Town Planning Ideas Upon Marcello Piacentini’S Work
Bauhaus-Institut für Geschichte und Theorie der Architektur und Planung Symposium ‟Urban Design and Dictatorship in the 20th century: Italy, Portugal, the Soviet Union, Spain and Germany. History and Historiography” Weimar, November 21-22, 2013 ___________________________________________________________________________ About the Internationality of Urbanism: The Influence of International Town Planning Ideas upon Marcello Piacentini’s Work Christine Beese Kunsthistorisches Institut – Freie Universität Berlin – Germany [email protected] Last version: May 13, 2015 Keywords: town planning, civic design, civic center, city extension, regional planning, Italy, Rome, Fascism, Marcello Piacentini, Gustavo Giovannoni, school of architecture, Joseph Stübben Abstract Architecture and urbanism generated under dictatorship are often understood as a materialization of political thoughts. We are therefore tempted to believe the nationalist rhetoric that accompanied many urban projects of the early 20th century. Taking the example of Marcello Piacentini, the most successful architect in Italy during the dictatorship of Mussolini, the article traces how international trends in civic design and urban planning affected the architect’s work. The article aims to show that architectural and urban form cannot be taken as genuinely national – whether or not it may be called “Italian” or “fascist”. Concepts and forms underwent a versatile transformation in history, were adapted to specific needs and changed their meaning according to the new context. The challenge is to understand why certain forms are chosen in a specific case and how they were used to create displays that offer new modes of interpretation. The birth of town planning as an architectural discipline When Marcello Piacentini (1881-1960) began his career at the turn of the 20th century, urban design as a profession for architects was a very young discipline. -

Regione Lazio
REGIONE LAZIO Direzione: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA Area: SUPPORTO AI COMUNI PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DETERMINAZIONE (con firma digitale) N. G13489 del 13/11/2020 Proposta n. 17157 del 06/11/2020 Oggetto: L.R.38/1999-DGR n.855 del 20/12/2018- Bando di concessione contributi ai Comuni, ad esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di opere e lavori pubblici finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici, ex L.R. n. 38/1999. Presa d'atto dei lavori della Commissione. Proponente: Estensore LO GATTO GIULIA _________firma elettronica______ Responsabile del procedimento LO GATTO GIULIA _________firma elettronica______ Responsabile dell' Area F. BISOGNI __________firma digitale________ Direttore Regionale M. MANETTI __________firma digitale________ Firma di Concerto Pagina 1 / 12 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI OGGETTO: L.R.38/1999-DGR n.855 del 20/12/2018- Bando di concessione contributi ai Comuni, ad esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di opere e lavori pubblici finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici, ex L.R. n. 38/1999. Presa d’atto dei lavori della Commissione. IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA Su proposta del Dirigente dell’Area Supporto ai Comuni per la Pianificazione Urbanistica il Recupero dei Centri storici e la Riqualificazione Urbana VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. -

Former Political Prisoners and Exiles in the Roman Revolution of 1848
Loyola University Chicago Loyola eCommons Dissertations Theses and Dissertations 1989 Between Two Amnesties: Former Political Prisoners and Exiles in the Roman Revolution of 1848 Leopold G. Glueckert Loyola University Chicago Follow this and additional works at: https://ecommons.luc.edu/luc_diss Part of the History Commons Recommended Citation Glueckert, Leopold G., "Between Two Amnesties: Former Political Prisoners and Exiles in the Roman Revolution of 1848" (1989). Dissertations. 2639. https://ecommons.luc.edu/luc_diss/2639 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Theses and Dissertations at Loyola eCommons. It has been accepted for inclusion in Dissertations by an authorized administrator of Loyola eCommons. For more information, please contact [email protected]. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License. Copyright © 1989 Leopold G. Glueckert BETWEEN TWO AMNESTIES: FORMER POLITICAL PRISONERS AND EXILES IN THE ROMAN REVOLUTION OF 1848 by Leopold G. Glueckert, O.Carm. A Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School of Loyola University of Chicago in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy May 1989 Leopold G. Glueckert 1989 © All Rights Reserved ACKNOWLEDGEMENTS As with any paper which has been under way for so long, many people have shared in this work and deserve thanks. Above all, I would like to thank my director, Dr. Anthony Cardoza, and the members of my committee, Dr. Walter Gray and Fr. Richard Costigan. Their patience and encourage ment have been every bit as important to me as their good advice and professionalism. -

The Porta Del Popolo, Rome Pen and Brown Ink on Buff Paper
Muirhead BONE (Glasgow 1876 - Oxford 1953) The Porta del Popolo, Rome Pen and brown ink on buff paper. Signed Muirhead Bone at the lower right. 222 x 170 mm. (8 3/4 x 6 5/8 in.) One of the first trips that Muirhead Bone made outside Britain was a long stay of two years - from October 1910 to October 1912 – in central and northern Italy, accompanied by his wife Gertrude and their children. After spending several weeks in Florence, the Bone family settled in Rome in the early months of 1911, and from October 1911 lived in a flat overlooking the Piazza del Popolo. During his time in Italy Bone produced thirty-two copper plates and numerous fine drawings, several of which were sent from Italy to London and Glasgow to be sold by his dealers. A number of Bone’s drawings of Italy were exhibited at the Colnaghi and Obach gallery in London in 1914, to very positive reviews. The present sheet depicts part of the outer façade of the city gate known as the Porta del Popolo, a section part of the Aurelian Walls encircling the city of Rome. The gate was the main entrance to Rome from the Via Flaminia and the north, and was used by most travellers arriving into the city for the first time. Built by Pope Sixtus IV for the Jubilee year of 1475, the Porta del Popolo was remodelled in the 16th century under Pope Pius IV. The Pope had asked Michelangelo to design the new outer façade of the Porta, but the elderly artist passed the commission on to the architect Nanni di Baccio Bigio, who completed the work between 1562 and 1565. -

A Literary Journey to Rome
A Literary Journey to Rome A Literary Journey to Rome: From the Sweet Life to the Great Beauty By Christina Höfferer A Literary Journey to Rome: From the Sweet Life to the Great Beauty By Christina Höfferer This book first published 2017 Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2017 by Christina Höfferer All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-4438-7328-4 ISBN (13): 978-1-4438-7328-4 CONTENTS When the Signora Bachmann Came: A Roman Reportage ......................... 1 Street Art Feminism: Alice Pasquini Spray Paints the Walls of Rome ....... 7 Eataly: The Temple of Slow-food Close to the Pyramide ......................... 11 24 Hours at Ponte Milvio: The Lovers’ Bridge ......................................... 15 The English in Rome: The Keats-Shelley House at the Spanish Steps ...... 21 An Espresso with the Senator: High-level Politics at Caffè Sant'Eustachio ........................................................................................... 25 Ferragosto: When the Romans Leave Rome ............................................. 29 Myths and Legends, Truth and Fiction: How Secret is the Vatican Archive? ................................................................................................... -

Roman Literature from Its Earliest Period to the Augustan Age
The Project Gutenberg EBook of History of Roman Literature from its Earliest Period to the Augustan Age. Volume I by John Dunlop This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at http://www.gutenberg.org/license Title: History of Roman Literature from its Earliest Period to the Augustan Age. Volume I Author: John Dunlop Release Date: April 1, 2011 [Ebook 35750] Language: English ***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK HISTORY OF ROMAN LITERATURE FROM ITS EARLIEST PERIOD TO THE AUGUSTAN AGE. VOLUME I*** HISTORY OF ROMAN LITERATURE, FROM ITS EARLIEST PERIOD TO THE AUGUSTAN AGE. IN TWO VOLUMES. BY John Dunlop, AUTHOR OF THE HISTORY OF FICTION. ivHistory of Roman Literature from its Earliest Period to the Augustan Age. Volume I FROM THE LAST LONDON EDITION. VOL. I. PUBLISHED BY E. LITTELL, CHESTNUT STREET, PHILADELPHIA. G. & C. CARVILL, BROADWAY, NEW YORK. 1827 James Kay, Jun. Printer, S. E. Corner of Race & Sixth Streets, Philadelphia. Contents. Preface . ix Etruria . 11 Livius Andronicus . 49 Cneius Nævius . 55 Ennius . 63 Plautus . 108 Cæcilius . 202 Afranius . 204 Luscius Lavinius . 206 Trabea . 209 Terence . 211 Pacuvius . 256 Attius . 262 Satire . 286 Lucilius . 294 Titus Lucretius Carus . 311 Caius Valerius Catullus . 340 Valerius Ædituus . 411 Laberius . 418 Publius Syrus . 423 Index . 453 Transcriber's note . 457 [iii] PREFACE. There are few subjects on which a greater number of laborious volumes have been compiled, than the History and Antiquities of ROME. -

In Lazio, Umbria E Toscana Ci Sono Antichi Borghi Dove Rivivere Culture E Tradizioni Di Un Tempo. Tour Operator
Tour Operator In Lazio, Umbria e Toscana ci sono antichi borghi dove rivivere culture e tradizioni di un tempo. Tour Operator Pensiamo e realizziamo viaggi per vivere le tradizioni ancora custodite in luoghi lontani dal turismo di massa. “Ogni volta che costruisco un tour per un cliente la mia mente vola in quei luoghi. È come se fossi lì a respirare quell’aria... Che bello! È affascinante e straordinariamente coinvolgente. Amo il mio lavoro” Stefano Capoccioni Try Nature www.trynature.it 1 La città scelta dai Papi, nel cuore della Tuscia. viterbo Dal contrasto tra le vecchie e le nuove tendenze artistiche gli umili costruttori viterbesi del dodicesimo secolo seppero trarre, con innato e tradizionale senso dell’arte, gli elementi per abbellire ed in- gentilire le loro case creando un proprio stile che desta sorpresa e ammirazione. Non per la grandiosità degli edifici, sibbene per la originalità dei particolari per la eleganza degli ornati, per l’ardi- tezza delle scale esterne o per lo slancio dei balconi, ogni abitazione, anche la più modesta, si distingue e si nobilita nell’ar- monia dell’insieme. Forse è per questo che tutto il quartiere di San Pellegrino ha conservato pressoché immutato, per tanti secoli, il suo origi- nario aspetto attraverso il quale pare di sentire lo spirito. A.D. 1961 Associazione Amici dei Monumenti 2 3 Questo borgo è stato nei secoli chiamato dai poeti “La città che muore” per via dei lenti franamenti della montagna sulla quale è adagiato; oggi, come uno scrigno, conserva le culture e le tradizioni di un tempo. -
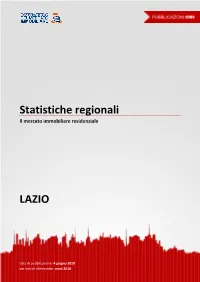
Statistiche Regionali Lazio 2019
Statistiche regionali Il mercato immobiliare residenziale LAZIO data di pubblicazione: 4 giugno 2019 periodo di riferimento: anno 2018 a cura della Direzione Regionale Lazio (Moreno Balestro) in collaborazione con Ufficio Provinciale Territorio di Roma (Emanuela Fantaccione) Direzione provinciale di Frosinone – Ufficio Provinciale Territorio (Giovanni De Vincentis) Direzione provinciale di Latina – Ufficio Provinciale Territorio (Angela Sileo) Direzione provinciale di Rieti – Ufficio Provinciale Territorio (Alessandro Micheli) Direzione provinciale di Viterbo – Ufficio Provinciale Territorio (Laura Mencarini) Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare [email protected] data di pubblicazione: 4 giugno 2019 periodo di riferimento: anno 2018 Le informazioni rese nella presente nota sono di proprietà esclusiva dell’Agenzia delle Entrate. Non è consentito vendere, affittare, trasferire, cedere i dati contenuti in questa pubblicazione, o assumere alcune altre obbligazioni verso terzi. Le informazioni possono essere utilizzate, anche ai fini della loro elaborazione, purché, nel caso di pubblicazione, venga citata la relativa fonte. Indice Il mercato immobiliare residenziale della regione ....................................................................................................................................3 Le compravendite ................................................................................................................................................................................4 -

Rome: a New Planning Strategy
a selected chapter from Rome: A New Planning Strategy by Franco Archibugi draft of a forthcoming book to be published by Gordon and Breach, New York an overview of this book CHAPTER 5: THE NEW STRATEGY FOR ROME 1. The "Catchment Areas" of the New "Urban Centres" 2. The Spatial Distribution of the Catchment Areas Table 2 - Catchment Areas of the Roman Metropolitan System (by thousands of inhabitants) 3. What decentralization of services for the new "urban centres"? 4. What "City Architecture"? 5. What Strategy for "Urban Greenery"? 6. Programmed Mobility 7. A "Metropolitan" Residentiality Notes References Further Reading THE NEW STRATEGY FOR ROME Authentic "polycentrism", therefore, is founded first of all on an evaluation of the "catchment areas" of the services that define it. The location of the centers and infrastructures of such services is a subsequent question (we would say "secondary" if with this adjective is meant not inferiority in importance, but rather a temporal and conceptual subordination). The polycentrism supported here in Rome means, first of all, a theoretical assignation of the potentiality of the catchment area of the Roman system to respective "units" of service that locationally assume the 1 role of realizing the objectives, reasserted by everybody numerous times of: integrating functions, improving accessibility, distances, traveling times, not exceeding the thresholds that have been indicated as "overloading". The locational problem of the new strategy therefore, is posed as a problem of not letting all the users participate in any function in any part of the system (the 2,8 million Roman citizens plus the by now recognized other 700 thousand citizens of the Roman "system"); but to functionally distribute the services in such a way as to not render "indifferent" (but on the contrary very.. -

Socio-Spatial Inequalities and Urban Transformation. the Case of Rome
Socio-Economic Planning Sciences xxx (xxxx) xxx–xxx Contents lists available at ScienceDirect Socio-Economic Planning Sciences journal homepage: www.elsevier.com/locate/seps Socio-spatial inequalities and urban transformation. The case of Rome districts ∗ Keti Leloa, Salvatore Monnib, , Federico Tomassic a Department of Business Studies, Roma Tre University, Via Silvio D'amico 77, Rome, 00145, Italy b Department of Economics, Roma Tre University; Via Silvio D'amico 77, Rome, 00145, Italy c Italian Agency for Territorial Cohesion, Rome, Via Sicilia 162, Rome, 00187, Italy ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords: Over the past thirty years, public policy in Rome has failed to effectively address a rising level of socio-economic Socio-spatial inequalities inequality. Indicators such as level of education or number of household members appear to be geographically Mapping concentrated and sensitive to the distance from the city centre. The hypothesis that socio-spatial inequalities Periphery strongly influence economic performance and foster political instability has been subject to numerous empirical Rome investigations. Nevertheless, studies of specific urban contexts are not common. The absence of empirical ap- plications at this scale is probably due to the fact that variables used for analysing the economic and social performance of regions are difficult to quantify or inapplicable at the micro level. The purpose of this paperisto examine the spatial distribution of socioeconomic inequalities in the municipal territory of Rome and to explore the conditions that account for them. We will analyse the spatial distribution of urban quality indicators and socio-economic profiles with data from different sources, aggregated at the neighbourhood level. 1. -

The Power of Images in the Age of Mussolini
University of Pennsylvania ScholarlyCommons Publicly Accessible Penn Dissertations 2013 The Power of Images in the Age of Mussolini Valentina Follo University of Pennsylvania, [email protected] Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/edissertations Part of the History Commons, and the History of Art, Architecture, and Archaeology Commons Recommended Citation Follo, Valentina, "The Power of Images in the Age of Mussolini" (2013). Publicly Accessible Penn Dissertations. 858. https://repository.upenn.edu/edissertations/858 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/edissertations/858 For more information, please contact [email protected]. The Power of Images in the Age of Mussolini Abstract The year 1937 marked the bimillenary of the birth of Augustus. With characteristic pomp and vigor, Benito Mussolini undertook numerous initiatives keyed to the occasion, including the opening of the Mostra Augustea della Romanità , the restoration of the Ara Pacis , and the reconstruction of Piazza Augusto Imperatore. New excavation campaigns were inaugurated at Augustan sites throughout the peninsula, while the state issued a series of commemorative stamps and medallions focused on ancient Rome. In the same year, Mussolini inaugurated an impressive square named Forum Imperii, situated within the Foro Mussolini - known today as the Foro Italico, in celebration of the first anniversary of his Ethiopian conquest. The Forum Imperii's decorative program included large-scale black and white figural mosaics flanked by rows of marble blocks; each of these featured inscriptions boasting about key events in the regime's history. This work examines the iconography of the Forum Imperii's mosaic decorative program and situates these visual statements into a broader discourse that encompasses the panorama of images that circulated in abundance throughout Italy and its colonies. -

AAR Magazine
AMERICAN ACADEMY IN ROME MAGAZINE SPRING 2018 SPRING 2018 Welcome to the Spring 2018 issue UP FRONT IN CLOSING of AAR Magazine. 2 33 LETTER FROM THE PRESIDENT DONORS This issue highlights recent work and collabora- tions by our Rome Prize winners and Italian Fellows. 4 36 Because this year was the tenth anniversary of the FAR AFIELD WHEN IN ROME Scharoun Ensemble Berlin in Rome, we reflect on Checking in with past Fellows and Residents Three Fellows share their favorite places in Rome how the concert series began. The spring issue also anticipates a solo show of new work by Yto Barrada, 6 the Roy Lichtenstein Artist in Residence from last INTRODUCING fall, which—along with the Patricia H. Labalme The 2018–2019 Rome Prize winners Friends of the Library Lecture by Mary Roberts in and Italian Fellows March and a conference on Islamic art and architec- ture in May—are the culminating events of East and 10 West, the Academy’s thematic series of events for FROM THE ARCHIVES 2017–18. Ten years of Scharoun Ensemble Berlin Finally, we are excited to announce the 2018–19 Rome Prize winners and Italian Fellows! 11 IN RESIDENCE Vi diamo il benvenuto all’edizione Spotlighting recent Residents primaverile 2018 dell’AAR Magazine. 15 CONVERSATIONS/ CONVERSAZIONI Questo numero dà spazio alle opere e alle collabora- This season’s discussions in Rome and the US zioni recenti dei vincitori del Rome Prize e dei nostri Italian Fellows. Poiché quest’anno ricorre il decimo anniversario dello Scharoun Ensemble Berlin a Roma, ripercorriamo la storia della serie di concerti.