Pietracatella
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
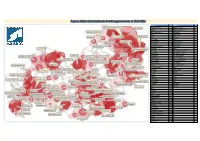
Cluster Molise
Regione Molise Casi Attualmente Positivi aggiornamento al: 28.03.2021 29/03/2021 60,00 Comune N° Comune N° Acquaviva d'Isernia 12 Petrella Tifernina 4 San Giacomo degli Schiavoni; 2 Termoli; 99 Agnone 51 Pettoranello del Molise 2 Baranello 10 Pietrabbondante 5 Montenero di Bisaccia; 3 Belmonte del Sannio 13 Pietracatella 1 Bojano 17 Portocannone 2 Bonefro 4 Pozzilli 2 Petacciato; 21 Campomarino; 29 Mafalda; 4 Busso 4 Provvidenti 3 Campobasso 105 Riccia 20 50,00 Portocannone; 2 Campodipietra 7 Rionero Sannitico 4 Guglionesi; 12 Campolieto 2 Ripalimosani 8 Campomarino 29 Roccamandolfi 1 Montecilfone; 1 Cantalupo nel Sannio 5 Roccavivara 2 Capracotta 8 Rotello 2 Capracotta; 8 San Martino in Pensilis; 19 Carpinone 2 San Giacomo degli Schiavoni 2 Casacalenda 16 San Giuliano di Puglia 6 Castelmauro 1 San Martino in Pensilis 19 Larino; 12 Trivento; 16 Castelpetroso 6 San Pietro Avellana 6 40,00 San Pietro Avellana; 6 Roccavivara; 2 Castelmauro; 1 Castelpizzuto 1 San Polo Matese 1 Castropignano 3 Santa Croce di Magliano 27 Belmonte del Sannio; 13 Guardialfiera; 2 Ururi; 3 Cercemaggiore 20 Santa Maria del Molise 1 Civitacampomarano; 4 Casacalenda; 16 Cercepiccola 1 Sant'Agapito 3 Agnone; 51 Montorio nei Frentani; 2 Cerro al Volturno 1 Sant'Angelo Limosano 2 Rionero Sannitico; 4 Chiauci 3 Sant'Elia a Pianisi 1 Rotello; 2 Civitacampomarano 4 Sepino 10 Pietrabbondante; 5 Lucito; 1 Bonefro; 4 Montelongo; 3 Colletorto 9 Sesto Campano 1 Ferrazzano 8 Spinete 1 30,00 Vastogirardi; 7 Pescolanciano; 4 Sant'Angelo Limosano; 2 Filignano 2 Termoli 99 Chiauci; -

MOLISE - DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE Servizio Prevenzione, Veterinaria E Sicurezza Alimentare Ufficio Sicurezza Alimentare
REGIONE MOLISE - DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare Ufficio Sicurezza Alimentare ELENCO DEGLI ALLEVATORI CHE COMPRANO IL MANGIME DA SOMMINISTRARE AGLI ANIMALI E CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI DEPOSITO E STOCCAGGIO (art. 5, comma 1 Reg. (CE) n. 183/2005) ASREM - SEDE OPERATIVA DI AGNONE N. Cod_Aziendale Nome e Cognome o Ragione Sociale SEDE CODIFICA 1 002IS012 DE SIMONE VANDALINA AGNONE 4 2 002IS022 DI SABATO ROCCO AGNONE 4 3 002IS030 MARCOVECCHIO GELSUMINA AGNONE 4 4 002IS043 CELLILLI FILOMENA AGNONE 4 5 002IS044 CELLILLI FLORINDO AGNONE 4-6 6 002IS053 DI PIETRO GIANLUCA AGNONE 4 7 002IS059 GUALDIERI GIUSEPPINA AGNONE 4 8 002IS061 DI MARIO CARMINE AGNONE 4 9 002IS063 D'AGNILLO LUCIA AGNONE 4 10 002IS066 LONGHI GIOVINA AGNONE 4 11 002IS068 DI PINTO ANNAMARIA AGNONE 4 12 002IS070 LONGO IDA AGNONE 4 13 002IS079 PANNUNZIO GINO AGNONE 4-6 14 002IS081 PANNUNZIO NICOLA AGNONE 4-6 15 002IS082 PANNUNZIO TONINO AGNONE 4-6 16 002IS084 PANNUNZIO GENUINO AGNONE 4-6 17 002IS086 MARCOVECCHIO RACHELINA AGNONE 4 18 002IS087 PANNUNZIO ANGIOLINA AGNONE 4-6 19 002IS090 PALLOTTO DILIA AGNONE 4 20 002IS091 BUOSCIO GIUSEPPE AGNONE 4-6 21 002IS092 DI MENNA BINA AGNONE 4 22 002IS095 DIANA ERCOLINO AGNONE 4 23 002IS096 DIANA MICHELE AGNONE 4-6 24 002IS098 DIANA SANDRA AGNONE 4 25 002IS099 LAURIENTE BRUNO AGNONE 4 26 002IS100 ORLANDO ROCCO AGNONE 4 27 002IS101 ORLANDO ANGELO AGNONE 4-6 28 002IS103 ORLANDO CESARE AGNONE 4 29 002IS105 ORLANDO GIUSEPPE AGNONE 4 30 002IS106 ORLANDO MERCEDE AGNONE 4 31 002IS107 ORLANDO -

Diapositiva 1
Le attività della Regione Molise nel Progetto ENERWOOD Metodologie per lo studio del potenziale da biomasse della Regione Molise Gruppo di lavoro progetto ENERWOOD Regione Molise N. Colonna ENEA A. Occhionero, R. Petti TASK FORCE AUTORITÀ AMBIENTALE P. De Pari, P. Gioia GEOSERVIZI srl Programmazione Energetica e Ruolo delle Biomasse Centrum Palace Hotel Campobasso, 4 dicembre 2007 Organizzazione della presentazione Scopi e metodologia Organizzazione database e risultati preliminari Elaborazioni cartografiche e analisi GIS 2 La stima delle biomasse • Le biomasse sono per loro natura disperse sul territorio. • Per “sfruttare” le biomasse è necessario sapere non tanto, o non solo, quante sono ma dove esse sono. • Qualsiasi impiego non può prescindere dalla fase di raccolta e concentrazione. • Il processo di trasformazione più idoneo dipende dalle caratteristiche della biomassa Umidità, Rapporto C/N, PCI 3 Quali biomasse? Residuali dal settore agricolo, Biomasse di provenienza forestale, Biomasse residuali dal settore agro-industriale. Classificate per origine e/o tipologia e/o caratteristiche fisico- chimiche 4 Obiettivo del lavoro • Quante • Dove • Tipo ……..meglio: Quante x Dove x Tipo Livello minimo di restituzione: comunale Disporre di questa informazione costituisce la base per valutare le opzioni di politica energetica, consente di valutare progetti presentati a livello regionale, permette di pianificare azioni o definire politiche mirate, valutare costi. 5 Quante biomasse ? Molise, su base annua migliaia di tonnellate CAMPOBASSO -

The Extra Virgin Olive Oil Must Be Marketed in Bottles Or Containers of Five Litres Or Less
29.10.2002EN Official Journal of the European Communities C 262/9 4.8. Labelling: The extra virgin olive oil must be marketed in bottles or containers of five litres or less. The name ‘Alto Crotonese PDO’ must appear in clear and indelible characters on the label, together with the information specified in the rules governing labelling. The graphic symbol relating to the special distinctive logo to be used in conjunction with the PDO must also appear on the label. The graphic symbol consists of an ellipse enclosing, on a hill in the foreground, the bishop's palace of Acherentia, with the sky as a background. The colours used are brown 464 C for the bishop's palace, green Pantone 340 C for the hill on which it stands and blue Pantone 2985 C for the sky (see Annex). 4.9. National requirements: — EC No: G/IT/00200/2001.06.14. Date of receipt of the full application: 8 July 2002. Publication of an application for registration pursuant to Article 6(2) of Regulation (EEC) No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin (2002/C 262/05) This publication confers the right to object to the application pursuant to Article 7 of the abovementioned Regulation. Any objection to this application must be submitted via the competent authority in the Member State concerned within a time limit of six months from the date of this publication. The arguments for publication are set out below, in particular under point 4.6, and are considered to justify the application within the meaning of Regulation (EEC) No 2081/92. -

Importexport Catalogo Delle Aziende Molisane
IMPORTEXPORT CATALOGO DELLE AZIENDE MOLISANE IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT SOMMARIO SETTORE AGROALIMENTARE 8 SETTORE ARTIGIANATO 34 SETTORE ARREDAMENTO 38 SETTORE COMMERCIO 42 SETTORE COSTRUZIONI 50 SETTORE ELETTRONICA 54 SETTORE INFORMATICA 58 SETTORE IMPIANTISTICA 60 SETTORE LEGNO 62 SETTORE MECCANICA 66 SETTORE PLASTICA 70 SETTORE SERVIZI 72 SETTORE TESSILE 74 SETTORE TURISMO 78 IMPORT EXPORT Realizzazione Grafica: Omnia Service di Angelo Leccese C.da Colle delle Api, 07/B - 8600 Campobasso - Tel./Fax: 087.8785 www.omniaservicemolise.com - [email protected] IMPORT EXPORT PRESENTAZIONE L’idea di creare il primo catalogo import - export delle aziende molisane nasce dall’esi - genza di fornire agli operatori economici, alle organizzazioni e alle istituzioni estere una guida completa e di facile consultazione delle imprese che, nei diversi settori economici, sono artefici dell’affermazione del“Sistema Molise” nel mondo. Avere a disposizione in un unico strumento conoscitivo tutte le informazioni su un ter - ritorio, attraverso le sue aziende, e sulle sue produzioni costituisce un elemento indispen - sabile per accompagnare le numerose iniziative di promozione del processo di internazionalizzazione delle imprese molisane, realizzate da Unioncamere Molise, attraverso lo sportello SPRINT, Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione, nato dalla collabora - zione con Regione Molise, Ministero delle Attività Produttive, ICE, SIMEST e SACE. Lo stretto legame tra imprese e Unioncamere Molise ha consentito di “inventariare” in un’unica guida il ricco patrimonio di conoscenze del sistema camerale sugli operatori mo - lisani che quotidianamente si adoperano per raggiungere i mercati di tutto il mondo. La pubblicazione, che rientra tra le attività di promozione dell’internazionalizzazione delle imprese molisane (POR Molise 000-006, Azione . -

Contratto Istituzionale Di Sviluppo Molise
Contratto Istituzionale di Sviluppo Molise Roma, 09 Luglio 2019 Progetti immediatamente realizzabili Stadio di maturità Importo proposto a valere Proponente Descrizione oggetto progettuale sul CIS (Mln/€) Sviluppo turistico lungo i tratturi: Campodipietra + - recupero e valorizzazione del percorso tratturale Pre-fattibilità 129.391.270,50 € 61 comuni - incentivazione e potenziamento dell'offerta turistica La dotazione finanziaria assegnata al progetto è coerente con l’attuale stato dell’elaborazione progettuale. La proposta comprende altresì un insieme di interventi presentati singolarmente da vari Comuni: Bonefro Recupero e valorizzazione del centro storico, strategie per il riuso Fattibilità Chiessa parrocchiale S. M. Assunta: restauro, rifacimento copertura, messa in Ripamolisani Esecutivo sicurezza, ripristino pavimentazione ecc. Jelsi Realizzazione di un percorso “slow travel” Esecutivo Jelsi Recupero Complesso Santa Maria delle Grazie Esecutivo Recupero e adeguamento locali Chiesa Madre per creazione Centro di Ripamolisani Definitivo Documentazione e Ricerca Civitanova del Progetto per la creazione del sistema Tratturi Fattibilità Sannio Toro Interventi sul Tratturo ed aree tratturali + Ponte romanico di Toro Preliminare Toro Interventi sul chiostro e sul convento Santa Maria di Loreto Preliminare Jelsi Recupero funzionale del Centro storico comunale Fattibilità Toro Interventi strutturali sugli immobili (esproprio e ristrutturazione) Preliminare Recupero di un’azienda agricola comunale per la produzione di prodotti agricoli Jelsi -

Studio Di Incidenza, Elaborato in Ottemperanza Alle Disposizioni Con- Tenute Nell'art
SOMMARIO PREMESSA ............................................................................................................................................. 2 ELENCO DEGLI ACRONIMI UTILIZZATI...................................................................................... 3 INTRODUZIONE ...................................................................................................................................... 4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO ............................................................................................................... 6 CARATTERISTICHE DEL PIANO / PROGETTO ........................................................................................... 9 INQUADRAMENTO AMBIENTALE DI AREA VASTA ............................................................... 28 IL PAESAGGIO DELLA PROVINCIA ....................................................................................................... 31 INQUADRAMENTO FAUNISITICO .......................................................................................................... 37 I SIC E LE ZPS DEL TERRITORIO PROVINCIALE....................................................................... 40 VALUTAZIONE DELLE INCIDENZE ....................................................................................................... 44 RELAZIONI SPAZIALI TRA I SIC DELLA PROVINCIA E GLI ISTITUTI FAUNISTICI E RELATIVE ................... INCIDENZE .......................................................................................................................................... -

Interreg IPA CBC Programme Italy - Albania Montenegro Targeted Call for Project Proposals Template for Expression of Interest (Eoi)
Interreg IPA CBC Programme Italy - Albania Montenegro Targeted call for project proposals Template for Expression of Interest (EoI) Organisation name in original language and in English Comune di Jelsi(CB) , Municipality of JELSI(IS) Background and expertise Please briefly present your organisation (e.g. its type, scope of work, areas of activity and if applicable, number of staff members). Max 750 characters. Jelsi is an Italian town of 1,769 inhabitants, in the province of Campobasso, in Molise. The most important event that takes place in Jelsi, and which attracts many tourists every year, is the Festival of the wheat in honor of Sant'Anna. The festival is very old, it began as thanks for the minor damages suffered by the community after the earthquake of 1805, and became, from the second half of the 20th century, one of the most representative festivals of Molise and Italian agriculture. The Municipality is very active in the initiatives of territorial development and promotion of sustainable tourism. Indeed, the municipal administration participates in various projects to promote the cultural and historical wealth of the country. Profile of your organization Please tick the box. Public bodies Bodies governed by public law Non-profit organisations, established according to the applicable legal framework/law in the respective country Select one or more specific objectives. please note that for 1.1. only small scale project are admitted and for 3.1 is not admitted Template for EoI January 2019 Page 1 Please tick the box. S.O. 1.1. S.O. 2.1. S.O. 2.2. -

Agenzia Agorà Società Cooperativa Sociale
Ente accreditato alla sezione nazionale dell’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale - Codice SU00011 AGENZIA AGORÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AGGIORNATO AL 17 DICEMBRE 2020 Curriculum Vitae e presentazione 1 Ente accreditato alla sezione nazionale dell’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale - Codice SU00011 INDICE Presentazione 1. CONFIGURAZIONE SOCIETARIA pag. 3 2. OGGETTO SOCIALE pag. 5 3. ATTIVITÀ pag. 8 4. BILANCIO pag. 19 2 5. STRUTTURA AZIENDALE pag. 25 Ente accreditato alla sezione nazionale dell’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale - Codice SU00011 Presentazione L’Agenzia Agorà Società Cooperativa Sociale ONLUS (di seguito per brevità Agorà), è impegnata, da oltre un decennio, nella gestione di progetti di servizio civile nazionale nei vari settori d’intervento previsti dalla legge 68/011 nonché nell’erogazione di altri servizi sociali. Dal 2008 è iscritta alla prima classe dell’Albo Nazionale degli enti di servizio civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 1. CONFIGURAZIONE SOCIETARIA Costituita nel 2001, quale Associazione di Promozione e Sviluppo Sociale no profit ex lege 383/00, il 31 marzo 2017, con atto repertorio n. 48676, è stata trasformata in società cooperativa sociale ONLUS. Dal 21 aprile 2017, è iscritta alla C.C.I.A.A. di Avellino al n. 02280260643, con il n. REA 193276, e il n. C121517 presso l’Albo delle Società Cooperative - sezione cooperativa a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seguenti. Posizione Assicurativa INAIL n. 21062266 - Avellino Posizione Contributiva INPS n. 0805311448 Sede Legale e Operativa: Via Pasquale Greco 6 – 83100 Avellino (AV) 3 Sede secondaria: Via Luigi D’Amato n. -
From Predation to Management: Monitoring Wolf Distribution and Understanding Depredation Patterns from Attacks on Livestock
Published by Associazione Teriologica Italiana Volume 29 (1): 101–110, 2018 Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy Available online at: http://www.italian-journal-of-mammalogy.it doi:10.4404/hystrix–00070-2018 Research Article From predation to management: monitoring wolf distribution and understanding depredation patterns from attacks on livestock Elena Fabbri1, Edoardo Velli1, Federica D’Amico2, Marco Galaverni3, Luigi Mastrogiuseppe4, Federica Mattucci1, Romolo Caniglia1,∗ 1Area per la Genetica della Conservazione, ISPRA, Ozzano dell’Emilia Bologna, Italy 2Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Parma, Italy 3Area Conservazione, WWF Italia, Rome, Italy 4Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, Azienda Sanitaria Regionale Molise, Campobasso, Italy Keywords: Abstract Canis lupus genetic profile The Italian wolf population, close to extinction in the mid-19th century, now counts about 1800 indi- livestock predations viduals. Its ongoing expansion raises social conflicts, especially in agricultural and semi-urbanized non-invasive genetic monitoring areas. Thus, monitoring wolf distribution, abundance and impact on the farming economy is a pri- pack dynamics ority for conservation. We analysed canid DNA from 57 swabs from livestock kills, 13 faeces and pedigrees 21 carcasses, to estimate the minimum number of individuals, their genetic variability and taxon (wolf, dog or hybrids), reconstruct the structure of local wolf packs, and describe the possible hunt- Article history: ing patterns in a hitherto poorly investigated area of the Central Apennines. We genotyped, at the Received: 20 October 2017 mitochondrial DNA control region and at 12 autosomal and four Y-linked microsatellites, 38 swab, Accepted: 26 April 2018 three faecal and 19 muscular samples, corresponding to 42 individuals that Bayesian and Multivari- ate analyses assigned to 28 wolves, nine dogs and five admixed individuals. -

Archivio Di Stato Di Campobasso
ARCHIVIO DI STATO DI CAMPOBASSO Via Orefici 43 (cod. Post. 86100); tel. 0874164651. Consistenza totale: bb., fasci, fasce., volI. e regg. 43.416; pergg.299. Biblioteca: manoscritti 21, volI. 3.778, opuscoli 1.355 e riviste 1.035. Laboratorio di legatoria e restauro: via Larino 19. Servizio di fotoriproduzione. La voce è stata curata da Renata Pasquale De Benedittis. SOMMARIO Introduzione 785 Antichi regimi Corte marchionale poi Regia corte di Bonefro Regia corte di Campobasso Corte ducale poi Regia corte di Campolieto Barona1 corte di Casalciprano Barona1 corte di Ferrazzano Barona1 corte di Fossaceca Corte marchionale poi Regia corte di Macchia Valfortore Barona1 corte di Matrice Corte marchionale poi Regia corte di Montagano Regia corte di San Giovanni in Galdo Corte ducale poi Regia corte di Sant’Elia Regia corte di Toro Periodo napoleonico Intendenza di Molise Consiglio generale di amministrazione degli stabilimenti di beneficenza Corpo degli ingegneri di ponti e strade Giudicati di pace Tribunale di prima istanza Corte criminale Restaurazione Intendenza di Molise Sottointendenza di Larino 788 Consiglio generale degli ospizi u Corpo degli ingegneri di ponti e strade poi Corpo degli ingegneri di acque e strade H Giudicati circondariali )l 26. 784 Guida generale degli Archivi di Stato Tribunale civile 788 Gran corte criminale 789 Miscellanea di atti sul brigantaggio e processi politici )) Consiglio di guerra di guarnigione 0 II Prefettura Sottoprefettura di Larino Questura Uffici distrettuali delle imposte dirette Ufficio del genio civile Ufficio di leva di Campobasso Distretto militare di Campobasso Giudicature di mandamento Preture Tribunale di Campobasso 792 Procura del re presso il tribunale di Campobasso Tribunale di Larino Corte di assise di Campobasso Archivi notarili Catasti 797 Atti demaniali Stato civile 7;s Opere pie, istituzioni di assistenza e beneficenza, ospedali 799 Archivi di famiglie e di persone Raccolte e miscellanee 800 indice dei fondi 801 L’Archivio di Campobasso, previsto dal decreto 22 ott. -

51 the Wines of Molise
Ambassador National Italian American Foundation Vol . 31, No.1 n Fall 2019 n www.niaf.org Heritage Travel in Molise Is This Leonardo’s Lost Angel? Hiking the True Cinque Terre Saving NYC’s Historic Erben Organ A Festival of Sculpted Wheat NIAF Anniversary Gala Preview! Ambassador The Publication of the National Italian American Foundation Vol . 31, No.1 n Fall 2019 n www.niaf.org CONTENTS 34 Features 26 Heritage Travel in Molise 34 Hiking the True Cinque Terre Connecting Molisani Family Ties Beyond the Beaches and Tourists By Susan Van Allen By Rachel Bicha 5141 30 Leonardo’s Lost Angel? 38 Driving the Via Emilia Some Experts Believe da Vinci On the Mother Road of Made the Statue Found in Emilia-Romagna Patricia de Stacy Harrison San Gennaro Church By Silvia Donati Gabriel A. Battista Chairs By Paul Spadoni Don Oldenburg Director of Publications 41 Festival of the Great Grain Mother and Editor Molise’s Worldwide Gift of Natalie Wulderk Sculpted Wheat Communications Manager and Assistant Editor By Kirsten Keppel Gabriella Mileti Bottega NIAF Editor 44 No Pipe Dream AMBASSADOR Magazine The Master Organist Saving 44 is published by the National Italian American Foundation New York’s Historic On the Cover: (NIAF) 34 19th-Century Erben Organ 1860 19th Street NW A quaint street in Washington DC 20009 By Maria Garcia Oratino, a town in the POSTMASTER: Send change of address to Sections Province of Campobasso NIAF, 1860 19th Street NW Lettere 6 that becomes a Washington DC 20009 The North End Foundation Focus 10 48 destination in our ©2019 The National Italian NIAF On Location 15 Visiting Boston’s Little Italy cover story Heritage American Foundation (NIAF).