P.A.T.I. Della Lessinia Centrale Comune Di Bosco Chiesanuova P.A.T.I
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Relazione Paesaggistica.Pdf
1 INTRODUZIONE .......................................................................................................................... 3 1.1 Premessa .............................................................................................................................................. 3 2 DOCUMENTAZIONE TECNICA GENERALE STATO DEI LUOGHI ................................................... 4 2.1 Analisi dello stato dei luoghi .................................................................................................... 4 2.1.1 Inquadramento generale dell’area di intervento .............................................................................. 4 2.1.2 Inquadramento geologico - idrogeologico ........................................................................................ 6 2.1.4 – I sistemi insediativi storici e il patrimonio architettonico ............................................................. 8 2.1.4.1 – I sistemi insediativi storici e il patrimonio architettonico della Lessinia ................................................... 8 2.1.5 – Valori Naturalistico Ambientali e Storico Culturali, le Tessiture Territoriali e i Sistemi Tipologici di forte caratterizzazione locale ............................................................................................................... 16 2.1.6 – Indicazione ed analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico dell’area d’intervento ............................................................................................................................................. -

Classifica Gelaterie
BLACK AND WHITE Chievo 403.714 ARTIGIANALE DODO Peschiera 4.402 SAVOIA Verona 394.604 I MIGLIORI TRE DANIEL Zevio 4.366 IL GELATONE Verona 339.138 IL GELATONE Nogara 4.026 TEMPTATIONS Soave 290.162 VITTORIA GELATO E CAFFÈ Verona 3.972 IL MUSTACCHIO Verona 234.108 ELENA GELATEO DI BERARDINELLI TEO Verona 3.929 CRISTALLO EL COSSETT EUROPA San bonifacio 224.447 ISOLA GELATERIA DANIELA Veronella 3.827 BARDOLINO CASTELLETTO L'ARTE DEL GELATO Legnago 219.829 DELLA SCALA CREMA E CIOCCOLATO San Martino B.A. 3.435 WHITE ES Zevio 169.101 PONTE PIETRA Verona 3.410 LA PARONA DEL GELATO Parona 162.294 LIMONAIA Torri Del Benaco 3.031 AKROPOLIS San Giovanni Lupatoto 137.309 CREMERIE Affi 2.840 PAMPANIN Verona 118.245 IMPERO Verona 2.561 GELATERIA MATTIELLI Soave 117.394 TRICOCCO Verona 2.521 GELATERIA STEFY Caldiero 88.543 TORTA DELLA NONNA Peschiera 2.498 CORTE VITTORIA Sommacampagna 84.765 CAFFÈ OTTOLINI Verona 2.227 L'ARTIGIANO DEI SAPORI Malcesine 82.614 ARTE DEL GELATO Verona 2.218 NANÀ Verona 68.730 DOLORES Cerea 1.579 LA PECORA NERA Verona 68.685 MAZZINI Verona 1.300 LA GELATERIA DELLO STADIO Verona 68.422 BLUE ICE Lugagnano 1.259 ARTIK Verona 66.058 SLURP Bussolengo 1.251 GANDINI IL GELATO San bonifacio 65.586 IL LATTE DEL PARCO Bosco Chiesanuova 1.168 LA GELATTERIA Villafranca 62.374 CENTO PER CENTO Malcesine 1.146 OASI Verona 59.236 AGRIGELATERIA MANZATI Palazzolo Di Sona 1.123 FRATELLI FAINELLO Costermano sul Garda 56.735 CIOCCOLATO ISALBERTI Cerea 1.019 LA DOLCE VITA San zeno di Montagna 53.456 ANGELINA Lazise 835 LA GOLOSA Dossobuono 48.847 SOTTOZERO San Giovanni Lupatoto 714 MOZART Verona 48.788 GROMM Verona 687 MASTER'S CREAM Legnago 43.735 ASKI Verona 631 TOP UNO Villafranca 43.029 TEMPI DELIZIOSI Sant'Ambrogio 617 GELATOTECA Negrar 41.782 BELLINI 1929 San Giovanni Lupatoto 14.264 DALLA VALLE Tregnago 610 TUGÒ Verona 38.751 ARTIGIANALE FRIZZOLAN Bosco Chiesanuova 13.428 LA LIMONATA Torri del Benaco 505 BONGELATO Bovolone 37.852 IGLOO Verona 12.720 CREMAMORE Verona 499 GELATERIA DEL BORGO San Martino B.A. -

AZIENDA U.L.S.S. N. 9 SCALIGERA Sede Legale: Via Valverde 42 – 37122 VERONA
AZIENDA U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA Sede Legale: via Valverde 42 – 37122 VERONA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori: - dott. Giuseppe Cenci Direttore Amministrativo - dott. Denise Signorelli Direttore Sanitario - dott. Raffaele Grottola Direttore dei Servizi Socio-Sanitari ha adottato in data odierna la presente deliberazione: OGGETTO PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA – INDIVIDUAZIONE AMBITI TERRITORIALI CARENTI ANNO 2021 Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si individuano per l’anno 2021 gli ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale Sentito il Direttore della Funzione Territoriale e il Responsabile UOS Medicina Convenzionata, Privati Accreditati e Controlli, Premesso che: - con nota n. 47579 di prot. del 2.2.2021 la Direzione Programmazione Sanitaria – LEA – Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali – Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto ha richiesto di inviare la rilevazione annuale di fini della pubblicazione relativa all’anno 2021 delle zone carenti ordinarie e straordinarie di pediatria di libera scelta; - con deliberazione n. 1128 del 31.12.2020 si era provveduto a rilevare le zone carenti straordinarie a seguito delle cessazioni dei pediatri di libera scelta a partire dall'1.9.2020 e fino al 31.12.2020, trasmesse ai competenti Uffici regionali con nota n. 9304 del 20.1.2021; - preso atto che i componenti del Comitato Aziendale, sentiti a mezzo posta elettronica in data 4.3.2021, considerata l’urgenza, hanno espresso parere favorevole in relazione all’individuazione degli ambiti territoriali carenti anno 2021 che, ivi compresi quelli già rilevati con la succitata deliberazione n. -

Il Capo Del Dipartimento Per Gli Affari Interni E Territoriali Del Ministero Dell'interno
Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con Il Ragioniere Generale dello Stato VISTO l’articolo 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno uno specifico fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale; CONSIDERATO che lo stesso articolo 115 dispone che con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del citato decreto-legge, si provvede al riparto delle risorse assegnate tenendo conto della popolazione residente e del numero di contagi da COVID-19 accertati; PRESO ATTO che, per le predette finalità, sul capitolo di bilancio 1370 istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, sono stati stanziati 10 milioni di euro per l’annualità 2020, destinati ai comuni e alle province e città metropolitane; SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 aprile 2020; DECRETA Articolo 1 (Riparto -

Linee E Orari Bus Extraurbani - Provincia Di Verona
Linee e orari bus extraurbani - Provincia di Verona Servizio invernale 2019/20 [email protected] 115 Verona - Romagnano - Cerro - Roverè - Velo ................................... 52 Linee da/per Verona 117 S.Francesco - Velo - Roverè - S.Rocco - Verona .............................. 53 101 S. Lucia - Pescantina - Verona ........................................................14 117 Verona - S.Rocco - Roverè - Velo - S.Francesco .............................. 53 101 Verona - Pescantina - S. Lucia ........................................................15 119 Magrano - Moruri - Castagnè - Verona .............................................54 102 Pescantina - Bussolengo - Verona .................................................. 16 119 Verona - Castagnè - Moruri - Magrano .............................................54 102 Verona - Bussolengo - Pescantina .................................................. 16 120 Pian di Castagnè/San Briccio - Ferrazze - Verona ............................ 55 90 Pescantina - Basson - Croce Bianca - Stazione P.N. - p.zza Bra - P. 120 Verona - Ferrazze - San Briccio/Pian di Castagnè ............................ 55 Vescovo ............................................................................................... 17 121 Giazza - Badia Calavena - Tregnago - Strà - Verona ......................... 56 90 P.Vescovo - p.zza Bra - Stazione P.N. - Croce Bianca - Basson - 121 Verona - Strà - Tregnago - Badia Calavena - Giazza ......................... 58 Pescantina ............................................................................................17 -

Comunicato Stampa
Via Ca’ di Cozzi, 41 37124 VERONA Tel. 045.8301509 Fax. 045.8342622 e-mail: [email protected] www.atoveronese.it Ufficio Stampa Anna Martellato 349.3311341 [email protected] COMUNICATO STAMPA AATO METTERÀ IN FUNZIONE IL SISTEMA FOGNARIO DELLA COMUNITÀ MONTANA PROGETTI ANCHE A SANT’ANNA D’ALFAEDO E SAN MAURO DI SALINE VERONA – Sant’Anna d’Alfaedo, San Mauro di Saline e Bosco Chiesanuova. Ma anche Peschiera, Lazise, Bardolino Cavaion Veronese, San Vito al Mantico, San Vito di Negrar. Sono in tutto nove i Comuni in cui si concentrerà il lavoro di Gardesana Servizi (per la zona del Garda) e quello Acque Veronesi (per tutto il resto del territorio), le due società di gestione dell’AATO Veronese, ossia l’autorità d’Ambito, ente pubblico che governa il servizio idrico integrato a Verona e provincia. Il costo totale dei lavori sarà di quasi 6milioni di euro. BOSCO CHIESANUOVA, AATO RENDE FUNZIONALE IL SISTEMA FOGNARIO PREDISPOSTO DALLA COMUNITÀ MONTANA. Arzarè Regno Corbiolo. Queste frazioni di Bosco Chiesanuova saranno oggetto di lavori da parte di Acque Veronesi. L’Autorità d’Ambito ha infatti approvato il progetto, del costo totale di 250mila euro, che vedrà l’allacciamento delle frazioni al collettore di Fondovalle. Un progetto complesso e suddiviso in vari stralci. In un primo momento l’intervento prevede al posa di un tratto di nuova fognatura, per rendere funzionale il sistema fognario già predisposto a suo tempo dalla Comunità Montana della Lessinia per il trasferimento al depuratore di Verona dei reflui prodotti a Lughezzano e Arzarè. La nuova fognatura si allaccerà alla rete esistente e sarà lunga più di un chilometro, recapitando i reflui verso valle fino al depuratore di Verona. -

Scarica Il Documento
CAPOFILA N. DISTRETTO COM CAPOFILA COM COMUNI DISTRETTO COMUNI Affi Brentino Belluno Brenzone Caprino Veronese Cavaion Veronese VR 1 Comunità Montana 18 Caprino V.se del Baldo del Baldo Costermano Ferrara di Monte Baldo Malcesine Rivoli Veronese S. Zeno di Montagna Torri del Benaco 11 Dolcè Fumane Sant’Ambrogio Marano di Valpolicella 15 VP VR 2 Negrar della Sant'Ambrogio S. Ambrogio di Valpolicella Lessinia Valpolicella S. Anna d’Alfaedo Occidentale Bussolengo Pastrengo 17 Pescantina Pescantina S. Pietro in Cariano 10 Bosco Chiesanuova Cerro Veronese Erbezzo Bosco 2 Chiesanuova Grezzana Rovere Veronese S. Mauro di Saline Velo Veronese VR 3 Badia Calavena della Comunità Montana Lessinia della Lessinia Cazzano di Tramigna Orientale Illasi Mezzane di sotto Montecchia di Crosara 3 Illasi Roncà S. Giovanni Ilarione Selva di Progno Tregnago Vestenanova 17 CAPOFILA N. DISTRETTO COM CAPOFILA COM COMUNI DISTRETTO COMUNI Belfiore Monteforte D’Alpone 4 San Bonifacio S. Bonifacio Soave Albaredo d’Adige Arcole Bevilacqua Bonavigo Boschi S.Anna VR 4 Cologna Veneta del Cologna Veneta 7 Cologna V.ta Colognese Minerbe Pressana Roveredo di Guà Terrazzo Veronella Zimella Caldiero Colognola ai Colli 8 San Martino BA Lavagno S. Martino Buon Albergo 20 San Giovanni Lupatoto 5 Zevio Zevio Angari Bovolone Isola Rizza Oppiano 6 Bovolone Palù Ronco all’Adige VR 5 Legnago delle Valli Roverchiara S. Pietro di Morubio Casaleone Cerea 9 Cerea Concamarise Sanguinetto Castagnaro 11 Legnago Legnago Villa Bartolomea 17 CAPOFILA N. DISTRETTO COM CAPOFILA COM COMUNI DISTRETTO COMUNI Buttapietra Gazzo Veronese Isola della Scala 10 Isola D/S Nogara Salizzole VR 6 Sorgà Isola della Scala Isolano Castel d’Azzano Erbè Mozzecane 12 Mozzecane Nogarole Rocca Trevenzuolo Vigasio 12 Povegliano veronese Sommacampagna 13 Villafranca Valeggio sul Mincio Villafranca Veronese VR 7 Villafranca Castelnuovo del Garda Zona Mincio Veronese 14 Peschiera D/G Peschiera del Garda Sona Bardolino 16 Bardolino Garda Lazise. -

4. SERVIZI 4.1 Numero Di Aziende Impiegate Nei Servizi Di Seguito Viene Riportato Graficamente Il Numero Delle Aziende Impiegate
4. SERVIZI 4.1 Numero di aziende impiegate nei servizi Di seguito viene riportato graficamente il numero delle aziende impiegate 2004 nel settore “Istruzione, sanità e altri servizi pubblici, sociali e personali”. Nel computo complessivo delle aziende attive, questo settore da un contributo numerico soltanto discreto rispetto ad esempio a quello delle Costruzioni o del Commercio. Andando invece a vedere quello che succede nei singoli comuni della Comunità montana, si può notare che i comuni di Negrar, Sant’Ambrogio di Valpolicella e Grezzana sono nell’ordine i più attivi in questo campo. Decisamente deficitario in questo settore risulta invece il comune di Selva di Progno, San Mauro di Saline e Velo Veronese. Piano di sviluppo socio economico 2007– 2011 Comunità montana della Lessinia 1 4.2 Ecocentri comunali Tale indicatore è costituito dal numero di ecocentri comunali intesi come aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non hanno installati al loro interno strutture tecnologiche e non effettuano processi di trattamento. Negli ecocentri sono raccolti i rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche conferiti direttamente da privati, dagli operatori della raccolta differenziata e dai gestori del servizio pubblico. Come mostra la seguente i comuni Comunità Montana che hanno al loro interno il maggior numero di ecocentri sono Marano, Fumane e Selva di Progno. Gli ecocentri comunali LEGENDA: Numero di ecocentri 0 1 2 Erbezzo Sant'Anna Bosco d'Alf aedo Selv a Chiesanuov a Velo di Progno Veronese Dolce' Rov ere' Badia Vestenanova Veronese Cerro Calav ena Marano Veronese di Valpolicella San Mauro Fumane di Saline San Giov anni Negrar Ilarione Grezzana Tregnago Sant'Ambrogio di Valpolicella Piano di sviluppo socio economico 2007– 2011 Comunità montana della Lessinia 2 4.3 Impianti di selezione e recupero rifiuti Il recupero attualmente la più frequente forma di gestione dei rifiuti. -
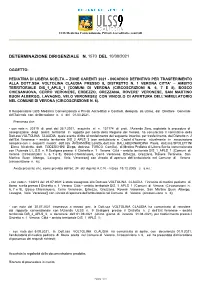
1570 10/08/2021
UOS Medicina Convenzionata, Privati Accreditati e controlli DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL OGGETTO: PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA – ZONE CARENTI 2021 - INCARICO DEFINITIVO PER TRASFERIMENTO ALLA DOTT.SSA VOLTOLINA CLAUDIA PRESSO IL DISTRETTO N. 1 VERONA CITTA’ – AMBITO TERRITORIALE DIS_1_APLS_1 [COMUNI DI VERONA (CIRCOSCRIZIONI N. 6, 7 E 8), BOSCO CHIESANUOVA, CERRO VERONESE, ERBEZZO, GREZZANA, ROVERE’ VERONESE, SAN MARTINO BUON ALBERGO, LAVAGNO, VELO VERONESE)] CON VINCOLO DI APERTURA DELL’AMBULATORIO NEL COMUNE DI VERONA (CIRCOSCRIZIONE N. 6). Il Responsabile UOS Medicina Convenzionata e Privati Accreditati e Controlli, delegato, da ultimo, dal Direttore Generale dell’Azienda con deliberazione n. 4 del 01.03.2021, Premesso che: - con nota n. 20219 di prot. del 26.7.2021, acquisita al n. 131174 di prot., l’Azienda Zero, espletate le procedure di assegnazione degli ambiti territoriali in oggetto per conto della Regione del Veneto, ha comunicato il nominativo della Dott.ssa VOLTOLINA CLAUDIA quale avente diritto al conferimento del seguente incarico, per trasferimento, dal Distretto n. 2 dell’Est Veronese – ambito territoriale DIS_2_APLS_3 (con ambulatorio a Castel d’Azzano, attualmente in associazione semplice con i seguenti medici: dott.ssa ARCAMONE Loretta, dott.ssa DALLABERNARDINA Paola, dott.ssa SPOLETTINI Elena Nicoletta, dott. TODESCHINI Diego, dott.ssa TURCO Camilla), di Medico Pediatra di Libera Scelta convenzionato con l’Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera presso il Distretto n. 1 Verona Città – ambito territoriale DIS_1_APLS_1 [Comuni di Verona (Circoscrizioni n. 6, 7 e 8), Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Grezzana, Roveré Veronese, San Martino Buon Albergo, Lavagno, Velo Veronese)] con vincolo di apertura dell’ambulatorio nel Comune di Verona (circoscrizione n. -

PROVINCIA DI VERONA Servizi Turistico-Ricreativi
PROVINCIA DI VERONA Servizi Turistico-Ricreativi Allegato A) alla determinazione dirigenziale n. 3818/13 del 26/08/2013 – sostituisce l'allegato A) alla determinazione n. 2914 del 24/06/2013 ALBO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO ANNO 2013 COMUNE DI N. PRO LOCO INDIRIZZO APPARTENENZA 1 Albaredo d'Adige ALBAREDO D'ADIGE Piazza A. Moro, n. 3 37041 Albaredo d’Adige 2 Badia Calavena SPREA CUM PROGNO Via Zami, n. 1 37030 Badia Calavena 3 Belfiore BELFIORE Piazza della Repubblica, n. 7/8 37050 Belfiore 4 Bonavigo BONAVIGO Via Trieste 37040 Bonavigo 5 Bosco Chiesanuova BOSCO CHIESANUOVA Piazza Chiesa, n. 34/A 37021 Bosco Chiesanuova 6 Bovolone BOVOLONE Via Ospedale, n. 13 37051 Bovolone 7 Brenzone PER BRENZONE Via XX Settembre, n. 12 37010 Brenzone 8 Buttapietra BUTTAPIETRA V.le dell'Agricoltura, n. 1 37060 Buttapietra 9 Caldiero CALDIERO Piazza Vittorio Veneto 37042 Caldiero 10 Caprino Veronese CAPRINO VERONESE Via S.Pertini, n. 1 37013 Caprino Veronese 11 Casaleone CARPANEA Via Roma, n. 4 37052 Casaleone 12 Castagnaro CASTAGNARO Via Stazione, n. 1 37043 Castagnaro 13 Cavaion Veronese S. MICHELE Via Fracastoro, n. 1 37010 Cavaion Veronese 14 Cazzano di Tramigna CAZZANO DI TRAMIGNA Piazza Matteotti, n. 11 37030 Cazzano di Tramignia 15 Cerea CEREA Via XXV Aprile, n. 52 37053 Cerea 16 Cerro Veronese CERRO VERONESE Piazza Don A. Vinco n. 3 37020 Cerro Veronese 17 Cologna Veneta CITTA' DI COLOGNA VENETA Via Cavour n. 72 37044 Cologna Veneta 18 Colognola ai Colli COLOGNOLA AI COLLI Via S. Biagio n. 7 37030 Colognola ai Colli 19 Concamarise CONCAMARISE IN CAMMINO Via Piazza, n. -
Passeggiate in Lessinia Calendario Escursioni Estate 2019
PASSEGGIATE IN LESSINIA CALENDARIO ESCURSIONI ESTATE 2019 1 La Lessinia, la montagna di Verona. Una montagna dove la natura domina, con verdi alti pascoli, boschi di faggio, malghe e contrade. PASSEGGIATE Perdetevi tra i numerosi e sontuosi sentieri IN LESSINIA CALENDARIO ESCURSIONI e tra le bianche strade sterrate, molte delle quali ESTATE 2019 furono costruite durante la guerra per permettere alle truppe di raggiungere i territori di confine. Camminare nella luce e nei silenzi Scoprite la bellezza della natura, grazie della Lessinia è il modo perfetto ad un paesaggio ancora integro e intatto dai tempi antichi. per vivere emozioni indimenticabili. Lasciatevi affascinare da ponti naturali, cavità Venite a scoprirlo! carsiche, giacimenti fossili, grotte. Su questo altopiano sono numerose Ascoltate il silenzio delle contrade, tesori di storie le attività di escursionismo e tradizioni, dove ingegnosi “architetti” organizzate da associazioni con costruirono case, stalle, fienili usando i materiali guide professioniste, associazioni di cui la Lessinia è sempre stata ricca, la Pietra Pro Loco con volontari, il Parco e il Legno. Emozionatevi davanti a paesaggi mozzafiato e meravigliosi tramonti. Naturale Regionale, le guardie Lasciatevi coinvolgere da storie di antiche forestali e i gruppi escursionistici tradizioni e seguite esperte ed appassionate locali. Passo dopo passo… siamo “guide”, che vi faranno innamorare di questo arrivati a creare un Calendario bellissimo territorio. completo e dettagliato di tutte Assaggiate i prodotti tipici della Lessinia, frutto le escursioni e le camminate a cui dell’amore per la terra, dove tradizione è possibile partecipare in Lessinia e innovazione vanno di pari passo. Deliziate le vostre papille gustative con gli gnocchi durante l’estate 2019. -

Catalogo 2014
20. FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA FFDL.IT IL FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA RINGRAZIA I SUOI PARTNER THE FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA THANKS ITS PARTNERS COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA Per le attività culturali Claudio Melotti Sindaco di Bosco Chiesanuova Mayor, Bosco Chiesanuova Benvenuti a Bosco Chiesanuova. Mai come quest’anno, in Welcome to Bosco Chiesanuova. This year, more than ever, occasione della ventesima edizione, mi sento di salutare e on the occasion of the twentieth edition, it is my pleasure to di dare il benvenuto a tutti coloro che giungeranno a Bo- greet you and to welcome everyone who will come to Bosco sco Chiesanuova per il Film Festival della Lessinia, a partire Chiesanuova for the Film Festival della Lessinia, starting with dall’infaticabile team organizzativo, ai registi, agli ospiti, ai the tireless organizational team, the directors, the guests, giornalisti e naturalmente al pubblico che af ollerà il Teatro the press and, naturally, the public that will fi ll the Teatro Vit- Vittoria e la Piazza del Festival. Mai come quest’anno vo- toria and the Piazza del Festival. This year, more than ever, I glio dire grazie al Curatorium Cimbricum Veronense, che wish to thank the Curatorium Cimbricum Veronense, which nel 1995 proprio a Bosco Chiesanuova inventò il Festival, invented the Festival in 1995, here in Bosco Chiesanuova, agli sponsor, la Cassa Rurale Bassa Vallagarina, le Cantine and the sponsors: the Cassa Rurale Bassa Vallagarina, Ber- Bertani e la Fondazione Cariverona. Rivolgo un grazie alla tani Wineries, and the Fondazione Cariverona. I also wish Regione Veneto, alla Camera di Commercio e alla Provincia to thank the Veneto Region, the Chamber of Commerce of di Verona per il sostegno avuto.