Presenza Di Setina Irrorella
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rote Liste Spinner Und Schwärmer
HESSISCHES MINISTERIUM NATUR FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT IN HESSEN UND FORSTEN Rote Liste der Spinner und Schwärmer Hessens 1 Rote Liste der „Spinner und Schwärmer im weiteren Sinn” Hessens (Lepidoptera; „Bombyces et Sphinges” sensu lato) Hepialidae (Wurzelbohrer), Limacodidae (Schneckenspinner oder Assel- spinner), Sesiidae (Glasflügler), Cossidae (Bohrer), Thyrididae (Fenster- schwärmerchen), Lasiocampidae (Glucken), Endromidae (Scheckflügel), Saturniidae (Pfauenspinner), Lemoniidae (Herbstspinner), Sphingidae (Schwärmer), Drepanidae (Sichelflügler und Wollrückenspinner oder Eulenspinner), Notodontidae (Zahnspinner), Lymantriidae (Trägspinner), Nolidae (Kleinbären), Arctiidae (Bärenspinner) (Erste Fassung, Stand: 23.11.1998), Zusammengestellt im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten im Namen der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Lepidopterologen (Arge HeLep) von Andreas C. Lange und Jan T. Roth unter Mitwirkung von Mitarbeitern der Arge HeLep Anschrift der Autoren: Andreas C. Lange, Teutonenstraße 48, 65187 Wiesbaden Jan T. Roth, Westendstraße 49, 60325 Frankfurt/M. Red Data list of the ”Bombyces et Sphinges” sensu lato of Hesse (as of November, 23rd, 1998) Abstract: According to present knowledge 189 species of the ”Bombyces et Sphinges” sensu lato are recorded to occur presently or have been recorded in the past in the Federal State of Hesse, Federal Republic of Germany. The status of endangerment as defined by the criteria based on the IUCN-categories is considered as following: 0 ( = extinct) 16 species; 1 ( = nearly extinct) 8 species; 2 ( = highly endangered) 12 species; 3 ( = endangered) 24 species. In 11 species the data is not sufficent for classification, but endangerment is highly probable due to their confinement to endangered biotopes. 6 species are declining but not actually endangered. In 6 species data is deficient because of taxonomic or methodic difficulties. -

The Genus Setina Schrank, 1802 in Portugal (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae) SHILAP Revista De Lepidopterología, Vol
SHILAP Revista de Lepidopterología ISSN: 0300-5267 [email protected] Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología España Corley, M. F. V. The genus Setina Schrank, 1802 in Portugal (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae) SHILAP Revista de Lepidopterología, vol. 41, núm. 163, septiembre, 2013, pp. 331-335 Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología Madrid, España Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45529269007 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative 331-335 The genus Setina Schran 4/9/13 12:06 Página 331 SHILAP Revta. lepid., 41 (163), septiembre 2013: 331-335 eISSN: 2340-4078 ISSN: 0300-5267 The genus Setina Schrank, 1802 in Portugal (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae) M. F. V. Corley Abstract The records of Setina Schrank, 1802 from Portugal are considered and it is concluded from specimens examined that all records belong to S. cantabrica Freina & Witt, 1985. KEY WORDS: Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae, Setina, Portugal. O género Setina Schrank, 1802 em Portugal (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae) Resumo Os registos de Setina Schrank, 1802 oriundos de Portugal foram analisados e concluiu-se que todos os indivíduos examinados pertencem a S. cantabrica Freina & Witt, 1985. PALAVRAS CHAVE: Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae, Setina, Portugal. El género Setina Schrank, 1802 en Portugal (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae) Resumen Los registros de Setina Schrank, 1802 originarios de Portugal han sido analizados y se concluye que todos pertenecen a S. cantabrica Freina & Witt, 1985. PALABRAS CLAVE: Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae, Setina, Portugal. -

Scottish Macro-Moth List, 2015
Notes on the Scottish Macro-moth List, 2015 This list aims to include every species of macro-moth reliably recorded in Scotland, with an assessment of its Scottish status, as guidance for observers contributing to the National Moth Recording Scheme (NMRS). It updates and amends the previous lists of 2009, 2011, 2012 & 2014. The requirement for inclusion on this checklist is a minimum of one record that is beyond reasonable doubt. Plausible but unproven species are relegated to an appendix, awaiting confirmation or further records. Unlikely species and known errors are omitted altogether, even if published records exist. Note that inclusion in the Scottish Invertebrate Records Index (SIRI) does not imply credibility. At one time or another, virtually every macro-moth on the British list has been reported from Scotland. Many of these claims are almost certainly misidentifications or other errors, including name confusion. However, because the County Moth Recorder (CMR) has the final say, dubious Scottish records for some unlikely species appear in the NMRS dataset. A modern complication involves the unwitting transportation of moths inside the traps of visiting lepidopterists. Then on the first night of their stay they record a species never seen before or afterwards by the local observers. Various such instances are known or suspected, including three for my own vice-county of Banffshire. Surprising species found in visitors’ traps the first time they are used here should always be regarded with caution. Clerical slips – the wrong scientific name scribbled in a notebook – have long caused confusion. An even greater modern problem involves errors when computerising the data. -

Ballyogan and Slieve Carran, Co. Clare
ISSN 1393 – 6670 N A T I O N A L P A R K S A N D W I L D L I F E S ERVICE IMPORTANT INVERTEBRATE AREA SURVEYS: BALLYOGAN AND SLIEVE CARRAN, CO. CLARE Adam Mantell & Roy Anderson I R I S H W ILDL I F E M ANUAL S 127 National Parks and Wildlife Service (NPWS) commissions a range of reports from external contractors to provide scientific evidence and advice to assist it in its duties. The Irish Wildlife Manuals series serves as a record of work carried out or commissioned by NPWS, and is one means by which it disseminates scientific information. Others include scientific publications in peer reviewed journals. The views and recommendations presented in this report are not necessarily those of NPWS and should, therefore, not be attributed to NPWS. Front cover, small photographs from top row: Limestone pavement, Bricklieve Mountains, Co. Sligo, Andy Bleasdale; Meadow Saffron Colchicum autumnale, Lorcan Scott; Garden Tiger Arctia caja, Brian Nelson; Fulmar Fulmarus glacialis, David Tierney; Common Newt Lissotriton vulgaris, Brian Nelson; Scots Pine Pinus sylvestris, Jenni Roche; Raised bog pool, Derrinea Bog, Co. Roscommon, Fernando Fernandez Valverde; Coastal heath, Howth Head, Co. Dublin, Maurice Eakin; A deep water fly trap anemone Phelliactis sp., Yvonne Leahy; Violet Crystalwort Riccia huebeneriana, Robert Thompson Main photograph: Burren Green Calamia tridens, Brian Nelson Important Invertebrate Area Surveys: Ballyogan and Slieve Carran, Co. Clare Adam Mantell1,2 and Roy Anderson3 1 42 Kernaghan Park, Annahilt, Hillsborough, Co. Down BT26 6DF, 2 Buglife Services Ltd., Peterborough, UK, 3 1 Belvoirview Park, Belfast BT8 7BL Keywords: Ireland, the Burren, insects, invertebrates, site inventory Citation: Mantell, A. -

Flygande Fjärilar [Field Observations of Ultrasonic Sounds from Flying Mothsl
Ent. Tidskr'. 1 18 ( I997) Noli.s/Short note Fältobservationer av ultraljud hos flygande fjärilar [Field observations of ultrasonic sounds from flying mothsl INGEMAR AHLEN Närjag år 1981 publicerade en artikel i Entornolo- gisk Tidskrift (Ahl6n 1981) om ultraljud hos svenska vårtbitare, redovisade jag i inledningen en del allrnänna fakta om ultraljud hos insekter. Vidare berättade jag att jag då utöver vårtbitarna endast hört ultraljud från två olika insekter i Sverige, båda två okända till arten. Den ena är en insekt med tyrnbalorgan som sitter i trädkronor och lirter höra en mycket stark, ringande sång i skymningen vid midsommartid. Jag upptäckte den 1980 men arttillhörigheten är, trots många obser- vationer och ivrigt undersökande med bistånd från ett flertal entomologer under alla dessa år, fortfa- rande en gåta. Jag hoppas få återkornrna med ett svar om detta så småningom. Fig. I.7.vmbalorp;an hos hane av .stor borst,rpinnare Set- Den andra insekten, som jag nämnde i artikeln ina irrorella. Foto: RLme Arelsson. 1 98 1, var en fjäril som jag en gång hört flyga över Tj,ntbal in ma.le Setina irrorells. Photo: Rune Ar- vägen någonstans på Gotland. Den hade ett starkt organ elsson. skramlande läte i flykten. Jag fick inte se eller höra denna insekt igen förrän 1997. Under fält- arbete på Gotland fick iag då åter höra det märk- liga lätet. I ultraliudsdetektorn hördes tydligt att det var en insekt som kom flygande förbi. Ljudet tilltog och avtog sedan strax och försvann. Jag kunde i mörkret inte se något men blev helt säker på att det var samma fjäril som jag en gång säg och hörde I 980. -
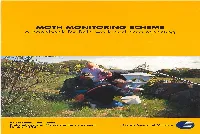
Moth Moniioring Scheme
MOTH MONIIORING SCHEME A handbook for field work and data reporting Environment Data Centre 1/1/1/ National Boord of Waters and the Environment Nordic Council of Ministers /////// Helsinki 1 994 Environmental Report 8 MOTH MONITORING SCHEME A handbook for field work and data reporting Environment Data Centre National Board of Waters and the Environment Helsinki 1994 Published by Environment Data Centre (EDC) National Board of Waters and the Environment P.O.BOX 250 FIN—001 01 Helsinki FINLAND Tel. +358—0—73 14 4211 Fax. +358—0—7314 4280 Internet address: [email protected] Edited by Guy Söderman, EDC Technical editng by Päivi Tahvanainen, EDC This handbook has been circulated for comments to the members of the project group for moth monitoring in the Nordic countries under the auspices of the Monitoring and Data Group of the Nordic Council of Ministers. Cover photo © Tarla Söderman Checking of installation of light trap at Vilsandi National Park in Estonia. Printed by Painotalo MIKTOR Ky, Helsinki 1 994 ISBN 951—47—9982—8 ISSN 0788—3765 CONTENTS .4 INTRODUCTION 5 PART 1: OBJECTIVES 7 1 Short term objectives 7 2 Medium-long term objectives 8 3 Additional objectives 8 4 Specific goals 9 5 Network design 9 5.1 Geographical coverage 9 5.2 Biotopes coverage 10 PART II: METRODOLOGY 11 1 Technical equipments and use 11 1.1 Structure of Iight traps 11 1.2 Field installation 13 1.3 Structure ofbait trap 14 1.4 Documentation of sites 15 1.5 Timing the light traps 15 1.6 Sampling procedures 15 2 Sample handling 16 2.1 Prestoring 16 2.2 Posting 16 -

Noctuoid Moths (Lepidoptera: Erebidae, Nolidae, Noctuidae) of North-East Kazakhstan (Pavlodar Region)
Ukrainian Journal of Ecology Ukrainian Journal of Ecology, 2017, 7(2), 142–164, doi: 10.15421/2017_32 ORIGINAL ARTICLE UDC 595.786 Noctuoid moths (Lepidoptera: Erebidae, Nolidae, Noctuidae) of North-East Kazakhstan (Pavlodar Region) S.V. Titov1, A.V. Volynkin2,3, V.V. Dubatolov4, M. Černila5, S.M. Reznichenko6 & V.S. Bychkov7 1 The Research Centre for Environmental 'Monitoring', S. Toraighyrov Pavlodar State University, Lomova str. 64, KZ-140008, Pavlodar, Kazakhstan. E-mail: [email protected] 2 Altai State University, Lenina pr. 61, Barnaul, RF-656049, Russia. E-mail: [email protected] 3 Tomsk State University, Laboratory of Biodiversity and Ecology, Lenina pr. 36, RF-634050, Tomsk, Russia 4 Institute of Systematics and Ecology of Animals, SB RAS, Frunze str. 11, RF-630091, Novosibirsk, Russia E-mail: [email protected] 5 The Slovenian Museum of Natural History, Prešernova 20, SI-1001, Ljubljana, Slovenia. E-mail: [email protected] 6 Shcherbakty branch of the Republican methodical center of phytosanitary diagnostics and forecasts, Sovetov 44, KZ-141000, Sharbakty, Shcherbakty distr., Pavlodar Region. E-mail: [email protected] 7 Institute of Archaeology named after A. Kh. Margulan, 44 Avenue Dostyk, st. Shevchenko 28, KZ-050010, Almaty, Kazakhstan. E-mail: [email protected] Submitted: 02.04.2017. Accepted: 23.05.2017 The paper contains data on the fauna of the Lepidoptera families Erebidae, Nolidae and Noctuidae of Pavlodar Region (North-East Kazakhstan). The check list includes 480 species (100 species of Erebidae, 8 species of Nolidae and 372 species of Noctuidae), 393 species are reported for the region for the first time. The map of collecting localities and pictures of the main landscapes of the region are presented. -

Gotland Holiday Report 2016
Gotland Holiday Report 26 May - 2 June 2016 Led by Amanda Borrows & Dr Martin Perrow Cypripedium calceolus © Amanda Borrows Greenwings Wildlife Holidays Tel: 01473 254658 Web: www.greenwings.co.uk Email: [email protected] ©Greenwings 2016 Itinerary Day 1 Thursday 26th May London – Arlanda – Visby Day 2 Friday 27th May Bro Church – Klintängarna – Hasslemyer Lake – Digerhuvud coastal road – Langhammar Day 3 Saturday 28th May Russvätar – Fjale crossroads – Liste Ångar – Dalhem turning – Dalhem Station Day 4 Sunday 29th May Ola Military Site – Öja windmills – Öja Church & Parish Meadows – Husrygg – Muskmyr Day 5 Monday 30th May Stora Karlsö – Gnisvärd skeppssättning Day 6 Tuesday 31st May Mallgårds Flush Fen – Djupvik –Visby - Lake Paviken Day 7 Wednesday 1st June Kallgatburg – Hejnum Kallgate Day 8 Thursday 2nd June Departure Day 1 Thursday 26th May London – Arlanda – Visby Due to flight times the group met up with Amanda & Martin at Visby, where the temperatures were high and the sun was shining. The Swedes are known for their efficiency but today efficiency was strictly lacking and due to some industrial dispute or work to rule, not all the baggage turned up. We found out there was no rhyme or reason for whose baggage was taken, thus, some of the group were joining the queue to fill out the paper-work. For those of the group whose bags turned up they went off with Martin to explore the small Bronze Age burial site next to the airport, where a few orchids were blooming and butterflies flitting. The site also had a good example of a traditional sheep hut. -

Integrated Taxonomy, Phylogeography and Conservation in the Genus
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Spixiana, Zeitschrift für Zoologie Jahr/Year: 2016 Band/Volume: 039 Autor(en)/Author(s): Ortiz Antonio S., Rubio Rosa Maria, Guerrero Juan José, Garre Manuel, Hausmann Axel Artikel/Article: Integrated taxonomy, phylogeography and conservation in the genus Chelis Rambur, [1866] in the Iberian Peninsula (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae) 273- 286 ©Zoologische Staatssammlung München/Verlag Friedrich Pfeil; download www.pfeil-verlag.de SPIXIANA 39 2 273-286 München, Dezember 2016 ISSN 0341-8391 Integrated taxonomy, phylogeography and conservation in the genus Chelis Rambur, [1866] in the Iberian Peninsula (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae) Antonio S. Ortiz, Rosa M. Rubio, Juan J. Guerrero, Manuel Garre & Axel Hausmann Ortiz, A. S., Rubio, R. M., Guerrero, J. J., Garre, M. & Hausmann, A. 2016. Inte- grated taxonomy, phylogeography and conservation in the genus Chelis Rambur, [1866] in the Iberian Peninsula (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae). Spixiana 39 (2): 273-286. The taxonomy of Chelis, a genus distributed within the Palaearctic region, is re- vised based on morphological and molecular data (DNA barcodes) in the Iberian Peninsula. The neighbour-joining and maximum likelihood trees, combined with adult male genitalia and morphology, support the existence of three species indicat- ing two major lineages, one corresponding to mountainous taxa (Chelis arragonensis and C. cantabrica), with restricted distribution, and the other represented by Chelis maculosa, a taxon with a broad European distribution and a great number of in- fraspecific taxa. Haplotypic variation is highly concordant with species taxonomy; the variation at a continental scale reveals a significant geographic pattern of haplo- groups: C. -

Systematic List of the Noctuoidea of Europe (Notodontidae, Nolidae, Arctiidae, Lymantriidae, Erebidae, Micronoctuidae, and Noctuidae)
Esperiana Buchreihe zur Entomologie Bd. 11: 93-205 Schwanfeld, 29. Juni 2005 ISBN 3-938249-01-3 Systematic List of the Noctuoidea of Europe (Notodontidae, Nolidae, Arctiidae, Lymantriidae, Erebidae, Micronoctuidae, and Noctuidae) Michael FIBIGER and Hermann H. HACKER Superfamily NOCTUOIDEA LATREILLE, 1809 Remarks to Classification In the European List of Noctuidae (FIBIGER and HACKER, 1991) we refrained from writing a justification for subdividing the family into subfamilies and tribes. Our understanding of the classification of the family has progressed since then, but only to some extent therefore several paraphyletic or even polyphyletic groupings still remain in the Noctuidae (s.l.) and in the other families dealt with here. Most of the tribes listed here are monophyletic and we believe that most of them will stand the test of time. In groups where research is lasting, we refer to the latest knowledge available. For example the family Noctuidae has now been divided into three families, the Noctuidae, Micronoctuidae and Erebidae, these corresponding roughly to the groups previously called “quadrifid“ and “trifid“ noctuids. Ongoing research, however, suggests that the arctiid clade might be derived from within the Erebidae (WELLER and MITCHELL, pers. com.). Other important results have been published in the last 13 years, some of which are: KITCHING and RAWLINS (in KRISTENSEN, 1998); KITCHING and YELA (1999); SPEIDEL, FÄNGER and NAUMANN (1996); SPEIDEL and NAUMANN (1996); POOLE (1995, and his catalogue from 1989); the North American Moths of North America (MONA) book series: LAFONTAINE and POOLE (1991), POOLE (1995), LAFONTAINE (1998, 2004); BECK (1996, 1999, 2000); the volumes of the book series Noctuidae Europaeae (1990-2003); and many papers in Esperiana. -

Lepidoptera, Arctiidae, Lithosiinae) Ñåâåðî-Âîñòî÷Íîãî Êàçàõñòàíà
Евразиатский энтомол. журнал 14(5): 429–439 © EUROASIAN ENTOMOLOGICAL JOURNAL, 2015 ×åøóåêðûëûå-ëèøàéíèöû (Lepidoptera, Arctiidae, Lithosiinae) Ñåâåðî-Âîñòî÷íîãî Êàçàõñòàíà Lichen-moths (Lepidoptera, Arctiidae, Lithosiinae) of North-Eastern Kazakhstan Â.Â. Äóáàòîëîâ*, Ñ.Â. Òèòîâ** V.V. Dubatolov*, S.V. Titov** * Институт систематики и экологии животных СО РАН, ул. Фрунзе 11, Новосибирск 630091 Россия. E-mail: [email protected]. * Institute of Systematics and Ecology of Animals, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Frunze Str. 11, Novosibirsk 630091 Russia. ** Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, Научно-исследовательский экологический центр «Мониторинг», ул. Ломова 64, Павлодар KZ-140008 Республика Казахстан. E-mail: [email protected]. ** Pavlodar State University named after S. Toraigyrov, The Research Centre for Environmental «Monitoring», Lomova Str. 64, Pavlodar KZ-140008 Kazakhstan. Ключевые слова: Lithosiinae, чешуекрылые, лишайницы, Казахстан, новый подвид. Key words: Lithosiinae, Lepidoptera, lichen-moths, Kazakhstan, new subspecies. Резюме. В статье приводится список 20 видов лишай- Cеверо-восточные районыы Казахстана стали изу- ниц, из которых 7 (Manulea pallitella Scop., M. pygmaeola чаться значительно раньше северо-западных и се- Dbld., Wittia sororcula Hfn., Pelosia muscerda Hb., P. obtusa верных; ещё в середине XIX века в горах Алтая (в рай- H.-S., Lithosia quadra L., Thumatha senex Hb.) ранее в оне Усть-Каменогорска и Усть-Бухтарминска) Северо-Восточном Казахстане известны не были. Приво- путешествовал известный сборщик чешуекрылых дятся описания мест сбора, периоды лёта, распростране- ние. Описан новый подвид M. complana dzhungarica ssp.n., Й. Киндерманн. Его сборы обработал австрийский характеризующийся однотонной жёлтой окраской кры- лепидоптеролог Ю. Ледерер [Lederer, 1853, 1855]; в льев и приуроченный к аридным местам обитания. этих работах было указано 9 видов Lithosiinae, из которых 3 вида описаны как новые. -

Hors Série Numéro 1
Octobre 2010 Les Cahiers du Musée des Confluences Si conserver les collections est une activité fondamentale d'un musée, assurer leur valorisation en est un devoir. L’étude documentaire des collections, conduite en interne ou en partenariat, ou encore les études scientifiques menées par des chercheurs extérieurs, aboutissent généralement à des publications qui participent de cette valorisation. La série « Études scientifiques » des Cahiers du Musée des Confluences permet, notamment, de rendre compte de ces travaux. Études Scientifiques n°1 Volume 5 : Études Scientifiques n°1 Prix : 9,50 € N°ISSN : 1966-6845 Revue thématique Sciences et Sociétés du Musée des Confluences Cahiers du Musée des Confluences Sommaire Éditorial 3 Bruno JACOMY In memoriam 5 Roland BÉRARD Les Macrohétérocères de la Région Rhône-Alpes 9 Roland BÉRARD, Jacques BORDON, Claude COLOMB, Michel SAVOUREY, Cédric AUDIBERT, Yves ROZIER, Joël CLARY Egregia marpessa : nouveau genre et nouvelle espèce de Fulgoridae de Bornéo (Hemiptera : Fulgoromorpha) 43 Steven CHEW KEA FOO, Thierry PORION & Cédric AUDIBERT Cinq nouveaux Fulgoridae asiatiques (Hemiptera : Fulgoromorpha) 51 Steven CHEW KEA FOO, Thierry PORION & Cédric AUDIBERT Étude des espèces d'Élatérides décrites par Mulsant et al., désignation des lectotypes, changements de statut et de combinaison (Coleoptera : Elateridae) 65 Par Lucien LESEIGNEUR LES CAHIERS DU MUSÉE DES CONFLUENCES ÉTUDES SCIENTIFIQUES N°1 1 LES CAHIERS DU MUSÉE DES CONFLUENCES 2 ÉTUDES SCIENTIFIQUES N°1 Éditorial Avec ce premier numéro des Études scientifiques, le Musée des Confluences renoue avec une tradition, aussi ancienne qu’essentielle, de l’institution. S’inscrivant dans la lignée des Archives du Muséum, des Cahiers Scientifiques et des plus récents Cahiers du Musée des Confluences, cette nouvelle série vient rendre compte de la vie et du travail, souvent souterrains et parfois méconnus du grand public, que mènent les chercheurs sur les collections importantes et diverses du Musée des Confluences.