Erminlo Caprotti F) L Avole Propriamente Nei Vasti Ammassi Di
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
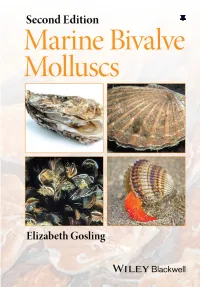
Marine Bivalve Molluscs
Marine Bivalve Molluscs Marine Bivalve Molluscs Second Edition Elizabeth Gosling This edition first published 2015 © 2015 by John Wiley & Sons, Ltd First edition published 2003 © Fishing News Books, a division of Blackwell Publishing Registered Office John Wiley & Sons, Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, PO19 8SQ, UK Editorial Offices 9600 Garsington Road, Oxford, OX4 2DQ, UK The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, PO19 8SQ, UK 111 River Street, Hoboken, NJ 07030‐5774, USA For details of our global editorial offices, for customer services and for information about how to apply for permission to reuse the copyright material in this book please see our website at www.wiley.com/wiley‐blackwell. The right of the author to be identified as the author of this work has been asserted in accordance with the UK Copyright, Designs and Patents Act 1988. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, except as permitted by the UK Copyright, Designs and Patents Act 1988, without the prior permission of the publisher. Designations used by companies to distinguish their products are often claimed as trademarks. All brand names and product names used in this book are trade names, service marks, trademarks or registered trademarks of their respective owners. The publisher is not associated with any product or vendor mentioned in this book. Limit of Liability/Disclaimer of Warranty: While the publisher and author(s) have used their best efforts in preparing this book, they make no representations or warranties with respect to the accuracy or completeness of the contents of this book and specifically disclaim any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. -

Phylum MOLLUSCA
285 MOLLUSCA: SOLENOGASTRES-POLYPLACOPHORA Phylum MOLLUSCA Class SOLENOGASTRES Family Lepidomeniidae NEMATOMENIA BANYULENSIS (Pruvot, 1891, p. 715, as Dondersia) Occasionally on Lafoea dumosa (R.A.T., S.P., E.J.A.): at 4 positions S.W. of Eddystone, 42-49 fm., on Lafoea dumosa (Crawshay, 1912, p. 368): Eddystone, 29 fm., 1920 (R.W.): 7, 3, 1 and 1 in 4 hauls N.E. of Eddystone, 1948 (V.F.) Breeding: gonads ripe in Aug. (R.A.T.) Family Neomeniidae NEOMENIA CARINATA Tullberg, 1875, p. 1 One specimen Rame-Eddystone Grounds, 29.12.49 (V.F.) Family Proneomeniidae PRONEOMENIA AGLAOPHENIAE Kovalevsky and Marion [Pruvot, 1891, p. 720] Common on Thecocarpus myriophyllum, generally coiled around the base of the stem of the hydroid (S.P., E.J.A.): at 4 positions S.W. of Eddystone, 43-49 fm. (Crawshay, 1912, p. 367): S. of Rame Head, 27 fm., 1920 (R.W.): N. of Eddystone, 29.3.33 (A.J.S.) Class POLYPLACOPHORA (=LORICATA) Family Lepidopleuridae LEPIDOPLEURUS ASELLUS (Gmelin) [Forbes and Hanley, 1849, II, p. 407, as Chiton; Matthews, 1953, p. 246] Abundant, 15-30 fm., especially on muddy gravel (S.P.): at 9 positions S.W. of Eddystone, 40-43 fm. (Crawshay, 1912, p. 368, as Craspedochilus onyx) SALCOMBE. Common in dredge material (Allen and Todd, 1900, p. 210) LEPIDOPLEURUS, CANCELLATUS (Sowerby) [Forbes and Hanley, 1849, II, p. 410, as Chiton; Matthews. 1953, p. 246] Wembury West Reef, three specimens at E.L.W.S.T. by J. Brady, 28.3.56 (G.M.S.) Family Lepidochitonidae TONICELLA RUBRA (L.) [Forbes and Hanley, 1849, II, p. -

Occurrence of the Hairy Ark Cockle (Anadara Gubernaculum, Reeve 1844) in Mayangan Coastal Waters, Subang – Province West Java: New Distribution Record of Indonesia
Asian Journal of Conservation Biology, December 2016. Vol. 5 No. 2, pp. 70-74 AJCB: FP0075 ISSN 2278-7666 ©TCRP 2016 Occurrence of the hairy ark cockle (Anadara gubernaculum, Reeve 1844) in Mayangan coastal waters, Subang – Province West Java: new distribution record of Indonesia Dewi Fitriawati1*, Nurlisa Alias Butet2 and Yusli Wardiatno2 1Master Program in Aquatic Resources Management, Graduate School of Bogor Agricultural University, Kampus IPB Dramaga – Bogor 16680, Indonesia 2Department of Aquatic Resources Management, Faculty of Fisheries and Marine Science, Bogor Agricultural University, Kampus IPB Dramaga – Bogor 16680, Indonesia (Accepted November 25, 2016) ABSTRACT Thirty six specimens of the hairy ark cockle (Anadara gubernaculum Reeve, 1844) were collected from Mayangan waters, Subang of Province West Java, during marine biodiversity survey along northern coast of Java Island, Indonesia. Previous records of the cockle showed its occurrence in Cilincing, northern coast of Jakarta, Semarang coastal waters of Province Central Java, and Sidoarjo coastal waters located in northern part of Province East Java. The identification of the species was performed by morphological characters and is supported by molecular analysis. This finding represents a new distribution record of the species in Indonesia. Keywords: Arcidae, bivalves, first record, mollusc, north Java. INTRODUCTION A.gubernaculum from Mayangan waters, Subang – Province West Java, Indonesia. At the same time it is a As an aquatic biodiversity hotspot, Indonesia has rich and diverse marine organisms, one of them is the cock- new distribution record of the species in Indonesian les group of Arcidae. The family Arcidae is a large and waters. diverse family of marine bivalve distributed worldwide in warm seas of tropical areas. -

The Foocal Pellets of the Trochidoo
[ 235 ] The Foocal Pellets of the Trochidoo. By Hilary B. Moore, B.Se., Zoologist at the Marine Station, Port Erin, I.a.M. With 12 Figures in the Text. FlECALPELLETSof the following species are described :- Gibbula cineraria (Linn.). G. umbilicalis (Da Costa). G. tumida (Montagu). G. magus (Linn.). Oantharus (Jujubinus) clelandi (Wood). Oalliostomazizyphinum (Linn.). Of the various molluscan frecalpellets so far described, none have shown a very high degree either of internal differentiation, or of external sculp- turing. In the latter respect the most complicated are perhaps those of the Nuculidre (Moore, 1) and the Pectinidre (Moore,2). In neither of these groups is there any trace of internal localisation of different types of material, but in the Mytilidre (Moore, 2) there is, in some species, a sorting of the finer material to the lateral regions of the frecal ribbon, and of the courser material to the centre. There is not however any clear-cut line of demarcation between the two regions. In the present group there is, in all the species described except Oalliostomazizyphinum, a localisation of the constituent materials accord- ing to their grade into certain definite regions of the pellet; and there is further, in all except Calliostoma, a very complex system of surface sculpturing. The pellets of Gibbula umbilicalis and G. cineraria may frequently be seen on the shore, where their peculiar shape makes them easily recognis- able. Moorhouse (3), speaking of Trochus niloticus from Low Isles, on the Great Barrier Reef, says: "Feeding appears to proceed at every opportunity, so that the amount of frecal matter deposited is very great. -

Surat Thani Blue Swimming Crab Fishery Improvement Project
Surat Thani Blue Swimming Crab Fishery Improvement Project -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Milestone 33b: Final report of bycatch research Progress report: The study of fishery biology, socio-economic and ecosystem related to the restoration of Blue Swimming Crab following Fishery improvement program (FIP) in Bandon Bay, Surat Thani province. Amornsak Sawusdee1 (1) The Center of Academic Service, Walailak University, Tha Sala, Nakhon Si Thammarat, 80160 The results of observation of catching BSC by using collapsible crab trap and floating seine. According to the observation of aquatic animal which has been caught by main BSC fishing gears; floating seine and collapsible crab trap, there were 176 kind of aquatic animals. The catch aquatic animals are shown in the table1. In this study, aquatic animal was classified into 11 Groups; Blue Swimming Crab (Portunus Pelagicus), Coelenterata (coral animals, true jellies, sea anemones, sea pens), Helcionelloida (clam, bivalve, gastropod), Cephalopoda (sqiud, octopus), Chelicerata (horseshoe crab), Hoplocari(stomatopods), Decapod (shrimp), Anomura (hermit crab), Brachyura (crab), Echinoderm (sea cucambers, sea stars, sea urchins), Vertebrata (fish). Vertebrata was the main group that was captured by BSC fishing gears, more than 70 species. Next are Helcionelloida and Helcionelloida 38 species and 29 species respectively. The sample that has been classified were photographed and attached in appendix 1. However, some species were classified as unknow which are under the classification process and reconcile. There were 89 species that were captured by floating seine. The 3 main group that were captured by this fishing gear are Vertebrata (34 species), Brachyura (20 species) Helcionelloida and Echinoderm (10 Species). On the other hand, there were 129 species that were captured by collapsible crab trap. -

Cementing Mussels to Oysters in the Pteriomorphian Tree: a Phylogenomic Approach
Cementing mussels to oysters in the pteriomorphian tree: a phylogenomic approach The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Lemer, Sarah, Vanessa L. González, Rüdiger Bieler, and Gonzalo Giribet. 2016. “Cementing mussels to oysters in the pteriomorphian tree: a phylogenomic approach.” Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 283 (1833): 20160857. doi:10.1098/ rspb.2016.0857. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2016.0857. Published Version doi:10.1098/rspb.2016.0857 Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:27822350 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA Cementing mussels to oysters in the rspb.royalsocietypublishing.org pteriomorphian tree: a phylogenomic approach Sarah Lemer1, Vanessa L. Gonza´lez2,Ru¨diger Bieler3 and Gonzalo Giribet1 Research 1Museum of Comparative Zoology, Department of Organismic and Evolutionary Biology, Harvard University, Cite this article: Lemer S, Gonza´lez VL, Bieler 26 Oxford Street, Cambridge, MA 02138, USA 2Department of Invertebrate Zoology, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, R, Giribet G. 2016 Cementing mussels to Washington, DC 20013, USA oysters in the pteriomorphian tree: a phylo- 3Integrative Research Center, Field Museum of Natural History, 1400 South Lake Shore Drive, Chicago, genomic approach. Proc. R. Soc. B 283: IL 60605, USA 20160857. SL, 0000-0003-0048-7296 http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2016.0857 Mussels (Mytilida) are a group of bivalves with ancient origins and some of the most important commercial shellfish worldwide. -

TREATISE ONLINE Number 48
TREATISE ONLINE Number 48 Part N, Revised, Volume 1, Chapter 31: Illustrated Glossary of the Bivalvia Joseph G. Carter, Peter J. Harries, Nikolaus Malchus, André F. Sartori, Laurie C. Anderson, Rüdiger Bieler, Arthur E. Bogan, Eugene V. Coan, John C. W. Cope, Simon M. Cragg, José R. García-March, Jørgen Hylleberg, Patricia Kelley, Karl Kleemann, Jiří Kříž, Christopher McRoberts, Paula M. Mikkelsen, John Pojeta, Jr., Peter W. Skelton, Ilya Tëmkin, Thomas Yancey, and Alexandra Zieritz 2012 Lawrence, Kansas, USA ISSN 2153-4012 (online) paleo.ku.edu/treatiseonline PART N, REVISED, VOLUME 1, CHAPTER 31: ILLUSTRATED GLOSSARY OF THE BIVALVIA JOSEPH G. CARTER,1 PETER J. HARRIES,2 NIKOLAUS MALCHUS,3 ANDRÉ F. SARTORI,4 LAURIE C. ANDERSON,5 RÜDIGER BIELER,6 ARTHUR E. BOGAN,7 EUGENE V. COAN,8 JOHN C. W. COPE,9 SIMON M. CRAgg,10 JOSÉ R. GARCÍA-MARCH,11 JØRGEN HYLLEBERG,12 PATRICIA KELLEY,13 KARL KLEEMAnn,14 JIřÍ KřÍž,15 CHRISTOPHER MCROBERTS,16 PAULA M. MIKKELSEN,17 JOHN POJETA, JR.,18 PETER W. SKELTON,19 ILYA TËMKIN,20 THOMAS YAncEY,21 and ALEXANDRA ZIERITZ22 [1University of North Carolina, Chapel Hill, USA, [email protected]; 2University of South Florida, Tampa, USA, [email protected], [email protected]; 3Institut Català de Paleontologia (ICP), Catalunya, Spain, [email protected], [email protected]; 4Field Museum of Natural History, Chicago, USA, [email protected]; 5South Dakota School of Mines and Technology, Rapid City, [email protected]; 6Field Museum of Natural History, Chicago, USA, [email protected]; 7North -

Rocky Shore Snails As Material for Projects (With a Key for Their Identification)
Field Studies, 10, (2003) 601 - 634 ROCKY SHORE SNAILS AS MATERIAL FOR PROJECTS (WITH A KEY FOR THEIR IDENTIFICATION) J. H. CROTHERS Egypt Cottage, Fair Cross, Washford, Watchet, Somerset TA23 0LY ABSTRACT Rocky sea shores are amongst the best habitats in which to carry out biological field projects. In that habitat, marine snails (prosobranchs) offer the most opportunities for individual investigations, being easy to find, to identify, to count and to measure and beng sufficiently robust to survive the experience. A key is provided for the identification of the larger species and suggestions are made for investigations to exploit selected features of individual species. INTRODUCTION Rocky sea shores offer one of the best habitats for individual or group investigations. Not only is there de facto public access (once you have got there) but also the physical factors that dominate the environment - tides (inundation versus desiccation), waves, heat, cold, light, dark, salinity etc. - change significantly over a few metres in distance. As a bonus, most of the fauna and flora lives out on the open rock surface and patterns of distribution may be clearly visible to the naked eye. Finally, they are amongst the most ‘natural’ of habitats in the British Isles; unless there has been an oil spill, rocky sea shores are unlikely to have been greatly affected by covert human activity. Some 270 species of marine snail (Phylum Mollusca, Class Gastropoda; Sub-Class Prosobranchia) live in the seas around the British Isles (Graham, 1988) and their empty shells may be found on many beaches. Most of these species are small (less than 3 mm long) or live beneath the tidemarks. -

Biodiversità Ed Evoluzione
Allma Mater Studiiorum – Uniiversiità dii Bollogna DOTTORATO DI RICERCA IN BIODIVERSITÀ ED EVOLUZIONE Ciclo XXIII Settore/i scientifico-disciplinare/i di afferenza: BIO - 05 A MOLECULAR PHYLOGENY OF BIVALVE MOLLUSKS: ANCIENT RADIATIONS AND DIVERGENCES AS REVEALED BY MITOCHONDRIAL GENES Presentata da: Dr Federico Plazzi Coordinatore Dottorato Relatore Prof. Barbara Mantovani Dr Marco Passamonti Esame finale anno 2011 of all marine animals, the bivalve molluscs are the most perfectly adapted for life within soft substrata of sand and mud. Sir Charles Maurice Yonge INDEX p. 1..... FOREWORD p. 2..... Plan of the Thesis p. 3..... CHAPTER 1 – INTRODUCTION p. 3..... 1.1. BIVALVE MOLLUSKS: ZOOLOGY, PHYLOGENY, AND BEYOND p. 3..... The phylum Mollusca p. 4..... A survey of class Bivalvia p. 7..... The Opponobranchia: true ctenidia for a truly vexed issue p. 9..... The Autobranchia: between tenets and question marks p. 13..... Doubly Uniparental Inheritance p. 13..... The choice of the “right” molecular marker in bivalve phylogenetics p. 17..... 1.2. MOLECULAR EVOLUTION MODELS, MULTIGENE BAYESIAN ANALYSIS, AND PARTITION CHOICE p. 23..... CHAPTER 2 – TOWARDS A MOLECULAR PHYLOGENY OF MOLLUSKS: BIVALVES’ EARLY EVOLUTION AS REVEALED BY MITOCHONDRIAL GENES. p. 23..... 2.1. INTRODUCTION p. 28..... 2.2. MATERIALS AND METHODS p. 28..... Specimens’ collection and DNA extraction p. 30..... PCR amplification, cloning, and sequencing p. 30..... Sequence alignment p. 32..... Phylogenetic analyses p. 37..... Taxon sampling p. 39..... Dating p. 43..... 2.3. RESULTS p. 43..... Obtained sequences i p. 44..... Sequence analyses p. 45..... Taxon sampling p. 45..... Maximum Likelihood p. 47..... Bayesian Analyses p. 50..... Dating the tree p. -

Fossil Bivalves and the Sclerochronological Reawakening
Paleobiology, 2021, pp. 1–23 DOI: 10.1017/pab.2021.16 Review Fossil bivalves and the sclerochronological reawakening David K. Moss* , Linda C. Ivany, and Douglas S. Jones Abstract.—The field of sclerochronology has long been known to paleobiologists. Yet, despite the central role of growth rate, age, and body size in questions related to macroevolution and evolutionary ecology, these types of studies and the data they produce have received only episodic attention from paleobiologists since the field’s inception in the 1960s. It is time to reconsider their potential. Not only can sclerochrono- logical data help to address long-standing questions in paleobiology, but they can also bring to light new questions that would otherwise have been impossible to address. For example, growth rate and life-span data, the very data afforded by chronological growth increments, are essential to answer questions related not only to heterochrony and hence evolutionary mechanisms, but also to body size and organism ener- getics across the Phanerozoic. While numerous fossil organisms have accretionary skeletons, bivalves offer perhaps one of the most tangible and intriguing pathways forward, because they exhibit clear, typically annual, growth increments and they include some of the longest-lived, non-colonial animals on the planet. In addition to their longevity, modern bivalves also show a latitudinal gradient of increasing life span and decreasing growth rate with latitude that might be related to the latitudinal diversity gradient. Is this a recently developed phenomenon or has it characterized much of the group’s history? When and how did extreme longevity evolve in the Bivalvia? What insights can the growth increments of fossil bivalves provide about hypotheses for energetics through time? In spite of the relative ease with which the tools of sclerochronology can be applied to these questions, paleobiologists have been slow to adopt sclerochrono- logical approaches. -

Structure of Subtidal Algal Assemblages on Soft- Bottom Sediments: Faunalflora Interactions and Role of Disburbances in the Bay of Brest, France
MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES Vol. 85: 115-130,1992 Published August 27 Mar. Ecol. Prog. Ser. Structure of subtidal algal assemblages on soft- bottom sediments: faunalflora interactions and role of disburbances in the Bay of Brest, France Christian Hily 'l*, Philippe Potin1, Jean-Yves ~loc'h~ 'CNRS. LP 4601, Station de Biologie marine, F-29211 Roscoff, France '~aboratoirede Physiologie vegetale, Institut dnEtudesMarines, Universitb de Bretagne Occidentale, Avenue Le Gorgeu. F-29287 Brest Cbdex, France ABSTRACT : Algal and fauna1 assemblages living on soft bottom sediments were studied in the Bay of Brest, France, using quantitative descriptions of the distribution, diversity and biomass of epibenthic species. Similar classification and ordination analyses were used on floral and animal data. Dense as- semblages of macrophytes, mainly Rhodophyceae, were found to grow on sandy mud sediments. Sediments were essentially covered by maerl beds of the calcareous red alga Lithothamnion corallioi- des and various shell substrates. Five maln algal assemblages extended along a west-east decreasing gradient of hydrodynamic activity (i.e. tidal currents, waves and turbidity). The high frequency of storms during the year is the main feature which disturbs both flora and epifauna. Interactions between flora and fauna were either direct, e.g. grazing and spatial competition, or indirect, most of the sub- strata occupied by macrophytes being shells of dead bivalves and gastropods. Moreover attachment of algae was largely dependent on population dynamics of shell species living in the area. As a conse- quence, in the most disturbed area, the macrophytes found were opportunistic species (Polysiphonia fibrillosa and Polysiphonia urceolata). In areas where the assemblage was unstructured, a fact which prevented the development of the herbivorous species, the animal assemblage was then dominated by suspension feeders (FicuLina ficus and Phallusia marnmillata) which competed for space with the macrophytes. -

Marine Molluscs (Scaphopoda, Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda) Around the Amouliani Island, Chalkidiki (Greece)
Bulletin of the Natural History Museum - Plovdiv Bull. Nat. Hist. Mus. Plovdiv, 2016, vol. 1: 25-29 Short note Marine Molluscs (Scaphopoda, Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda) around the Amouliani Island, Chalkidiki (Greece) 1,2* 1 Dilian G. Georgiev , Ognyan B. Todorov 1 - Regional Natural History Muzeum – Plovdiv, Hristo G. Danov Str., 34, BG-4000 Plovdiv, BULGARIA 2 - University of Plovdiv, Faculty of Biology, Department of Ecology and Environmental Conservation, 24 Tzar Assen Str., BG-4000 Plovdiv, BULGARIA * Corresponding author: [email protected] Abstract. A total of 91 species of marine molluscs at the waters of Amouliani are known after present study: Scaphopoda (1), Gastropoda (53), Bivalvia (33), and Cephalopoda (4). Keywords: Northern Greece, Mollusca, species diversity. Introduction COSSIGNANI et al. (1992), ABBOTT & DANCE The only information on marine molluscs (2000), GARILLI & GALLETTI (2006), ÖZTÜRK around Amouliani Island (Chalkidiki, Greece) (2011) and NERLOVIĆ et al. (2016). is known form the internet site of the Athos Scuba Diving Center. It provides important Results photographs (authors: Yiannis Iliopoulos, Adding the the six species of sea slugs Androniki Iliadou, Stephan Kyutchukov) of sea reported by the Athos Scuba Diving Center to slugs found at the waters of Amoliani Island our finds there, a total of 91 species of marine (http://athos-scuba.blogspot.bg/p/marine- molluscs have until now been recorded in the life.html) (Table 2). waters of Amouliani (Table 2): Scaphopoda (1), In this short note we provide some Gastropoda (53), Bivalvia (33), and contributions to the knowledge of the very rich Cephalopoda (4). sea mollusc fauna of this area. Acknowledgements Dilian Georgiev is grateful to Paolo Russo Material and Methods The study was carried out during 2015- (Italian Society of Malacology) for identification of a specimen of Striarca lactea.