Catalogo 2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rankings Municipality of Castel Morrone
9/24/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links ITALIA / Campania / Province of Caserta / Castel Morrone Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH ITALIA Municipalities Powered by Page 2 Ailano Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Falciano del AdminstatAlife logo Massico DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Alvignano ITALIA Fontegreca Arienzo Formicola Aversa Francolise Baia e Latina Frignano Bellona Gallo Matese Caianello Galluccio Caiazzo Giano Vetusto Calvi Risorta Gioia Sannitica Camigliano Grazzanise Cancello ed Gricignano di Arnone Aversa Capodrise Letino Capriati a Liberi Volturno Lusciano Capua Macerata Carinaro Campania Carinola Maddaloni Casagiove Marcianise Casal di Marzano Appio Principe Mignano Monte Casaluce Lungo Casapesenna Mondragone Casapulla Orta di Atella Caserta Parete Castel Pastorano Campagnano Piana di Monte Castel di Sasso Verna Castel Piedimonte Morrone Matese Castel Volturno Pietramelara Castello del Pietravairano Matese Pignataro Cellole Maggiore Cervino Pontelatone Cesa Portico di Powered by Page 3 Ciorlano Caserta L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Conca della Prata Sannita Adminstat logo Campania DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH PratellaITALIA Curti Presenzano Dragoni Raviscanina Recale Riardo Provinces Rocca d'Evandro Roccamonfina Roccaromana -

Linea L50 Piedimonte Benevento
Provincia di Caserta - Settore Trasporti, Mobilità e Infrastrutture Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Caserta Dipartimento di Ingegneria - Università del Sannio LINEA L50 PIEDIMONTE BENEVENTO Numero coppie corse Codice Nome Descrizione 7:00-9:00 13:00-15:00 17:00-19:00 Totale Giorno Percorrenza Media A+R Km Tipologia Giorni esercizio Percorrenze Annue Km Totali L50 Piedimonte Benevento Piedimonte S.Potito Gioia S. Benevento 1 1 1 5 132ScolasticaUniversitaria 200 132.000,00 132.000,00 143 Provincia di Caserta - Settore Trasporti, Mobilità e Infrastrutture Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Caserta Dipartimento di Ingegneria - Università del Sannio LINEA L51 PIEDIMONTE CASERTA Numero coppie corse Codice Nome Descrizione 7:00-9:00 13:00-15:00 17:00-19:00 Totale Giorno Percorrenza Media A+R Km Tipologia Giorni esercizio Percorrenze Annue Piedimonte Alife Dragoni Alvignano Caiazzo Piana di M. S. Leucio Caserta 1 1 1 6 92Feriale 305 168.360,00 Piedimonte Caserta Piedimonte Alife Dragoni Liberi Formicola Pontelatone S. Angelo in Formis S. Maria CV Caserta 2 2 1 9 123Feriale 305 337.635,00 Raviscanina S.Angelo d'Alife Piedimonte Alife Dragoni Alvignano Caiazzo Piana Di Raviscanina Caserta Napoli Monte Verna Triflisco Capua S.Maria CV L51 CasertaNapoli 1 1 1 3 208Feriale 305 190.320,00 S.Potito Piedimonte Alife Dragoni Alvignano Piedimonte Caserta Caiazzo Piana Di M.V. San Leucio Caserta 1 1 2 92Feriale 305 56.120,00 Km Totali S.Gregorio Castello M. Piedimonte Alife Dragoni Alvignano Caiazzo Piana Di M.V. -

Curriculum Vitae Europass
Curriculum Formativo e Professionale Formato Europeo Informazioni personali Nome / Cognome Alfonso Santagata Indirizzo Via Erennio Ponzio Alife 81011 – Caserta Telefono 368244627 Cellulare C.F. SNTLNS59S02A200D email [email protected] Cittadinanza Italiana Data di nascita 02/11/1959 Luogo di nascita Alife Sesso Maschile Titolo di Studio Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli studi di Napoli conseguita in data 25/02/1987. Specialista in Chirurgia d’urgenza e del Pronto Soccorso,conseguita presso l’Università degli studi di Napoli nell’anno accademico 1991/92. Diploma di Menagement dei servizi sanitari conseguito presso l’Università degli studi di Bologna nell’anno 1997. Esperienze Vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami presso la U.S.L. n 10 di Teano professionali come assistente chirurgo presso la divisione di Chirurgia Generale, dal Date 16/07/1990 al 21/04/1991. Lavoro o posizione ricoperti Dal 22/04/1991 al 31/12/1994 assistente medico di ruolo trasferimento Principali attività e chirurgia generale ASL Ce/1- Caserta. responsabilità Nome e indirizzo del datore di Dal 01/01/1995 al 23/03/2009 a tutt’oggi Dirigente medico area di chirurgia e lavoro specialità chirurgia d’urgenza di ruolo DLGS 502/92- LR32/94 chirurgia generale Tipo di attività o settore P.O. Piedimonte Matese. Dal 18/02/02 al 31/10/2006 Incarico di Dirigente di Struttura Semplice ( C2 ) Servizio di Day Surgery presso Chirurgia del P.O. di Piedimonte Matese. Dal 01/11/2006 a tutt’oggi Incarico di Dirigente di Struttura Semplice ( C1 ) Servizio di Day Surgery presso Chirurgia del P.O. -

Linea L42 Giano V. Pignataro Sparanise
LINEA L42 GIANO V. PIGNATARO SPARANISE Numero coppie corse Codice Nome Descrizione 7:00-9:00 13:00-15:00 17:00-19:00 Totale Giorno Percorrenza Media A+R Km Tipologia Giorni esercizio Percorrenze Annue Km Totali L42 Giano Vetusto Pignataro Sparanise Calvi Giano Vetusto Pignataro Sparanise Calvi 1 1 1 4 43 Feriale 305 52,460.00 52,460.00 129 LINEA L43 CAPUA PIGNATARO ROCCAROMANA Numero coppie corse Codice Nome Descrizione 7:00-9:00 13:00-15:00 17:00-19:00 Totale Giorno Percorrenza Media A+R Km Tipologia Giorni esercizio Percorrenze Annue 1 1 1 7 72 Feriale 305 153,720.00 Km Totali L43 Capua Pignataro Riardo Pietramelara Rocaromana Capua Pignataro Riardo Pietramelara Rocaromana 1 1 1 4 68 Festive 57 15,504.00 169,224.00 130 LINEA L44 LETINO CAPRIATI CASERTA Numero coppie corse Codice Nome Descrizione 7:00-9:00 13:00-15:00 17:00-19:00 Totale Giorno Percorrenza Media A+R Km Tipologia Giorni esercizio Percorrenze Annue Km Totali Letino Gallo Capriati Prata S. Pratella Ailano Pietravairano Letino Gallo Capriati Prata S. Pratella Ailano L44 Vairano Caserta Pietravairano Vairano Caserta 2 1 1 6 170 Feriale 305 311,100.00 311,100.00 131 LINEA L45 PIGNATARO BELLONA CASERTA Numero coppie corse Codice Nome Descrizione 7:00-9:00 13:00-15:00 17:00-19:00 Totale Giorno Percorrenza Media A+R Km Tipologia Giorni esercizio Percorrenze Annue Km Totali Pignataro Camigliano Vitulazio Bellona Capua S.Maria L45 Pignataro Caserta CV Caserta 2 1 1 6 64 Feriale 305 117,120.00 117,120.00 132 LINEA L46 TEANO CASERTA NAPOLI Numero coppie corse Codice Nome Descrizione -

Europeiska Gemenskapernas Officiella Tidning 11.10.2001 L
L 270/12 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 11.10.2001 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1979/2001 av den 10 oktober 2001 om ändring av förordning (EG) nr 2138/97 om avgränsning av produktionsområden för olivolja EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT b) i länet ”Ρεθύµνου”, skall produktionszonerna ersättas med DENNA FÖRORDNING följande zoner: med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ”— zon 1: gemenskapen, ∆ήµοι και Κοινότητες: Αδελέ, Αµνάτους, Κυριάννας, Μαρουλά, Μέσης, Παγκαλοχωρίου, Πρασσών, Πηγής, med beaktande av rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22 ∆. Ρεθύµνης, Ρουσσοσπητίου, Χρωµοναστηρίου, Χαµα- september 1966 om den gemensamma organisationen av λευρίου, Χαρακίων. marknaden för oljor och fetter (1), senast ändrad genom förord- ning (EG) nr 1513/2001 (2), — zon 2: ∆ήµοι και Κοινότητες: Αρµένων, Γουλεδιανών, Καρές, med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2261/84 av den Καστέλλους, Κούµων, Όρους, Σελλίου. 17 juli 1984 om allmänna bestämmelser om beviljande av stöd för framställning av olivolja och stöd till organisationer för — zon 3: producenter av olivolja (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1639/98 (4), särskilt artikel 19 i denna, och ∆ήµοι και Κοινότητες: Αγίου Κωνσταντίνου, Άνω Βαλσαµόνερου, Αργυρούπολης, Ατσιποπούλου, Βιλανδ- av följande skäl: ρέδους, Γερανίου, Γωνιάς, Ζουριδίου, Καλονυκτίου, Κάτω Βαλσαµόνερου, Κάτω Πόρου, Μούνδρους, Μυριο- κεφάλων, Πρινών, Ρουστίκων, Σαϊτούρων, Φρατζ. Μετο- Enligt artikel 18 i förordning (EEG) nr 2261/84 skall (1) χίων, Μαλακίου. skördar av oliver och olivolja fastställas för enhetliga produktionsområden på grundval av uppgifter från de — zon 4: producerande medlemsstaterna. ∆ήµος: Επισκοπής Ρεθύµνης. (2) Avgränsningen av produktionsområdena fastställs i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2138/97 — zon 5: av den 30 oktober 1997 om avgränsning av produk- Κοινότητες: Ασωµάτου, Λευκογείων, Μαριούς, tionsområden för olivolja (5), senast ändrad genom Μυρθίου. -

VINCOLI PAESISTICI - D.Lgs
Assessorato ai Rapporti con il Consiglio Regionale - Sport - Lavori Pubblici - Opere Pubbliche - Parcheggi - Cave e Torbiere, Acque Minerali, Termali e Miniere Commissario ad Acta PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE Ordinanza T.A.R. Campania - Napoli - Prima sezione - n. 719 del 18/5/05 M O L E I O S Capriati a Volturno Gallo Matese PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE I Fontegreca 61079_01 San Pietro Infine Letino Ciorlano Tavola n. 3 - CE: VINCOLI PAESISTICI - D.Lgs. 42/2004 61030_02 Provincia di Caserta Z Prata Sannita Valle Agricola territorio di San Gregorio Matese Mignano Monte Lungo San Gregorio Matese 62044_00 Il Commissario ad Acta delegato Pratella 61001_09 61064_03 (Decreto Ass. Reg. LL.PP. n. 439 del 6/9/05) 62044_01 62044_03 Coordinatore A.G.C. LL.PP., OO.PP., Attuazione, Espropriazione Piedimonte Matese Castello Matese Santa Croce del Sannio Ing. Eduardo Morrone Ailano Gruppo montuoso del Matese Rocca d'Evandro A Ambito massiccio del Matese Raviscanina Napoli, Giugno 2006 Presenzano Sassinoro 61069_03 62044_04 Piedimonte Matese 61065_01 61039_10 Sant'Angelo d'Alife Conca della Campania Pietraroia San Potito Sannitico Morcone Galluccio Tora e Piccilli 62026_03 L Vairano Patenora Cusano Mutri 61095_10 Pietravairano Alife Marzano Appio massiccio del Matese Gruppo montuoso del Matese 62054_04 Baia e Latina zona di Roccamonfina Gioia Sannitica Caianello 62054_01 SS 87 e zona di Pontelandolfo complesso vulcanico Roccamonfina Cerreto Sannita Gruppo vulcanico di Roccamonfina Pontelandolfo Roccamonfina Campolattaro Roccaromana Fragneto -

UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE Di CASERTA VIA APPIA ANTICA LOC
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI D.G.T. del SUD UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE di CASERTA VIA APPIA ANTICA LOC. PONTESELICE Turno: N° 000170-0/UMC-CE /UFF-TURNI del 15/10/2020 turno di Lunedì 19-10-2020 Mattina NOTA: Nel report non vengono riportate le attività annullate INGEGNERI Attività Richiedente Sede/Note Mattina MAINOLFI P. GSUPU UMC SEDE UMC SEDE ESP. GUIDA RICCIARDI P. REV<3,5P1 UMC SEDE UMC SEDE TECNICI Attività Richiedente Sede/Note Mattina IANNOTTA A. REV>3,5P1 UMC SEDE UMC SEDE ESAMINATORI A/B Attività Richiedente Sede/Note Mattina CAIAZZA A. TINFO UMC SEDE UMC SEDE 1 CAMPOPIANO D. TINFO UMC SEDE UMC SEDE 2 CASTALDO A. GMOTO CONS. CENTRO GUIDA PISTA ... CAPODRISE ASSISTENTI Attività Richiedente Sede/Note Mattina AVERSANO F. REV<3,5P1 UMC SEDE UMC SEDE OPER. DA DEFINIRE . REV>3,5P1 UMC SEDE UMC SEDE Pomeriggio NOTA: Nel report non vengono riportate le attività annullate INGEGNERI Attività Richiedente Sede/Note Pomeriggio IMPERATORE C. REV>3,5D AG. DM GROUP SRLS DRAGONI MAGLIOCCA A. IECML COMMISSIONE MEDICA LOCALE CASERTA MAINOLFI P. GSUP CONS. LA FENICE CASERTA RICCIARDI P. REV>3,5D AG. SUESSA REV. VAIRANO PATENORA SGAMBATO G. REV>3,5D AG. CICCAGLIONE ROCCA D'EVANDRO TECNICI Attività Richiedente Sede/Note Pomeriggio IANNOTTA A. REV>3,5D AG. EUROGUIDA MADDALONI SCIAUDONE G. REV>3,5D AG. CRA SAS LUSCIANO ESAMINATORI A/B Attività Richiedente Sede/Note Pomeriggio ALLOCCA S. GMOTO CONS. CENTRO GUIDA PISTA ... CAPODRISE CAIAZZA A. GAUTO LA GIUGLIANESE FRIGNANO CAIAZZA I. GAUTO SALVETTI MADDALONI CAMPOPIANO D. GAUTO DI NUZZO MADDALONI CASTALDO A. -

Bollettino.Pdf
********************************************************************************** * SI-13-SM-PDO2B * * * * SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE * * * * * * SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO * * * * * * UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA * * * * * * UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : CASERTA * * * * * * ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO * * * * * * ANNO SCOLASTICO 2012/2013 * * * * * * ATTENZIONE: PER EFFETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY QUESTA STAMPA NON * * CONTIENE ALCUNI DATI PERSONALI E SENSIBILI CHE CONCORRONO ALLA * * COSTITUZIONE DELLA STESSA. AGLI STESSI DATI GLI INTERESSATI O I * * CONTROINTERESSATI POTRANNO EVENTUALMENTE ACCEDERE SECONDO LE MODALITA' * * PREVISTE DALLA LEGGE SULLA TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. * * * * * ********************************************************************************** POSTI DI SOSTEGNO PER MINORATI PSICO-FISICI ***** TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL COMUNE 1. ARCHIAPATTI ANNALISA . 8/ 3/61 (CE) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. VISTA) DA : CEMM82901Q - S.GIOVANNI BOSCO -PORTICO DI CE ( PORTICO DI CASERTA ) A : CEMM82901Q - S.GIOVANNI BOSCO -PORTICO DI CE ( PORTICO DI CASERTA ) PRECEDENZA: UFF. NELLA SCUOLA SU ALTRA TIP. SOSTEGNO PUNTI 94 2. BARONE GIOVANNA . 7/ 6/63 (NA) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. VISTA) DA : CEMM82901Q - S.GIOVANNI BOSCO -PORTICO DI CE ( PORTICO DI CASERTA ) A : CEMM82901Q - S.GIOVANNI BOSCO -PORTICO DI CE ( PORTICO DI CASERTA ) PRECEDENZA: UFF. NELLA SCUOLA SU ALTRA TIP. SOSTEGNO PUNTI 99 3. D'ACO MASSIMO . 1/10/64 (CE) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) DA : CEMM851033 - CAPUA VIGNE SEZ. S.ANGELO IN F. ( CAPUA ) A : CEMM851011 - PIER DELLE VIGNE -CAPUA- ( CAPUA ) PUNTI 218 4. DE CHIARA ANGELICA . 25/ 5/65 (BO) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) DA : CEMM84501N - D. CIMAROSA -AVERSA- ( AVERSA ) A : CEMM01700D - G.PASCOLI-AVERSA- ( AVERSA ) PUNTI 120 5. DELLA ROSA SILVANA . 15/10/56 (CE) TIT. -

B) OJ No L 67, 25. 3. 1995, P. 1
29 . 7. 95 EN Official Journal of the European Communities No L 179/3 COMMISSION REGULATION (EC) No 1864/95 of 26 July 1995 fixing for the four previous marketing years 1990/91 to 1993/94 the average yields of olives and olive oil THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, (EEC) No 1934/93 (5), as amended by Regulation (EC) No 38/94 (% together with the adjustments made by Regula Having regard to the Treaty establishing the European tion (EC) No 1 840/94 f) except as regards municipalities Community, which have yields different from those of the zones to Having regard to Council Regulation No 136/66/EEC of which they belong ; 22 September 1966 on the establishment of a common organization of the market in oils and fats ('), as last Whereas the measures provided for in this Regulation are amended by the Act of Accession of Austria, Finland and in accordance with the opinion of the Management Sweden and Regulation (EC) No 3290/94 (2), and in parti Committee for Oils and Fats, cular Article 5 thereof, Having regard to Council Regulation (EEC) No 2261 /84 HAS ADOPTED THIS REGULATION : of 17 July 1984 laying down general rules on the granting of aid for the production of olive oil and of aid to olive oil producer organizations (3), as last amended by Regulation Article 1 (EEC) No 636/95 (4), and in particular Article 19 thereof, The average yields of olives and olive oil for the four Whereas, for the purpose of granting production aid to previous marketing years 1990/91 to 1993/94 shall be as olive growers who produce less than 500 kilograms of oil, specified in the Annex hereto . -

Elenco Controinteressati
INDICAZIONE NOMINATIVA DEI CONTROINTERESSATI IN RELAZIONE AL RICORSO R.G. N. 5846/2014 INNANZI IL TAR CAMPANIA DI NAPOLI. Il Comune di Cesa (C.F.: 81001370618) con sede in Cesa alla Piazza de Gasperi, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., a mezzo del sottoscritto avv. Giuseppe Somma difensore e procuratore dello stesso Ente comunale nel giudizio R.G. n. 5846 del 2014 innanzi la Sez. IV del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di Napoli Premesso che con Ordinanza n. 3915 del 09.06.2021 emessa dal TAR Campania di Napoli (Sezione Quarta) nell’ambito del giudizio R.G. n. 5846 del 2014, è stato previsto che Comune di Cesa (C.F.: 81001370618) quale parte ricorrente, proceda all’integrazione del contraddittorio, mediante la notificazione per pubblici proclami secondo le specifiche modalità prescritte nella stessa ordinanza, nei confronti di tutti i controinteressati non evocati in giudizio, ovvero nei confronti della Provincia di Caserta e di tutti i Comuni consorziati con il (C.I.T.L.) Consorzio Idrico Terra di Lavoro (C.F.: 00100070614) che furono chiamati a partecipare alla ripartizione del debito oggetto di causa (contratto dallo stesso C.I.T.L. con Enel Servizio Elettrico S.p.A.) in forza della Delibera n. 1 del 14.07.2014 adottata con i poteri dell’Assemblea del Consorzio Idrico Terra di Lavoro dal Commissario ad Acta per l'ottemperanza della Sentenza n.248/11 della Sezione IV del Tar Campania di Napoli e degli ulteriori provvedimenti adottati dal citato Commissario ad Acta, tutti impugnati dal Comune di Cesa con il sopra indicato ricorso R.G. -

Official Journal of the European Communities 11.10.2001
L 270/12 EN Official Journal of the European Communities 11.10.2001 COMMISSION REGULATION (EC) No 1979/2001 of 10 October 2001 amending Regulation (EC) No 2138/97 delimiting the homogenous olive oil production zones THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, ‘— zone 1: ∆ήµοι και Κοινότητες: Αδελέ, Αµνάτους, Κυριάννας, Having regard to the Treaty establishing the European Μαρουλά, Μέσης, Παγκαλοχωρίου, Πρασσών, Πηγής, Community, ∆. Ρεθύµνης, Ρουσσοσπητίου, Χρωµοναστηρίου, Χαµα- λευρίου, Χαρακίων. Having regard to Council Regulation No 136/66/EEC of 22 September 1966 on the common organisation of the market in — zone 2: oils and fats (1), as last amended by Regulation (EC) No 1513/ 2001 (2), ∆ήµοι και Κοινότητες: Αρµένων, Γουλεδιανών, Καρές, Καττέλλους, Κούµων, Όρους, Σελλίου. Having regard to Council Regulation (EEC) No 2261/84 of 17 July 1984 laying down general rules on the granting of aid for — zone 3: the production of olive oil and of aid to olive oil producer organisations (3), as last amended by Regulation (EC) No 1639/ ∆ήµοι και Κοινότητες: Αγίου Κωνσταντίνου, Άνω 98 (4), and in particular Article 19 thereof, Βαλσαµόνερου, Αργυρούπολης, Ατσιποπούλου, Βιλαν- δρέδους, Γερανίου, Γωνιάς, Ζουριδίου, Καλονυκτίου, Whereas: Κάτω Βαλσαµόνερου, Κάτω Πόρου, Μούνδρους, Μυριοκεφάλων, Πρινών, Ρουστίκων, Σαϊτούρων, Φρατζ. (1) Article 18 of Regulation (EEC) No 2261/84 stipulates Μετοχίων, Μαλακίου. that the olive yields and oil yields are to be fixed by homogeneous production zones on the basis of the — zone 4: figures supplied by producer Member States. ∆ήµος: Επισκοπής Ρεθύµνης. (2) The production zones are set out in the Annex to — zone 5: Commission Regulation (EC) No 2138/97 of 30 October 1997 delimiting the homogenous olive oil production Κοινότητες: Ασωµάτου, Λευκογείων, Μαριούς, zones (5), as last amended by Regulation (EC) No 2461/ Μυρθίου. -
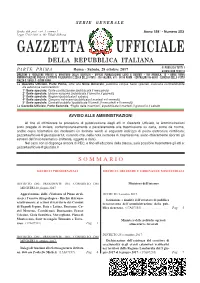
Gazzetta Ufficiale
SERIE GENERALE Spediz. abb.abb. post. post. - art.45% 1, -comma art. 2, 1 comma 20/b Anno 158° - Numero 253 LeggeLegge 27-02-2004,23-12-1996, n. n. 46 662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA TUTTI I PARTE PRIMA Roma - Sabato, 28 ottobre 2017 GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONEDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO PRESSOL’ISTITUTO IL POLIGRAFICOMINISTERO EDELLA ZECCA GIUSTIZIADELLO STATO - UFFICIO - VIA SALARIA, PUBBLICAZIONE 691 - 00138 LEGGI ROMA E - DECRETICENTRALINO - VIA 06-85081 ARENULA - LIBRE 70 RIA- 00186DELLO STATOROMA PIAZZAAMMINISTRAZIONE G. VERDI, 1 -PRESSO 00198 ROMA L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081 La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: [email protected], curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).