I Bastioni Di Pizzighettone Capitolo 5
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Classifica Scuole
CAMPIONATO STUDENTESCO CORSA CAMPESTRE CREMONA CADETTE FEMMINILI POS SCUOLA PUNTI 1 I.C. DIOTTI - CASALMAGGIORE 13 3 2 IC CREMA UNO - CREMA 32 3 3 IC CREMONA DUE - CREMONA 36 3 4 IC NELSON MANDELA C3 - CREMA 74 3 5 IC CREMONA TRE - CREMONA 77 3 6 IC CREMONA UNO - CREMONA 93 3 7 IC CASTELLEONE - CREMONA 96 3 8 IC GUSSOLA - GUSSOLA 97 3 9 IC CREMONA CINQUE - CREMONA 106 3 10 S.M. D. ALIGHIERI - CREMA 115 3 11 IC MONTODINE - CREMONA 119 3 12 IC CREMA DUE - CREMA 125 3 13 IC BAGNOLO CREM - BAGNOLO CREMASCO 125 3 14 IC VESCOVATO - VESCOVATO 168 3 15 I.C. RIVOLTA ADDA - RIVOLTA D'ADDA 177 3 16 I.C. SORESINA - SORESINA 201 3 17 I.C. SERGNANO - SERGNANO 226 3 18 IC CASTELVERDE - CASTELVERDE 230 3 19 IC CASALBUTTANO - CASALBUTTANO 254 3 20 IC PIADENA - PIADENA 266 3 21 IC PIZZIGH-S.BASS - PIZZIGHETTONE 292 3 22 IC SOSPIRO - SOSPIRO 365 3 CADETTI MASCHILI POS SCUOLA PUNTI 1 IC CREMA UNO - CREMA 24 3 2 S.M. D. ALIGHIERI - CREMA 25 3 3 IC CASTELLEONE - CREMONA 36 3 4 IC NELSON MANDELA C3 - CREMA 37 3 5 IC CREMONA CINQUE - CREMONA 49 3 6 IC CREMA DUE - CREMA 56 3 7 I.C. DIOTTI - CASALMAGGIORE 68 3 8 I.C. RIVOLTA ADDA - RIVOLTA D'ADDA 108 3 9 IC VESCOVATO - VESCOVATO 114 3 10 IC BAGNOLO CREM - BAGNOLO CREMASCO 127 3 11 IC CREMONA DUE - CREMONA 129 3 12 I.C. SORESINA - SORESINA 137 3 13 IC PIZZIGH-S.BASS - PIZZIGHETTONE 140 3 14 IC MONTODINE - CREMONA 155 3 15 IC GUSSOLA - GUSSOLA 162 3 16 IC CREMONA TRE - CREMONA 172 3 17 IC CREMONA UNO - CREMONA 178 3 18 I.C. -

LINEA K302 : Cremona - Soresina NUMERO VERDE: 800 111 717 - [email protected] Orario in Vigore Da: 9 Giugno 2016
LINE S.p.A. - Via Felice Cavallotti 62, LODI LINEA K302 : Cremona - Soresina NUMERO VERDE: 800 111 717 www.lineservizi.it - [email protected] Orario in vigore da: 9 giugno 2016 codice corsa 21200 21086 21102 k301-21176 21067 4133 2672 k301-2604 2674 2690 2689 4138 21171 2675 k301-21178 2676 2697 21219 2691 2692 k305-2615 F6 F5 F5 Sab F5 stagionalità F6 F6 Scol F6 Est F6 F6 Scol F6 F6 F6 F6 F6 F5 Scol F5 Sab Scol F6 Est F5 4Ago F6 no4Ago no4Ago no4Ago no4Ago no4Ago CREMONA TERMINAL-Corsia 13 A 05:30 06:05 06:20 06:20 06:25 06:50 08:15 10:15 11:15 12:10 13:10 14:15 14:15 14:15 14:15 15:45 17:15 18:00 18:00 18:30 19:45 CREMONA-Via Castelleone 18 05:32 06:07 06:22 06:22 06:27 06:52 08:17 10:17 11:17 13:12 14:17 14:17 14:17 15:47 17:17 18:02 18:02 18:32 19:47 CREMONA-Via Sesto/fr30 05:33 06:08 06:23 06:23 06:28 06:53 08:18 10:18 11:18 13:13 14:18 14:18 14:18 15:48 17:18 18:03 18:03 18:33 19:48 CREMONA-Via Sesto/fr70 05:35 06:10 06:25 06:25 06:30 06:55 08:20 10:20 11:20 13:15 14:20 14:20 14:20 15:50 17:20 18:05 18:05 18:35 19:50 CREMONA-PICENENGO 53 05:36 06:11 06:26 06:26 06:31 06:56 08:21 10:21 11:21 13:16 14:21 14:21 14:21 15:51 17:21 18:06 18:06 18:36 19:51 CREMONA-PICENENGO/fr80 05:37 06:12 06:27 06:27 06:32 06:57 08:22 10:22 11:22 13:17 14:22 14:22 14:22 15:52 17:22 18:07 18:07 18:37 19:52 SESTO ED UNITI-CASANOVA D.M.-Via Picenen 05:40 06:15 06:30 06:30 06:35 07:00 08:25 10:26 11:25 13:21 14:25 14:25 14:26 15:55 17:25 18:10 18:10 18:40 19:55 SESTO CR-CASANOVA D.M-Via Cremona/fr 4 05:41 06:16 06:31 06:31 06:36 07:01 08:26 10:27 11:26 -

Capitolo 5 Gli Indirizzi E Le Indicazioni Per Le Aree Industriali
Capitolo 5 Gli indirizzi e le indicazioni per le aree industriali (il presente capitolo sostituisce il par.4.2.4 del Documento Direttore) La presente relazione integra quella precedentemente inserita nel paragrafo 4.2.4 del Documento Direttore del PTCP vigente e descrive finalità e contenuti della variante parziale di adeguamento del Piano vigente alle disposizioni della l.r. 12/05 e successive modifiche e integrazioni in materia di aree industriali. 5.1 - Gli indirizzi e le indicazioni per le aree industriali Il tema dei poli industriali di livello sovracomunale costituisce un contenuto di livello orientativo del PTCP nei confronti della pianificazione comunale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 12/05 e nello specifico risulta disciplinato dalla l.r. 1/2000 art. 2 comma 32. Questo comporta la conferma integrale delle scelte e delle disposizioni operate nel PTCP vigente del 2003 e un aggiornamento dello stato di attuazione delle scelte programmatorie operate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. In una realtà caratterizzata dal sovradimensionamento e dalla frammentazione delle aree industriali e da una dinamica insediativa che risponde ad esigenze per gran parte locali, gli obiettivi prioritari diventano la razionalizzazione dimensionale e localizzativa delle previsioni di aree industriali e la definizione di criteri per il dimensionamento e la localizzazione delle nuove previsioni. Questo al fine di conseguire un aumento dell’efficienza localizzativa e della tutela del territorio attraverso la protezione delle risorse paesistico-ambientali, la minimizzazione del consumo di suolo e il conseguimento di buoni livelli di accessibilità esistenti e previsti. La massima priorità d’intervento è attribuita al recupero delle aree industriali dismesse localizzate in siti idonei, subordinando al loro completamento l’urbanizzazione o l'utilizzo di nuove aree industriali. -
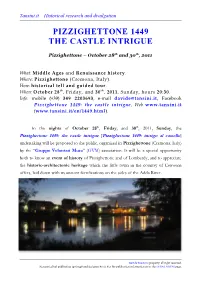
Pizzighettone 1449 the Castle Intrigue
Tansini.it – Historical research and divulgation PIZZIGHETTONE 1449 THE CASTLE INTRIGUE Pizzighettone – October 28th and 30th, 2011 What: Middle Ages and Renaissance history. Where: Pizzighettone (Cremona, Italy). How: historical tell and guided tour. When: October 28 th, Friday, and 30th, 2011, Sunday, hours 20:30. Info: mobile (+39) 349 2203693, e-mail [email protected], Facebook Pizzighettone 1449: the castle intrigue, Web www.tansini.it (www.tansini.it/en/1449.html). In the nights of October 28th, Friday, and 30th, 2011, Sunday, the Pizzighettone 1449: the castle intrigue [Pizzighettone 1449: intrigo al castello] undertaking will be proposed to the public, organized in Pizzighettone (Cremona, Italy) by the “Gruppo Volontari Mura” (GVM) association. It will be a special opportunity both to know an event of history of Pizzighettone and of Lombardy, and to appreciate the historic-architectonic heritage which the little town in the country of Cremona offers, laid down with its ancient fortifications on the sides of the Adda River. Davide Tansini’s property: all right reserved. Non periodical publication (47/1948 and 62/2001 Acts). For the publication information enter the LEGAL NOTES page. Tansini.it – Historical research and divulgation Suggestive locations will be background and integral part of the event: the coast borgo’s walls, lit up with the blaze of torches and lanterns. Really evoking location which will allow Davide Tansini – historian and studious of fortified architecture, associated of the “Istituto Italiano dei Castelli” and of the “Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda” – to tell a fact happened in 1449: the conquest of the garrison of Pizzighettone by the condottiero Francis Sforza Visconti. -

Agriturismi+Provincia+Di+Cremona.Pdf
Provincia di The province of / Die Provinz Cremona La provincia di Cremona è compresa tra i due grandi fiumi lombardi: il Po (a sud) e l’Adda (ad ovest). Interamente pianeggiante, il suo territorio offre tutto il ventaglio delle ricchezze padane: grandi aziende agricole, allevamenti modernissimi, grandi riserve di caccia, ma anche industrie e manifatture tra le più moderne. Cremona, città ricca di storia e di pregevoli monumenti, offre uno stile di vita capace di far gioire delle cose belle della vita, a partire da quelle che si gustano a tavola... The province of Cremona is wedged between the two large rivers of Lombardy: the Po (to the south) and the Adda (to the west). Totally flat, its land offers the whole range of riches of the Po: large commercial farms, the latest methods in livestock farming, large hunting reserves, but also some of the most modern industries and factories. Cremona, a city steeped in history and precious monuments, offers a lifestyle encouraging you to delight in the beautiful things of life, starting with those enjoyed at the table... Die Provinz Cremona liegt zwischen den beiden großen Flüssen der Lombardei: dem Po (im Süden) und dem Adda (im Westen). Ihre zur Gänze flache Landschaft bietet eine große Bandbreite an Reichtümern der Poebene: große Agrarbetriebe, hypermoderne Zuchtbetriebe, große Jagdreviere, aber auch Industrie und modernste Manufakturbetriebe. Cremona, eine geschichtsträchtige Stadt mit sehenswerten Denkmälern, bietet einen Lebensstil, der die schönen Dinge des Lebens hervorhebt, beginnend bei jenen, die man bei Tisch genießen kann... 85 Provincia di Cremona Agricola “Motta” di Franzoni Agriturismo Sant’Alessandro Giacinta & C. -

Comune.Pizzighettone.Cr.It
ilL’INFORMATORE Torrione DEL COMUNE DI PIZZIGHETTONE - n. 1 - luglio 2010 www.comune.pizzighettone.cr.it SOMMARIO L’energia verde e la salvaguardia ambientale 2 Bilancio e dintorni 3 Un grande successo per Pizzighettone 6 La Valle dell’Adda 9 Servizi Sociali, una situazione al tracollo 11 Reti di Solidarietà del Territorio 14 Nuvole tra le mura 15 Orientamento universitario all’Informagiovani 16 Spazio di ascolto 17 Soggiorno climatico anziani 18 Lo scempio 19 della lingua italiana Gruppi consiliari 20 www.comune.pizzighettone.cr.it Luigi Bernocchi, Sindaco il Torrione LA PAROLA AL SINDACO L’energia verde e la salvaguardia ambientale Con il continuo progredire dello sviluppo economico Ma concretamente come possiamo procedere per dare il e industriale mondiale, il fabbisogno energetico delle nostro contributo? La nostra amministrazione comunale nazioni è diventato sempre più imponente e pressante; già da qualche tempo si è attivata per la realizzazione di questa continua richiesta di materie prime e di energia ci impianti fotovoltaici sugli edifi ci di proprietà, utilizzando sta portando verso l’esaurimento defi nitivo delle risorse forme contrattuali che consentono di azzerare i costi di naturali del nostro pianeta, oltre che alla completa rovina installazione e manutenzione. Come avrete avuto l’occa- dell’ecosistema in cui viviamo. sione di vedere, la Scuola Media E. Fermi è già stata Avendo ben presente questo pericolo, che sembra sem- dotata di tali impianti per cui non “pesa” più sul bilan- pre più un’inevitabile spada di Damocle, ma soprattutto cio del nostro Comune per quanto riguarda il consumo con l’obiettivo di rallentare se non sovvertire completa- energetico. -

Modifiche Proposte Da Padania Acque Al Piano
“Evoluzione e finanziamento del Piano d’Ambito” proposta da Padania Acque Disamina dell’istanza di variante al Programma degli Interventi - CdA U.ATO del 19/7/2017. MODIFICHE PROPOSTE DA PADANIA ACQUE Elenco interventi AL PIANO DEGLI INTERVENTI 2016/2019 approvato dalla Conferenza dei Comuni del 115 interventi confermati con anno di pianificazione modificato e 30/5/2016 (MTI2) con realizzazione entro il 2019 – tabella 1. + modifiche 209 approvate dal CdA 46 interventi confermati con importo modificato. U.ATO. interventi 13 interventi confermati e accorpati in altri interventi – tabella 2. confermati Attuale nel periodo di Programma 31 interventi confermati senza nessuna modifica. pianificazione degli 2016/2019 Interventi 4 interventi confermati e “confluiti in budget” – tabella 3. 2016/2019: 271 4 interventi (di cui 3 competenza Comune) non inclusi nella 62 interventi proposta di Padania Acque ma che ci dovrebbero essere in individuati quanto conclusi o in corso di realizzazione – tabella 4. interventi 0 interventi eliminati dalla pianificazione – tabella 5. non 18 interventi con modifica anno di pianificazione e con confermati realizzazione dopo il 2019 – tabella 6. nel periodo di 40 interventi al momento non inclusi nella proposta di Padania pianificazione Acque – tabella 7. 2016/2019 TABELLA 1 - 115 interventi confermati con anno di pianificazione modificato e con realizzazione entro il 2019 NB: potrebbe contenere modifiche importo. PIANO D'AMBITO ATTUALE PROPOSTA PADANIA ACQUE OBIETTIVO DA OBIETTIVO DA ANNO DI RAGGIUNGERE RIFACIMENTO -

Ordine Provinciale Dei Medici Chirurghi E Degli Odontoiatri Di Cremona
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI CREMONA VIA PALESTRO, 66 - 26100 CREMONA Tel.: 0372/35224 - Fax: 0372/27368 [email protected] [email protected] Albo professionale Anno 2019 (Aggiornato al 31/12/2018) ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI CREMONA VIA PALESTRO, 66 - 26100 CREMONA Tel.: 0372/35224 - Fax: 0372/27368 [email protected] [email protected] Albo professionale ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI CONSIGLIO DIRETTIVO E DEGLI ODONTOIATRI DI CREMONA Presidente Lima Gianfranco VIA PALESTRO, 66 - 26100 CREMONA Vice Presidente Mauri Fabrizio Tel.: 0372/35224 - Fax: 0372/27368 [email protected] Tesoriere Priori Fabio Angelo [email protected] Segretario Pani Aldo Consigliere Abbiati Annalisa Consigliere Agosti Marco Consigliere Bini Annamaria Consigliere Carnevale Giuseppe Consigliere Carniti Nerino Consigliere Crea Francesco Consigliere Firetto Silvia Consigliere Guarneri Ernesto Consigliere Mariconti Maria Assunta AlboConsigliere Morandi Andrea Consigliere Savoldi Pierangelo Consigliere Signorini Pietro Enrico Consigliere Telli Stefania professionale REVISORI DEI CONTI EFFETTIVI Presidente Lena Alessandro Carina Igino Quinzani Filippo REVISORI DEI CONTI SUPPLENTE Bozzetti Anna Maria ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI CREMONA VIA PALESTRO, 66 - 26100 CREMONA Tel.: 0372/35224 - Fax: 0372/27368 [email protected] [email protected] Albo professionale ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI CREMONA VIA PALESTRO, 66 - 26100 CREMONA Tel.: 0372/35224 - Fax: 0372/27368 [email protected] [email protected] Albo professionale Medici Chirurghi Anno 2019 ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI Legenda Annotazioni DI CREMONA VIA PALESTRO, 66 - 26100 CREMONA - Doppia iscrizione Albo Medici Chirurghi e Albo Odontoiatri Tel.: 0372/35224 - Fax: 0372/27368 A [email protected] D - Esercizio Psicoterapia (Legge n. -

Pretura Di Cremona
Pretura di Cremona Fascicoli Contenzioso Busta 1 Anno 1931 fasc. 905 Contravvenzione dell‟ordinanza di rientro nella propria abitazione non più tardi “dell‟Ave Maria” e di non trattenersi nelle osterie (Cremona) fasc. 907 Contravvenzione alla legge 24/3/1921 sulla pesca (pesca senza licenza e con reti di misura vietata) (Stradone Brescia-Cremona) fasc. 908 Contravvenzione art. 51 R.D. 2/12/1928: transito in bicicletta senza fanale acceso (Cremona) fasc. 911 Transito con autocarro trainante un rimorchio la cui targa posteriore era priva di illuminazione (Cremona) fasc. 918 Pesca senza licenza ed esercizio vendita ambulante di pesce senza il prescritto certificato di autorizzazione (Ostiano) fasc. 926 Simulazione di reato con la falsa denuncia ai Carabinieri di aver subito un furto (Persico Dosimo) fasc. 937 Offesa all‟onore e al prestigio di una guardia giurata, aggressione a mano armata e rifiuto di declinare le generalità (Spinadesco) fasc. 946 Inosservanza della legge sulla caccia per avere in due giorni ucciso delle quaglie (Ostiano) fasc. 957 Mancata applicazione degli obblighi del contratto di lavoro dei salariati e braccianti (Ca‟ d‟Andrea) fasc. 955 Contravvenzione al Regolamento Comunale di igiene mediante la vendita di pane mal cotto (Corte de‟ Cortesi) Anno 1932 fasc. 1201 Truffa, ingiusto profitto ed emissione assegni a vuoto (Fiorenzuola d‟Arda-Cremona) fasc. 1204 Contravvenzione al foglio di via obbligatorio (Cingia de‟ Botti) fasc. 1208 Attraversamento incauto del passaggio a livello a San Lorenzo Picenardi con carro agricolo (San Lorenzo Picenardi) fasc. 1209 Presunta sottrazione di animali dalla stalla nell‟azienda agricola condotta in affitto (Villarocca di Pessina Cremonese) fasc. -

La Situazione E' Aggiornata a Tutt'oggi 07/05/2019
AMBITO CREMONA-OVEST SORESINA Acquanegra Cr.se – Grumello Cr.se – Sesto ed Uniti – Crotta d’Adda – Formigara – Pizzighettone – Annicco – Cappella Cantone – S.Bassano Olmeneta – Soresina – Azzanello – Castelvisconti – Casalmorano – Paderno Ponchielli – Casalbuttano – Corte de’ Cortesi con Cignone – Bordolano. LA SITUAZIONE E’ AGGIORNATA A TUTT’OGGI 07/05/2019 BARTOLI LAURA Corte de’ Cortesi – Bordolano -Cignone ha posti liberi BROCCA GIANLUIGI Soresina-Azzanello-Casalmorano- Castelvisconti non ha posti liberi BURGIO CARMELO Soresina –Formigara –Cornaleto ha posti liberi BUSSINI MARCO Soresina ha posti liberi CAPPELLETTI ALESSANDRA Paderno Ponchielli –Cignone -Casalbuttano - Ossolaro ha posti liberi CARRAI PAOLA Sesto ed Uniti – INCARICATO PROVVISORIO ha posti liberi CASANA PATRIZIA Soresina ha posti liberi CASOLA MARIA Sesto Cr.se – Casanova D/M. - Crotta d’Adda – Cappella Cantone ha posti liberi CREA FRANCESCO Soresina non ha posti liberi DI MALTA ANTONIO Soresina- Casalmorano – Mirabello ha posti liberi FRIGNATI DANTE ANGELO Soresina non ha posti liberi GENTILE ROSARIO Pizzighettone – Roggione – ha posti liberi ISTODORESCU GEORGETA Soresina – San Bassano ha posti liberi KAMALI DOLAT ABADI Pizzighettone – Regona- Roggione ha posti liberi LUPI IREANA Olmeneta ha posti liberi MAINARDI LEANDRO Acquanegra Cr.se – Fengo -Grumello – Farfengo ha posti liberi MANCINI LUIGI Casalbuttano ed Uniti ha posti liberi MASSONE ALDA Soresina ha posti liberi ORSONI M. GABRIELLA Pizzighettone non ha posti liberi PRIORI FABIO Polengo – Casalbuttano ha posti liberi RONZA GIOVANNA Casalbuttano – Polengo-Paderno Ponchielli ha posti liberi SARTORI FABRIZIO Grumello Cr.se – Zanengo ha posti liberi SCUTELLA’ SONIA Pizzighettone non ha posti liberi SVERZELLATI GIOVANNI S.Bassano – Cappella Cantone ha posti liberi VETRANO CALOGERO Annicco – Barzaniga – Grontorto non ha posti liberi . -

The Town Walls of Pizzighettone: a Fortified Settlement Crossed by a River, Through Six Centuries of History
THE TOWN WALLS OF PIZZIGHETTONE: A FORTIFIED SETTLEMENT CROSSED BY A RIVER, THROUGH SIX CENTURIES OF HISTORY GIANFRANCO GAMBARELLI - Gruppo Volontari Mura O.N.L.U.S., Pizzighettone (CR) GIULIANA CARDANI - Politecnico di Milano Dip. di Ingegneria Civile ed Ambientale [email protected] ROLANDO PIZZOLI -, Politecnico di Milano DICA - Associazione Culturale Famiglia Sinaghina di Busto Arsizio (VA) LA CINTA MURARIA DI PIZZIGHETTONE: UN INSEDIAMENTO FORTIFICATO ATTRAVERSATO DA UN FIUME E DA SEI SECOLI DI STORIA La cittadina di Pizzighettone, in provincia di Cremona, rappresenta un raro esempio di insediamento fortificato attraversato barriere naturali sono da sempre state determinanti per la forma e la struttura delle Adda che con la sua profondità e le sue forti correnti, ha rappresentato per gli assalitori un quasi insormontabile ostacolo. La cinta murata del borgo, risalente al XIV secolo, fu rafforzata prima dai Visconti e poi dagli Sforza sotto la direzione di Guiniforte Solari, in quanto caposaldo del confine orientale del Ducato di Milano. Nel 1585, sotto il dominio spagnolo ci fu un tentativo di aggiornare la fortezza con i nuovi principi fortificatori con la costruzione di baluardi, terrapieni e parapetti, ma le periodiche il progetto fu abbandonato. Fu solo a partire dal 1646, dopo aver rettificato il corso del fiume Adda, che Pizzighettone fu dotato di un complesso sistema bastionato, che si estendeva su entrambe le sponde del fiume. Nel 1706 Pizzighettone passò strada fra Milano e Mantova, furono costruite e aggiornato il -

Relazione Illustrativa
Comune di Comune di Comune di Comune di Comune di Cremona Spinadesco Sesto ed Uniti Castelverde Persico Dosimo Comune di Comune di Comune di Comune di Comune di Acquanegra Crotta d’Adda Bonemerse Pizzighettone Stagno Lombardo Provincia di Cremonese Cremona Comune di Comune di Comune di Comune di Gadesco Pieve Malagnino Grumello Cremonese Gerre dè Caprioli Delmona ed Uniti Piano Territoriale d’Area del Cremonese Scenari strategici e proposta metodologica REL.01 Relazione illustrativa Il Presidente della Provincia Gruppo di lavoro Massimiliano Salini Luca Menci (Responsabile scientiico) Marco Banderali L’assessore alla Pianiicazione territoriale Giovanni Leoni Roberto Bertoli Alex Massari Il Dirigente del Settore Pianiicazione territoriale Maurizio Rossi Gianluca Vicini Andrea Censi Il Responsabile del Settore Pianiicazione territoriale Barbara Armanini Marzo 2012 Approvato con Delibera del C.P. n° _________ del _____________ Piano Territoriale d’Area del Cremonese Relazione illustrativa SOMMARIO 1. Premessa ................................................................................................................................................................ 1 2. Analisi conoscitiva e ricognizione delle previsioni derivanti dagli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale ........................................................................................................................................... 4 2.1 Dinamiche insediative ...................................................................................................................................