Visualizza E Scarica Il Numero Completo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Texto IV-5 Fantina Tedim
TEDIM, F.; LEONE, V. (2018). The deadly avalanche of Rigopiano (Itália): evidences of a constructed loca scale disaster , The overarching issues of the european space - preparing the new decade for key socio-economic and environmental challenges, Porto, Fac. Letras Univ. Porto. pp. 408 - 424 THE DEADLY AVALANCHE OF RIGOPIANO (ITALY): EVIDENCES OF A CONSTRUCTED LOCAL SCALE DISASTER Fantina TEDIM Faculty of Arts, University of Porto, Portugal Charles Darwin University, Australia [email protected] Vittorio LEONE Forestry and Environmental Sciences University of Basilicata, Italy(retired) [email protected] Abstract In a context of enhancing development, namely using natural resources and amenities to attract investments and create jobs, local interests can undervalue the natural risks. Our work demonstrates how local decisions and private, and political issues can interplay increasing risks and converge in creating a small-scale disaster. On January 18 th 2017, an avalanche of size 5 (200,000 m 3) buried under 4 meters of snow the Rigopiano Hotel, in the National Park of Gran Sasso and Maiella, in Italy. In this four-star resort, 38 people were blocked inside when the avalanche hit. Two people, who fortuitously escaped the avalanche because they were outside the hotel, contacted the Operational Center for Emergency. Rescue activities started after some hours of misunderstanding about alarm truthfulness. After some days of frantic efforts, carried out 24h/24 by up to 330 people, 9 people were pulled out alive and in good conditions, whereas 29 victims were pulled from wreckage. Our research demonstrates how the coincidence of structural and contingent factors of natural and human origin converged into a disaster. -

La Radioattivita' Ambientale Nei Quattro Parchi Della Regione Abruzzo
RAPPORTI TECNICI / TECHNICAL REPORTS LA RADIOATTIVITA’ AMBIENTALE NEI QUATTRO PARCHI DELLA REGIONE ABRUZZO S. Barbizzi1, S. Calvarese2, R. Fico2, M. Belli1 & U. Sansone3 1 Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), Servizio di Metrologia Ambientale, Roma - Italia 2 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise «G.Caporale», Teramo - Italia 3International Atomic Energy Agency (IAEA), Agency’s Laboratories, Seibersdorf - Austria RIASSUNTO A partire dal 1998 l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise «G.Caporale» di Teramo ha avviato una serie di indagini radioecologiche nei territori della Regione Abruzzo al fine di acquisire maggiori conoscenze sulla mobilità geochimica e biologica dei radionuclidi rilasciati dall’evento accidentale di Chernobyl. Sono stati regolarmente prelevati campioni di erba, funghi, muschi e terreni all’interno del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco Nazionale della Maiella. I risultati hanno messo in evidenza la presenza di ricadute radioattive conseguenti all’evento di Chernobyl confrontabili tra i diversi quatro parchi e che il 137Cs è ancora presente negli ambienti semi-naturali in quantità tali da non porre problemi di rischio radiologico PAROLE CHIAVE Radioattività ambientale, 137Cs, 40K, Parchi Regione Abruzzo. Introduzione neggiato. A seguito dell’esplosio- ENVIROMENTAL Le ricadute radioattive conse- ne nel reattore nucleare ucraino RADIOACTIVITY guenti all’evento incidentale di infatti, insieme ad elementi gasso- IN FOUR NATIONAL PARKS Chernobyl del 26 aprile 1986 han- si ed aerosol, sono state rilasciate OF THE ABRUZZO REGION no interessato in maniera irregola- particelle di diverse dimensioni, (CENTRAL ITALY) re i territori dei diversi paesi euro- costituite da frammenti di combu- pei, a causa delle diverse condi- stibile e da materiale strutturale Summary zioni meteorologiche ed orografi- del reattore. -

CURRICULUM VITAE - Paolo Ciucci (Updated 7 Dec 2019)
CURRICULUM VITAE - Paolo Ciucci (updated 7 Dec 2019) Paolo Ciucci Associate Professor Department of Biology and Biotechnologies “Charles Darwin” Sapienza Università di Roma Viale dell’Università, 32 – 00185 Roma Tel. (office) +39.06.49914750 Fax +39.06.491135 E-mail: [email protected] External Services ID: - ORCID (https://orcid.org/): 0000-0002-0994-3422 - Researcher ID (http://www.researcherid.com): C-7677-2009 Content p. Main interest and expertise ............................................................................................... 1 Education ..................................................................................................................... 1 Academic Positions .......................................................................................................... 2 Fellowships and Awards ................................................................................................... 2 Institutional appointments/committees ............................................................................... 2 Teaching ..................................................................................................................... 3 Academic committees ...................................................................................................... 4 Student supervision ......................................................................................................... 5 Funding .................................................................................................................... -
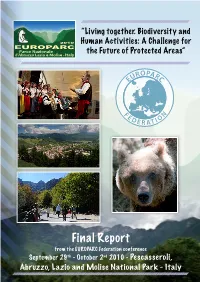
Pdfeuroparc Conference 2010 Report
“Living together. Biodiversity and Human Activities: A Challenge for the Future of Protected Areas” ROPAR EU C F N E D O E R AT I Final Report from the EUROPARC Federation conference September 29th - October 2nd 2010 - Pescasseroli, Abruzzo, Lazio and Molise National Park - Italy ROPAR EU C Contents I. IN BRIEF F N E D O 4 Welcome to the EUROPARC Conference E R AT I General Overview 6 II. IN FOCUS Keynote: speakers 2010: Words from the platform! EUROPARC General Assembly 2010 Transboundary certificate awards Glances and memories from the excursions Workshops: Working together for biodiversity Alfred Toepfer scholarship winners 16 III. IN GENERAL Erika Stanciu (President, EUROPARC Federation) Carol Ritchie (Director Europarc Federation) Sarat Gidda (Convention for Biological Diversity) Harvey Locke (Vice President for Conservation Strategy of the Wild Foundation, Boulder Colorado USA) Jon Jarvis (Director National Park Service USA) Else Oestergaard Andersen (Thy National Park, Denmark) Helen Read (City of London, England) Giuliano Tallone (Ente Parco Nazionale del Circeo, Italy) 2 WELCOME TO THE EUROPARC 2010 CONFERENCE elcome to the Abruzzo, Lazio and Molise National WPark, we are very delighted to have you here. As president i wish to thank the EUROPARC FEDERATION, EUROPARC staff and administration and in particolar the president Erika Stanciu and the director Carol Ritchie, for choosing Italy, Abruzzo and our National Park for the 2010 conference. Greetings to the local Authorities and to the International guests. A special thank you to all that have worked hard to make this event possible. I would like to wish you a pleasant stay and good work hoping that we may be able to exchange many profitable experiences and ideas for the future of protected areas. -

Strongylid Nematodes Shared Between Domestic and Wild Ruminants In
STRONGYLID NEMATODES SHARED BETWEEN DOMESTIC AND WILD RUMINANTS IN MAIELLA NATIONAL PARK (ABRUZZO REGION - CENTRAL ITALY) B PAOLETTI1, S ANGELUCCI2, S MORELLI1, C SMOGLICA1, A BARLAAM1, A DI CESARE1 1Faculty of Veterinary Medicine, University of Teramo, 64100 Italy; 2Maiella National Park, Via del Vivaio snc, 65023 Caramanico Terme, Italy Keywords - Strongyles, Ruminants, Maiella National Park, Central Italy INTRODUCTION. Strongylid nematodes (SN) are recognized as a major constraint to livestock production. The control of SN relies heavily on the use of chemotherapeutics; as a consequence, anthelminthic resistance (AR) is increasing (Barone et al., 2020). It is known that wild ruminants are competent hosts of a number of SN that typically infect livestock and it is assumed that they could also act as reservoirs in the translocation of anthelmintic resistance (Chintoan-Uta et al., 2014). This risk is heightened where the pasture of domestic and wild ruminants overlaps. The aim of the present study was to obtain novel information on the distribution of SN in sheep and wild ruminants (i.e., red deer, chamois) sharing the same pasture in the Maiella National Park. MATERIALS AND METHODS. In 2019, a total of 20 faecal pool samples were collected from sheep (n. 7) and wild ruminants (n. 13) (Figures 1, 2, 3) that shared the same pasture in the highlands of the Maiella National Park (Abruzzo region, central Italy). The samples were examined by a classic copromicroscopic technique (Euzeby, 1981). Gastrointestinal strongyle (GIS) positive pools were subjected to coprocolture (MAFF, 1986) (Figure 4). L3s were morphologically and molecularly identified (Gasser et al., 1993; van Wyk et al., 2013). -

Abruzzo 6 M N R E V O G Abruzzo N
INSIDE: Ancient Ceramics and Ceremonies 4 Snapshots d Sweet Sulmona 5 r a o B m s i of r Cooking and Skiing u o T t n e in Abruzzo 6 m n r e v o G Abruzzo n a Cool Places to Stay 8 i l a t I L’Aquila SPECIA L REPORT : ABRUZZO dream of ® Maiella Mountains IVolumeT6, Issue 9 A www.dreamofitalyLY.com November 2007 Abruzzo : ITALY AS IT ONCE WAS Pescara’s Porto Turistico ast night you left New York and that’s flown under the tourism radar L this morning you woke up in for a long time. The headline covering “ 1954!”joked Mario Scalzi of The the visit in the local newspaper said Italian Travel Promotion Council as he simply, “You found us.” welcomed several hundred American tour operators, travel agents Indeed it wasn’t until the and journalists to Pescara this 1960s that any substantial spring. The group arrived, to infrastructure, especially a red carpet rolled out on the highways, came to the runway and a band, on the region. Historically, Abruzzo inaugural Eurofly flight from was a rural and poor society Fontana delle 99 Cannelle, L’Aquila New York’s JFK Airport to somewhat isolated from the Pescara. While Scalzi may rest of the country. This have been referring to the might explain why between 1950’s architecture of the city’s airport, 1901 and 1915 alone, a million people in so many ways Abruzzo does seem emigrated from Abruzzo and neigh - like a throwback to a dif - boring Molise. -

Dr. Geol. Adele Garzarella Informazioni Personali
Curriculum Vitae – Dr. Geol. Adele Garzarella Informazioni personali Nome e Cognome Adele Garzarella Indirizzo via Nazionale, 122, 66015, Fara San Martino (Ch) Italia Cellulare: +39.338.8141363 E-mail [email protected] Nazionalità Italiana Data di nascita 13/12/1977 Genere F Campo di occupazione Scienze geologiche SPERIENZE DI LAVORO E Periodo Settembre 2018 – Gennaio 2019 Occupazione Collaboratore esterno Attività principale e responsabilità Ricerca. Laboratorio. Pubblicazioni scientifiche. Tutor tesi di laurea. Datore di lavoro Dipartimento Ingeo, Università degli Studi “G. d’Annunzio”, Chieti-Pescara, via dei Vestini, 66100 Chieti Periodo 2017-2019 Occupazione Membro della Commissione "Geoparco della Majella" Attività principale e responsabilità Redazione del dossier per la candidatura del Parco Nazionale della Majella a Geoparco UNESCO Datore di lavoro Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo Periodo Febbraio 2017 – Giugno 2018 Occupazione Docente - Progetto alternanza scuola lavoro Attività principale e responsabilità Docente di Geologia Datore di lavoro Istituto Algeri Marino – Casoli (CH) Periodo Marzo 2016 – Febbraio 2018 Occupazione Assegnista di ricerca Attività principale e responsabilità Ricerca. Laboratorio. Pubblicazioni scientifiche. Supporto alla didattica. Tutor di tesi di laurea. Datore di lavoro Dipartimento Ingeo, Università degli Studi “G. d’Annunzio”, Chieti-Pescara, via dei Vestini, 66100 Chieti Periodo Gennaio 2014 Occupazione Contratto co.co.co. Attività principale e responsabilità Micropaleontologia, laboratorio. Datore di lavoro Dipartimento Ingeo, Università degli Studi “G. d’Annunzio”, Chieti-Pescara, via dei Vestini, 66100 Chieti Periodo Dal 2007 a oggi Occupazione Collaboratore esterno Attività principale e responsabilità Cultore della materia e supporto alla didattica per gli insegnamenti di Paleontologia e Micropaleontologia; attività di tutoraggio, attività didattico- integrative; Correlatore di Tesi di Laurea. -
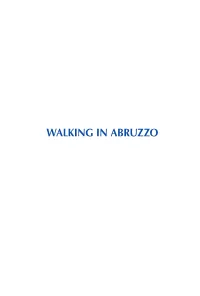
Walking in Abruzzo Walking in Abruzzo
WALKING IN ABRUZZO WALKING IN ABRUZZO About the Author GRAN SASSO, MAIELLA AND ABRUZZO NATIONAL Stuart Haines is a walker, mountain lover, guidebook writer, project man- PARKS, AND SIRENTE-VELINO REGIONAL PARK ager and occasional viticulturalist. His explorations of the remoter cor- ners of central Italy began in 2004, following many years of climbing and by Stuart Haines adventuring in the Alps, North America and his native UK. Since 2007 he has been based between Bristol, England, and Casa La Rocca, the country house in the heart of Abruzzo that he renovated with his partner, Hil. The house offers self-catered accommodation for visitors to the region and is the base for Stuart’s support service for walkers, cyclists and everyone who comes to discover the grandeur of Abruzzo for themselves – route advice, drop-offs and pick-ups, pack transport, overnight booking and the organic Montepulciano d’Abruzzo house wine all available under one roof – www.casalarocca.it. JUNIPER HOUSE, MURLEY MOSS, OXENHOLME ROAD, KENDAL, CUMBRIA LA9 7RL www.cicerone.co.uk © Stuart Haines 2019 Second edition 2019 CONTENTS ISBN: 978 1 85284 978 8 First edition 2011 Map key ...................................................... 9 Overview map ................................................ 10 Location of walks .............................................. 11 Printed in China on behalf of Latitude Press Ltd A catalogue record for this book is available from the British Library. INTRODUCTION ............................................. 13 All photographs are by the author unless otherwise stated. Abruzzo ..................................................... 15 Geological history ............................................. 16 Route mapping by Lovell Johns www.lovelljohns.com Human history ................................................ 17 Contains OpenStreetMap.org data © OpenStreetMap Animals and birds .............................................. 19 contributors, CC-BY-SA. NASA relief data courtesy of ESRI Plants and flowers ............................................ -

Download Detailed Trip Notes
Guided ‘Small Group' adventure Abruzzo Apennines Mountains, Monasteries & Castles A cultural walking tour through the three National Parks of Abruzzo: great mountain scenery, amazing cultural heritage and beautiful medieval villages in Italy’s green Heart TRIP NOTES 2019 © Genius Loci Travel. All rights reserved. [email protected] | www.genius-loci.it ***GENIUS LOCI TRAVEL - The Real Spirit Of Italy*** Guided ‘Small Group' adventure INTRODUCTION At just a short distance from Rome, the Abruzzo is one of the most interesting areas in Italy, featuring some amazing mountain scenery, not as famous as the Dolomites further north, but with a nature so precious that the region now even boasts three main national parks and a number of regional parks. You’ll find some pieces of almost pristine landscape, where even wolves, deer and brown bears still wander around. The nature here is overwhelming and well protected. During this tour you’ll visit all three national parks, each very different from the other, but all equally beautiful. You will of course make some wonderful walks through all of this abundant nature, which makes you feel like you’re far away from everything else. You visit some of Italy’s most beautiful national parks, among which is the Gran Sasso National Park – featuring the highest peak in the Apennines – the savage Maiella National Park, dotted with remote medieval monasteries, some of which were founded by the famous Pope Celestine V, and of course the Abruzzo National Park, one of the oldest protected landscapes in Italy. But nature is not the only feature of this area, and we don’t forget about the cultural treasures of this region either. -

Abruzzo, the Authentic Wilderness of Central Italy TRIP NOTES 2021
Drive & Hike, Walk & Discover Abruzzo, the Authentic Wilderness of Central Italy Walking through the 3 National Parks of the Abruzzo, abundant nature, dotted with cultural highlights TRIP NOTES 2021 © Genius Loci Travel. All rights reserved. [email protected] | www.genius-loci.it ***GENIUS LOCI TRAVEL - The Real Spirit Of Italy*** Drive & Hike, Walk & Discover INTRODUCTION At only a short distance from Rome lies one of the most interesting nature areas of Italy, the Abruzzo, featuring an almost pristine landscape. The mountains of the Central Italian region are part of the Apennine mountain range and include several peaks over 2000 m high, including the Corno Grande in the Gran Sasso Massif (2913 m). In this landscape of wild mountains and rolling hills, wolves and bears still roam free. Nature here is overwhelming and now protected by three national parks, each very different from the other. You’ll visit the Gran Sasso National Park, the savage Maiella National Park, dotted with remote medieval monasteries and the Abruzzo National Park, one of the oldest protected landscapes in Italy. During your tour you will walk through all of this abundant nature and have the opportunity to climb up to the very top of the Corno Grande. You will walk through the spectacular Orfento Canyon. You will explore the Lama Bianca Nature Reserve and hike on the Camosciara footpath where you can observe chamois roaming in the wild. During your walks you will cross meadows full of colourful alpine flowers and wild orchids, while hiking in the woods alongside little streams you will be able to admire giant centuries- old beech trees. -

Proposal Bay of Naples
Guided ‘Small Group' adventure Abruzzo Apennines Mountains, Monasteries & Castles A cultural walking tour through the three National Parks of Abruzzo: great mountain scenery, amazing cultural heritage and beautiful medieval villages in Italy’s green Heart TRIP NOTES 2019 © Genius Loci Travel. All rights reserved. [email protected] | www.genius-loci.it ***GENIUS LOCI TRAVEL - The Real Spirit Of Italy*** Guided ‘Small Group' adventure INTRODUCTION At just a short distance from Rome, the Abruzzo is one of the most interesting areas in Italy, featuring some amazing mountain scenery, not as famous as the Dolomites further north, but with a nature so precious that the region now even boasts three main national parks and a number of regional parks. You’ll find some pieces of almost pristine landscape, where even wolves, deer and brown bears still wander around. The nature here is overwhelming and well protected. During this tour you’ll visit all three national parks, each very different from the other, but all equally beautiful. You will of course make some wonderful walks through all of this abundant nature, which makes you feel like you’re far away from everything else. You visit some of Italy’s most beautiful national parks, among which is the Gran Sasso National Park – featuring the highest peak in the Apennines – the savage Maiella National Park, dotted with remote medieval monasteries, some of which were founded by the famous Pope Celestine V, and of course the Abruzzo National Park, one of the oldest protected landscapes in Italy. But nature is not the only feature of this area, and we don’t forget about the cultural treasures of this region either. -

Wildland Fires in Italy 2009
If you want to cultivate peace, preserve creation. Pope Benedict XVI XLIII WORLD PEACE DAY 1 JANUARY 2010 EDITORIAL OFFICE SUPERVISION Dep. Commissioner Alfredo Milazzo, Dep. Commissioner Mauro Capone COORDINATION OF WORKING GROUP AND TEXT PREPERATION Assistant Commissioner Angela Malaspina WORKING GROUP Assistant Commissioner Lorenza Colletti, Chief Superintendant Marco Di Fonzo, Assistant Commis- sioner Angelo Mariano, Assistant Commissioner Marco Pezzotta, Corporal Laura Mariani, Administration Massimiliano Falchi COMPILATION OF STATISTICS AND GRAPHES Vice Sergeant Maurizio Amendola, Constable Enrico D’Amato, Vice-Auditor Isabella Soldo INVESTIGATIVE ACTIVITY OF THE ITALIAN FOREST CORPS Assistant Commissioner Angelo Marciano, Inspector Antonio Valvano, Sergeant Amato Patrone, Computer technician Marco Santarelli COVER PHOTOGRAPH Liguria Regional Command INDEX FOREWORD 5 REFLECTIONS ON FOREST FIRES 7 DATA COLLECTION AND SHARING 13 FIRE STATISTICS 13 DATA COLLECTION BY THE ITALIAN FOREST CORPS (CFS) 13 THE WILDFIRE DATA COLLECTION ORGANISATIONAL MODEL 13 TIME FRAME 14 FIRE CADASTER 14 FIRES 16 WILDFIRES IN 2009 16 WILDFIRE BY REGION 19 THE MOST SERIOUS FIRES IN 2009 22 FOREST FIRES BY MONTH 25 FIRES CLASSIFIED BY SIZE 27 FIRES CLASSIFIED BY DURATION 32 FORESTED AREAS AFFECTED BY FIRE 33 WILDFIRES IN PROTECTED AREAS 35 THE RECURRENCE OF FIRE 40 THE STARTING POINT OF A WILDFIRE 41 THE CAUSES 42 NON-WOODLAND FIRES 48 WILDFIRES AND SAFETY 50 THE OPERATIVE CENTRE AND THE “1515” HELPLINE 53 AIR SUPPORT IN THE FIGHT AGAINST WILDFIRES 54 INVESTIGATIVE